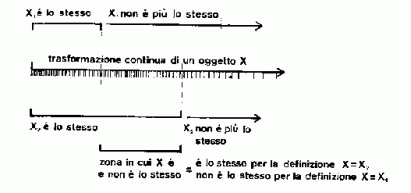
|
Capitolo Terzo L’identità |
§ 1. Introduzione.
Anche l’identità, come l’unità, discussa nel capitolo precedente, fa parte di quegli aspetti dell’esperienza che vorremmo indicare come categoriali, e per motivi strettamente simili. Non meno delle configurazioni unitarie, infatti, contribuisce a dare all’ordine delle cose esperite l’aspetto che esso ha, quale che sia il particolare contenuto di oggetti e di eventi per un dato osservatore in un momento dato della sua biografia.
In ciascuno di tali momenti, come abbiamo visto, l’esperienza che l’uomo ha direttamente di sé e del mondo intorno a sé è fatta di una quantità innumerevole, benché non infinita, di cose, semplici, complicate, facilmente descrivibili o no; tali cose sono discernibili una dall’altra, e normalmente risultano ben segregate ed autonome, dislocate nello spazio secondo rapporti di distanza osservabili altrettanto direttamente quanto gli oggetti tra cui intercorrono: tale organizzazione, come s’è visto, poggia intieramente su leggi empiricamente verificabili: il mondo constatabile non è suddiviso in pezzi arbitrariamente, nè possiamo mutare arbitrariamente la sua suddivisione.
Possiamo fare un passo avanti. Da questa scena, alcune delle cose che adesso contribuiscono a popolarla possono uscire, altre prima non presenti entrarvi a far parte, e la trasformazione in questo senso può essere così radicale che in un tempo più o meno breve tutti gli elementi di una esperienza qui-ora risultino sostituiti; in questo caso possiamo dire che il suo «contenuto» è totalmente cambiato. Possiamo benissimo immaginare una quantità di esperienze possibili aventi «contenuti» completamente diversi, i più usuali e i più strani. D’accordo che immaginare esperienze è qualcosa di sostanzialmente diverso dall’avvertirle, cioè dal viverle; ma questo fatto, per ora, non ha importanza in relazione a quanto vogliamo dire. L’importante è che nel rappresentarci ciascuna di esse possiamo eliminare radicalmente dagli ingredienti percettivi usati nel comporla qualcuna delle comuni proprietà che fanno parte dell’esperienza d’ogni giorno. Potremmo fare a meno di certi colori, come il rosso e il verde, o di tutti i colori visibili, servendoci solo di grigi diversi, come nei film in bianco e nero; potremmo eliminare il movimento, immaginando una scena statica come una fotografia; potremmo evitare che in essa compaiano oggetti riconoscibili e significativi, componendola con forme geometriche o macchie aventi forme più o meno definite ma tali da non suggerire il ricordo di oggetti noti (nel limite del possibile, che è piuttosto ristretto); e così via.
Ma come non potremmo immaginare niente di tutto ciò senza uno spazio in cui abbia luogo, e senza unità costituite in quello spazio, così non lo potremmo immaginare per una durata temporale nulla, e senza la permanenza di tali unità (sia pure brevissima) nell’ambito della durata temporale. Questi aspetti del mondo osservabile li dobbiamo considerare non come contenuti occasionali, soltanto possibili, ma appunto come strutture costitutive e condizioni dell’esistenza di tali contenuti. Ad esempio l’identità: non è possiblle immaginare una scena in cui gli elementi costitutivi non possiedano in qualche grado una propria identità; possiamo rappresentarceli come divenienti di attimo in attimo un’altra cosa, diversa, da quella che erano un attimo prima, in un caos indescrivibile di trasformazioni. Ma per immaginare una continua perdita di identità occorre pure immaginare una identità che va perduta, una identità durata solo un attimo; inoltre non potremmo nemmeno parlare di elementi diversi della scena in assenza totale di identità, né di trasformazioni che, in quanto tali, sono processi definiti ed autoidentici, tanto è vero che hanno un inizio e una fine.
Come nel caso già illustrato dell’unità. Anzi, è difficile decidere se l’unità percettiva presupponga la identità o, viceversa, se l’essere un evento autoidentico poggia sul fatto di essere uno: sembrerebbe che ogni oggetto possa essere riconosciuto come «uno» solo nel caso che permanga identico almeno per il tempo necessario a distinguerlo, e che qualcosa possa possedere una propria identità solo a patto di essere costituita unitariamente. Ma non è detto: per dimostrare il contrario basterebbe trovare esempi adatti. Forse esistono esempi di identità senza unità, e di unità senza identità. In tale caso la tesi più ovvia, ora detta, risulterebbe falsa.
Il ruolo essenziale dell’identità nel costituirsi dell’esperienza umana è stato visto chiaramente, come è avvenuto per il problema dell’unità, fin dalle origini della nostra cultura. Il tentativo di costruire una teoria dell’identità ha condotto subito i ricercatori di fronte a difficoltà molto grosse, soprattutto di ordine logico e linguistico. Forse proprio per questa ragione il problema dell’identità come proprietà empirica degli oggetti ha tardato tanto a venire in luce ed a trovare il suo posto in un contesto teoretico adeguato, mentre l’intelligenza umana elaborava analisi finissime sui presupposti logici della sua definizione; e, forse, le troppo vive preoccupazioni destate dalle difficoltà che sorgevano su questo piano, con gli inevitabili echi di ordine metafisico, indussero la maggior parte degli autori a ritenere che l’eventuale dimensione empirica del problema venisse intieramente a dipendere dalle soluzioni che potevano essere date nell’altra sede: il problema dell’identità degli oggetti, si sostenne a lungo, si risolve intieramente nel problema del giudizio di identità. O addirittura: gli oggetti possono apparirci identici in quanto il pensiero umano li pensa alla luce di una logica di cui l’identità fa parte, o come principio, o almeno come momento necessario di un processo che conduce alla, sua negazione.
Non possiamo seguire qui la complessa storia di queste idee. Ci soffermeremo su alcuni punti particolari, come nella sezione precedente, prendendo in esame quegli aspetti della questione che meglio di altri - a nostro avviso - servono a mettere in luce la natura del problema che interessa, noi come studiosi delle proprietà dell’ esperienza diretta.
§ 2. Identità e mutamento
Ci sembra di poter dire che già nelle prime dottrine avanzate dai filosofi intorno all’identico e il diverso vi è un punto particolarmente delicato, quello che in seguito riapparirà più volte nella storia del pensiero obbligando l’attenzione degli studiosi in direzioni che difficilmente portano ad incontrare il problema fenomenologico dell’identità. Il punto può essere riassunto così: per quanto due cose possano essere considerate simili, ben difficilmente potremo chiamarle identiche; sarà assai facile trovare fra esse una differenza, magari minima; se non sarà trovata empiricamente, potremo comunque pensarla. Dire che due cose sono identiche comporta un certo margine di grossolanità, che resta tale anche se gli usi del discorso quotidiano ce la permettono. Non vi sono, a rigore, due cose identiche. Ma una stessa cosa può essere detta autoidentica? Neppure: scrive Aristotile: «dicendo che una cosa è identica a se stessa la si tratta come due» (Metaph., 1018 a, 9), e tanto più se la consideriamo in due momenti successivi, sia pure quanto si voglia vicini nel tempo. L’autoidentità delle cose sarebbe dunque garantita solo dalla totale assenza di trasformazioni, e dall’assenza del flusso temporale. Platone costituì un mondo dove vigevano tali condizioni, e vi collocò le idee.
Un esempio degli esiti a cui conduce una così severa dottrina dell’identità è il sistema filosofico di Eraclito. Non solo tutto scorre come un fiume, ma non possiamo bagnarci due volte in quello stesso fiume. Trascorso un attimo, piccolo quanto si voglia, nel fiume sono già intervenute trasformazioni tali da non permettere più di chiamarlo, a rigore, quello stesso. Probabilmente, questa è una caricatura del pensiero di Eraclito; è vero che il frammento 91 [1] dice letteralmente che non è possibile entrare due volte nel medesimo fiume, ma il frammento 49 a avverte che in realtà «nei medesimi fiumi entriamo due volte e non entriamo, siamo e non siamo»: e questo modo di esprimere il concetto ci porta davanti al punto decisivo di tutta la questione. Dicendo che non entriamo due volte nello «stesso» fiume, diciamo una volta che il fiume è lo stesso, e una volta che non lo è; non potremmo altrimenti introdurre il concetto eracliteo servendoci del linguaggio comune, capito da tutti. In pratica, non potremmo spiegare la critica di Eraclito al senso comune senza dar credito a quest’ultimo almeno per un momento, all’inizio; in modo che, prima accettiamo provvisoriamente che quel fiume, mentre stiamo parlando, è sempre lo stesso, e subito aggiungiamo che è sbagliato credere così, dal momento che, mentre lo stavamo dicendo, in esso sono avvenuti cambiamenti abbastanza grandi da impedirci di chiamarlo - a rigore - lo stesso. Per questo, come dice il frammento 49a «entriamo due volte, ma non entriamo». Entriamo due volte nel senso ovvio che ha questa espressione; capito il quale compiamo un altro passo avanti, più sottile: ma non vi entriamo due volte, perché non è - la seconda volta - lo stesso. Si duo faciunt idem, non est idem.
Anche Platone, in un interessante passo del Sofista, sembra farsi portavoce di una tesi simile (benché sia difficile decidere se egli appoggi tale tesi, o semplicemente la prospetti come possibile). A un certo punto Teeteto e uno straniero di Elea stanno discutendo del moto e della quiete[2]. È facile capire come il movimento costituisca un esempio critico, quando si tenti di applicare il concetto di identità in senso rigoroso, dal momento che un oggetto in movimento o in trasformazione, benché sia continuamente riconoscibile come «quel dato oggetto», istante per istante è altrove rispetto a prima, o comunque è disposto spazialmente in modo diverso da com’era nei momenti immediatamente precedenti. Dunque, lo straniero di Elea, dopo aver fatto ammettere a Teeteto che il moto esiste, e che esso non è compatibile con il restare lo stesso, dato che è trasformazione, arriva ad indicare una contraddizione: se, come precedentemente era stato ammesso, ogni cosa quella che è, e cioè «tutto partecipa dell’identico» (256 a 7-8) come mai il moto, che consiste nel non restare identico, può esistere? Avendo Teeteto convenuto che qui c’è una difficoltà, lo straniero aggiunge: «allora bisogna riconoscere, senza protestare, che il moto è identico eppure non è identico. Infatti quando diciamo che esso è identico e non è identico, ciò non diciamo dal medesimo punto di vista ; ma quando diciamo che è identico, lo diciamo tale per la sua partecipazione all’identico, mentre quando diciamo che non è identico, lo diciamo per quanto ha in comune col diverso». Naturalmente, questo passo è scritto nel linguaggio e nello spirito della dottrina platonica delle idee, e a stretto rigore dovrebbe essere interpretato solo in tale luce. All’incirca cosi, credo: il moto, in quanto esiste, partecipa dell’essere - dell’essere proprio quello che è; ma partecipando anche del cambiamento, ha qualcosa in comune con l’eterogeneità, la non identità. Di qui l’apparente (o reale) contraddizione.
Tuttavia, credo che il passo possa essere interpretato anche fuori dal contesto tipicamente platonico cui si riferisce, e cioè che possa essere letto avendo di mira la realtà attuale della esperienza del moto o del mutamento. Nell’esperienza del moto vi sono indubbiamente due aspetti: quello dell’autoidentità della cosa che è protagonista del moto, per cui ci è impossibile non vedere che è proprio essa e non altro che si muove o trasforma, e quello del cambiamento attraverso cui la cosa in questione resta quella cosa stessa. Il concetto astratto del moto è bene costruito da Platone tenendo presenti queste due esigenze, quali che siano le difficoltà sul piano logico create dalla loro compresenza. L’identità1 è mantenuta attraverso una continua perdita di identità2, quest’ultima non compromettendo in alcun modo la prima. Naturalmente, perché ciò abbia luogo occorre che l’identità1, non venga definita allo stesso modo che l’identità2; per questo va detto che di esse «non parliamo dal medesimo punto di vista «.
L’esperienza del moto va d’accordo con questa descrizione. Ma da un punto di vista strettamente logico rimane il senso che qualcosa non cammina a dovere; non risulta definito, ad es., il limite tra quel tanto che, nella trasformazione, garantisce l’identità del protagonista e quel tanto che effettivamente cambia.
Ciò, dal punto di vista delle proprietà osservabili del moiimento e delle trasformazioni in genere, non costituisce alcuna difficoltà, come vedremo in seguito: vi sono cambiamenti compatibili con il mantenimento dell’identità, ed altri che conducono ad un salto qualitativo in cui l’identità va perduta. La difficoltà vera è qui squisitamente linguistica: l’identità, per essere una parola descrittiva di esperienze reali, dovrebbe ammettere delle gradazioni; ma, d’altra parte, nessun concetto sembra ammettere - da un punto di vista logico - così poche gradazioni come l’identità: A è identico a B, o non è identico a B. Possiamo dire che è insieme identico e non identico solo se vi sono, come scrive Platone, due sensi diversi. Uno di questi può essere la definizione rigida; ma allora l’altro deve essere una definizione almeno un po’ meno rigida.
Torniamo al fiume di Eraclito. Esso subisce continue trasformazioni: osservandole, le vediamo come trasformazioni di «quel» fiume, che intanto resta lo stesso (definizione meno rigida dell’identità di quel fiume) per tutta la durata dell’osservazione; il fiume infatti viene percepito come una unità avente una data forma, certi margini, un posto ben definito nello spazio visibile, ecc., e in questo senso appare lo stesso; ma poi la nostra attenzione viene attratta dal mutare continuo delle increspature sulla sua superficie: allora immaginiamo di confrontare l’aspetto di questa superficie in due momenti successivi distanti tra loro, ad es., due secondi, e vediamo che è molto diverso. La superficie è tutta la parte visibile del fiume; tutto il fiume, dunque, a stretto rigore è cambiato, non è più lo stesso (definizione più rigida dell’identità del fiume). Ma un piccolo cambiamento ci sarà comunque, anche se considererò il fiume due volte alla distanza di pochi millesimi di secondo; di conseguenza, solo considerando il fiume in un dato attimo esso è realmente autoidentico. Dovrebbe stare assolutamente fermo, e dovrebbe giacere in un mondo dove il tempo non c’è, perché non ci fosse la possibilità di considerarlo - sia pure fermo - in due attimi successivi t1 e t2. Quest’ultima è la definizione più rigida dell’identità, quella imposta dalle esigenze della logica.
Dunque, quando si cerca di considerare l’identità in due sensi molto probabilmente si tenta di assumere, in una situazione data, due ambiti diversi di trasformazione, tali che uno di essi stia dentro all’altro, in modo che quando, in base a un primo criterio, A (punto di partenza) si è già trasformato abbastanza per non essere più identificabile come A, c’è tuttavia, un altro criterio, più largo, che permette ancora di considerarlo come A.
In questo modo A può essere ancora =A, e già non più =A. Naturalmente, finché i criteri non siano specificati, resterà assai difficile capire cosa possa voler dire «A è e non è contemporaneamente A». I criteri a loro volta devono essere appoggiati a specifici modi possibili di considerare l’oggetto di cui ci si occupa. La difficoltà dunque non è una difficoltà inerente la natura delle trasformazioni, ma riguarda solo il nostro modo di usare il linguaggio nel descriverne alcuni aspetti.
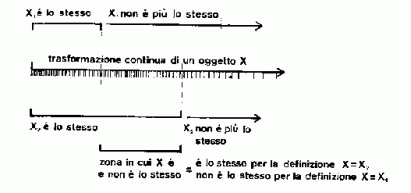
Fig.61
Aristotile, come al solito assai vicino alle concezioni del senso comune, sembra in qualche passo sostenere appunto questa tesi.
Nella Metafisica (1006 b), per esempio, è detto che « una stessa cosa potrebbe essere o non essere soltanto nel caso di un equivoco, qualora, ad es., quel che noi chiamiamo uomo altri chiamassero non-uomo. Quel che è in questione - aggiunge Aristotile - non è già se lo stesso possa insieme essere e non essere uomo di nome, ma di fatto. Se uomo significa lo stesso che non -uomo ... tra essere e non essere uomo, essendo identica la cosa, non ci sarebbe alcuna differenza. Questo appunto vuoi dire esser l’identica cosa: come chi dicesse abito e vestito».
In altre parole, è possibile che succeda di non essere esattamente d’accordo sui limiti entro i quali un dato oggetto da noi incontrato, per certe caratteristiche che ha, può essere detto uomo: un’altra persona potrebbe (riferendosi ad una definizione più ristretta) escludere che si tratti di un uomo. La difficoltà in cui ci troveremmo non dipende da qualche contraddizione che sia interna all’oggetto, ma su un modo diversamente inteso di dare una definizione. Tanto è vero che se assumiamo - come diremmo noi oggi - una definizione ostensiva per la parola «uomo», e cioè mostriamo con il dito indice un uomo pronunciando la parola «uomo» mentre qualcun altro, indicandolo ugualmente, pronuncia la parola «non uomo», avremmo che «uomo» e «non-uomo» vogliono dire lo stesso in due lingue diverse, come già concludeva Aristotile.
Questo modo di ragionare può essere utilmente applicato anche al caso del movimento e delle trasformazioni in atto[3], Possiamo decidere, mentre osserviamo una trasformazione, che l’oggetto a un certo punto è ancora quello, mentre un altro osservatore dice di no; per esempio, se un colore rosso si sta tra sformando verso il giallo attraverso una serie di arancioni, un pittore potrà dirmi a un certo momento che questo rosso non è più un rosso, mentre io, essendo un profano in fatto di colori, persisto a trovare adatto tale aggettivo.
L’adozione di un punto di vista come questo facilita molto, ad Aristotile, l’elaborazione di una teoria del mutamento, quale è quella esposta nel sesto libro della Fisica (253 b, 6-263 b, 18). Tutto ciò che cambia, cambia da un termine a un altro, ed esiste un momento esatto in cui si può dire che un processo di mutamento si è concluso (benché non si possa dire altrettanto per l’inizio di un mutamento). È possibile constatare che una trasformazione è già compiuta, come è possibile constatare che una trasformazione è in atto. Una cosa cambia in ciascuna delle porzioni di tempo che costituiscono, nell’insieme, la durata del suo cambiamento (236 b 19-32). In nessuna di queste fasi una cosa è e non è contemporaneamente (235 b, 15). Le fasi possono essere assunte come piccole a piacere, perché sono suddivisibili all’infinito (273a, 20-28).
In che modo può essere mantenuta l’identità dell’oggetto attraverso i cambiamenti avvenienti nel tempo? La risposta di Aristotile è estremamente suggestiva: ogni cosa che abbia subito un cambiamento è ancora, una volta che questo sia compiuto, nella cosa in cui è stata cambiata (235 b, 26-27). Indubbiamente una simile risposta può trovare posto solo in una prospettiva teoretica che abbia alla sua base una metafisica; questo non toglie che (per i tempi in cui è stata formulata) debba essere considerata come una presa di posizione chiara, coraggiosa e comprensibile.
Una così duttile teoria del mutamento, che ammette per
le trasformazioni la più ampia libertà e nello stesso tempo sottolinea
l’esistenza, in esse, di confini definiti o almeno definibili, permette ad Aristotile
di dire che l’identità può essere intesa in parecchi sensi diversi
(Top. 103 a-103 b; 151b, 28-152 b). In almeno
due luoghi della Metafisica egli parla dell’eguale ![]() del simile e dell’identico
del simile e dell’identico ![]() - (1021 a, 11 e 1054 b, 3) oltre che dell’identità in senso
stretto (
- (1021 a, 11 e 1054 b, 3) oltre che dell’identità in senso
stretto (![]() -1004
b, 11; 1054 b, 3) discutendone i significati e dando interpretazioni
- se non erriamo - leggermente diverse in punti diversi. In 103 a, 6-24
dei Topici, dove prospetta una nuova tripartizione del significato della identità,
Aristotile riprende l’esempio di Eraclito (senza nominarlo, come se volesse
far intendere che non ha intenzione di discutere il problema dello «stesso
fiume»), appena leggermente modificandolo: «può sembrare per
altro che l’acqua sgorgante dalla stessa fonte, pur dicendosi la stessa, sia
in certo modo differenziata, al di fuori dei suddetti significati (identità
di genere e identità di specie). Ciò tuttavia non regge, ed un
caso siffatto dev’essere piuttosto classificato sullo stesso piano di quanto
è riferito in un modo qualunque ad un’unica specie; gli oggetti di una
tale natura risultano infatti tutti quanti omogenei e pressoché uguali
tra loro. Ogni parte d’acqua è invero identica per la specie ad un’altra
parte, poiché ha con questa una certa somiglianza; l’acqua che sgorga
dalla stessa fonte non è dal canto suo differenziata per nessun’altra
ragione, se non perché possiede in sé più spiccata tale
somiglianza» (Trad. G. Colli). Questo modo di dire
le cose sembra banalizzare il drammatico problema di Eraclito, ma forse è
l’unico modo in cui la categoria dell’identità risulta suscettibile di
applicazione al mondo dell’esperienza umana.
-1004
b, 11; 1054 b, 3) discutendone i significati e dando interpretazioni
- se non erriamo - leggermente diverse in punti diversi. In 103 a, 6-24
dei Topici, dove prospetta una nuova tripartizione del significato della identità,
Aristotile riprende l’esempio di Eraclito (senza nominarlo, come se volesse
far intendere che non ha intenzione di discutere il problema dello «stesso
fiume»), appena leggermente modificandolo: «può sembrare per
altro che l’acqua sgorgante dalla stessa fonte, pur dicendosi la stessa, sia
in certo modo differenziata, al di fuori dei suddetti significati (identità
di genere e identità di specie). Ciò tuttavia non regge, ed un
caso siffatto dev’essere piuttosto classificato sullo stesso piano di quanto
è riferito in un modo qualunque ad un’unica specie; gli oggetti di una
tale natura risultano infatti tutti quanti omogenei e pressoché uguali
tra loro. Ogni parte d’acqua è invero identica per la specie ad un’altra
parte, poiché ha con questa una certa somiglianza; l’acqua che sgorga
dalla stessa fonte non è dal canto suo differenziata per nessun’altra
ragione, se non perché possiede in sé più spiccata tale
somiglianza» (Trad. G. Colli). Questo modo di dire
le cose sembra banalizzare il drammatico problema di Eraclito, ma forse è
l’unico modo in cui la categoria dell’identità risulta suscettibile di
applicazione al mondo dell’esperienza umana.
Fondare, come fa Aristotile, una identità su di un rapporto di forte somiglianza è certamente una bestemmia, nei puri cieli della logica; però in concreto apre molte possibilità.
Ad esempio: una rigorosa definizione dell’identità non permetterebbe, come abbiamo visto all’inizio, di parlare di più cose identiche; ma, se rinunciamo a questo eccelso grado di purezza, possiamo elaborare una teoria delle operazioni di confronto tra oggetti all’inizio presunti identici ed enunciare i criteri per cui è possibile decidere la presenza o l’assenza dell’identità (Top. 151b, 28 -152b, 35), tra i quali (152a 31-33) il seguente: «quando... gli oggetti in questione non siano entrambi identici ad un medesimo qualcosa, non potranno evidentemente neppure risultare identici tra essi», su cui successivamente Euclide [4] ha fondato parecchie dimostrazioni, del tutto «formali».
Queste poche citazioni certo non possono dare una idea adeguata della complessità con cui il problema dell’identità - o meglio: i problemi dell’identità - si prospettarono alla mente dell’uomo quando la riflessione su come il mondo è fatto stava sorgendo dal nulla. Ma due punti mi pare che già così emergano chiari: da una parte l’esigenza di definire l’identità sul piano puramente logico, cioè spogliandola da ogni riferimento a ciò che può essere detto identico parlando di eventi constatabili; e dall’altra l’esigenza di trattare l’identità come un concetto rigoroso, sì, nei limiti del possibile, ma tenendo presente anche la possibilità di applicarlo descrittivamente agli eventi con cui l’uomo ha a che fare, e di cui parla.
La prima di queste due esigenze troverà risposte sempre più adeguate, dall’Organon dello stesso Aristotile, attraverso la logica stoica e le scuole logiche medievali, Sacchieri e Leibniz, fino agli ultimi cento anni di logica matematica.
Questo filone non è di nostra competenza, ma va senz’altro detto che i progressi compiuti in tale direzione sono risultati tanto piti decisivi, quanto più i ricercatori si sono adoperati a dividere nettamente i problemi di natura logica da quelli di ordine empirico, e specialmente da quelli psicologici. La formalizzazione della logica rappresenta l’ultima grande tappa, ed è stato possibile realizzarla proprio tagliando nettamente fuori i problemi riguardanti la natura ed il funzionamento del pensiero.
§ 3. L’identità come proprietà degli oggetti.
L’altra esigenza, quella di definire un concetto dell’identità che sia rigoroso, ma agevolmente applicabile ai fatti empirici, ha subito svariate oscillazioni prima che si giungesse con la teoria della gestalt ad una impostazione fenomenologica ben depurata. da residui intellettualistici.
Ogni tanto il problema si è prospettato nella forma che noi, qui, giudichiamo corretta: «quali condizioni devono ricorrere affinché un segmento di esperienza venga avvertito come autoidentico, attraverso il tempo e le trasformazioni?»; ma di solito, dopo che questa impostazione si era annunciata, tornavano a galla risposte di natura intellettualistica, cioè soluzioni in cui il problema dell’identità intesa come proprietà osservabile, direttamente avvertita prima ancora che ci accorgiamo della necessità di trovare una teoria, era pregiudicato da preoccupa zioni di tipo logico.
Cartesio è uno degli autori che con maggiore chiarezza hanno impostato il problema dell’identità in senso strettamente fenomenologico. La domanda, come è posta da lui, è quella stessa che si pone uno di noi quando desidera affrontare qualche particolare aspetto del medesimo problema in una ricerca sperimentale[5]. «Io non intendo parlare dei corpi in generale, perché queste nozioni generali sono d’ordinario più confuse; ma di qualche corpo in particolare. Prendiamo, per esempio, questo pezzo di cera che è stato proprio ora estratto dall’alveare: esso non ha perduto ancora la dolcezza del miele che conteneva, serba ancora qualcosa dell’odore dei fiori dai quali è stato raccolto; il suo colore, la sua figura, la sua grandezza sono manifesti; è duro, è freddo, lo si tocca, e, se lo colpite, darà qualche suono. Infine, tutte le cose che possono distintamente far conoscere un corpo, s’incontrano in questo.
«Ma ecco che, mentre io parlo, lo si avvicina al fuoco: quel che vi restava di sapore, esala, l’odore svanisce, il colore si cangia, la figura si perde, la grandezza aumenta, divien liquido, si riscalda, a mala pena si può toccarlo, e, benché lo si batta, non renderà più alcun suono. Ma la cera resta, dopo questo cambiamento? Bisogna confessare che essa resta; nessuno può negarlo «. Tutte le qualità sensibili sono trasformate, ma l’oggetto rimane lo stesso: non lo stesso sotto qualche aspetto particolare, ma, occorre notare, lo stesso nel senso che chiunque, interrogato, direbbe che è sempre quello (» personne n’en doute, personne ne juge autrement»).
Questa è la domanda; la risposta però è intellettualistica: l’apparenza della cera viene accantonata, e la soluzione del problema viene vista nel fatto che l’uomo, a differenza delle bestie, può concepire la cera (sia pure incorrendo in qualche errore) grazie al suo pensiero. Come nella dottrina aristotelica delle trasformazioni, a una domanda di natura empirica viene data risposta mediante l’introduzione di un nuovo concetto. Aristotile avrebbe detto che la cera com’era all’inizio del discorso è presente nella cera mutata, dopo che è stata avvicinata al fuoco acceso; Cartesio dice che le sue qualità avvertibili sono «il vestito» dell’oggetto pensato, la cui continuità riposa, dunque, sul fatto di poterlo pensare come continuo.
Locke può essere citato come un altro esempio eccellente di impostazione fenomenologica dello stesso problema. Egli introdusse nell’ Essay Concerning Human Understanding, pubblicando la seconda edizione, un intero capitolo sull’identità e la diversità (Chapt. XXVII «Of Identity and Diversity»); ciò per seguire un consiglio datogli dal fisico e fisiologo Molyneux, autore di un trattato d’ottica nel quale per la prima volta venne posto il problema della congruenza tra dati visivi e dati tattili. Il problema di Locke è quello della genesi delle idee di identità e diversità; secondo lo schema del suo libro, trovare l’origine di un’idea vuol dire indagare le condizioni di esperienza in cui si realizza e da cui, successivamente, può essere richiamata. Così, all’inizio del capitolo, nel corso di alcuni paragrafi, sono discussi problemi assai più vicini a quello della percezione dell’identità che a quello della sua definizione.
Locke osserva che la questione nasce dal fatto che a volte ci accade di poter identificare un oggetto già conosciuto altrove e in altro tempo, dopo che il nostro rapporto diretto con esso è stato per un certo periodo interrotto. La rappresentazione astratta di questa situazione d’immediata esperibilità è la base su cui si forma l’idea di identità.
Ma anche se non c’è stata interruzione, il solo fatto di stare osservando qualcosa conduce a constatarne l’identità. «Quando vediamo che una data cosa si trova in un qualunque luogo, in un qualunque istante di tempo, siamo sicuri (checché essa sia) che si tratta proprio di quella cosa, e non altra che in quello stesso tempo esista in altro luogo, per quanto indistinguibile essa possa essere per ogni altro rispetto: e in ciò consiste l’identità» (Trad. C. Pellizzi). L’identità, qui, è implicitamente riconosciuta come un carattere constatabile negli oggetti, come una proprietà constatata («we are sure») in essi. Il problema, inoltre, qui si presenta empiricamente ben determinato, perché il dubitare che una data cosa sia quella che è, non viene descritto come un dubitare in astratto - metafisico o addirittura metaforico - ma viene identificato col dubitare, semplicemente, che possa trattarsi di qualche altra cosa, assai simile a quella in questione.
Poco dopo, infatti, aggiunge: «Quando domandiamo se una cosa qualunque sia la stessa o no, questo sempre si riferisce a qualcosa che è esistito in quel dato tempo e in quel dato luogo, di cui era certo, in quell’istante, che era identica con se stessa, e con nessun’altra «. Sia, dunque, corretto o no il nostro giudizio di identità, (anzi, nel momento stesso in cui poniamo in questione, con una domanda, l’identità di qualcosa) l’autoidentità di essa è garantita. Questo vuoi dire che l’autoidentità dell’oggetto osservato è indipendente dal giudizio che noi vogliamo o possiamo pensare, intorno alla sua identità, o alla sua identificabilità. Vuol dire, anche, che è del tutto sofistico tentar di mettere in dubbio la sua autoidentità istante per istante: Locke non avrebbe ammesso la posizione di una questione come la seguente: «mentre sto guardando questo libro, è esso veramente sempre lo stesso libro?». Perché la risposta sarebbe: «se questo libro ti appare, o ti si presenta, come sempre lo stesso, in questo senso esso è sempre lo stesso» - posizione, questa, tipicamente fenomenologica.
Ancora un passo avanti. Locke distingue nettamente il problema dell’identità di oggetti che debbano venir considerati come aggregati, dal problema riguardante l’identità di oggetti che tali non sono; gli argomenti sono questi: supponiamo che esistano dei corpi impenetrabili, al loro interno continui, racchiusi da una superficie immutabile, atomi di materia, insomma. Ciascuno, in ogni istante, è identico a se stesso: e, data la sua definizione, deve restare autoidentico finché esiste. Ugualmente, se due o più di essi si uniscono per formare un’ unica massa, ciascuno sarà lo stesso, «e fintantoché esistano uniti assieme, la massa, consistente degli stessi atomi, dev’essere la stessa massa, o lo stesso corpo, anche se le parti siano aggruppate nei modi più diversi. Ma se si tolga via uno di questi atomi, o se ne aggiunga uno nuovo, non sarà più la stessa massa o lo stesso corpo». L’identità degli aggregati, dunque, consiste nella somma delle identità degli elementi: non deriva dai rapporti tra elementi, ma dal numero di essi e dal fatto che siano proprio quelli e non altri (§ 4).
Ma una massa di materia e un corpo vivente non possono essere paragonati, sotto questo profilo. «Nello stato delle creature viventi, la loro identità non dipende da una massa delle stesse particelle, ma da qualcos’altro». Non si tratta più di «coesione di particelle di materia comunque unite»; si tratta che «tale organizzazione di dette parti... sia atta a ricevere e distribuire nutrimento.., ecc.», cioè sia funzionale: tale funzionalità resta garantita anche attraverso la sostituzione di un certo numero di elementi che entrino a far parte di «una consimile continuata organizzazione» (§ 5).
Il concetto di organizzazione serve a Locke per distinguere la materia vivente da quella inanimata, e poi la vita animale da quella vegetale, e l’unità della persona umana rispetto al resto. Forse non è il caso di seguirlo fin là. Sta di fatto che, nello stabilire una distinzione tra aggregati ed organizzazioni (siano viventi o no, non importa), egli si è servito di criteri assai vicini a quelli che oggi possiamo adottare, sulle tracce di Wertheimer e von Ehrenfels, per distinguere il rapporto di sommazione da quello di connessione funzionale.
La risposta di Leibniz a queste tesi di Locke è un esempio perfetto di come una posizione rispondente alle esigenze imposte da una prospettiva concretamente fenomenologica dell’esperienza possa essere rovesciata, nel nome di quelle imposte dalla logica pura. Bellissimo ascoltare il dialogo tra Locke e Leibniz (scritto tutto da Leibniz naturalmente, a commento del Saggio, «una delle opere più belle e più stimate dei nostri giorni «), dove pagina per pagina il rigore dell’argomentazione astratta mette alle corde il senso comune, pazientemente e difficoltosamente teorizzato dall’inglese: e non è agevole risolversi per appoggiare incondizionatamente uno dei due.
Locke, dicendo che una cosa è la stessa perché non è un’altra, magari simillima, che sta altrove o esiste in un momento diverso, sbaglia. Infatti si fonda su un presupposto indimostrato: «che la penetrazione [6] non è conforme a natura. Questa supposizione è ragionevole - ammette Leibniz - ma la esperienza mostra pur ch’essa non ha valore qui, quando si tratta di distinzione». Per esempio, le ombre o i raggi di luce si possono compenetrare, e in tutti i casi «potremmo ben immaginare un mondo nel quale i corpi facessero altrettanto». Le differenze vere sono interne, non esterne, spazio-temporali. Il principium individuationis non sta nella distinguibilità. «Se due individui fossero perfettamente simili ed uguali, e, in una parola, indistinguibili per sé medesimi, non si avrebbe principio d’individuazione; ed oso pur dire che non si avrebbe distinzione individuale o differenza d’individui, posta quella condizione». È questa l’enunciazione del postulato dell’identità degli indiscernibili. Con esso diventa perfino impossibile fare l’esempio degli aggregati formati da atomi, perché gli atomi «se ve ne fossero d’identica forma e grandezza, si verrebbe ad averne d’intrinsecamente indistinguibili, ed insuscettibili di essere distinti»; sarebbero dunque un atomo solo e naturalmente, essendo uno solo, non potrebbero formare un aggregato[7].
Con ciò è resa impossibile la distinzione tra aggregati e organizzazioni. Gli esempi di organizzazioni (piante, animali) citati da Locke, e non tutti, ma solo alcuni, possono tuttavia, secondo Leibniz, avere identità: non grazie alle connessioni funzionali che legano le parti, ma perché hanno un elemento in più: la monade, o l’anima. Questo è un concetto tipicamente sommativo dell’organismo: un organismo è un aggregato che si distingue dagli altri perché contiene un pezzo in più che gli altri non hanno. L’organizzazione tra le parti non conta: «la figura è un accidente che non passa de subjecto in subjectum «.
Che questo atteggiamento da logico puro sia, ventidue secoli dopo, ancora quello di Eraclito (all’inizio di questo capitolo volutamente da noi contrapposto a quello più duttile e naturalistico di Aristotile) risulta ora qui chiaramente leggendo avanti lo stesso brano: «e bisogna dire che corpi organizzati altrettanto bene di altri corpi non permangono gli stessi se non in apparenza... È press’a poco come d’un fiume, che cambia perpetuamente d’acqua»! (§ 4).
4. Il punto di vista elementaristico (Hume).
La psicologia di Hume, come ha più volte sottolineato Köhler, si presenta in apparenza come un empirismo decisamente radicale; ma in realtà, nelle sue premesse, contiene assai più assunzioni intorno all’esperienza di quante non sia possibile trovare in essa confermate. È possibile esperire fatti che Hume non avrebbe ammesso mai tra «i fatti»: per esempio, le relazioni tra eventi; oppure, non vi si trovano affatto cose che secondo il suo punto di vista devono esserci: come la influenza decisiva dei giudizi sul modo di apparire delle sensazioni.
Il suo empirismo è ricco di presupposti intellettualistici. Lo stesso concetto di «sensazione elementare» che sta alla base della sua teoria della conoscenza, lungi dall’essere un dato dell’esperienza, è un costrutto logico (come l’atomo, ad es.), derivato dall’assunzione implicita di una fisica e di una fisiologia. Questi errori di fondo non tolgono nulla al valore eccezionale dell’opera di Hume, soprattutto in rapporto alla psicologia moderna: nessun autore che abbia, in passato, sostenuto una teoria atomistica ed elementaristica delle percezioni, l’ha sostenuta con altrettanta coerenza e ricchezza di argomenti. Inoltre, la natura stessa della teoria - come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte nel corso della prima parte di questo libro - si presta a dimostrazioni ineccepibili dal punto di vista logico, e a elaborazioni di una chiarezza e di un rigore schiaccianti.
Nel trattare l’identità, Hume oscilla tra le esigenze di Locke e quelle di Leibniz. Quelle di Locke rappresentano la istanza empiristica, quelle di Leibniz, il gusto di andare anche contro l’evidenza empirica pur di salvare l’esattezza meccanica della dimostrazione. Nei suoi argomenti, egli tiene distinti il problema dell’identità intesa come proprietà predicabile (o no) di un oggetto che subisce cambiamenti, e il problema dell’identità-permanenza, cioè del mantenimento dell’identità da parte di un oggetto considerato in momenti successivi e staccati della sua storia.
Per quanto riguarda il primo argomento, egli interviene nella polemica Locke-Leibniz così: «supponiamo che un ammasso di materia, di cui le parti siano connesse e contigue, ci stia innanzi. È evidente che dobbiamo attribuire una perfetta identità a questo ammasso, purché tutte le parti continuino ad essere le stesse senza interruzione o variazione... Ma, supponendo che una parte piccolissima, impercettibile, venga aggiunta o sottratta, benché strettamente parlando, la identità del tutto sia assolutamente distrutta, tuttavia, siccome di rado pensiamo con tanta precisione, non ci facciamo scrupolo di dire che l’ammasso di materia è lo stesso non ostante quell’insignificante alterazione». Vi è un passaggio così «piano e facile» dall’oggetto com’era prima a come è ora che spontaneamente «tendiamo a immaginare che noi stiamo considerando lo stesso oggetto» (Ed. cit. pag. 309).
Questa concessione, fatta quasi a malincuore, apre la possibilità a due considerazioni nuove, psicologicamente molto interessanti. La prima è questa: la parte che si può togliere o aggiungere a un tutto senza intaccare la sua identità non è una grandezza assoluta ma è «in proporzione al tutto» (legge di Weber). «L’aggiunta o la sottrazione di una montagna non sarebbe sufficiente a produrre una diversità in un pianeta, mentre il cambiamento di pochi pollici basta a distruggere l’identità di altri corpi «. Segue un’ipotesi: ciò forse accade perché è la mente che crea la continuità tra l’oggetto prima e dopo la sottrazione o l’aggiunta, e la continuità delle operazioni della mente su cui gli oggetti agiscono viene a dipendere «non dalla loro reale grandezza, ma dalla loro reciproca proporzione»; ed è «il corso ininterrotto del pensiero quello che costituisce l’identità imperfetta» (ibid.).
La seconda considerazione psicologicamente interessante è la seguente: una grossa sottrazione o aggiunzione, oppure un rimarchevole mutamento interveniente in un corpo può distruggere la sua identità, «ma dove il mutamento si produce gradualmente e insensibilmente siamo meno inclinati ad attribuire ad esso il medesimo effetto «. La nostra mente sente di passare «facilmente» da uno stato all’altro, in condizioni come queste, e così «per questa continuità di percezione la mente attribuisce un’identità ed esistenza continuata all’oggetto «. E qualche pagina più avanti aggiunge di aver constatato che gli eventi per loro natura mutevoli ed incostanti tollerano passaggi più subitanei, nelle loro trasformazioni, senza che vi sia perdita di identità. Innegabilmente, su questi punti l’empirismo di Hume si dimostra più sensibile e ricco di sfumature di quello d’ogni suo predecessore.
Vi è poi il problema dell’identità-permanenza. Qui l’atteggiamento del nostro filosofo è decisamente associazionistico. Le percezioni che subiscono una interruzione e poi riprendono a esistere inalterate vanno considerate come eventi in sé privi di relazione; non come fasi di un evento, ma come eventi diversi. Dato che si presentano come somiglianti, esse ci inducono a considerarle identiche, e a collegarle insieme con la postulazione di una esistenza continua capace di giustificare tale identità; «identità fittizia: nulla che appartenga realmente a queste percezioni diverse fra loro, e le possa unire insieme».
Il connettivo che intercorre tra le varie fasi di apparizione di un oggetto è il giudizio. Noi «supponiamo» che un oggetto sia il medesimo «benché più volte presente e assente ai sensi, e gli attribuiamo un’identità non ostante l’interruzione delle percezioni, perché, pensiamo che, se avessimo tenuto l’occhio o la mano costantemente su di esso, ci avrebbe prodotto una percezione invariabile e ininterrotta». Questa è una «conclusione, che va al di là delle impressioni dei sensi «. Il tramite fra una presenza e l’altra si realizza così: «Ogni volta... che vediamo tale perfetta somiglianza, noi ci chiediamo se essa sia frequente in quella specie di oggetti... e a seconda di quel che concludiamo in proposito, formiamo anche il giudizio sulla identità dell’oggetto» (pagg. 255-256).
Eppure, un atteggiamento così coerente e drastico appare in qualche punto leggermente incrinato. L’evidenza delle esperienze comuni è talmente forte - e Hume talmente onesto - che risulta impossibile negarla fino in fondo. Alla fine del libro (Sec. VI § 2) l’Autore descrive quello che ci succede pensando alla continuità di un oggetto più volte riveduto: è per la mente un passaggio così facile e piano «come se essa contemplasse un oggetto solo e continuo». E nonostante tutti i ragionamenti perseveriamo nell’errore: «per quanto possiamo constatare ad ogni istante che la successione è variabile e interrotta, si può esser certi che un momento dopo le attribuiamo una perfetta identità e la consideriamo come invariabile e ininterrotta»; «benché con la riflessione e col ritorno a un metodo più accurato di pensare ce ne correggiamo di continuo, pure non riusciamo a sostenere a lungo la nostra filosofia, e a liberare l’immaginazione da questa sua tendenza». Così alla fine ci risolviamo ad affermare «coraggiosamente» che la cosa è realmente sempre la stessa, a dispetto del suo apparire e sparire, e per «giustificare tale assurdo ai nostri occhi» inventiamo principi metafisici atti a garantire esistenza e continuità reali.
Inoltre, deve ammettere che c’è qualcosa nelle percezioni stesse che spinge a creare il legame di unificazione, «qualcosa inesplicabile e misteriosa» che è accompagnata alla «tendenza a tali finzioni (della continuità)»; e non è, lo dice espressamente, un’abitudine linguistica. Si tratta del fatto che gli eventi più facilmente unificabili in una identità continua «sono quelli soltanto che risultano da una successione di parti unite dal rapporto di somiglianza e di contiguità». Questo è innegabilmente un passo verso la teoria della forma. C’è anche l’osservazione empirica, in questi ultimi anni controllata indipendentemente da G. A. Miller e G. Vicario [8], che conferma tale ipotesi: «sentendo un rumore frequentemente interrotto e rinnovato, diciamo che è sempre lo stesso rumore, benché sia evidente che i suoni hanno soltanto un’identità specifica, o somiglianza, e che non c’è di numericamente identico altro che la causa che li produce» (pag. 311).
Le idee ora esposte vanno tenute ben presenti, perché sono le idee che dopo Hume saranno professate da quasi tutte le scuole psicologiche entro l’arco di un secolo e mezzo, e forse anche due (1739 - Treatise di Hume; 1935 - Principles di Koffka). Lo sviluppo delle idee humiane intorno all’identità avverrà - senza radicali cambiamenti - per merito soprattutto di J.Struart Mill e H. Taine. La psicologia sperimentale, nata dalla psicofisica nella seconda metà dell’ottocento, è anch’essa, agli inizi, per cinquant’anni e più, del tutto humiana. Intendiamo dire questo in senso stretto: cioè con la duplice faccia dell’elementarismo rigoroso professato sul piano teorico e frequentemente applicato senza compromessi, e -d’altra parte - con la squisita sensibilità per gli aspetti delle esperienze reali, spesso del tutto incompatibili con la teoria, ma pieni di suggestioni teoretiche, forse appunto per questo.
§ 5. Russell e Quine.
Abbiamo preso in considerazione, fin qui, il problema dell’identità in due momenti, staccati e molto distanti tra loro, della storia del pensiero filosofico occidentale. La presentazione è stata ridotta all’essenziale (o a quanto ci è sembrato essenziale in rapporto all’impostazione nostra del problema); molti argomenti strettamente connessi a quello dell’identità sono stati rigorosamente esclusi dalla nostra attenzione. Un confronto tra questi due momenti, dunque, non può che apparire arbitrario. Ma ho l’impressione che una considerazione possa essere fatta, d’ordine così generale da non poter parere neppure dall’esterno come un giudizio storiografico, ed è questa: il problema del mantenimento della identità attraverso le trasformazioni si è arricchito, da Aristotile a Hume, di numerosi particolari, ciascuno per conto suo estremamente interessante; l’identità come fatto e come giudizio, come azione del giudizio sui fatti; l’identità ricostituita dopo una interruzione; le modificazioni dell’identità negli aggregati amorfi in confronto a quelle delle strutture organizzate; i modi specifici in cui le trasformazioni possono avvenire senza intaccare le identità, ecc.; ma il problema di fondo è rimasto lo stesso. Vi è chi dice che ci si può gettare due volte nello stesso fiume, e chi lo nega. L’identità come aspetto della realtà empirica è suscettibile di sempre più soddisfacenti precisazioni e specificazioni, ma resta sempre qualcosa di sostanzialmente impreciso e non bene specificato; e, appena la precisione viene raggiunta sul piano logico, si scopre che la nuova forma di identità non può funzionare in un mondo forse non perfettamente «logico», come il nostro.
Un altro confronto, tra le discussioni sull’identità come si presentavano ai tempi dell’empirismo inglese e quelle che intercorrono tra gli studiosi d’oggi, porterebbe, credo, alla stessa conclusione: nuovi fatti e nuove idee hanno arricchito ulteriormente il problema, generando nuovi problemi particolari; ciascuno di questi vuol essere affrontato con certi speciali metodi e con una data logica. Il problema grosso, di fondo, resta. Molti colleghi, suppongo, avanzerebbero riserve intorno a questa affermazione; forse il problema di fondo è un problema apparente. I logici matematici, in effetti, sempre più spesso si rifiutano di vedere nell’identità empirica una questione alla quale ci si possa interessare dal loro punto di vista; gli studiosi di impostazione fenomenologica - e non parlo solo dei gestaltisti, ma anche di ricercatori di origine diversa (Merleau -Ponty, Gurwitsch) - non fanno rientrare i problemi di logica pura nell’ambito dei loro interessi. discutibile se questa sia una strada buona o no. Sta di fatto che problemi ancora uniti o interrelati, non solo ai tempi di Hume ma anche in quelli di Wundt, oggi fanno parte di specializzazioni diverse. Il problema dei loro rapporti è scomparso? Difficile decidere. Semplicemente, non si vede in che modo potrebbero venire riconnessi.
Tra i non molti studiosi contemporanei che si sono interessati occasionalmente dell’identità con la curiosità bilaterale dei classici, vanno citati B. Russell e W. V. O. Quine.
Essi, almeno per quanto riguarda questo specifico problema, rappresentano posizioni opposte: B. Russell è il Leibniz della situazione, benché assai meno drastico nelle affermazioni di base e molto più aperto alle esigenze dell’applicazione empirica del concetto di identità; anzi, probabilmente guidato nella sua ricerca proprio da queste. É il Leibniz della situazione, perché cerca di derivare la continuità e l’identità degli oggetti attraverso il tempo a partire da una base fatta di oggetti istantanei, autoidentici in senso logico appunto perché istantanei. Sono reali solo le cose considerate in un istante dato: le cose, nel senso normale della parola, cioè estese nel tempo ed autodientiche, sono una costruzione che conduce a previsioni altamente probabili (quindi sono un’ottima nozione del senso comune) ma senza corrispondenza nella realtà. W. V.O.Quine, invece, occupa una posizione del tutto diversa: egli imposta in maniera originale e, secondo noi, singolarmente convincente, un rapporto di derivazione dell’identità puramente logica dall’atto della definizione ostensiva: la quale è, ovviamente, un rimando alle proprietà delle configurazioni percettive.
Per capire il punto di vista di Russell, teniamo presente che da un evento autoidentico in senso logico, e quindi istantaneo, non può essere dedotta l’esistenza di nessun altro evento né prossimo né remoto, tanto dal punto di vista dello spazio che da quello del tempo.
Tale esistenza può essere solo postulata. Il postulato suona così: «Dato un evento A, succede spessissimo che, in qualche tempo contiguo, vi sia, in qualche luogo contiguo, un evento del tutto simile ad A». Questo postulato viene chiamato postulato della quasi-permanenza, ed è la generalizzazione del postulato della varietà limitata di J. M. Keynes[9]). In questo modo, «una «cosa» è una serie di tali eventi. Se «cosa» è un concetto praticamente conveniente, lo si deve al fatto che tali serie di eventi sono comuni»[10].
Dato che Russell ha in mente il tempo della fisica, e quindi la possibilità di suddividere infinitamente ogni durata per piccola che essa sia, la probabilità che, dato un pezzo di materia collocato in una certa regione dello spazio ed esistente nell’istante t1, ci sia un pezzo di materia quasi identico e quasi nello stesso posto nello istante t2 prossimo a t1, sull’asse del tempo fisico, quanto si voglia, è indubbiamente altissima. La suddivisibilità del tempo fisico garantisce - allo stesso modo -transazioni graduali a piacere tra uno stato e un altro, successivo, di un dato corpo, e in ciò consiste l’identità attraverso le trasformazioni. Identità puramente nominale, beninteso quasi come quella di Hume: se ne può parlare solo assumendo che tra ogni oggetto e il suo probabile contiguo spazio-temporale intercorra la relazione chiamata «lo stesso» (transitiva); e una collezione grandissima di oggetti così legati può essere chiamata la «stessa cosa». Gli oggetti precedenti quello considerato sono parti della sua storia. Solo questo ci permette di dire non con certezza, ma con probabilità altissima - «che una goccia d’acqua nel mare in un dato tempo, piuttosto che una qualunque altra goccia, è la «stessa» di una certa goccia in un altro tempo»[11].
Come si vede facilmente, l’adozione di questo postulato potrebbe tornare utile per dare un senso definito e non fenomenologico - alle proposizioni che parlano di continuità o di identità nell’ordine degli stimoli, sia distali che prossimali[12].
Mentre in Russell l’identità logica è il punto di partenza e quella fenomenica il punto di arrivo, in Quine [13] le cose vengono prospettate in senso inverso. «Ci si può bagnare due volte nello stesso fiume, ma non nella stessa acqua»; anzi, più esattamente «ci si può bagnare due volte nello stesso fiume senza bagnarsi due volte nella stessa acqua e si può... bagnarsi due volte nella stessa acqua eppure in due fiumi differenti»[14].
Questa distinzione, concettualmente così facile, come puo essere rintracciata nell’esperienza diretta del fiume? Vi è modo per mettere alla base di essa qualcosa che possa essere ridotto ad una definizione ostensiva, o ad un gruppo di definizioni ostensive?
Definire ostensivamente significa, semplicemente, mostrare, esibire o indicare ciò a cui vogliamo dare un dato nome. Quando impariamo una lingua nuova stando in un paese dove nessuno sa parlare la nostra, di solito cominciamo da definizioni ostensive: si mostra il pane, la porta, la finestra e il nostro interlocutore emette dei suoni che ci sforziamo di imitare. Come è facile intuire, non sempre la definizione ostensiva è priva di ambiguità: possiamo voler sapere come si dice «verde» e a questo scopo mostrare un cespuglio; e l’interlocutore ci inseguerà a dire «cespuglio». Forse, mostrando prima il cespuglio, poi una foglia, poi un terzo oggetto di colore verde, alla fine otterremo l’informazione voluta. Questo richiede che il nostro interlocutore astragga un aspetto percettivo da più ostensioni. È già un processo di concettualizzazione. L’uso della ostensione è precario, passando da cose a concetti.
Inoltre, come scrive Quine, «l’atto di indicare è per sé ambiguo per quanto concerne la estensione temporale dell’oggetto indicato»[15]. Questa difficoltà emerge con particolare evidenza nel caso del fiume (o di altre situazioni simili), dando luogo al problema di Eraclito.
Supponendo che il fiume al quale alludeva l’antico sapiente fosse il Caystro (padre di Efeso, come scrive Pausania), se andiamo sulle rive di esso, e lo mostriamo dicendo: «Caystro», chi ci ascolta può credere che la parola «caystro» voglia dire «questa zona d’acqua, adesso»; ma se crede che i limiti temporali dell’ostensione - il tempo trascorso con il dito teso ad indicare - non debbano essere necessariamente i limiti temporali della cosa designata, gli resta la possibilità di fare più di una ipotesi. «Caystro» può voler dire «acqua», oppure «un fiume», oppure «questo fiume», ecc. Può indicare, in breve, ogni classe di cui l’oggetto indicato potrebbe far parte.
Un successivo atto di ostensione può migliorare le cose se è effettuato nello stesso posto ed in un tempo diverso; chiamando a e b gli oggetti delle due ostensioni accompagnate dalla parola «caystro», potremmo dire che, pur non sapendo il nostro interlocutore che cosa tale parola in effetti indichi, sa ormai che di quella cosa a e b fanno parte. «Se tuttavia indichiamo progressivamente altre parti che si affianchino ad a e b, le alternative diminuiscono sempre più fino a che il nostro ascoltatore, aiutato dalla propria tendenza a favorire i raggruppamenti più semplici, riuscirà ad afferrare l’idea del Caystro», ad esclusione delle altri classi possibili.
Oltre che in tempi diversi, occorrerà moltiplicare le ostensioni in luoghi diversi, lungo il corso del fiume. Ora scrive Quine - «senza l’identità, n atti di ostensione determinano meramente n oggetti, ciascuno di indeterminata estensione spazio-temporale. Ma quando si afferma l’identità di un oggetto in varie e successive ostensioni, facciamo si che le nostre n ostensioni si riferiscano al medesimo e più grande oggetto e forniamo così al nostro ascoltatore un terreno induttivo che gli permette di indovinare quale sia la portata dell’oggetto che avevamo in mente»[16]. L’identità, per Quine, è rappresentata da un fattore puramente linguistico: la stessa parola, «caystro», viene detta nelle diverse circostanze; il suo significato sarà, dunque, un’entità che fa riferimento al contenuto delle varie ostensioni, ma non alle differenze per cui tale contenuto può variare dall’una all’altra; «fino a quando ciò che ci si propone di dire sul fiume Caystro non implica di per sé distinzione fra le parti transitorie a, b, ecc., guadagnamo in semplicità formale se rappresentiamo ciò di cui stiamo parlando come un singolo oggetto, Caystro, invece che come una molteplicità di oggetti a, b, ecc. in rapporto di parentela di fiumi» [17 ](cioè, legati dall’appartenenza alla classe «il tale fiume»).
Rispettando questo criterio - che limita l’uso del procedimento agli «universi di discorso» in cui «non sia di alcun rilievo qualsiasi distinzione fra parti dello stesso fiume» - è possibile realizzare concettualmentse sia l’integrazione di oggetti transitori in insiemi distesi nel tempo, sia l’integrazione di luoghi singolarmente indicabili in insiemi estesi spazialmente, sia -naturalmente - le due cose insieme, come quasi sempre avviene.
Questa tesi di Quine - che ho esposto in maniera estremamente succinta, a dispetto della ricchezza e sottigliezza delle dimostrazioni formali impiegate dall’autore - si colloca all’opposto di quella di Russell, perché, come dicevo, l’identità al livello logico trova la sua base ultima nell’identità come proprietà del dato d’osservazione. Russell, almeno nel libro citato poco fa, opporrebbe che già l’identità delle parti transitorie a, b, ecc. è una finzione logica costruita come integrazione delle esistenze istantanee delle gocce dell’acqua del fiume.
Sta di fatto, però, che il fiume si può mostrare, e che mentre è mostrato possiede certe caratteristiche di omogeneità che rendono difficile operare in esso tagli spaziali e tagli temporali netti, mentre consentono di pensare abbastanza spontaneamente ad una forma di integrazione piuttosto che a un’altra. Nell’argomento di Quine c’è un punto delicato, che rimanda decisamente dal piano della discussione logica a quello dell’analisi fenomenologica: là dove dice che «il nostro ascoltatore, aiutato dalla propria tendenza a favorire i raggruppamenti più semplici, riuscirà ad afferrare l’idea del Caystro». Questo punto è decisivo, nella dimostrazione, perché se le classi a cui a, b ecc. possono appartenere sono infinite [18] nessuna enumerazione di segmenti mostrati come «oggetti transitori» definisce univocamente una di esse. Così, nell’ambiguità, la mente umana, decide per il «raggruppamento più semplice», che può voler dire molte cose, ma di cui l’omogeneità spaziale e temporale che collega le varie parti di un fiume è certamente un buon esempio.
Circostanze come queste, in cui la logica non può fare a meno di rimandare a una fenomenologia dell’esperienza, ci con-vincono che le ricerche fatte intorno ai caratteri ostensibili dell’identità possono avere il loro peso - forse non decisivo, ma neppure piccolo - nella costruzione di una teoria generale dell’identità.
§ 6. L’identicità.
Seguendo lo schema del precedente capitolo, esporremo qui di seguito un certo numero di esperimenti e di riflessioni capaci, crediamo, di mostrare in quale modo si possa fare concretamente qualche passo in tale direzione. Gli esperimenti presi in considerazione non sono certamente tutti quelli che si sarebbero potuti utilizzare, ma solo quelli che ci pareva di poter riunire per mezzo di un filo conduttore abbastanza semplice; le altre ricerche potranno essere rintracciate dal lettore attraverso la lettura diretta dei lavori che qui riferiremo, ed integrate in una prospettiva più ampia di quella che è consentita dai nostri limiti; e vedrà, nel compiere questo lavoro, quanto ce ne sia ancora da fare.
Suddivideremo la trattazione nel modo seguente:
a)l’identicità, intesa come autoidenticità attraverso il tempo (soglie differenziali), e intesa come perfetta uguaglianza tra due oggetti, in situazioni di confronto simultaneo;
b)l’identità come conservazione della struttura attraverso la sostituzione delle parti (Locke, von Ehrenfels);
c)la conservazione dell’identità attraverso l’interruzione delle presentazioni e in situazioni di pluriunivocità.
Il punto a) verrà trattato qui subito. La discussione dei punti b) e c) occuperà per intiero il prossimo capitolo.
Come vedemmo fin dall’inizio, l’enunciato dell’identità logica, inteso nella sua forma più rigorosa, esclude che si possa parlare di autoidentità di un oggetto che duri nel tempo, perché, anche ammesso che tale oggetto non abbia a trasformarsi o a mutare di posizione anche minimamente, resta il fatto che il tempo passa, e l’oggetto A nell’istante t2 non è più strettamente parlando, l’oggetto A nell’istante t1.
Detto in tale forma, questo concetto è inapplicabile alla realtà dell’esperienza, essendo gli oggetti dell’esperienza sempre nel tempo, per poco che durino. Tuttavia, dal punto di vista della fenomenologia della percezione c’è qualcosa da dire. Un aspetto del problema non è specificato a sufficienza: dobbiamo prendere in considerazione il tempo della fisica oppure il tempo percepito? cioè, quello che diversifica A in t2 da A in t1 è semplicemente il fatto che questi due momenti possono venire teoricamente associati a due diverse posizioni di un pendolo nel corso di una sua oscillazione, oppure il fatto (eventuale) che le modificazioni soggettive indicabili con l’espressione «senso del tempo che passa» trasformano concretamente l’oggetto di momento in momento?
Il quesito ora posto non è nè sofistico nè ozioso. Ricordiamo quanto è stato detto nella prima parte di questo studio a propoposito dell’errore dello stimolo: in forma molto generalizzata, si può dire che l’errore dello stimolo consiste nello attribuire all’oggetto dell’esperienza diretta caratteristiche pensabili come proprie delle condizioni di stimolazione, quindi proprietà definibili in termini di misurazione fisica.
Ora, il tempo misurabile con i cronometri è certamente una caratteristica della stimolazione: infatti, viene assunto come variabile indipendente tutte le volte che abbiamo da misurare soglie di contemporaneità, o durate minime percepibili, o quando vogliamo studiare la valutazione di durate temporali, o come esse vengono confrontate ecc. Ma esso non è una caratteristica dell’evento percepito, tant’è vero che noi in realtà percepiamo la contemporaneità tra due eventi anche in casi in cui gli stimoli fisici corrispondenti non sono contemporanei, e valutiamo come uguali o diseguali - in particolari condizioni - durate che dal punto di vista della misurazione cronometrica non lo sono, e così via. Nelle soglie di contemporaneità, in particolare, avviene che tra il primo evento e il secondo, per le misurazioni fisiche, vi è un intervallo di tempo di una certa grandezza
![]()
mentre dal punto di vista dell’osservatore tra i due
eventi non vi è alcun intervallo![]() ;
cioè, fra t1 e
t2 non è passato alcun tempo; il flusso temporale
reale, constatabile, non va mai confuso, in nessun caso, con il tempo fisico
misurato; gli oggetti percepiti non sono - diciamo così - immersi nel
tempo misurato dagli strumenti, ma durano nel campo temporale fenomenico, il
quale, a sua volta, ha proprietà variabili in funzione di cambiamenti
intercorrenti tra fatti giacenti nel tempo fisico.
;
cioè, fra t1 e
t2 non è passato alcun tempo; il flusso temporale
reale, constatabile, non va mai confuso, in nessun caso, con il tempo fisico
misurato; gli oggetti percepiti non sono - diciamo così - immersi nel
tempo misurato dagli strumenti, ma durano nel campo temporale fenomenico, il
quale, a sua volta, ha proprietà variabili in funzione di cambiamenti
intercorrenti tra fatti giacenti nel tempo fisico.
Riflettendo bene su quanto abbiamo detto ora, è chiaro che affermare - dal punto di vista dell’esperienza diretta - che l’oggetto A di adesso non è lo stesso oggetto A di un momento fa perché il primo è associato all’istante t1 del tempo fisico e il secondo all’istante t2, è proprio commettere l’errore dello stimolo, cioè è attribuire ad A, come suo ambiente temporale, il tempo della fisica invece che quello dell’esperienza, in cui esso si trova realmente. Infatti, supponiamo che t1 e t2, istanti definibili con misurazioni fisiche, delimitino una durata di tempo fisico piccola abbastanza per dar luogo ad un fenomeno di «contemporaneità percepita». Tra A considerato in t1 e A considerato in t2, dobbiamo dire, non è passato alcun tratto di tempo fenomenico, e A deve essere considerato contemporaneo con se stesso.
Questo ragionamento è senza dubbio paralogistico; ma appunto dimostra che ragionare in modo misto, mettendo oggetti fenomenici nello spazio e nel tempo della fisica, od oggetti della fisica nello spazio e nel tempo dell’esperienza umana, conduce a paralogismi[19].
Il problema è, dunque, se il flusso temporale dell’esperienza - comunque avvertito - influisca, semplicemente trascorrendo, sull’identità di un oggetto dell’osservazione.
Bergson, nell’«Évolution créatrice» sostiene che ciò avviene sempre. «Consideriamo il più stabile degli stati interni, la percezione visiva di un oggetto esterno immobile. L’oggetto può bene restare sempre lo stesso, e io posso continuare a guardarlo, dalla stessa parte, dallo stesso angolo visuale, alla stessa luce: l’immagine che ne ho differisce tuttavia da quella che ne ho avuto poco fa, se non altro perché è più vecchia di un istante rispetto a questa (elle a veilli d’un istant)» [20]. Ciò, se è vero quanto abbiamo cercato di dimostrare or ora, è sbagliato. Il trascorrere del tempo fisico non fa parte dell’oggetto fenomenico; dunque tale oggetto non «invecchia» per il tempo fisico che passa; eventualmente, invecchierà per altri fatti che gli succedono intorno, nel tempo dell’esperienza.
Bergson prosegue: «C’è lì la mia memoria che proietta qualche cosa di quel passato in questo presente. Il mio stato d’animo, avanzando nella via del tempo, s’accresce continuamente della durata che raccoglie... Ma è comodo non badare a questo cambiamento ininterrotto, e non notarlo se non quando sia divenuto tanto profondo da imprimere al corpo un nuovo atteggiamento, all’attenzione una direzione nuova. Ma la verità è che si cambia continuamente e che lo stato stesso (l’état lui même) è già un cambiamento»[21].
Alla fine del primo passo citato, il trascorrere del tempo è inteso in senso puramente cognitivo: so che l’oggetto è diventato più vecchio, dunque è cambiato e posso considerarlo come non «lo stesso». Nel secondo tratto di citazione, invece, il tempo sembra essere un certo ordine di trasformazioni continue presenti nel campo dell’esperienza insieme all’oggetto guardato: quelle che caratterizzano il trascorrere del tempo psicologico. Questa percezione del trascorrere del tempo potrebbe comportare qualche trasformazione nell’oggetto osservato, potrebbe essere la «condizione» di qualche suo aspetto (benché, è da dire, la presenza fenomenica del tempo non è sempre ugualmente intensa: a volte non è neppure avvertita, a volte assume un ruolo predominante, come nelle situazioni di attesa).
Ma normalmente, e certamente in situazioni che corrispondono a quella descritta da Bergson, il senso dell’avanzare del tempo si costituisce come una esperienza interna, riguarda la memoria, le modificazioni dello stato d’animo, l’attenzione, i pensieri che frattanto ci passano per il capo; e il fatto che accadono in queste regioni dell’esperienza non implica che debbano coinvolgere anche ciò che sta in altre: l’oggetto può benissimo restare autoidentico e immutato mentre io («io», l’osservatore: regione del campo dell’esperienza autonoma e ben distinta dalle altre) sono pervaso dai più vari sentimenti. A volte, può darsi che la struttura dell’oggetto resti coinvolta in tali trasformazioni interne. Poco prima di perdere i sensi, ad es., in caso di svenimento, gli oggetti si deformano e mutano di colore in un senso ben definito, venendo meno le costanze di forma e di chiarezza. Di solito, però, non succede niente di tutto questo: l’oggetto osservato non è toccato dalle modificazioni degli stati vissuti come interni: esse, infatti, agiscono o non agiscono sull’oggetto in questione; ma se agiscono deve essere mostrabile in esso qualche sua parte o proprietà che concomitantemente muta: l’effetto dell’azione dev’essere visibile. Se questo non accade, allora i miei sentimenti del tempo non possono essere annoverati tra le variabili della struttura dell’oggetto. Cioè, l’oggetto è un sistema indipendente rispetto ad essi.
Pensare diversamente vuol dire ammettere le sensazioni inavvertite (cfr. il Capitolo II, § 1): se penso che i miei sentimenti agiscono sulla percezione dell’oggetto osservato, ma in modo così debole che io non me ne accorgo, devo ammettere che ci sono sensazioni fuori di ogni possibilità di constatazione. Abbiamo visto incontro a quali difficoltà teoriche si va, su questa strada
Dunque: non necessariamente - anzi, solo a condizioni ben definite e piuttosto insolite il trascorrere del tempo dell’esperienza porta mutamenti negli oggetti presenti nell’esperienza stessa.
Non vi è, cosi, nessun motivò per ritenere che gli oggetti esperiti non possano essere constatabilmente autoidentici: 1) il passare del tempo misurabile con strumenti fisici non è mia variabile che agisca direttamente sugli oggetti esperiti (altrimenti, errore dello stimolo); 2) il tempo come dato psicologico può agire, ma può benissimo anche non agire su tali oggetti, e normalmente è così: non si può dire - comunque - che agisca quando tale azione non è avvertibile (altrimenti, occorre postulare le sensazioni inavvertite). Questi due argomenti, presi insieme, rendono privo di pertinenza l’assunto secondo cui un oggetto può essere considerato come continuamente non-lo-stesso attraverso lo scorrere del tempo. Dunque, abbiamo certamente esperienza di oggetti autoidentici in senso del tutto rigoroso.
Nulla ci vieta di credere, anzi, che l’idea dell’identità logica, a prima vista inapplicabile agli oggetti aventi una dimensione temporale, è nata proprio come proiezione astratta di situazioni ben concrete ed esperibili: quelle di oggetti immobili e perfettamente inalterati sotto lo sguardo prolungato di un osservatore. Scriveva Hume - e qui il suo parere è da noi completamente accettato -: «non si può ragionare bene se non si intende completamente l’idea di cui si ragiona, e non è possibile intendere perfettamente quest’idea se non se ne rintraccia l’origine e non si esamina quella prima impressione dalla quale essa nasce; l’esame dell’impressione dà chiarezza all’idea, e l’esame dell’idea dà uguale chiarezza all’insieme dei nostri ragionamenti».
7. Identità e identicità.
Nelle osservazioni svolte fin qui, l’identità dell’oggetto era implicita nella sua autoindenticità, nell’essere, cioè, quell’oggetto privo di mutamenti apprezzabili attraverso il tempo. Il tempo passa, e nell’oggetto non appaiono mutamenti: se non vi si scorgono mutamenti, men che meno sarà avvenuto quel cambiamento così radicale che ci permette di dire «non è più lo stesso».
Ma non dobbiamo perdere di vista il fatto che, in realtà, i problemi sono due: l’identicità dell’oggetto (che può essere con se stesso, o con altri - come vedremo più avanti) e la sua identità; infatti, l’esperienza ci presenta situazioni in cui un oggetto può - in modo continuo o no - perdere l’identicità con se stesso senza perdere affatto la propria identità.
Gli eventi in cui interviene all’improvviso un brusco cambiamento qualitativo sono piuttosto rari; essi, però, sono quelli che meglio permettono di studiare - mediante l’introduzione di una particolare tecnica - il problema della perdita dell’identità.
Sono situazioni molto comuni, invece, quelle in cui la trasformazione qualitativa interviene progressivamente: una luce che gradatamente si spegne, un suono che si affievolisce o un suono che in modo continuo si alza di tono (come la sirena, o il glissando degli strumenti ad arco), o un’ameba vista al microscopio, con quei suoi movimenti che la mutano di forma a ogni attimo che passa, ecc. Momento per momento la cosa osservata è diversa da com’era poco prima; ma non per questo possiamo dire che «non è più la stessa».
Vediamo come può essere effettuato lo studio dell’identità attraverso i mutamenti qualitativi istantanei.
Michotte [22] riferisce alcuni esperimenti condotti nel suo istituto a Lovanio. «Si proietta su uno schermo una superficie colorata qualunque, un cerchio blu, per esempio; di esso, viene cambiata bruscamente la forma, il colore o la grandezza. In queste condizioni, si ha l’impressione che l’oggetto ha subito un cambiamento, pure restando quello stesso ; è lo stesso cerchio luminoso che è diventato verdastro, per esempio, o che si è dilatato, o che è diventato ovale «.
Il fatto di avvertire un cambiamento qualitativo che non intacca l’identità dell’oggetto, però, accade solo se sono rispettati alcuni limiti. Cambiando oltre un certo limite, per esempio, la grandezza, o - ancora meglio - cambiando subitaneamente più proprietà dell’oggetto, si produce un’impressione nettamente diversa: «si vede apparire un oggetto nuovo, nel posto dove era collocato il precedente».
Ciò che si vede, dunque, non è più un cambiamento, ma una sostituzione; una cosa che è lì, viene all’istante «rimpiazzata» da un’altra. Questo, anche quando parecchi aspetti della cosa precedente siano comuni alla cosa che appare dopo. Anche due sole qualità trasformate possono bastare a produrre la sostituzione: per esempio, basta una alterazione combinata di brillantezza e grandezza restando invariate, nell’oggetto, proprietà come la forma, la microstruttura della superficie, il fatto di essere oggetto piano, ecc.
Non c’è alcuna possibilità di stabilire a priori quale particolare combinazione di qualità progressivamente alterate a preferenza di altre abbia infine il potere di interrompere l’identità dell’oggetto. Qui non è questione di logica: la soluzione di Quine dipende dal fatto che il Caystro non si trasforma abbastanza da apparire a un certo momento «una altra» cosa.
Probabilmente esiste una legge definita (di cui le varie leggi che verremo in seguito esponendo sono solo approssimazioni, o aspetti parziali) grazie alla quale sul piano fenomenico la particolare proprietà qualitativa detta «identità» è legata a sistemi di altre proprietà visibili negli oggetti, e dipende direttamente da esse.
Questo è un aspetto del problema posto da Cartesio coll’esempio della cera portata accanto al fuoco: come e quanto dovrebbero cambiare le qualità sensibili di un oggetto affinché la sua identità risulti interrotta? Negli esperimenti descritti poco fa vi è un elemento molto importante che li differenzia rispetto al problema proposto da Cartezio, e sta nel fatto che in essi i cambiamenti si producono bruscamente.
Per avvicinarci di più all’esempio del filosofo, il procedimento sperimentale deve essere modificato: occorre che nelle situazioni assunte a oggetto di ricerca sia presente la continuità delle trasformazioni.
Supponiamo che uno sperimentatore stia variando in modo continuo l’intensità di uno stimolo (l’intensità di una sorgente sonora, o di una sorgente di luce), avendo dato come consegna ad un soggetto di segnalare le eventuali modificazioni avvertite nel corrispondente oggetto osservato.
Ciò che l’osservatore sente o vede durante un primo periodo di ispezione, è proprio l’identità dell’oggetto che è stato invitato ad osservare; solo da un certo momento in avanti gli sembrerà di notare dapprima un lieve cambiamento, e poi - eventualmente - un cambiamento più decisivo e netto.
Nel corso dell’intera osservazione, non è l’identità dell’oggetto che va perduta: l’oggetto è sempre quello. Solo che vi sono distinguibili due fasi: quella in cui l’oggetto resta immutato, non interessato da visibili trasformazioni, e quella in cui, pure non perdendo la propria identità, l’oggetto è visibilmente interessato da una trasformazione.
Tra queste due fasi, c’è da sottolineare l’esistenza di un momento particolarmente interessante. Il momento in cui «sembra» che l’oggetto stia mutando, benché non lo si possa dire con sicurezza.
A questo proposito, ci sia concessa una breve parentesi.
Alla fine del primo capitolo abbiamo detto che il criterio migliore da assumere come guida nello studio delle percezioni (se vogliamo lavorare nel senso indicato dai gestaltisti) sta nell’adozione, in senso assai stretto, di un principio : l’«esse est percipi» metodologico: in materia di percezioni la realtà su cui si lavora è proprio l’oggetto per quello che appare in un momento dato, e a certe condizioni.
Si potrebbe dunque, a questo punto, sollevare la seguente obbiezione: se all’osservatore sembra di notare un cambiamento (benché non sia in grado di dirlo con sicurezza) vuol dire che tale cambiamento percettivamente c’è, e la soglia è oltrepassata. Un evento percettivo non può mai «sembrare», perché è quello che è.
L’elementarità del criterio metodologico indicato dall’«esse est percipi», però, non deve far sottovalutare la complessità delle sue possibili applicazioni. Nel caso ora in discussione, succede che un evento (una trasformazione) appare come apparente, come dubbia. L’apparire in questo caso vuol dire «è forse così». Il minimo cambiamento intervenuto nell’oggetto percepito «sembra» non nel senso che appare, ma nel senso che appare dubbio: abbiamo l’impressione di averlo avvertito, mentre non siamo affatto sicuri che sia proprio così.
Queste sono le situazioni chiamate da B. Russell «pale perceptions»[23]; ad es.: «sentite un aereoplano che se ne va; da principio siete sicuri di udirlo, e alla fine siete sicuri di non udirlo pifù. Ma, nell’intervallo, c’è un periodo durante il quale non siete sicuri se ancora lo udite oppure no «. In questo senso, a proposito di alcune varietà di esperienze, si può mettere in evidenza un ambito entro il quale un mutamento qualitativo non appare ancora come decisamente esplicito, ma come un evento che potrebbe essere anche illusorio; si possono trovare esempi di questo tipo specialmente in campo acustico, e soprattutto in prossimità delle soglie assolute. (Nella vita quotidiana, in casi come questi, chiediamo spontaneamente a chi si trova vicino a noi: «hai sentito anche tu un rumore così e così?»).
Prima che questo particolare stato di dubbio abbia luogo, ad ogni modo, vi è la percezione dell’identicità. Se si tratta di un suono, il suono continua ad apparire eguale durante un certo tempo, e così una sorgente luminosa resta per un po’ egualmente intensa. Dopo il momento di dubbio si avverte realmente che il suono cresce d’intensità, o cambia di frequenza, o modifica il timbro; o che la sorgente luminosa varia di intensità, o muta di colore, ecc.
Ciò che l’osservatore avverte, dunque, è l’assenza di modificazioni interessanti l’evento osservato, cioè la sua autoidenticità intesa come carattere qualitativo, l’assenza del quale potrebbe subito essere notata. Autoidenticità che possiede gli stessi modi di apparenza per qualsiasi osservatore e per qualsiasi oggetto osservato, dato che consiste nell’assenza di modificazioni avvertibili, e dato che qualsiasi mutamento rilevato basterebbe a intaccarla.
Da questo punto di vista, il fatto che esistono le soglie acquista un significato veramente non trascurabile. Esso non si risolve nella constatazione dell’esistenza di gente che discrimina meglio o che discrimina peggio; né nel fatto che - con lo stesso soggetto - l’attenzione, l’impostazione soggettiva, le istruzioni, l’affaticamento ecc. possono portare alla misurazione di valori diversi. Ma per la seguente considerazione: l’identità intesa in senso strettissimo, come l’assoluta assenza di modificazioni, può essere un dato dell’esperienza immediata, e a certe condizioni lo è; chi dicesse, contro questa tesi, che in realtà l’oggetto della nostra esperienza - mentre lo osserviamo - sta mutando incessantemente, cadrebbe in errore: l’oggetto veramente visto durante l’osservazione non risente minimamente anche di abbastanza larghi mutamenti nelle condizioni di stimolazione, tali da poter essere agevolmente misurati sul piano fisico. L’oggetto della fisica, fuori dalle coordinate spazio-temporali dell’esperienza, potrà anche essere in mutamento incessante, e, anzi, ci sono molte ragioni per credere proprio questo; ma l’oggetto realmente percepito con cui abbiamo direttamente a che fare è largamente indipendente da quel mutamento che i fisici descrivono, e, anzi, da assai più notevoli modificazioni che noi possiamo introdurre, tenendole sotto controllo.
Questa circostanza aggiunge ancora forza all’idea che prima abbiamo prospettato: che l’identità come dato dell’esperienza può benissimo essere assunta come il paradigma empirico dell’identità in senso logicamente stretto.
Questo, per quanto riguarda la percezione delle trasformazioni interne di un oggetto.
Altro è il problema dell’identicità intesa come rapporto che intercorre reciprocamente tra due oggetti.
Un oggetto può apparire identico a un altro; cioè, essere tale che, per quanto attentamente cerchiamo di osservarlo, non troviamo in esso alcun particolare che lo renda differente da un altro oggetto posto accanto ad esso. Se questo accade, deve accadere anche il contrario; l’altro oggetto, quello che fa da termine di paragone, non potrà risultare differente in alcun particolare dal primo.
Confrontando tra loro due oggetti perfettamente simili (ad esempio, due quadrati esattamente della stessa misura, ritagliati da un foglio di carta cromaticamente omogenea) li vedremo certamente, a momenti, del tutto uguali; siamo certi che chiunque li giudicherebbe così; ma, attimo per attimo, abbiamo l’impressione di qualche differenza, spesso difficilmente descrivibile, qualcosa nel loro aspetto che li rende non identici; a volte un riflesso di luce, a volte la distribuzione della microstruttura del colore, cioè della grana che effettivamente non può presentarsi disseminata nella stessa maniera in due diverse zone. In questo senso, nessun osservatore accurato potrebbe dire che due oggetti visti contemporaneamente sono perfettamente identici.
Due oggetti, cioè, non possono apparire identici l’uno all’altro nello stesso senso rigoroso in cui un oggetto appare identico a se stesso quando, sotto l’osservazione di qualcuno, tutti i mutamenti interessanti le sue condizioni di stimolazione cadono largamente al di sotto della soglia differenziale.
In ogni caso le differenze riscontrabili nel corso di un confronto sono, al solito, puramente negative. Chi guarda, cioè, può dire che i due oggetti non gli sembrano assolutamente identici, benché gli sia impossibile dire: questo è più chiaro, questo è più piccolo, questo ha una sfumatura di colore che l’altro non ha, ecc.
Inoltre, le appena apprezzabili differenze che sembra di scorgere tra i due oggetti confrontati, spesso hanno il carattere della «soggettività»; vale a dire, si ha l’impressione che di-pendano dal nostro modo di guardare i due oggetti, o dal nostro modo di impostarci nei loro confronti. Ce ne rendiamo perfettamente conto quando siamo noi a fare il confronto; ma lo si vede altrettanto bene quando è un altro a farlo. La persona che confronta due oggetti molto simili tra loro li cambia leggermente di posizione, socchiude gli occhi, muta la posizione del capo, inclinandolo, e cerca - in definitiva - di variare le condizioni di osservazione momento per momento in maniera da separare le impressioni di differenza dovute a diversità interne agli oggetti confrontati, dalle impressioni di differenza dovute al modo di osservare, alla luce dell’ambiente, a fattori, quindi, non legati intrinsecamente all’oggetto.
Da un punto di vista puramente teorico, si dovrebbe poter dare il caso di più oggetti identici: sarebbe il caso in cui le differenze fisiche tra la distribuzione e l’intensità degli stimoli corrispondenti a ciascuno di essi stanno tutte largamente sotto la soglia differenziale. Di fatto, eseguire un confronto tra due oggetti con l’intenzione di stabilire se sono identici o no è un’impresa sempre difficile; la circostanza ora descritta, in cui l’osservatore dubita spesso delle differenze intravviste fra i due oggetti, imputandole spontaneamente al proprio modo di guardare, o a condizioni che comunque sono esterne agli oggetti messi in rapporto, sembra giustificare un punto di vista che ha goduto di grande credito agli inizi della psicologia scientifica, e le cui origini teoriche risalgono senza dubbio all’empirismo sensistico classico.
Secondo questo punto di vista l’identicità di due oggetti non è una relazione che insiste sul piano dell’esperienza diretta, ma il frutto di qualche mediazione che ha luogo nell’atto di osservare.
L’argomento è stato prospettato da Stumpf [24] in modo assai elegante: stimoli diversi provocano sempre sensazioni diverse, solo a volte assai simili e confondibili: cioè falsate da un affrettato giudizio di identità che pronunciamo nei loro confronti. Infatti; scegliamo tre impressioni cromatiche molto prossime A, B, e C corrispondenti a tre stimolazioni leggermente diverse a, b e c, in modo che a>b>c (dove il segno > indica qualunque rapporto che possa intercorrere tra colori, o il suo inverso: ad es.: «più chiaro di» o «più scuro di», oppure «più saturo di» o «meno saturo di», ecc.) ma in modo che si abbia l’impressione che A = B e B=C, mentre A ¹ C. Stumpf, sostiene, semplicemente, che dicendo A = B o B =C, noi ci inganniamo, perché la proprietà transitiva, che la relazione di eguaglianza deve possedere, non può essere contraddetta; dunque, in realtà A ¹ B e B ¹ C.
Questa tesi ha dato luogo a parecchie discussioni, ed ha provocato la formulazione di alcune ipotesi fisiologiche e psicologiche molto interessanti. Sono intervenuti, sull’argomento Ebbinghaus, Titchener, G. E. Müller e Cornelius (Koffka, sostenitore lui stesso di una interpretazione che riferiremo tra poco, racconta con ricchezza di citazioni e di dettagli la storia di queste controversie in un saggio del 1917)[25]. Prima di riferire il punto di vista di Koffka, riassumeremo in breve quello di Cornelius, che costituiscse un notevole passo avanti rispetto all’impostazione elementaristica delle tesi precedentemente proposte.
Secondo Cornelius[26], Stumpf incorre in un errore che discende direttamente dall’assunzione troppo rigida dell’ipotesi della costanza; Stumpf pensa che il confronto intercorra tra le sensazioni A, B, e C rigidamente legate ai rispettivi stimoli a, b, e c. Il confronto, invece, intercorre fra tre esperimenti:
1) A confrontato con B; 2) B confrontato con C; 3) A confrontato con C. La sensazione deve essere considerata come funzione della configurazione dell’intiera situazione sperimentale. Aggiungiamo alle lettere che indicano le sensazioni messe in confronto un indice che rappresenti l’esperimento in cui sono presentate; avremo, nel primo esperimento, A1= Bl; nel secondo esperimento B2= C2; nel terzo A3 ¹ C3. Non sorge alcuna contraddizione, perché Al non è A3, e C2 non è C3.
In altre parole: può essere benissimo che l’oggetto (A con B) sia uguale all’oggetto (B con A), l’oggetto (B con C) uguale all’oggetto (C con B) e infine l’oggetto (A con C) diverso dall’oggetto (C con A) ; non ne deriva alcuna contraddizione; infatti l’oggetto (A con B) non è l’oggetto (A con C), e l’oggetto (C con B) non è l’oggetto (C con A).
L’argomento di Cornelius, come ben si vede, è molto vicino allo spirito della gestalt. Ma la posizione gestaltistica -appunto, quella rappresentata nel nostro caso da Koffka - è ancora più radicale. Il confronto non è un’operazione compiuta dal soggetto su due o più esperienze, ma è un termine che designa semplicemente una caratteristica che in certe situazioni è già data, come sono dati i suoi termini («Comparison is no longer a new act supervening upon the given sensation»)[27]. La situazione di confronto simultaneo discussa da Koffka si presenta così: gli oggetti da confrontare sono due superfici grigie di forma quadrata, poste una accanto all’altra in modo da formare un rettangolo con il lato maggiore disposto orizzontalmente. Quando i due grigi sono esattamente gli stessi ciò che l’osservatore vede è semplicemente un rettangolo grigio, con una sottile linea in mezzo che lo divide in due quadrati.
Questo è l’oggetto descritto quando pronunciamo il giudizio di eguaglianza. Il nostro compito era quello di dare un giudizio su due grigi, e per questo diciamo «vedo due quadrati dello stesso grigio» - una descrizione fenomenologicamente corretta sarebbe «rettangolo grigio, diviso in due da una sottile linea». Quando la differenza fra i due grigi esiste, essa non emerge da una operazione di confronto tra una sensazione e un’altra, ma è una proprietà di questo rettangolo: la chiarezza del grigio di questo rettangolo presenta uno «scalino». Koffka sottolinea il fatto che non si tratta di uno scalino metaforico, ma di uno scalino in senso stretto, ascendente - p. es. - da sinistra a destra. Non quindi due livelli di grigio, ma una direzione.
Questa caratteristica della direzionalità
(più scuro ® meno
sinistra ® destra)
non è un’impressione fluttuante, una sensazione transitoria che accompagna l’atto del confronto, ma una proprietà intrinseca dell’esperienza visiva attuale («a central property of this whole undivided experience»).
Questa struttura caratterizza le situazioni di confronto il cui esito è un giudizio di diversità.
Dunque, non solo - come diceva Cornelius - abbiamo a che fare con relazioni tra esperienze e non con sensazioni separate, ma abbiamo a che fare con esperienze diversamente organizzate, con oggetti diversi. Nel caso di Cornelius la base del confronto è costituita da due fatti, nel caso di Koffka la base è costituita da un fatto solo, scindibile in due momenti, nel caso che vi sia diversità. Il grigio più chiaro è tale in relazione all’altro che gli è accanto, e viceversa. Non esiste un grigio di una data chiarezza, e un grigio di una data altra chiarezza, in assoluto. L’espressione «in relazione all’altro» rappresenta, sul piano linguistico, il fatto della direzionalità chiaro-scuro.
§8. Identità e movimento.
Tirando ora in breve le somme, tanto l’identicità di un oggetto con se stesso, quanto l’identicità intesa come relazione reciproca tra oggetti, dal punto di vista dell’esperienza concreta dell’uomo, possiedono proprietà direttamente constabili ben definite, corrispondenti a particolari strutture.
Gli oggetti possono essere identici con se stessi attraverso il tempo, perché - a date condizioni - le modificazioni dei relativi stimoli possono essere tenute agevolmente sotto le soglie differenziali di trasformazione, e perché le modificazioni soggettive che accompagnano il trascorrere del tempo psicologico possono benissimo n o n influenzare la struttura dell’oggetto: l’oggetto in cui non sono avvertibili modificazioni è autoidentico; il fatto di poterlo pensare come trasformato o come collocato in altri momenti del tempo fisico esula dal problema reale della sua identità, che è largamente indipendente da tali ordini di fatti.
Non si può dire altrettanto dell’identicità come relazione tra più oggetti. Indubbiamente si può parlare di identicità anche in questi casi, in quanto non è confondibile con la relazione di somiglianza, anche fortissima. (In questa relazione c’è, normalmente, qualcosa di sensibilmente diverso, che però appare trascurabile). Ma tale identicità non va intesa come una proprietà di ciascuna delle cose messe a confronto, bensi come proprietà della situazione totale costituita dalla compresenza delle due cose nel campo attuale dell’esperienza diretta. Come l’autoidenticità è assenza di modificazioni apprezzabili, così l’identicità reciproca può essere definita come assenza di direzionalità apprezzabile, nel senso di Koffka.
A questo punto occorrerebbe parlare anche dell’identità in situazioni di confronto successivo e dei problemi che ne derivano, assai più grossi e meno risolti di quelli riferiti finora. Ma la trattazione di questo tema andrebbe al di là del confine che ci siamo proposti di non oltrepassare: nostro compito è - in questo libro - di riferire esperienze che non comportino l’adozione di una teoria della memoria; che siano, cioè, esperienze dirette, nel senso di essere realizzabili in qualsiasi momento come constatazioni attuali. Nel confronto successivo, anche effettuato entro tempi molto brevi, è invece implicito il riferimento a un costrutto puramente logico, quello di traccia mnestica, il cui impiego rende le cose spesso più complicate e a volte meno convincenti.
Certo, dal punto di vista della formulazione dei giudizi di identità, vi è qualcosa di straordinario nelle situazioni di confronto successivo: ed è il fatto che si possano giudicare, anzi, prima di giudicare avvertire con sicurezza due eventi come identici o no, uno dei quali è ora presente mentre l’altro è già trascorso. La cosa è tanto familiare da non destare sorpresa, forse. Ma sta di fatto che in circostanze simili siamo in grado di vivere immediatamente l’identità di due esperienze profondamente differenti: un fatto direttamente osservato e una traccia [28]. Il primo è presente nello spazio ostensibile, il secondo no; il primo sta in un momento ben definito del tempo vissuto, «ora», e il secondo, pure esistendo in un certo modo «adesso», si presenta come appartenente a un altro momento, di solito scarsamente precisato; il primo ha tutti i suoi particolari bene articolati e distribuiti secondo relazioni definite, il secondo a malapena ne possiede qualcuno e quasi sempre non stabilmente; il primo ha colori (anzi, può essere una data gradazione di colore), il secondo no - tranne nei casi di eidetismo per i quali, del resto, il problema si pone fin dall’inizio in modo diverso. Tuttavia non solo possiamo affermare l’identità di una cosa in situazioni come queste, ma controllarne perfino la identicità, notando se è cambiata e in che senso è cambiata. Qui sta il paradosso: nel confronto fra due cose costituite in maniera totalmente diversa, e vissute come talmente identiche, che il fatto di rintracciare un’eventuale differenza tra esse diventa un compito a volte non facile.
Anche qui va notato - come in tutti gli altri casi che ci interessano come studiosi delle organizzazioni percettive - che l’esattezza del nostro giudizio non ha alcuna importanza (cioè l’esattezza dal punto di vista di eventuali controlli operativi che siamo in grado di eseguire, o comunque dipendente da assunzioni estranee alla configurazione dal dato immediato). La cosa importante è che confrontando un evento presente con uno che sappiamo o avvertiamo trascorso, oltre a poter dire «sono incerto» o «mi sembra» che sia la stessa cosa, o che siano due cose identiche, possiamo anche dire «è lo stesso» o «sono identici», con estrema sicurezza. Si potrebbe obbiettare che, in realtà, ben poche volte ci troviamo nella situazione di dirlo con estrema sicurezza; ma questo accade perché quando siamo indotti a pronunciarci intorno all’identità di qualcosa normalmente ci troviamo in una situazione di dubbio. In effetti, l’evidenza fenomenologica dell’identità intesa in questo senso è confermata dal fatto che quasi sempre n o n abbiamo dubbi né diciamo nulla [29], e ci appare come assolutamente normale il fatto di ritrovare, ad es., rientrando nella nostra stanza, dopo un po’ che ne eravamo usciti, tutte le solite cose.
Gli oggetti che abbiamo utilizzati finora nelle operazioni di confronto simultaneo, erano oggetti per quanto è possibile semplici e privi di articolazioni interne : due quadrati di plastica o di cartone grigio. Questi oggetti omogenei all’interno dei propri confini, benché a rigore non si possa dire che non hanno parti (infatti ci intendiamo benissimo quando, di fronte a un quadrato perfettamente omogeneo, diciamo «la parte superiore destra» o «la parte centrale» o «la zona lungo il lato di base» (cfr. il capitolo precedente) tuttavia non hanno parti separate tra loro da un confine definito, cioè non hanno parti discernibili.
Da questo momento in avanti, però, dovremo considerare anche casi più complessi. L’identità di un oggetto con se stesso che è implicita nell’autoidenticità, normalmente non va perduta nel momento in cui cessa quest’ultima. L’esempio di Cartesio alle prese col pezzo di cera vicino al fuoco è paradigmatico, in questo senso: tutte le proprietà possono trasformarsi, e tuttavia l’oggetto restare quello.
Gli oggetti che prenderemo in considerazione nelle prossime pagine saranno protagonisti sia di spostamenti nello spazio che di trasformazioni interne, due classi di accadimenti che molto correttamente (da questo punto di vista) Aristotile accomunava nell’unico concetto di «moto». Tanto nel primo caso che nel secondo si pongono alcuni specifici problemi riguardanti il rapporto tra il tutto e le parti.
Lo spostamento nello spazio non solo è compatibile col mantenimento dell’identità dell’oggetto, ma anche con quello della sua autoidenticità: si può benissimo vedere che una data cosa si sposta continuamente, andando da un posto all’altro, senza che nel frattempo sia interessata da trasformazioni interne. È un po’sofistico tentar di sostenere che il fatto stesso di occupare un posto diverso nei diversi luoghi del suo percorso la renda diversa: non è detto che i mutamenti che interessano le relazioni tra la cosa e l’ambiente esterno debbano di necessità ripercuotersi al suo interno. Può accadere, d’accordo: un quadrato grigio che si muova contro uno sfondo diviso in zone bianche e nere può esser visto diventare più scuro quando passa per una zona bianca e più chiaro quando arriva in una zona nera. Ma questa è una relazione che intercorre tra il colore dell’oggetto e un certo tipo di sfondo sul quale in un dato momento egli viene a trovarsi, e non una relazione che lega quel colore al fatto di essere in moto. Si può dire che la velocità può determinare alcune alterazioni nella forma dell’oggetto, per certi valori che assuma: ma anche qui occorre andare cauti. Infatti, quando a una certa velocità nell’oggetto osservato si cominciano a notare deformazioni, la netta impressione dell’osservatore è che esse dipendano appunto dalla velocità, che siano apparenti e non realmente interne all’oggetto. Tale impressione non scompare mai, pure riducendosi, anche quando la velocità è alta e le deformazioni accentuate. Nel caso di movimenti sufficientemente lenti è possibile constatare che, durante tutto il tragitto, nulla accade all’oggetto in moto. Resta identico, e resta - a fortiori - lo stesso.
Naturalmente, per il problema che stiamo trattando (e per l’impostazione generale che stiamo seguendo[30]), non fa differenza alcuna se il movimento assunto come oggetto d’osservazione è un movimento «reale» oppure un movimento ottenuto per mezzo di stimolazioni statiche, come avviene nel caso delle traslazioni stroboscopiche.
Il movimento stroboscopico può essere realizzato agevolmente nelle seguenti condizioni: due sorgenti luminose di una data intensità sono collocate, una accanto all’altra ad una distanza sufficientemente piccola, di fronte ad un osservatore, in un ambiente buio o quasi buio; due interruttori permettono di comandare l’accensione e lo spegnimento di ciascuna di esse. Ora, accendiamone una; dopo una breve esposizione, la spegnamo. Segue una pausa di buio, che indicheremo con p. La fine di tale pausa è segnata dall’accensione dell’altra sorgente.
Se la pausa p è abbastanza grande (non possiamo dare misure precise, qui, per ragioni che esporremo subito) ciò che l’osservatore descriverà può essere riassunto così: una luce in una certa posizione, buio, un’altra luce in un altra posizione, a breve distanza dalla prima.
Se riduciamo progressivamente la pausa p, avvicinando nel tempo lo spegnimento della prima sorgente all’ accensione della seconda, dopo una particolare fase di transizione[31], la situazione si trasforma radicalmente: l’osservatore ha ora davanti a sé un oggetto luminoso che entra a un tratto in movimento e - percorsa una traiettoria ben visibile - va a fermarsi quasi nel luogo dove prima si accendeva l’altra luce; il quasi significa qui un po’ prima: infatti, quando il movimento stroboscopico è ottimale, i punti di partenza e di arrivo tendono sensibilmente ad avvicinarsi[32].
Il valore esatto di p, necessario alla realizzazione del fenomeno, può essere stabilito solo conoscendo anche l’intensità luminosa delle sorgenti e la distanza intercorrente tra esse; come ha stabilito A. Korte: se l’intensità delle sorgenti aumenta, affinché il fenomeno si realizzi ottimalmente, occorre che sia aumentata la distanza tra esse, o la grandezza di p; se viene aumentata la distanza, occorre che sia aumentata l’intensità, o la grandezza di p; e così via, secondo una regola molto semplice[33].
Nel caso del movimento stroboscopico normalmente l’oggetto durante il percorso presenta caratteristiche diverse da quelle che ha nelle due posizioni di partenza e di arrivo [34] la forma è meno determinata, benché riconoscibile, vi è una tendenza all’allungamento nella direzione del movimento, e la luminosità è apprezzabilmente meno intensa; l’autoidenticità va dunque perduta, mentre l’identità no. Quando i due stimoli vengono accesi alternativamente con una pausa abbastanza lunga nel mezzo, in modo da essere ben lontani dalla situazione ottimale, ciò che si vede sono, alternativamente, due zone illuminate le quali, mentre sono visibili, sono immobili; ricorrendo le condizioni ottimali, l’osservatore ha a che fare con un oggetto in moto. Passando più volte, avanti e indietro, da quelle condizioni a queste si può dare la definizione ostensiva dell’identità: c’è un punto critico nettamente avvertibile, dove si vede che i due posti prima occupati alternativamente da due oggetti diversi vengono ora occupati, sempre alternativamente, da uno stesso oggetto mediante un movimento che collega un luogo coll’altro.
§ 9. Gli esperimenti di von Schiller.
Il lettore ricorderà che Hume, parlando a malincuore dell’irragionevole inclinazione che hanno episodi diversi della esperienza ad unificarsi in un’esistenza continua, osservava come i fatti che hanno «più tendenza a tali finzioni...» «sono quelli... che risultano da una successione di parti unite dal rapporto di somiglianza e di contiguità «. Avviene proprio cosi; e, se l’esperienza concreta e attuale conta qualcosa, non si tratta per nulla di una «finzione» della mente umana.
Gli esperimenti che riferirò adesso sono stati compiuti da Paul von Schiller nel 1933[35]. Sembrano proprio un ampliamento del discorso di Hume, ma svolto da una prospettiva teoretica completamente capovolta.
Il movimento stroboscopico viene utilizzato nella seguente maniera; nella prima fase della presentazione appare una figura, bene illuminata, in campo scuro, secondo le regole; nella seconda fase, subito dopo la brevissima pausa, vengono presentate due figure. Di esse, una è uguale a quella della prima fase, l’altra diversa. Per esempio:
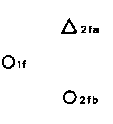
Fig. 62
In questo caso la diversità è nella forma: la figura a destra in basso è un dischetto esattamente come l’oggetto della prima fase; quella destra in alto un triangolo.
Chiunque sa prevedere quello che succederà in una alternativa stroboscopica di questo genere( e questo fatto di per se stesso è già una dimostrazione della tesi fondamentale;tutta via, non è male guardare l’esperimento); il dischetto 1f ( prima fase) si mette in moto e va a fermarsi nel luogo 2fb (seconda fase, figura uguale), mentre compare, a destra in alto, un triangolo (2fa).
Se non esistesse lo specifico fattore di unificazione «somiglianza» (seconda legge di Wertheimer, cfr. Cap. precedente) il dischetto 1f si sarebbe trovato di fronte ad una alternativa equipollente, al momento di muoversi.
Ecco la prova: sia la situazione fatta così:
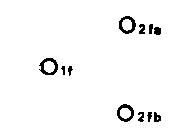
Fig.63
L’osservatore in questo caso può vedere 1f spostarsi in 2fa oppure in 2fb, come vuole, e senza difficoltà. Non c’è alcuna ragione obbiettiva (in senso stretto: appartenente all’oggetto) perché 1f vada preferibilmente sopra o sotto; quindi vi è una ragione soggettiva (anche in senso stretto: dovuta all’impostazione che l’osservatore prende), dato che in uno dei due posti 1f deve pur andare.
Supponiamo che 1f sia un dischetto rosso, 2fa a un dischetto rosso e 2fb un dischetto verde. Di nuovo la situazione si regola da sola: 1f va in 2fa. Questa volta è la somiglianza rispetto al colore che agisce, come prima agiva la somiglianza rispetto alla forma.
Disponendo di due tipi di somiglianza, ora possiamo costruire una situazione ambigua, dove di nuovo decide l’impostazione soggettiva. Eccola:
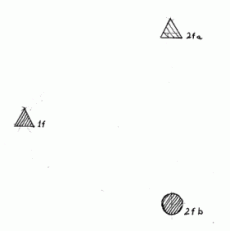
Fig. 64
In questo caso, 1f può conservare l’identità di forma se va in 2fa a e l’identità di colore se va in 2fb. Non può conservare le due cose insieme. Dato che possiamo con più o meno eguale facilità vedere una soluzione o l’altra, potremo concludere che - in questo caso - il fattore forma e il fattore colore hanno più o meno lo stesso peso, la stessa forza.
Tale conclusione, però, non è molto importante in sé.
È importante invece notare un’altra cosa: un oggetto può perdere totalmente una sua qualità, restando lo stesso. Ne può perdere anche più d’una contemporaneamente, o tutte, ad es., in una situazione stroboscopica semplice, fatta cosi:
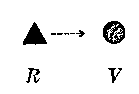
Fig. 65
In questo caso un triangolo rosso diventa un cerchio verde, eppure resta lo stesso; cioè resta lo stesso mutando tutte le sue caratteristiche, che sono queste due soltanto. É la situazione che riferisce Cartesio a proposito della cera; solo che in questo caso non ci è possibile pensare che l’identità è garantita da qualcosa che sta oltre il dato fenomenico, e di cui esso è un «vestito». Infatti, oltre il dato fenomenico qui non c’è nulla, perché il movimento stroboscopico con tutte le sue proprietà è puramente fenomenico. Dunque, l’identità attraverso il mutamento di tutte le caratteristiche, è un dato fenomenico a sua volta, e su questo piano va affrontato il problema.
Infatti, procedendo nel modo descritto poco sopra, e cioè iniziando la presentazione con tempi non ottimali per l’intervallo compreso tra la prima e la seconda fase, in modo che l’osservatore possa vedere singolarmente 1f e poi 2fa e 2fb come oggetti distinti, e successivamente stringendo l’intervallo fino a renderlo ottimale, è possibile assistere all’instaurarsi del legame d’identità, per cui 1f e, ad es., 2fb - nella prima situazione riferita - cessano a un tratto di essere due dischetti statici e diventano un dischetto in movimento, mentre il triangolo appare e scompare per conto suo. In questo senso, una affermazione come «la somiglianza di forma determina l’autoidentità dell’oggetto» trova intieramente il suo senso nei particolari della situazione osservata: è una descrizione puramente fenomenologica e nello stesso tempo un segmento di teoria. Come teoria enuncia l’esistenza di una connessione funzionale, nella forma più generale e semplice (x=f(y)), tra due ordini di dati; come descrizione, ogni parola in essa contenuta può essere tradotta in una definizione ostensiva. Questo è veramente il meglio che, per mezzo di un’analisi fenomenologica, si possa desiderare di ottenere.
Hume, poi, menziona anche la contiguità. La contiguità èquel fattore di unificazione di cui, in campo statico, parla la prima legge di Wertheimer. Essa funziona, in situazioni di alternativa stroboscopica, come la somiglianza. Gli esempi sono sempre di von Schiller.
Si abbia la seguente distribuzione degli stimoli:
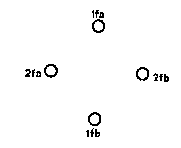
Fig.66.
Qui, 1fa, 2fb, 1fb e 2fa sono disposti come i vertici di un quadrato, ruotato di 45° rispetto alla posizione che avrebbe se un suo lato fosse disposto orizzontalmente. 1fa dista dalla posizione di 2fa e 2fb in egual misura; e così 1fb.
Ripetendo le presentazioni stroboscopiche, si vede che i due punti della prima presentazione vanno a collocarsi nei luoghi che occupano nella seconda, sia muovendosi in senso orario, sia in senso antiorario. La strada che devono percorrere nei due casi è eguale: la soluzione percettiva dunque avviene a volontà.
Che la vicinanza possa agire come fattore determinante, lo si prova mutando le relazioni spaziali tra i luoghi dei punti nella prima fase e i luoghi dei punti nella seconda; lasciando inalterate le altre proprietà visibili della situazione.
Disponiamo, ad esempio, i luoghi di partenza e di arrivo in questo modo:
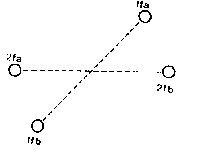
Fig.67
adesso 1fa va in 2fb, e 1fb in 2fa, seguendo il minore percorso. Questa situazione si presta come punto di partenza per una breve digressione. In essa sta la spiegazione di un curioso effetto che, credo, tutti avranno notato una volta o l’altra andando al cinematografo.
Quando durante la proiezione del film compare sullo schermo una di quelle scene in cui la diligenza, inseguita da qualche pericoloso personaggio a cavallo, o per altri motivi ugualmente pressanti, corre sempre più velocemente lungo la sua strada, lo spettatore che osservi le grandi ruote a raggi le vede a tratti ruotare per il verso giusto e poi, quasi improvvisamente, invertire il verso della rotazione; da questo momento in avanti l’impressione è paradossale: la diligenza avanza in senso contrario a quello che si dovrebbe ricavare guardando il movimento delle ruote; poi di nuovo, a un tratto, le ruote ripren dono a girare per il verso giusto, e così via.
Per capire questo fatto, basta tener presente l’esperimento ora citato di von Schiller, e la posizione che hanno i raggi delle ruote della diligenza, successivamente nei vari foto-grammi.
Partiamo da una situazione che ha luogo assai difficilmente, quando effettuiamo una ripresa cinematografica. Supponiamo che l’intervallo di tempo intercorrente tra lo scattare di ogni fotogramma ed il suo successivo sia uguale, o un multiplo, dell’intervallo di tempo impiegato da un raggio qualunque della ruota per percorrere uno spazio angolare pari a quello compreso tra due raggi qualunque della stessa ruota. (Si suppone che tutti i raggi siano di forma esattamente uguale, e regolarmente intervallati).
A queste condizioni, su ogni fotogramma appare la ruota sempre nella stessa posizione. Se la ruota ha quattro raggi, e nel primo fotogramma essi appaiono disposti lungo gli assi orizzontale e verticale, appariranno così in tutti gli altri fotogrammi successivi:
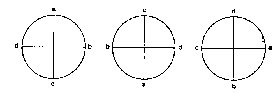
Fig. 68.
Infatti, tra un fotogramma e l’altro la ruota avrà compiuto o un quarto di giro, o mezzo giro, o tre quarti di giro e così via; e dunque nel successivo fotogramma apparirà in una posizione omologa, cioè con i raggi - non importa uno per uno quali - disposti nella stessa maniera.
Ma ora supponiamo che l’intervallo di tempo tra un fotogramma e l’altro non sia né uguale né multiplo dell’intervallo di tempo che un raggio della ruota impiega per coprire lo spazio angolare pari a quello compreso tra due raggi. Questo succede normalmente. I raggi, nei diversi fotogrammi, occuperanno posizioni sempre diverse, e non tali da potersi sovrapporre ai raggi dell’immagine precedente. Cosi:
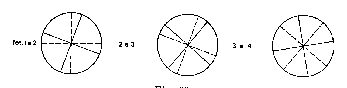
Fig. 69
Se si riflette un momento, è facile capire che una serie di posizioni come questa può essere ottenuta, con velocità di rotazione diverse, tanto fotografando a intervalli una ruota che gira in senso orario, quanto una che gira in senso antiorario: nel caso riprodotto qui subito, sia che compia un sesto di giro in senso orario tra un fotogramma e l’altro, sia che compia, nello stesso tempo, un dodicesimo di giro in senso antiorario:
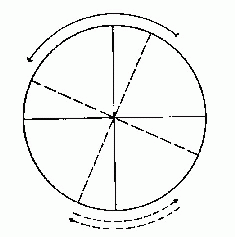
movimenti reali possibili -----
movimento veduto______
Fig. 70
ma, proiettando consecutivamente i due fotogrammi su uno schermo, le due immagini si unificheranno in una sola maniera: secondo la legge della vicinanza. La ruota sullo schermo girerà, dunque, esclusivamente in senso antiorario.
Ciò mostra, intanto, l’indipendenza del movimento percepito (grazie all’unificazione stroboscopica) dal movimento che è stato fotografato dalla macchina.
Se il moto della diligenza è uniforme, si riprodurrà, di fotogramma in fotogramma, sempre il medesimo mutamento di posizione, quindi sempre la stessa condizione di vicinanza, la stessa unificazione stroboscopica, e, infine, lo stesso verso di rotazione.
Se il moto non è uniforme (restando uniformemente distribuiti nel tempo gli scatti dell’otturatore della cinepresa) ed è, per esempio, uniformemente accelerato, sovrapponendo il primo fotogramma e il secondo, e poi il secondo al terzo, vedremo che l’angolo compreso tra i raggi nelle due posizioni viene man mano modificandosi. Ogni raggio della ruota, infatti, impiega meno tempo a raggiungere la posizione prima occupata dall’altro, di attimo in attimo. La sequenza delle sovrapposizioni appare dunque così:
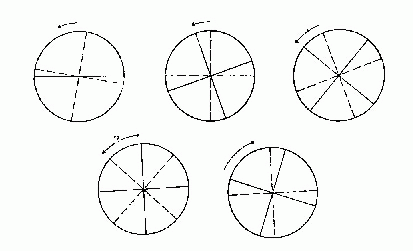
Fig. 71
Guardando la proiezione, che è fatta da una serie di salti stroboscopici tra fotogramma e fotogramma, è chiaro che dovremo percepire una inversione della rotazione, dato che a un tratto i rapporti di vicinanza, tra i raggi proiettati da un fotogramma a quelli proiettati dal fotogramma successivo, vengono ad invertirsi. Ed è facile capire, a questo punto, che proseguendo la presentazione seguendo sempre la medesima legge dopo un po’ avremo un’altra inversione, e così via, fino a che la diligenza potrà aumentare la sua velocità. Quando i cavalli avranno raggiunto il limite delle possibilità, o avremo il moto uniforme della diligenza - e quindi stasi apparente o rotazione apparente in uno stesso senso delle ruote sullo schermo; oppure la diligenza progressivamente rallenterà - e allora avremo daccapo tutte le inversioni di rotazione, e per i medesimi motivi.
Questa digressione, come è facile vedere, non aggiunge niente di nuovo. Ho notato però spesso che il riferimento ai fatti della vita di ogni giorno desta nell’ascoltatore (o nel lettore) un sentimento di assenso piuttosto vivo, quando a lui è capitato di notare, per conto suo, certi fatti che poi sente o vede riferiti da altri in un certo contesto teorico; assenso che normalmente valica i limiti del fatto constatato, per estendersi almeno in parte alla teoria in cui si inserisce. Il che è bene, ed è male. È bene perché la teoria della percezione deve essere una teoria dei fatti che quotidianamente ci circondano e accompagnano; deve essere una teoria dell’esperienza reale. È male perché nessuna citazione di fatti può sorreggere una teoria: questo è un compito che spetta solo ai ragionamenti costruiti intorno ai fatti.
Ad ogni modo: ecco un esperimento che spiega un’esperienza curiosa.
Fin qui abbiamo visto il fattore della vicinanza e quello della somiglianza (forma, colore), in gioco come variabili nell’instaurarsi di un’identità attraverso il movimento stroboscopico, uno alla volta possibile, naturalmente, metterli conflitto.
Da una situazione di conflitto si vede quanto fortemente un oggetto tenda a mantenere la propria identità attraverso i propri attributi qualitativi. L’esistenza di situazioni in cui l’oggetto trasforma tutti i suoi aspetti visibili e rimane autoidentico non esclude che ogni oggetto tenda a mantenere la propria identità quanto più è possibile in forza di tali aspetti.
Gli esperimenti di von Schiller dimostrano che le reazioni di vicinanza contano poco quando molti fattori di som glianza vengono accumulati in contrasto ad esse. Se due oggetti sono lontani, ma simili per forma, grandezza, lucentezza e colore, tenderanno - nell’alternativa stroboscopica - a realizzarsi come un unico oggetto, anche se l’altro oggetto proposto, diverso sotto quegli aspetti, è posto assai vicino a quello presentato nella prima fase. Se la ruota di cui parlavamo poco fa fosse fatta con due coppie di raggi molto diversi, disposti in modo che i raggi uguali si trovino contrapposti l’uno all’altro rispetto al mozzo, così:

Fig.72
secondo von Schiller potrebbe realizzarsi la soluzione contraria a quella derivante dalla sola vicinanza, fino a valori molto alti. La ruota potrebbe girare in senso antiorario, nel nostro esempio, anche per uno spazio angolare di 75º, in forza della somiglianza tra i raggi, contro i 15º a favore della vicinanza.
La tecnica di von Schiller permette di mettere in luce anche altri fattori di identificazione attraverso il movimento, non riconducibili direttamente alle leggi di Wertheimer.
Una situazione interessante riguarda il movimento di un oggetto nella terza dimensione. La situazione è questa:
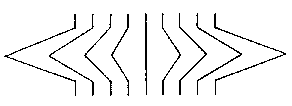
Fig. 73
le varie figure, nell’ordine, rappresentano le diverse e successive presentazioni effettuate a intervalli temporali ottimali per il collegamento stroboscopico. Guardando una alla volta tali figure, si vede bene che non sono identiche ma solo analoghe; guardandole insieme, si vede altrettanto bene che l’intera serie, compresa tra la seconda e la penultima, potrebbe essere considerata come una classe di proiezioni della prima o dell’ultima figura.
L’osservatore, di fronte a questa serie di collegamenti stroboscopici, vede la prima figura spostarsi dalla sua posizione iniziale, e, sventolando come una banderuola, passare alla posizione finale. La figura gira nella terza dimensione, e a un certo momento mostra con la sua punta la direzione in cui sta l’osservatore.
Qui, attraverso i collegamenti stroboscopici, si realizza la identità della figura, dall’inizio alla fine della presentazione. Ma le varie tappe sono configurate in modo tale che - se sì vede il movimento nella terza dimensione - viene conservata non solo l’identità, ma anche l’identicità della figura. Allora, si realizza il movimento nello spazio tridimensionale; con ciò la figura mantiene la sua identicità.
Oppure: certe figure hanno una spiccata direzionalità. Pagine fa abbiamo citato il punto di vista di Koffka intorno ai confronti simultanei; egli parlava di direzionalità a proposito di una serie di grigi disposti uno dopo l’altro in modo da rispettare l’ordine di chiarezza.
Questo modo di usare il termine «direzionalità» è certo leggermente metaforico; un significato molto più primitivo può essere trovato, credo, osservando figure come queste:
![]()
Fig. 74.
Tali figure tendono a spostarsi in una direzione piuttosto che in un’altra Sembrerebbe a tutta prima che certe sottigliezze espressive non possano entrare nel sistema concettuale di una scienza seria e dignitosa; questa «tendenza a muoversi» pare più che altro un modo di dire, prediletto dai pittori o dai loro critici, per i quali il movimento è una idea che travalica assai largamente i limiti della meccanica.
Ma non è così. Tra gli esperimenti di von Schiller ve n’e uno realizzato con la seconda delle figure ora riprodotte.
L’esperimento viene condotto in questo modo: la figura scelta è proiettata su uno schermo contemporaneamente, in quattro posizioni diverse, lungo il tracciato di un cerchio ideale. Questa è la prima fase. Poi, dopo il breve intervallo che divide le due fasi, la stessa costellazione viene ripresentata, sempre lungo il tracciato del cerchio immaginario, ma ruotata in toto di 45º Sullo schermo, così, ogni figura viene ad occupare una posizione esattamente intermedia tra i posti dove, nella prima fase, giacevano due figure uguali. Così:
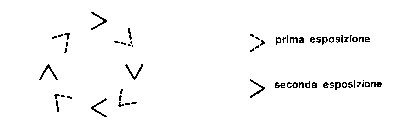
Fig. 75.
Ora, stando alle condizioni di prossimità spaziale, l’intera ghirlanda di figure potrebbe ruotare sia in senso orario che in senso antiorario, a volontà. Ma questo non succede. La ghirlanda gira in senso orario, cioè per il verso voluto dalla direzionalità delle figure che la compongono. Se orientiamo le singole figure della ghirlanda per il verso opposto, cambia anche il verso della rotazione.
Questo fatto prova che quando diciamo «la tale figura possiede del movimento» oppure «tende a slittare nella tale direzione» parlando di figure dipinte o scolpite, e quindi sotto un importante aspetto veramente statiche, usiamo espressioni assai meno metaforiche di quanto si vorrebbe credere a tutta prima. Dando alla figura l’occasione di muoversi e la possibilità di procedere in due direzioni ugualmente buone sotto gli altri punti di vista, è proprio quel suo equilibrio interno a decidere, e a determinare il processo di identificazione.
Ma parlando di questi ultimi esperimenti di von Schiller abbiamo ormai abbandonato il mondo degli oggetti elementari, in se stessi omogenei e privi di articolazioni. Gli ultimi fatti riferiti non potrebbero essere spiegati senza il ricorso al concetto di struttura.
Dalla lettura dei passi di Locke e di Hume è risultato molto bene, credo, che il problema dell’identità delle unità elementari non può essere agevolmente tradotto in quello dell’identità delle organizzazioni complesse. In larga misura ciò è vero; apparentemente si presentano, anzi, come due tipi diversi di problema. Vi è però un importante punto di incontro tra le due questioni: che ruolo svolgono le parti elementari nell’identità dell’organizzazione? cioè: quale è il destino dell’identità delle parti nelle situazioni in cui essa diventa incompatibile con la conservazione dell’identità del tutto?
![]()
Note
[1] Ci riferiamo all’edizione di R. Walzer, Firenze, 1939.
[2] Ci serviamo dell’edizione oxoniense di Burnet, 19508, vol. I. Vedi: 256 a.
[3] Anche da un punto di vista storico, credo, non è un arbitrio: infatti Aristotile ha trattato quasi sempre dell’identità rispetto al genere e alla specie insieme con l’identità rispetto alle trasformazioni, come sottolinea W. D. Ross. Nel primo libro dei Topici, in un passo che citeremo tra poco (103 a), l’identità di numero - essere Io «stesso» a dispetto del fatto di essere nominato con nomi diversi - viene esplicitamente associata all’identità generica e specifica; nella Fisica (223 b) la relazione «consecutivo a... « viene esemplificata tanto tra oggetti e tra momenti del tempo, che tra classi, o specie.
[4] Euclide, Elementa, I - ![]() - 1)
- 1)![]() (cose eguali ad una stessa cosa sono eguali tra loro). In «Greek Mathematical
Works», London, 1951, vol. I, pag. 444.
(cose eguali ad una stessa cosa sono eguali tra loro). In «Greek Mathematical
Works», London, 1951, vol. I, pag. 444.
[5] R. Descartes, Oeuvres Choisies, Paris, 1950, I, pag. 94 e segg.
[6] Cioè la possibilità che un corpo occupi parzialmente o totalmente lo spazio occupato da un altro. La traduzione è di Emilio Cecchi (Nuovi Saggi, Bari, 1929), pag. 208 e segg.
[7] Kant (Cr. d. Rag. Pura, Anal. Trasc. - Appendice) molto finemente osserva che «Leibniz prese le apparenze per cose in sé, quindi per intelligibilia, cioè oggetti dell’intelletto puro (sebbene le designasse con il nome di fenomeni...), e in tal caso il suo principio dell’indiscernibilità (principium identitatis indiscernibilium) non poteva certo venir contestato». Ma naturalmente, nell’esperienza noi abbiamo a che fare con gli oggetti della sensibiltà, e ragionandoci sopra facciamo uso dell’intelletto in senso empirico, non puro; allora «la pluralità e la diversità numerica sono già indicate dallo spazio stesso, in quanto condizione delle apparenze esterne».
L’intiero paragrafo - intitolato «Identità e diversità» - sembra suggerire l’idea che l’identità logica, interpretata nel senso di Leibniz, è assolutamente inapplicabile al mondo spaziale dell’esperienza umana. (Ci siamo serviti della traduzione di G. Colli, Torino, 1957, pag. 337).
[8] Vedi oltre cap. IV, § 3.
[9] J. M. Keynes, Treatise on Probability, XXII, §§ 7-12, London, 19576, pagg. 257 e segg.
[10] B. Russell, The Human Knowledge, trad. it. di C. Pellizzi, Milano, 19632, pag. 490.
[11] B. Russell, Op. cit., pag. 490.
[12] Cfr. Cap. II, pag. 78.
[13] W. V. O. Quine, From a Logical Point of View, Harvard. 19612. Trad. it. di E. Mistrette, 4, 1-5, pag. 61 e segg.
[14] Op. cit., pag. 61.
[15] Op. cit., pag. 62.
[16] Op. cit., pag. 64.
[17] Op. cit., pag. 65.
[18] ...come in effetti qualunque punto del Caystro mostrato in qualunque attimo può appartenere alla classe delle masse d’acqua, o alla classe degli oggetti che si trovano entro quel metro cubo, o alla classe che ha per membri tutti gli oggetti a 13 Km. dalla foce di un fiume, o a qualunque altra comunque definita. Se ogni ostensione indica un oggetto che può appartenere a qualunque classe pensabile, comunque sia grande il numero delle ostensioni, il Caystro non sarà mai univocamente definito.
[19] Una osservazione identica fatta da Köhler a proposito dello spazio. Cfr. Gestalt Psychology, N. Y.-London, 1947; pag. 213. « Se qualcuno si aspetta di esperire le cose come localizzate nel proprio cervello, non si rende conto che la prima metà del suo problema riguarda il campo visivo inteso come esperienza, mentre la seconda metà (in cui compare l’espressione «il cervello») è riferita ad un oggetto fisico che è nello spazio fisico. E ciò significa che egli si aspetta di veder localizzate parti dello spazio visivo in rapporto a posti dello spazio fisico: nozione che è del tutto impossibile».
[20] H.Bergson, L’Évolution créatrice, in Oeuvres, Paris, 1959, pagg. 495-96.
[21] Ibid., pag. 496.
[22] A.Michotte, A propos de la permanence phénoménale. Faits et théories, « Acta Psychologica «, 1950 (7), pagg. 298 e segg.
[23] B. Russell, Human Knowledge: its Scope and Limits, N. Y., 1948. Trad. it. di C. Pellizzi, Milano, l9632 pag. 397.
[24] K. Koffka, Perception: an Instroduction to the Gestalt Theory, «Psych. Bull.», 1922, pagg. 537 e segg.
[25] K.Koffka, Probleme der experimentellen Psychologie, I, «Die Unterschiedschwelle» «Die Naturwissensch. «, 1917, V.
[26] H. Cornelius, Psychologie als Erfahrungswissenschaft, Leipzig, 1897, pagg. 273 e segg.
[27] K. Koffka, Perception: an Introduction to the Gestalt Theorie, « Psych. Bull. «, 1922, pag. 542.
[28] Vedi:W.Köhler,Zur Theorie des Sukzessivvergleichnis und Zeitfehler, «Psych. Forsch «, 1923; pagg. 115 e segg.
[29] G. Petter, Lo studio sperimentale del’identità fenomenica. « Riv. di Psic.», 1957, 2, pag. 18.
[30] Da un punto di vista correttamente fenomenologico, ogni movimento avvertito come tale è un movimento « reale «. Gli psicologi gestaltisti hanno discusso e rifiutato la distinzione tra movimenti «reali» e movimenti «apparenti» - oltre che sul piano fenomenologico - anche su quello delle basi fisiologiche degli eventi cinetici (vedi K. Koffka, Principles, pagg. 281 e 286).
[31] Vedi, cap. IV, § 6 di questo libro il fenomeno «F -puro».
[32] Cfr. K. Koffka, Principles, pag. 287.
[33] A.Korte, Kinematoscopische Untersuchungen, «Zeitsch. f. Psych.», 1915; pagg. 194-296.
[34] K. Steinig, Zur Frage der Wahrnehmunq von Zwischenstadien, bei stroboskopisch dargebotenen Bewegungen, «Zeits. f. Psych.», 1929 (109), pagg. 291-336.
[35] P. von Schiller, Stroboskopische Alternativversuche, «Psych. Forsc.» ,1933, pag.179 e segg.