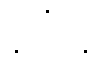
|
Capitolo Quarto L’identità |
(continuazione)
Kafka, Il Castello
§ 1. L’identità nelle strutture organizzate: gli esperimenti di Ternus.
Poche pagine fa, abbiamo visto che Locke vedeva nella «organizzazione» un aspetto dell’esperienza umana capace di restare immutato a dispetto della sostituzione materiale delle parti (o almeno di alcune parti) che la costituiscono.
Quella citazione può essere considerata come un primo abbozzo dei criteri che Christian von Ehrenfles[1], nel 1890, enuncerà come base per la definizione delle qualità formali:
1) nessun elemento che faccia parte di una organizzazione contiene, preso per se stesso, una «parte» di quell’organizzazione;
2) tutti gli elementi che costituiscono una data organizzazione possono essere sostituiti da altri, diversi, senza che quell’organizzazione venga meno - a patto che sia rispettata una certa regola. La regola riguarda i rapporti intercorrenti tra gli elementi; infatti : a) considerare un elemento per se stesso vuol dire prescindere dai rapporti che ha cogli altri; e b) conservare i rapporti sostituendo gli elementi equivale a conservare l’organizzazione. L’organizzazione è, dunque, un sistema di rapporti.
Nel caso di una melodia, il sistema di rapporti è rappresentato dalle distanze tonali intercorrenti tra nota e nota, nell’ordine. Lo stesso accade in campo visivo.
Tre punti disposti così
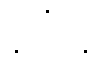
sono percettivamente un triangolo, che siano segnati in nero, in rosso o in blu, e aumentando o diminuendo a piacere (ma in proporzione) le distanze intercorrenti tra essi. Nessun punto è un triangolo, come nessuna nota è una melodia.
Se una struttura ha più parti discernibili, alcune di esse prese insieme possono costituire a loro volta una struttura più o meno arbitraria, quando siano considerate a sé - in pratica, quando le altre siano soppresse. Per esempio, questo rombo
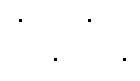
contiene il triangolo

Le esigenze interne delle parti arbitrarie [2] possono essere conformi a quelle della struttura di cui fanno parte, oppure in contrasto con esse.
Per esempio, questa figura
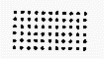
ha una direzionalità chiaramente orizzontale-verticale; e contiene, tra le altre possibili, queste due parti arbitrarie:

la a) condivide gli stessi caratteri di direzionalità della struttura da cui è derivata, mentre la b) possiede chiaramente una direzionalità diversa, così ![]() . Tanto nella a) che nella b), inoltre, possono essere rintracciate ulteriori organizzazioni più piccole, e congruenti con le maggiori per direzionalità, oppure no; queste due coppie di punti, ad es., si trovano tanto in a) che in b)
. Tanto nella a) che nella b), inoltre, possono essere rintracciate ulteriori organizzazioni più piccole, e congruenti con le maggiori per direzionalità, oppure no; queste due coppie di punti, ad es., si trovano tanto in a) che in b)
![]()
![]()
I singoli punti, infine, non possiedono alcuna direzionalità, e dunque non hanno esigenze interne che possano contrastare con una o un’altra soluzione percettiva.
Alla luce di queste considerazioni, credo, va soprattutto intesa la ricerca di Ternus sull’identità[3].
Il tipo di identità utilizzata da Ternus è quella che si ottiene con il salto stroboscopico. Due piccole sorgenti di luce vengono accese e spente alternativamente rispettando le leggi del movimento stroboscopico ottimale[4].
Queste due sorgenti di luce occupano, nello spazio fisico, due posizioni a e b; nello spazio percettivo vi sono due posizioni A e B tra le quali un punto luminoso va e viene.
Mettiamo ora tra a e b, a metà strada, una nuova piccola sorgente di luce; la posizione che essa occupa è c; fino a questo momento le stimolazioni erano così distribuite, nel tempo della fisica: la sorgente in a si accende, poi si spegne, passa qualche frazione di secondo, e la sorgente in b si accende a sua volta, per poi spegnersi; ora, accenderemo la sorgente in a, e insieme quella in c, e le spegneremo insieme, per subito riaccendere quella in c insieme con quella in b, e alla fine spegnerle insieme.
Che cosa dovrà succedere? Ragioniamo per un momento come se le sorgenti in a e in b non ci fossero. La sorgente in c si spegne e si riaccende restando sempre in c. La sua prima accensione e la sua seconda non corrispondono, fenomenicamente, all’accensione di due punti luminosi nella posizione C dello spazio percepito ma a quella di uno stesso punto che ora è spento ed ora è acceso. Quando siamo in mare di notte, e dalla barca vediamo un piccolo faro a riva, non diciamo di vedere alcune sorgenti luminose che si alternano su una medesima posizione, nel buio, e a turno lanciano un raggio di luce verso di noi; diciamo di vedere una sorgente di luce, ora accesa e ora spenta. Quindi la identità fenomenica della fonte che si accende a riaccende in C è garantita. Koffka, riferendo le esperienze di Ternus, parla appunto di fusione per prossimità spaziale «potendosi considerare l’identità di posizione nello spazio come il caso della maggiore prossimità possibile»[5].
Se tutto questo è vero (e soltanto questo) utilizzando i tre stimoli nel modo detto dovremmo vedere nella posizione C dello spazio fenomenico una luce che, accesa, si spegne e tosto si riaccende, mentre dalla posizione A una luce passa alla posizione B, cosi:
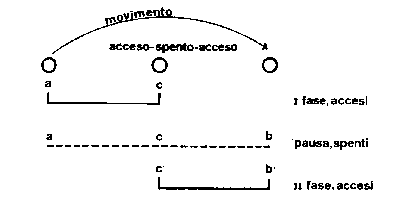
Fig. 76
In realtà, si vede tutt’altra cosa. Un punto luminoso passa dalla posizione A alla posizione C, mentre un altro passa dalla posizione C alla posizione B, così:

Fig.77
I ragionamenti svolti poco fa non giustificano questa previsione. La sorgente di mezzo doveva restare in C per ragioni di prossimità; l’altro punto luminoso non doveva trovare maggiori difficoltà a passare da A a B, di quante non ne avesse incontrate prima che nella posizione C venisse posta un’altra luce. Ma questi ragionamenti noi li facciamo tenendo presenti due strutture, così come possono essere presentate separatamente: 1) moto della luce da A a B; 2) luce che lampeggia due volte in C.
Cerchiamo di tener presente, invece, quello che è successo quando abbiamo combinate le due cose insieme. Primo momento, coppia di luci in A e C - secondo momento, coppia di Luci in C e B:

Fig. 78
La coppia di luci si è spostata in blocco un po’ più in là; si è conservata, cioè la struttura «coppia», elementarissima fin che si vuole, ma bene organizzata. Da un punto di vista puramente teorico, la luce in C poteva, mantenere la propria identità, e l’altra pure, attraverso il movimento da A a B. Ma l’identità non si è mantenuta per i singoli punti luminosi, bensì per la struttura di cui facevano parte.
Per illustrare meglio i successivi esperimenti, adotteremo anche noi l’espediente grafico utilizzato da Ternus nel rappresentare le distribuzioni delle luci nello spazio e, insieme, la successione delle esposizioni.
Ogni presentazione consta, come s’è detto, di tre fasi: una prima in cui vengono presentati alcuni punti luminosi in date posizioni, la seconda costituita da un breve intervallo di oscurità, la terza in cui vengono presentati altri punti luminosi, parte dei quali in posizioni già occupate nell’esposizione precedente.
Un punto così
![]()
rappresenta un punto luminoso presentato durante la prima esposizione; un cerchietto così
![]()
rappresenta un punto luminoso della stessa grandezza presentato nella seconda esposizione; un punto circondato da un cerchietto così
![]()
rappresenta un punto luminoso presentato sia nella prima che nella seconda esposizione.
L’esperienza precedentemente descritta può venir dunque rappresentata a questo modo:

Fig. 79
Ciò che in effetti si vede verrà rappresentato da linee tratteggiate che collegano, secondo le esigenze della struttura, i punti accesi nella prima presentazione, e da linee continue che collegano, sempre secondo la struttura, i punti accesi nella seconda. Nel caso detto poco fa, così:
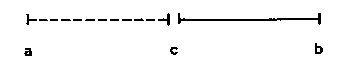
Fig. 80
Vediamo un altro esempio. La disposizione è questa:
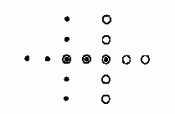
Fig. 81
e questo il rendimento percettivo:

Fig. 82
Anche qui, ogni punto ha mantenuta la propria funzione nella struttura complessiva, cambiando posizione nello spazio fenomenico anche se esigenze puramente locali richiedevano che non si muovesse di li. In questo caso, ogni punto del braccio orizzontale della croce si è spostato nel luogo successivo a destra, prima occupato da un altro. Il braccio orizzontale, nel complesso, è slittato lungo se stesso di due intervalli.
Bene. Prendiamo allora una situazione che, per questo aspetto della struttura, è strettamente analoga:
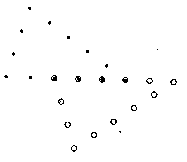
Fig. 83
Osservando l’asse orizzontale in questa distribuzione di punti, si vedrà facilmente che è simile a quello presentato poco fa. Anche qui, dunque, la linea dovrebbe scorrere lungo se stessa e scalare di due intervalli.
Ma le cose non vanno nel modo di prima, stavolta. Il movimento è dell’intera figura, e la linea orizzontale non scorre lungo se stessa, ma viene formata, nella seconda fase della presentazione, dai punti che stavano disposti obliquamente sopra di essa, prima. A questo modo:
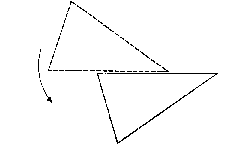
Fig. 84
Una soluzione che andava bene nel caso precedente, per la substruttura costituita dalla linea orizzontale, non va più bene in questo caso. Perché? Perché essa fa parte di una struttura maggiore, ed è questa che impone una nuova soluzione; tale soluzione deve salvare la struttura più importante. La tendenza che ha. la substruttura a conservarsi identica, e che si realizzerebbe qualora fosse presentata isolatamente, qui non conta. L’autoidentità da salvare è, in questo caso, quella del triangolo[6].
Questo è il principio. Provi ora il lettore a prevedere le soluzioni percettive che si avranno, impostando gli stimoli nei seguenti modi:
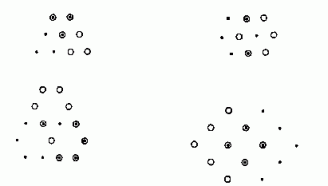
Fig. 85
Un caso a parte, e particolarmente interessante, è rappresentato da questo esempio, sempre di Ternus:
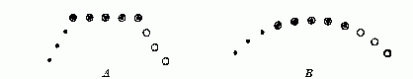
Fig. 86
Le soluzioni percettive sono le seguenti:
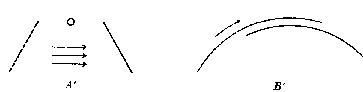
Fig. 87
La seconda (B’) consiste nella conservazione della struttura totale. In questo senso, il caso è identico a quello della croce che si sposta in toto lungo il suo braccio orizzontale.
La prima (A’) invece è tale, quale sarebbe se non ci fossero i tre punti di mezzo, quelli che restano esposti in tutte e due le fasi. Dunque i tre punti, la linea formata da essi, non ha un ruolo funzionale nella soluzione percettiva: presenti in quella posizione o tolti di li, i punti restanti compiono il loro movimento nello stesso modo.
La ragione della diversità delle due soluzioni deve essere dunque in questo pezzo centrale delle due figure.
Difatti, mentre nella fig. 85 B quel gruppo di punti è legato omogeneamente agli altri, nella fig. 85 A, no. L’esistenza di un angolo spezza la linea dando luogo a sottonnità discernibili, e queste possiedono una certa autonomia. Questa struttura è fatta di due parti, di cui una permane nella stessa posizione in tutte e due le fasi, mentre l’altra resta libera di seguire quell’itinerario stroboscopico che seguirebbe anche in assenza degli altri tre punti.
La fig. 85 B, invece - benché fatta di punti - ha un andamento omogeneo, e tale omogeneità viene rispettata nella soluzione.
Che in molte di queste situazioni la conservazione della configurazione complessiva avvenga a spese delle esigenze proprie delle parti (le quali, appunto, si comporterebbero a modo loro se non fossero incastrate nella configurazione maggiore), e specialmente di quei punti che semplicemente potrebbero ricomparire due volte nello stesso posto, può essere provato mutando opportunamente le condizioni di sperimentazione. Per quanto riguarda i punti, basta congegnare la presentazione in modo che, nell’intervallo tra la prima fase e la seconda, quelli che devono essere presenti in entrambe le fasi restino accesi tutto il tempo. In questo modo essi non possono diventare meta di un itinerario stroboscopico. Dal punto di vista della stimolazione prossimale infatti - occorre che, dopo l’estinzione locale del primo stimolo, abbia luogo un secondo stimolo entro un tempo abbastanza breve ed entro un’ambito spaziale adatto; altrimenti non vi è percezione di moto.
I punti critici, in questo modo, non hanno un attimo di disponibilità: così gli altri punti cambiano di luogo, dalla prima alla seconda fase, secondo gli itinerari che seguirebbero se fossero disposti su uno sfondo omogeneo. È dunque proprio l’organizzazione dell’oggetto di cui sono elementi ciò che li trascina da un luogo all’altro secondo leggi definite, nei casi ora esposti.
§ 2. Identità e permanenza. La «presenza amodale».
Torniamo ancora una volta ai nostri empiristi inglesi, che a proposito di questi fatti - a modo loro, se vogliamo - avevano già visto quasi tutto l’essenziale (Hume, negandolo).
Le situazioni esaminate fino a questo punto erano costituite da oggetti all’interno dei quali accadeva un cambiamento, una trasformazione, oppure da oggetti che mutavano il sistema di relazioni spaziali con l’ambiente nel quale si trovavano collocati. Qui il problema dell’identità sta nel fatto che non sappiamo, a priori, circostanza per circostanza, se e come l’identità sopravviva alle trasformazioni; essendo precedentemente dato per certo (soglie differenziali) che essa si mantiene quando nessuna trasformazione interessa la cosa considerata.
Ma in tutti questi casi l’intera storia dell’oggetto stava tutta sotto i nostri occhi, dal punto di partenza, attraverso il momento critico del cambiamento, fino all’esito dell’evento.
Nel corso delle nostre esperienze quotidiane, però, raramente avviene che ci nascano dubbi intorno all’identità di una cosa che subisce cambiamenti sotto il nostro controllo diretto. Occorre essere un po’ smaliziati, oppure semplicemente molto sofistici, per porre seriamente la domanda: «se questo cambia, perché è lo stesso? «.
Invece, il problema dell’identità si pone in maniera molto concreta quando, come appunto Locke dice, ritrovando una data cosa dopo averla perduta di vista, ci domandiamo se è la medesima di prima. L’interruzione del contatto diretto tra noi e la cosa può essere breve o lunga; cioè, può essere questione di secondi o frazioni di secondi, può essere questione di minuti, di ore, o di mesi e anni.
Rispettando i limiti che ci siamo imposti per questa trattazione, toccheremo solo alcuni gruppi di esperimenti riguardanti le interruzioni brevissime, in modo da non dover implicare nella discussione riferimenti al problema dell’identità nella memoria. Il nostro modo di accostare il problema di Locke, dunque, si avvicina molto a quello di Hume; il lettore ricorderà come questo autore avesse annotato - tra i fatti più spiacevolmente contrarii alla sua teoria - il caso del «rumore frequentemente interrotto e rinnovato», e quello dell’oggetto che appare e scompare in modo che «ad ogni istante» possiamo constatare che la sua realtà sensoriale è intermittente. Il nostro compito, adesso, è proprio quello di vedere da vicino cosa sono queste «identità fittizie».
Per arrivare a intendere bene questo genere di fenomeni, occorre prendere le mosse dall’analisi di alcuni fatti apparentemente molto diversi.
Koffka [7] immagina che in un tribunale abbia luogo, durante un dibattimento, il seguente dialogo:
«Avvocato: Dov’era il libro?
Testimone:Sul tavolo, signore.
A.: Che cosa c’era sotto il libro?
T.: Il tavolo, signore.
A.: Come fate a saperlo?
T.: Ma, signore, l’ho visto.
A.: Siete disposto a testimoniare sotto giuramento che sotto quel libro non vi era una apertura nel tavolo stesso, attraverso la quale fosse possibile lasciar cadere una rivoltella?
T.: No di certo.
A.: E perché no?
T.: Perché non potrei averla vista, dal momento che il libro ci sarebbe stato giusto sopra.
A.: E ancora voi volete sostenere di aver visto che sotto il libro c’era il tavolo? Grazie».
L’avvocato ha ragione, aggiunge Koffka, perché le constatazioni del testimone gli servono solo per ricostruire una situazione di fatto, circa la quale il punto di vista del testimone è solo una prospettiva. Ma il fatto che il testimone non potesse vedere sotto il libro, benché vedesse il libro sul tavolo non comporta alcuna contraddizione, dal punto di vista fenomenologico.
Davanti a me, in questo momento, c’è una parete bianca sulla quale è appeso un piccolo quadro: a rigor di logica, per poter dire che il quadretto sta davanti al muro dovrei poter vedere che un pezzo di muro sta dietro al quadretto. Ma potrebbe esserci anche un buco, dietro ad esso, praticato nella parete ed avente la esatta forma e grandezza della cornice del quadro. A rigor di logica, cioè, non potremmo mai enunciare frasi descrittive contenenti l’espressione davanti a, proprio perché non possiamo mai descrivere con assoluta certezza qualcosa come dietro a; se io sono l’osservatore e dico che in questo momento, di fronte a me, qualcosa sta dietro a qualcosa, che ne so io? potrebbe sempre non essere vero. Potrebbe, anzi, non esserci nulla.
Dovremmo dunque escludere del tutto espressioni di questo tipo dal linguaggio descrittivo che applichiamo al nostro mondo. Esse mancano di logica. Potrò dire che qualcosa sta dietro a qualcosa d’altro solo rispetto a un secondo osservatore; quando io, dall’esterno, vedo che una delle due cosa sta tra l’osservatore e l’altra. Con il soggetto in prima persona, espressioni così andrebbero bandite.
(Prendiamo un caso assai diverso: da un foglio di cartone bianco ritagliamo un disco, col diametro di una ventina di centimetri; su di esso, con un bel color nero, dipingiamo una spirale, tracciata abbastanza. grossa da poter essere chiaramente visibile. Ora fissiamo questo disco a qualche supporto infilandogli un ago perfettamente nel centro, e lo facciamo ruotare. A seconda del verso della rotazione, si vede distintamente il disco contrarsi, oppure espandersi continuamente; ma per quanto la nostra osservazione venga prolungata, non vedremo mai diventare il disco con la spirale più piccolo o più grande. Questa è una contraddizione. Non può contrarsi senza diventare più piccolo, e non può espandersi senza diventare più grande. Pure, succede così. Se il nostro linguaggio descrittivo vuol essere esente da contraddizioni, dobbiamo decidere che un esperienza come questa non può essere descritta).
In realtà, i nostri discorsi quando vogliono essere descrittivi devono rispettare, nella loro logica, la logica delle cose. Se vi è una proprietà del mondo esperito per cui l’oggetto parzialmente nascosto da un altro non appare interrotto o mancante di pezzi là dove io, stando in questa posizione, non posso vederlo, sono autorizzato - contraddizioni o no - a dire che questo sta davanti a quello e viceversa.
Per capire veramente il significato fenomenologico di una espressione come questa, bisogna porre la intera questione in maniera meno diretta. Non: «quel quadro, è davanti al muro?»; ma: «potresti dire che il muro cessa là dove comincia il quadro?»; oppure: «guardando la zona del muro che si trova all’altezza del quadro, e procedendo da sinistra a destra, puoi dire che, nel punto in cui il tuo sguardo incontra la cornice, il muro si interrompe, o finisce, nello stesso senso in cui - procedendo ancora per un momento - puoi dire che poco più in là finisce il quadro? «.
Non possiamo dirlo: il muro non finisce accanto al quadro nello stesso senso in cui il quadro finisce nel luogo segnato dalla cornice; avvertiamo bene che sarebbe un uso linguistico scorretto. La proprietà dell’uso linguistico - nel senso strettamente tecnico che alcuni filosofi di Oxford recentemente sono venuti precisando [8] - costituisce, in casi come questi, un criterio di notevole valore. I criteri «obbiettivi», solidamente comportamentistici, non possono aiutarci molto quando l’analisi fenomenologica deve essere svolta su situazioni che richiedono l’impiego di mezzi particolarmente fini, perché si possa dire che sono state esaurientemente studiate. Nel caso di una figura «sopra» uno sfondo, Tolman ha proposto di assumere, come equivalente comportamentale del fatto, il criterio della «possibilità di afferrare» («pick-up-ableness»)[9]: una figura, che sia tale in rapporto ad uno sfondo, sarebbe così semplicemente quel segmento di campo visivo che l’uomo o l’animale andrebbe a «prendere», qualora vi fosse spinto da una motivazione o da un condizionamento; i contorni di una figura sarebbero i suoi possibili limiti tattili, e il carattere di «cosa» sarebbe la possibilità di una manipolazione. Questo criterio costituisce una proposta metodologica interessante, specialmente se il nostro campo di studi è quello della psicologia animale; ma limita fortemente il terreno delle possibili esplorazioni: in realtà una figura può essere in vari modi (ad es. con varie distanze) davanti ad uno sfondo, il suo carattere di «cosa» può variare a seconda del tipo di microstruttura che la caratterizza, a seconda dei margini che ha, e in funzione del tipo di sfondo che le sta dietro. Inoltre, ciò che Tolman propone di chiamare «pik-up-ableness», e che Koffka [10] descrive dicendo «it is the figure we are «concerned with«», non si risolve nella percezione della «possibilità di prendere»: quando un segmento del campo percettivo diventa figura il suo colore risulta anche visibilmente più saturo, i dettagli hanno maggiore vivacità, ecc.[11].
Si potrebbe sostenere che tutte queste sottigliezze descrittive hanno poco importanza. Ma non è così.
Metelli ha dimostrato che tutte queste proprietà più o meno facilmente descrivibili possono essere ricondotte a tre aspetti fondamentali del fenomeno di articolazione in figura e sfondo, non derivabili l’uno dall’altro: oggettualità, stratificazione e risalto; inoltre, che fra questi tre aspetti indipendenti possono intercorrere relazioni funzionali tali da determinare - caso per caso, a seconda della loro distribuzione, il tipo di organizzazione che avrà luogo[12].
Dunque, il criterio suggerito da Tolman è troppo povero per essere utilmente impiegato nello studio della complessa dinamica del fenomeno: i fattori in gioco in realtà sono molti, e alcuni di essi possono essere individuati solo con l’impiego di una certa raffinata malizia, di cui lo sperimentatore bravo è naturalmente dotato.
Il linguaggio comune funziona meglio (almeno in casi come questi) che non gli «equivalenti comportamentali». In esso c’è un nome per ognuno degli aspetti fenomenicamente rilevabili, e quindi le descrizioni dei fattori possono risultare fedeli e calzanti. Altrettanto fedeli e calzanti possono risultare le descrizioni dei risultati ottenuti combinando tali fattori.
Nell’esempio che stavamo discutendo, la descrizione del risultato è molto semplice: «il muro sta dietro e il quadro è davanti». Questo modo di esprimerci dipende direttamente dal modo di apparire della situazione considerata; «sta» ed «è» sono un invito a prendere atto di quanto succede là, tra le cose di cui stiamo parlando. La descrizione include la situazione che è oggetto dell’osservazione in una classe più ampia difatti (constatazioni di tipo tattile, acustico; strutture locomotorie, ecc.) in cui normalmente diremmo che qualcosa sta dietro o è davanti, e sottolinea l’esistenza di una identità strutturale tra questa situazione e quelle.
Dunque, basta guardarsi bene intorno per capire cosa vuol dire «stare dietro a» o - che è la stessa cosa - «stare sotto a», e rispettivamente «stare davanti» e «stare sopra». Fuori dalla finestra, l’albero sta davanti alla casa di fronte, dietro a questa sta una collina il cui profilo si staglia c o n t r o un monte. E così via. Naturalmente, occorre tener presente che non si tratta di un fatto banale.
Se ci avviciniamo alla finestra chiusa e, tenendo il capo bene fermo in una posizione, ripassiamo con una penna i contorni dell’albero, della casa, della collina ecc. sul vetro, e poi consideriamo questo rozzo quadretto, si vedrà chiaramente anche lì - per male che sia riuscito - come l’albero è «davanti» alla casa, e questa alla collina ecc. Ma, in un altro senso, è innegabile che sul vetro non c’è alcun «davanti»: la superficie del vetro è piana, e le varie articolazioni distinguibili possono essere solo «accanto» l’una all’altra.
La proiezione retinica può essere immaginata anche così[13], come il disegno sul vetro; nell’occhio di chi osserva non vi sono né davanti né dietro. La relazione davanti-dietro è caratteristica dell’esperienza immediata. Le linee tracciate con la penna sul vetro, esattamente come i confini tra tipi diversi di stimolazione sulla retina, dividono il piano in regioni: ogni regione trova i suoi limiti nella linea d’inchiostro che la circonda. In questo senso, sulla lastra della nostra finestra, non vi è una casa, né una collina, né altro, ma solo regioni adiacenti e separate.
Guardando in realtà il mondo fuori dalla finestra, queste cose ci sono. Queste cose, analogamente allo schizzo sul vetro, hanno visibilmente confini. Ma la differenza che rende le due situazioni inconfrontabili sta nel fatto che sulla lastra ogni linea delimita quasi altrettanto bene l’area che ha da una parte, quanto l’area che ha dall’altra; mentre i contorni che hanno le cose concretamente vedute sono solo contorni delle cose, non dello sfondo: essi delimitano solo da una parte, e non dall’altra.
Questo ci permette di parlare di una funzione unilaterale dei margini.
Nella discussione tra l’avvocato e il testimone, il testimone ha ragione - dal suo punto di vista - non meno dell’avvocato: i margini del libro n o n erano i margini del tavolo; di conseguenza si poteva dire che sotto il libro il tavolo realmente c’era.
§ 3. Le unificazioni «amodali».
L’esistenza di questa funzione unilaterale dei margini parrebbe, a prima vista, aver poco a che fare con il problema della identità degli oggetti. La connessione, però, diventa evidente quando passiamo dall’esame dei casi di figure piazzate su uno sfondo che le contiene interamente a casi in cui ciò non avviene, come il seguente:
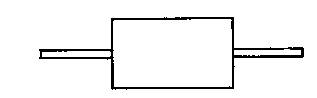
Fig. 88
Non c’è osservatore che non veda, qui, una sovrapposizione tra due oggetti: i due rettangoli allungati che toccano il rettangolo centrale ai due lati, ciascuno con il suo lato minore, sono in realtà due parti appartenenti allo stesso oggetto: un rettangolo lungo e sottile collocato tra un rettangolo più grosso e lo sfondo vero e proprio.
L’unificazione tra i due pezzi visibili avviene «dietro» grazie alla terza legge di Wertheimer (continuità); ma ciò è reso possibile dal fatto che i lati minori dei rettangoli a contatto con i lati verticali del rettangolo centrale sono tutt’uno con tali lati, e questi sono confini esclusivamente all’estensione di tale rettangolo, non a quella dei rettangoli laterali. Non si tratta di funambolismi verbali al servizio di una fenomenologia spicciola; chi voglia rendersene conto confronti queste due figure:

Fig. 89
Nella seconda i margini comuni hanno funzione bilaterale, e le figure che connettono sono tra loro coordinate. Nessuna di queste figure sta parzialmente dietro all’altra; stanno solo affiancate.
Come mai in certe condizioni una linea diventa confine di ciò che le sta da una parte piuttosto che di ciò che sta dall’altra, è un problema che qui non possiamo discutere. Diremo, in breve, che dipende proprio da quelle «certe condizioni «. Rimandiamo il lettore al libro ormai più volte citato di Kurt Koffka (pagg. 177-210 - tutto il V capitolo), dove le molte questioni connesse a questa domanda sono discusse ampiamente. Il fatto importante che ci occorreva sottolineare è questo: le cose dell’esperienza diretta esistono, da un punto di vista strettamente fenomenologico, anche là dove ci sono nascoste da qualche altra cosa; l’assunto berkeleyano, secondo cui è visibile solo ciò che ha colore, pure obbedendo a una propria logica ineccepibile, è sbagliato; anzi, è sbagliato in senso altrettanto strettamente berkeleyano: se è vero che «esse est percipi «, il fatto che noi percepiamo certe cose come parzialmente nascoste garantisce il fatto che è proprio così.
Fin qui, abbiamo discusso dei confini spaziali.
Ma la stessa cosa succede anche per i confini temporali.
Il «rumore frequentemente interrotto e rinnovato» di Hume può essere realizzato molto bene, oggi, con semplici attrezzature. Chi legge un autore così pieno di idee come è appunto Hume, e così ricco di esempi, dovrebbe - capitolo per capitolo - riprodurre per se stesso tutte le esperienze di cui l’autore ha parlato, con la stessa cura che mette nel cercare un’edizione perfettamente attendibile e ben commentata, o un certo numero di monografie esaurienti ed aggiornate intorno a quell’autore e la vita del suo tempo. Un filosofo, generalmente, dice le cose assai sul serio, e cerca la discussione e il dissenso: un lettore che voglia veramente capire il succo del discorso e cercare i motivi per cui certe tesi possono essere condivise e certe altre no (oggi come allora) non dovrà accontentarsi di immaginare le esperienze che l’autore letto riferisce a sostegno delle proprie teorie: l’autore, scrivendo, non si riferiva infatti all’atto di «immaginare» esperienze, ma all’averle. Il lettore legge e ricorda casi analoghi, e passa via. In realtà, potrebbe dire con sicurezza si o no solo mettendosi difronte all’evento di cui si parla, che non va mai confuso con una descrizione. Per questa via, ne sono certo, troverebbe molte altre cose di cui l’autore non ha parlato, e moltissime che gli sono completamente sfuggite. E, tra queste, certo qualcuna che costituisce un autentico approfondimento all’argomento della discussione.
Se ci mettiamo a realizzare il rumore interrotto frequentemente, troveremo che possono accadere molte cose diverse.
Intanto, una che a Hume sarebbe molto piaciuta: a certe condizioni, i tratti di rumore presentati successivamente non si unificano. Ogni breve pezzo è una unità a sé stante, che cessa di esistere nel momento in cui cessa di essere sentita. Questo avviene, per esempio, ascoltando il rumore uniforme della modulazione di frequenza (che è un rumore bianco, cioè formato dall’insieme di tutte le frequenze udibili) attraverso i diffusori di un comune apparecchio radiofonico, e interrompendo a tratti la corrente che alimenta l’impianto per mezzo di un interruttore abbastanza silenzioso (il clic dell’interruttore potrebbe essere introdotto come un’ulteriore variante: quello che descrivo è il caso più semplice). Lo sfondo, qui, è il silenzio. Nel silenzio compare il tratto di rumore che subito cessa; poi riappare per cessare ancora, ecc.
Introduciamo una lieve modifica, altrettanto semplice da realizzare. Invece di usare l’interruttore, utilizziamo la manopola che regola il volume. Per i nostri scopi, occorrerebbe che il minimo del volume di emissione fosse largamente al di sotto della soglia assoluta - cioè, non si dovrebbe sentire assolutamente nulla. Di solito, con i comuni apparecchi, è proprio così. Bene. Ora, estinguiamo gradatamente (nel giro di un secondo, ad es.) il nostro rumore e subito dopo rinforziamolo fino al volume di prima, e ripetiamo parecchie volte l’operazione. Ciò che si sente, è un rumore che va e viene (propriamente: «va» e «viene» anche in senso spaziale; infatti, si avrà una lieve impressione di avvicinamento ed allontanamento della sorgente, mista alla sensazione del diminuire e risalire dell’intensità) senza estinguersi mai, anche se per qualche attimo - con la manopola al minimo - al nostro orecchio non è pervenuta alcuna sollecitazione.
Disponendo di due apparecchi, è possibile fare un’altra prova: un apparecchio viene fermato su una lunghezza d’onda che permette di sentire, per esempio, della musica, o una conversazione. L’altro apparecchio viene intanto utilizzato per ottenere il solito rumore bianco. Invece di un interruttore, questa volta, utilizzeremo un deviatore di buona qualità, come oggi facilmente si trovano in commercio. Per mezzo del deviatore, ascolteremo brevi tratti di conversazione o di musica, alternati a brevi tratti di rumore bianco.
Provando diverse volte a variare i tempi dell’alternanza, troveremo senz’altro un ritmo in cui si sente distintamente la conversazione o la musica come continne, su cui, a tratti, si sovrappone un rumore, il quale non intacca minimamente la loro continuità. La serie si presenterà così:

Fig. 90
non cosi:
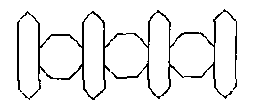
Fig. 91
Chi abbia bene in mente il significato dell’ultimo esempio discusso, a proposito della struttura figura-sfondo, si renderà facilmente conto che queste due rappresentazioni grafiche non sono due mere rappresentazioni : non corre tra esse ed il fatto acustico corrispondente un rapporto paragonabile a quello passante tra un gruppo di linee e punti dell’alfabeto Morse ed una parola detta, o tra un grafico e l’andamento del fenomeno che descrive.
Le due figure tracciate qui sopra, non rappresentano la situazione acustica, ma sono la stessa cosa in campo visivo. Cioè, non è che le due serie di oggetti (acustica e visiva) si somiglino, ma sono costruite rispettando le stesse leggi. La configurazione dell’esempio disegnato ripete le proprietà essenziali dei due ordini difatti (non delle due classi di stimolazioni, ovviamente; esse non sono neppure paragonabili, e del resto in questo discorso non c’entrano, perché qui stiamo trattando di esperienze reali): i margini dei dischetti in fig. 89 (rumore) hanno esclusivamente una funzione unilaterale; quindi non sono margini della fascia compresa tra le due parallele.
Nella illustrazione di sotto, i margini delle figure chiuse hanno funzione bilaterale, come in alcuni casi succede (e cioè quando dividono figure coordinate): dove finisce una zona, comincia l’altra. È il caso citato per primo: rumore, silenzio, rumore, silenzio, ecc.[14].
Si potrà obbiettare che Hume non possedeva gli strumenti che abbiamo noi. Ma non ha nessuna importanza. La fonte dei suoni e dei rumori è indifferente. Un rumore di cascata sentito dietro la casa, in montagna, è come un rumore registrato, solo che non può essere facilmente interrotto a scopo di esperimento. Il tipo di rumore o di suono può importare, a volte; non certo la sua origine fisica: difatti, confini unilaterali o bilaterali ed altre cose di questo genere sono proprietà fenomeniche degli eventi percepiti, ed esclusivamente tali.
Per quanto riguarda la continuità del suono «attraverso» un rumore, vi è un fatto che vale la pena di essere riferito con qualche dettaglio. È un esperimento realizzato pochi anni fa da Vicario con l’ausilio di un comune registratore a nastro, un oscillatore e un generatore di rumore bianco[15].
Regolando opportunamente l’oscillatore, Vicario registrava su un nastro magnetico una data nota pura, ad esempio, il La 440, per la durata di parecchi minuti.
Su un altro nastro registrava poi parecchi minuti di rumore bianco.
Si sa che nei comuni registratori il nastro magnetico scorre a velocità perfettamente uniforme. Grazie a questa circostanza è molto facile misurare esattamente la durata temporale dei suoni che si vogliono ottenere: basterà tagliare il nastro su cui sono registrati in pezzi di lunghezza opportunamente calcolata.; ad esempio: il nastro scorre davanti alla testina sensibile alla velocità di 19 cm/sec., e occorre avere un suono della durata di 600 millisec.; l’otteniamo tagliando da un nastro su cui è incisa la nota voluta un segmento lungo 11,4 cm.
Grazie a questa semplice tecnica, si può andare a vedere (anzi, a sentire) cosa succede di un suono quando cessa improvvisamente e viene all’istante sostituito da un rumore. Basta tagliare tot centimetri dal nastro che contiene il «La 440», tot centimetri dal nastro che contiene rumore bianco, incollarli esattamente alle estremità ed inserire il nastro così ottenuto nel magnetofono, per l’audizione. Con nostra notevole sorpresa (chi scrive era presente alla realizzazione dei primi esperimenti), quello che si sente non è affatto la cessazione di un suono e l’inizio di un rumore, ma un suono che improvvisamente viene coperto da un rumore «attraverso» il quale lo si continua a sentire, nettamente, senza possibilità di equivoco.
Componendo allo stesso modo una serie di pezzi di nastro, secondo il seguente schema: La 440 - rumore bianco - La 440, il secondo segmento di suono si unisce perfettamente al primo; anzi, una descrizione adeguata potrebbe essere questa: il primo La entra nel rumore, si sente benissimo attraverso il rumore, poi il rumore cessa e si continua a risentire il La nitidamente, senza disturbi.
Non vi è soluzione di continuità, nella nota.
La soluzione della continuità si ha in certe situazioni particolari. Vicario, variando sistematicamente i differenti aspetti della situazione, trovò che il rumore bianco non deve avere una intensità troppo bassa rispetto a quella del suono se si vuole che l’effetto abbia luogo. Semplificando le cose, se il primo La è forte, il rumore bianco molto debole, e il secondo La forte come il primo, ciò che si sente è una nota che viene a cessare improvvisamente, un rumore che comincia da quel momento, poi cessa di colpo mentre una nota uguale alla precedente inizia a risuonare.
Il confronto tra questa situazione e la precedente mostra con efficacia la differenza che c’è tra la discontinuità e la continuità. La discontinuità contiene margini con funzione bilaterale; cessa una cosa e comincia un’altra. La continuità è caratterizzata dal fatto che il margine interveniente a un certo punto (inizio del rumore) non è margine temporale del suono, il quale mantiene la sua identità ininterrotta. Inoltre, il confronto tra queste due situazioni può mostrare molto bene che differenza passa tra l’identità percepita e l’identità pensata: nel secondo esempio, sentendo la seconda nota subito dopo il rumore poco intenso, può darsi che diciamo «è la nota di prima che ricomincia». Chi ascoltasse questa nostra descrizione e prescindesse dalla natura dell’evento descritto, potrebbe classificare questo protocollo come un giudizio di identità, dato che vi si menziona «la nota di prima «; ma è del tutto sbagliato - come sempre è sbagliato classificare le risposte dei soggetti senza tener conto della reale situazione che hanno davanti.
Questa è «la nota di prima» perché ha caratteristiche uguali; ma «ricomincia»; cioè ha un inizio, c’è un momento in cui comincia «adesso». Nella situazione precedente l’identità consiste nel fatto che la nota non viene a cessare mai e quindi ha un inizio solo. Non è giudicata la stessa, ma è la stessa.
Questi esempi, dunque, riguardano i tagli operati nel tempo, come quelli di prima (figura-sfondo) riguardavano i tagli operati nello spazio. Le situazioni alle quali dobbiamo arrivare, però, sono quelle che più da vicino si prestano a illustrare il problema dell’identità come esso si presenta nelle occorrenze della vita quotidiana: e sono i casi in cui l’interruzione, attraverso la quale l’identità continua, è spazio-temporale.
§ 4. Il «passare dietro».
Le ricerche svolte su questo gruppo di fenomeni sono quasi tutte dovute al lavoro della scuola psicologica dell’Università di Lovanio, guidata da Albert Michotte van Den Berck. Il primo lavoro risale al 1943, ed è della dott. A. C. Sampaio; quattro anni dopo fu pubblicato un saggio molto ampio di L. Knops su tutta una serie di aspetti particolari connessi ai fenomeni di identità e permanenza, ed in seguito il tema fu ripreso in altre ricerche, discussioni ed analisi teoriche per opera dello stesso Michotte e di altri collaboratori.
Per essere più chiari nell’esposizione, divideremo l’argomento in tre problemi specifici, destinati però a riunirsi in un problema unico, che è appunto quello dell’identità fenomenica attraverso i tagli operati insieme nello spazio e nel tempo. I tre problemi possono esser messi in luce a partire dalla discussione di un esempio assai comune.
Supponiamo di essere seduti al tavolino di un caffè, all’aperto; davanti a noi vi è una piazza piuttosto grande - supponiamola più o meno deserta - che in mezzo ha un bel monumento, massiccio, con una base di parecchi metri cubi. Ogni tanto un’automobile passa lungo l’altro lato della piazza, venendosi quindi a trovare per qualche momento al di là del monumento, rispetto a noi.
Mettiamoci adesso a ragionare su questa circostanza in modo strettamente analitico, come se fossimo fedeli allievi di Berkeley o di Helmholtz. Dovendo descrivere un evento come quello ora indicato, è irresistibile la tentazione di dire semplicemente che «un’automobile è passata dietro al monumento, qui di fronte, e poi, proseguendo, è andata nella tal direzione»; ma appariremmo, agli occhi dei nostri maestri, molto ingenui. Una descrizione fatta così è scorretta. Difatti, che cosa può voler dire «passare dietro»? parlando di dati sensoriali, a stretto rigore, niente. Si riproduce qui, con poche modifiche, il caso discusso poco fa dello sfondo che «sta dietro» alla figura.
Se in un simile modello del campo visivo una regione non può stare dietro a un’altra, meno che meno una regione può passare dietro a un’altra.
Le prove che Berkeley e Helmholtz citerebbero sono di vario genere, ma le più importanti mi sembrano due: a) l’occhio umano vede, in quanto il mondo circostante si proietta sulla retina: la retina è una superficie, su cui si muovono dunque solo figure piane, le quali possono soltanto essere in contatto o no (avere, cioè, qualche tratto di margine in comune o no), certo mai giacere su piani diversi; b) se guardo la scena attraverso un foro praticato in uno schermo, o attraverso un tubo che permette di vedere le cose solo pezzo per pezzo, a piccole parti, cercherò invano un luogo dove si veda qualcosa davanti a un’altra, o qualcosa che si muove dietro a un’altra; vedrò solo porzioni di colore, tra cui può intercorrere un’unica relazione spaziale: «accanto a».
Seguiamo dunque - su queste basi - la storia dell’immagine di quel veicolo che sta andando verso il monumento: nel campo visivo esso è una sagoma colorata di una data forma che si muove verso un’altra sagoma - la base del monumento - un po’ più grande, avente anch’essa una data forma e certi colori.
La distanza tra esse si riduce sempre più, fino a che entrano in contatto. E fin qui non sorgono problemi.
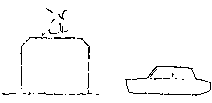
Fig. 92
Su quanto accadrà subito dopo, ci possono essere quattro ipotesi: 1) la sagoma che chiamiamo automobile intaccherà il margine della sagoma detta monumento, in modo che quest’ultima risulterà progressivamente distrutta, in un dato luogo, per far posto alla vettura:

Fig. 93
2) o avverrà il contrario: la base del monumento resterà intatta e la sagoma dell’automobile andrà progressivamente distruggendosi accanto ad essa, fino all’annullamento:
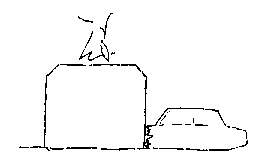
Fig. 94
3) o le due cose si distruggeranno a vicenda:
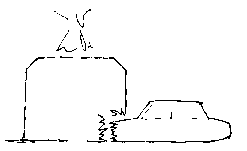
Fig. 95
4) o i loro confini si intersecheranno, dando luogo ad una terza regione:
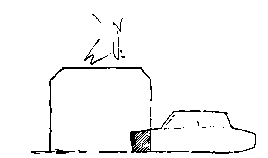
Fig. 96
Qualunque altra ipotesi geometricamente possibile implica un riferimento alla terza dimensione: su un piano (retina, topografia dei luoghi esplorati con lo schermo di riduzione) non si danno altre soluzioni.
Tuttavia, guardando la situazione in concreto, pare proprio che abbia luogo qualcosa che è bene descritta dalle parole «va dietro, si nasconde progressivamente dietro» ecc.
Questo è il primo punto[16].
Il secondo va individuato in ciò che succede quando l’automobile spunta fuori dall’altra parte del monumento. Infatti, usando la logica di poco fa, l’automobile dovrebbe progressivamente materializzarsi a sinistra del monumento; perché prima non c’è - a rigore -, e subito dopo c’è per intero: le fasi intermedie saranno dunque quelle che caratterizzano il passare dal non esserci all’esserci. Cosi, non sarà sbagliato, dal punto di vista di Berkeley e Helmholtz, dire che la vettura si materializza.
Pure, descrivendo l’evento, viene da dire che essa «riappare».
Il terzo punto riguarda il momento in cui abbiamo cominciato a osservare la scena, o abbiamo visto arrivare l’automobile da qualche via che dà sulla piazza, o, semplicemente, abbiamo preso atto del fatto che un’automobile stava passando per la piazza, provenendo non importa da dove. Anche qui abbiamo a che fare con qualcosa che adesso c’è, e un attimo fa non c’era. Il caso differisce da quello illustrato sotto il punto secondo, perché là vorremmo dire «ri-appare», riferendoci alle fasi già viste prima, che costituiscono il punto primo; qui invece, ciò che ora c’è, e poco fa non c’era, non trova riscontro in qualcosa d’altro di precedentemente presente nel campo.
Anche qui, a rigore, dovremmo dire solo che qualcosa si è creata, tra le cose che stavamo osservando. Ma il nostro vocabolario, che è dato dal senso comune, contiene espressioni molto diverse per indicare appropriatamente eventi che - secondo i maestri dell’empirismo - andrebbero inclusi in una classe sola: l’oggetto nuovo si è «creato», è «nato», si è «formato», oppure è «spuntato», «apparso», ecc.? Una differenza che già beva colpito Teofrasto, il quale, all’inizio del suo trattato «Sul fuoco» notava con estremo interesse che noi possiamo generare il fuoco, mentre, quando scavando un pozzo troviamo l’acqua, non facciamo altro che renderla visibile.
Cominceremo con la discussione di casi come questi.
§ 5. Apparire e sparire. Nascita e annullamento.
Prima di tutto, che cosa avviene quando qualcosa che prima non c’era appare improvvisamente nel campo visivo di qualcuno?
Facciamo un esempio specifico, e descriviamolo dapprima in termini strettamente fisici: su una parte ben delimitata della retina di un occhio umano improvvisamente ha luogo un certo tipo di stimolazione, provocata, ad es., da un fascio a sezione quadrata di luce bianca. uscente da una sorgente luminosa opportunamente regolata; tutti gli elementi sensibili di quella retina che si trovano compresi entro certi limiti vengono dunque interessati da un processo fotochimico contemporaneamente.
Queste, le condizioni di stimolazione. Per esse faremo due casi: 1) la zona interessata dal processo è molto piccola; 2) è abbastanza estesa.
Mettiamoci ora dalla parte dell’osservatore.
Nel caso 1), egli vede, in un certo luogo del suo campo visivo (che supponiamo omogeneo) formarsi un puntino di luce, che prima non c’era.
Nel caso 2) egli vede - non crearsi all’improvviso un quadrato luminoso, come sarebbe ovvio immaginare - ma sorgere una luce in rapida espansione dal centro alla periferia, che in un attimo raggiunge i lati di un quadrato. Il quadrato non si è costituito all’improvviso, dunque: le sue parti non si sono formate contemporaneamente; c’è stato un vero e proprio processo di formazione. Come quando accendiamo la luce in una stanza buia: l’impressione che è le sue varie parti si illuminino progressivamente, benché molto rapidamente.
Questo movimento apparente di espansione è noto in psicologia col nome di movimento[17]. Galileo credendolo un fenomeno fisico - cioè una proprietà delle condizioni di stimolazione distale anziché una proprietà del mondo fenomenico - annoverò un caso di movimento g (l’esplosione dei fulmini) tra le ragioni a favore della tesi secondo cui la luce si propaga con velocità finita, benché grandissima. Curioso caso di fondamento empirico sbagliato per una teoria corretta.
Una cosa abbastanza grande, dunque, non si può presentare nel nostro campo visivo «di colpo»; il suo apparire, se pure quasi istantaneo, è progressivo.
L. Knops ha classificato numerose esperienze, ottenute con il movimento g, come effetti di «nascita» dell’oggetto percettivo nel campo visivo[18].
La «nascita» può innanzitutto presentarsi come «esplosione»: è il caso del movimento g in situazioni come quella che abbiamo descritto. il caso, anche, di movimenti di espansione ottenuti mediante il rapido allargamento di una figura proiettata su uno schermo; supponiamo che un rettangolo luminoso (5 cm x 6) venga presentato su di uno schermo nel modo seguente :prima la sua parte centrale, che subito viene allargata scostando i suoi margini verticali con una velocità di circa 400 cm/sec. fino a raggiungere la grandezza voluta, così:
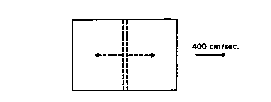
Fig. 97
Usando una velocità di apertura uguale a questa - oppure anche molto minore, fino a 90 cm/sec. circa, ma con rettangoli progressivamente più lunghi, pari restando le altre condizioni - ciò che si vede non è più l’esplosione, ma il dispiegamento. (I vocaboli che qui adoperiamo sono quelli riferiti da Knops, e spontaneamente impiegati dagli osservatori che ebbero il compito di descrivere le varie situazioni). Il dispiegamento è una specie di movimento «a ventaglio» (espressione spesso ricorrente nelle descrizioni) in cui le varie parti della cosa si sviluppano sotto gli occhi dell’osservatore, andando ad occupare un loro posto nella figura, dove poi restano immobili. Se il rettangolo ha una altezza tale da essere veduto come una linea (0.3 cm), queste varie parti si vedono uscire una dall’altra come gli elementi di un telescopio, ciascuno per collocarsi nella sua posizione, dopo essersi sfilato dal precedente.
Oltre a questi modi in cui gli oggetti possono «formarsi» sotto lo sguardo dell’osservatore ve ne sono degli altri, che Knops nel suo saggio descrive con molta finezza. Rimandiamo il lettore a quell’opera. Ricorderemo solo che, quando i movimenti di apertura sono molto lenti, dai 22 cm/sec. in giù, e i rettangoli abbastanza grandi, lunghi cioè 40 cm ed oltre (alti, come abbiamo detto, 5 cm), verso la fine della presentazione, cioè quando l’oggetto è prossimo a raggiungere le sue dimensioni definitive, si può avere nettamente il senso che esso si stia dilatando, come un palloncino che venga gonfiato, o che stia crescendo, cioè che si vadano formando su di esso nuove parti, progressivamente aggiunte al suo corpo.
Per apprezzare appieno il significato di queste scoperte di Knops, bisogna pensare che sono tutte ottenute con una stessa stimolazione: una figura quadrangolare che viene presentata un poco alla volta, a partire dal centro, solo con gradienti temporali diversi. A questa monotonia di eccitazioni retiniche corrisponde una ricchezza straordinaria di strutture fenomenologiche, non sempre facili da descrivere, ma sempre, per chi le stia osservando, configurate con chiarezza.
Esse, nel loro insieme, costituiscono la classe dei casi in cui, all’apparire di un oggetto nel campo visivo, vediamo che tale oggetto nasce : che, cioè, comincia ad esistere nel momento in cui comincia ad essere percepito.
Questi sono i casi in cui Berkeley ha ragione.
Ma Berkeley voleva che sempre fosse così. In realtà, la quantità di casi in cui incominciando a vedere una data cosa ne avvertiamo insieme la preesistenza sono estremamente più numerosi, nel corso delle esperienze di ogni giorno.
La maggior parte degli oggetti dell’esperienza diretta sono fenomenicamente preesistenti all’atto di avvertirli come presenti; e sono preesistenti, nello stesso senso in cui sono grandi o piccoli, colorati, regolari o irregolari ecc. Cioè l’«esser preesistente» è un carattere proprio dell’oggetto in quanto oggetto veduto, non un giudizio che formuliamo, una credenza da parte nostra, una supposizione, spontanea fin che si vuole. Questo essere preesistente non è un attributo dell’oggetto inteso come cosa in sé, o come oggetto fisico. Noi potremmo supporre che non ci siano nell’universo nè cose in sé, né oggetti fisici, e i dati immediati dell’esperienza ci si costituirebbero davanti con tutte le loro caratteristiche di preesistenza. Il mondo degli oggetti osservabili - senza alcun pregiudizio - è realmente presupposto all’atto dell’osservazione.
Citeremo un solo caso di questo tipo, desumendolo sempre dalla stessa ricerca di Knops.
Su uno schermo davanti all’osservatore viene proiettato un quadrato rosso. A un certo momento, accanto al lato verticale destro di questo quadrato compare un filo di luce bianca, lungo un po’ meno del lato, il quale aumenta di spessore progressivamente diventando un sottile rettangolo disposto verticalmente, e ancora progressivamente allargandosi raggiunge le dimensioni di un quadrato, poi quelle di un rettangolo disposto orizzontalmente, sempre più lungo, e così via.
È facile ottenere una presentazione di questo genere. Se avete un proiettore, infilate al posto della diapositiva da proiettare un rettangolo di cartone scuro, nel quale sia intagliata una figura così (a)
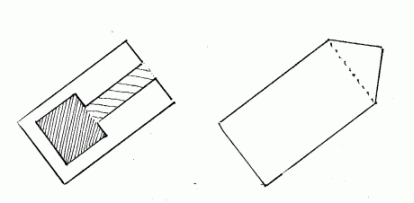
Fig. 98
avendo ricoperto quella parte dell’intaglio che corrisponde al quadrato con un po’ di plastica color rosso, e l’altra parte (il canale) con plastica trasparente. Un altro rettangolo di cartone scuro (b), con la medesima altezza del primo, sarà infilato nella stessa sede destinata alle diapositive, in modo che ricopra il canale su cui è tesa la plastica bianca fino al bordo rosso. Così sullo schermo, si vede il quadrato rosso da solo. Progressivamente, poi, fate scorrere il cartone che nasconde il canale: sullo schermo apparirà un po’ alla volta la fascia bianca.
Ma come? Qui sta il punto.
Voi scoprite la fascia un poco alla volta: la fascia dunque è immobile; è il cartone che spostandosi la scopre.
Ma sullo schermo, quel filo di luce che appare al fianco del quadrato rosso e poi subito si allarga, è nitidamente veduto come un rettangolo che sta sfilandosi dal di sotto del quadrato rosso; esattamente come un cassetto della scrivania, che, quando lo aprite, esce dal mobile: voi ne vedete una porzione sempre maggiore, ma non avete affatto l’impressione che esso stia crescendo. Era già tutt’intiero nel mobile, prima che vi accingeste a tirarlo fuori.
Occorre riflettere bene su questo punto. Accanto al quadrato rosso, c’è solo una zona rettangolare col lato minore per base, la quale sta allargandosi: di questo rettangolino, il lato che è a contatto con il quadrato resta immobile, il lato opposto si sposta progressivamente verso destra, mentre i due lati minori - sopra e sotto - si allungano progressivamente; così si arriva alla forma di un quadrato e poi a quella di un rettangolo disposto orizzontalmente. Adottando il criterio di Berkeley, non c’è altro che possa essere veduto.
Pure, noi vediamo che il rettangolo esce da di sotto il quadrato; vediamo, cioè, che momento per momento quel rettangolo ora visibile non è tutto il rettangolo: c’è ancora una parte che tra un momento verrà fuori, ed io non vedo ancora, ma vedrò tra un attimo; quando sarà uscita. Io, in breve, vedo che non vedo ancora; e questo dura finché il processo di allungamento si arresta.
Sul piano retinico, c’è un’area stimolata che aumenta. Per l’osservatore, c’è qualcosa di parzialmente nascosto che viene man mano fuori, da dietro.
Tornando per un momento alle nostre riflessioni sui margini in situazioni di figura e sfondo, potremo dire che, nel presente caso, il lato del rettangolino progressivamente uscente che è a contatto con il quadrato non è in realtà margine del rettangolino, ma s o 1 o del quadrato (funzione unilaterale dei margini). Quindi non lo limita; quindi esso prosegue al di là; e di conseguenza è presente là dove non è veduto.
Ma il lato opposto si muove, e con esso si muovono - allungandosi - i lati adiacenti: tutta l’area compresa fra questi tre lati si muove solidalmente, e dato che dall’altra parte non c’è limite - perché appunto il margine del quadrato è tale solo per il quadrato, ecco che il materiale del rettangolo viene fuori da li, dove era già presente amodalmente.
«Dato amodale» è appunto il termine che ha coniato Micotte per designare questo genere di realtà percettive. Amodale, perché la sua presenza non è la modificazione attuale di una modalità sensoriale: un colore visto, un suono udito ecc., ma è costituita senz’altro dalla presenza reale di quelle parti degli oggetti circostanti che, per la posizione che hanno rispetto ad altri oggetti e rispetto a noi, non sono direttamente vedute[19].
In questo senso, ogni casa ha anche i muri che dal punto di vista occupato da me ora non si vedono: difatti, non avverto quella casa come uno scenario di cartapesta, vuoto dietro. In questo senso esiste percepibilmente lo spazio che è alle mie spalle e io non vedo, con gli oggetti che lo popolano. A questo punto, l’» esse est percipi» di Berkeley si rivolta contro il suo autore: se appoggio una carta da gioco sulla mia penna stilografica in modo che di qua e di là spuntino le due estremità di essa, la mia penna è tutta intiera, proprio perché la percepisco come tutta intiera. E così la fascia bianca di Knops è dietro al quadrato, perché la percepisco come uscente da lì dietro.
Questa sorta di permanenza d’anteriorità («a parte ante» come dice la Sampaio) può presentarsi nelle più svariate forme.
Prima di lasciare l’argomento, vorrei accennare ad ancora una di esse, che mi pare degna di studio.
La situazione di partenza è questa: ho davanti uno scaffale pieno di libri e ne sto cercando uno, che dev’essere lì; per un po’ non lo vedo, poi, improvvisamente, lo trovo.
Questa situazione può realizzarsi in due modi: può darsi che io abbia passato lo sguardo su quel libro - magari più di una volta - senza averlo riconosciuto. Può accadere così, ma non è il caso che intendo discutere ora. Il caso che ora importa è un altro: a un dato momento vedo il libro cercato, e magari mi dico, «ma come ho fatto a non vederlo prima?». Lo scaffale si suppone di tali dimensioni da rientrare quasi tutto entro il mio campo visivo; o, comunque, è tale da poter essere abbracciato con uno sguardo.
Oppure, altro caso uguale: ho appena guardato attentamente tutti i ripiani dello scaffale, e un amico - alla fine dell’operazione - mi dice: «hai visto il tale libro?»; io subito mi rimetto in esplorazione, e a un dato momento lo vedo, nel suo posto, tra gli altri.
Posso dire che è «comparso» nel momento in cui l’ho «visto»? Certo no. Ma questo (come nel caso del «dietro» e del «davanti») parrebbe condurre ad una contraddizione: come non l’ho «visto» prima se, guardando allo scaffale, «vedevo» bene tutti i libri? Dunque, vedevo anche quello.
Da un punto di vista strettamente logico è cosi. Ma la fenomenologia della percezione ha, come più volte abbiamo visto, una sua logica - che del resto non è irriducibile alla «logica» in senso stretto.
Il libro, in realtà, esisteva percettivamente ed era dunque parte della mia esperienza diretta anche prima che lo «vedessi».
Ricordiamo quanto è stato detto più sopra: il testimone poteva ben dire che sotto il libro c’era il tavolo, perché la domanda che ci dobbiamo porre, nello svolgere una fenomenologia corretta, è questa: «ho forse visto il tavolo che si interrompeva in prossimità dei bordi del libro? «.
Così in questo caso: non vi è niente di contradditorio nel dire che adesso ho visto questo libro, pur avendo visto bene tutti i libri tra i quali si trovava, anche prima. Le domande da porre, infatti, sono:
a) «vedendo» il libro ho visto che in quel momento esso si formava, od ho visto che c’era già?
b) guardando quella zona di libri, prima, avevo visto forse uno spazio vuoto nel luogo dove ora vedo il libro?
c) nel momento in cui l’ho «visto», ho percepito in esso qualche trasformazione, grazie alla quale stava diventando il libro cercato?
Perché appunto dire che il libro si è costituito nel momento in cui lo scoprivo, vorrebbe dire, in concreto: a) che l’ho visto formarsi; b) o dal niente, nello spazio vuoto di prima; c) o grazie alla trasformazione di uno dei libri già veduti.
Al contrario, se posso dire che: a) vedendolo, non l’ho visto comparire; b) né prima avevo notato un vuoto al suo posto; c) non è diventato improvvisamente il libro che cercavo, questo vuol dire che esso era fenomenicamente li, a tutti i titoli, nel mio campo percettivo, e cioè lo vedevo - anche se solo dopo l’ho «visto». Il linguaggio quotidiano molto correttamente dice: «era lì, e non lo vedevo» (essendo la pura presenza visiva diversa dall’atto di vedere, in senso stretto).
§ 6. Una ricerca di A. C. Sampaio.
Tutto questo discorso serve da commento all’inizio di quel breve episodio, in cui si vede l’automobile che passa dietro a un monumento.
All’inizio, dunque, le cose vanno così: che l’automobile sia uscita da una strada laterale, o che mi sia accorto della sua presenza mentre già transitava per la piazza, certo fin dal primo attimo l’ho veduta con il carattere di permanenza «a parte ante».
Ora la macchina si sta avvicinando alla base del monumento, e in breve i suoi contorni toccano i contorni di questa. Qui, secondo il punto di vista di Berkeley ed Helmholtz, dovrebbe aver luogo una delle quattro alternative prospettate più sopra.
L’episodio, da questo momento in avanti, va considerato alla luce della ricerca di A. C. Sampaio e di una ricerca successiva, di L. Burke[20].
Gli oggetti dell’osservazione diretta presentano chiaramente una forte resistenza a «sparire» - cioè a uscire dal campo dell’esperienza in modo che si avverta il loro annullamento.
Prendiamo un semplice punto nel buio. La Sampaio mostrava a degli osservatori un punto luminoso proiettato su uno
schermo in una stanza buia; il punto si muoveva da destra a sinistra con una velocità di 10 cm/sec., e dopo aver percorso sei centimetri di strada veniva improvvisamente spento.
«I risultati che abbiamo ottenuti sono molto curiosi - scrive la Sampaio -: circa il 60% degli osservatori hanno l’impressione che il punto continui il suo movimento dopo la sua sparizione, e che esso «passi dietro a qualcosa». «Il movimento, dunque, non è tagliato di netto, ma continua ad esistere fenomenicamente durante un certo tempo».
Se il punto luminoso, poi, si muove verso un oggetto (ad esempio, un cerchio) e viene spento quando entra in contatto con esso o qualche millimetro prima che tale contatto avvenga, l’impressione di continuità del movimento è ancora più grande; cioè, non più il 60% degli osservatori, ma tutti, vedono distintamente il moto del punto sparito dietro all’oggetto in questione.
Quanto maggiore è la velocità del punto durante la sua traiettoria visibile tanto più lontano, dietro all’oggetto, esso si spinge.
Se il punto in moto viene fatto spegnere qualche centimetro prima che raggiunga l’orlo dell’oggetto verso il quale è diretto si ha l’impressione che il punto sparisce, mentre il suo movimento continua.
La cosa non deve sembrare strana; nel mondo delle esperienze immediate il movimento è cosa distinta dal mobile. Benché non possiamo pensare, nel mondo degli oggetti trausfenomenici, un movimento senza qualcosa che si muova, possiamo benissimo osservare - in qesto mondo, dove le nostre esperienze hanno luogo - il movimento dello stato puro, senza alcun portatore.
L’osservazione più interessante in questo senso è dovuta a Wertheimer: nel famoso saggio del 1912, che è generalmente considerato come l’atto di nascita della teoria della gestalt, egli descrisse alcune situazioni particolari, realizzabili con la stessa tecnica che permette di mostrare il movimento stroboscopico, solo utilizzando tempi leggermente maggiori o minori di quelli che delimitano le condizioni temporali ottimali (vedi pag. 189); tempi oltre i quali, cioè, si ha o la successione discreta. delle accensioni dei due oggetti, o, rispettivamente, la loro contemporaneità[21].
In una di queste situazioni Wertheimer presentava come primo oggetto una sbarretta orizzontale, e come secondo oggetto una identica sbarretta disposta verticalmente, nelle posizioni illustrate dalla figura qui accanto[22].
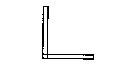
Fig. 99
L’evento veniva descritto così: «È una rotazione, molto chiara, uniforme, facilmente descrivibile in termini fisici; si vede la sbarretta orizzontale muoversi leggermente verso l’alto; la si vede muoversi - alla fine - anche in prossimità della posizione verticale: l’intiero evento costituisce una unità. Si vede chiaramente che il moto non è interrotto, che è una rotazione completa dalla posizione a alla posizione b. Però occorre notare che non vi è traccia della sbarretta o del suo colore verso la metà della rotazione».
Oppure, con la sbarretta all’inizio in posizione verticale, e alla fine in posizione orizzontale: «Si tratta senza dubbio di un movimento, chiaro, ben definito ed evidente: una rotazione di circa 90 . Non può essere descritta come una successione. La sbarretta verticale però non si muove: si vede piuttosto un mutamento, come un «andare attraverso». Si vede la sbarretta orizzontale «coricarsi giù»... Benché nulla si veda ruotare (cioè, l’oggetto non ruota) è chiaro che avviene un movimento e che la fine di tale movimento consiste nel coricarsi giù della sbarretta orizzontale»[23].
E altri osservatori, in situazioni analoghe: «Ho visto un movimento rotatorio di 90 , chiaro ed evidente. Il «passare attraverso» da una posizione all’altra si vedeva chiaramente: nulla però era visibile tra le due posizioni: il fondo restava nero e in quiete «. «Non si può dire che oggetto ci fosse: ho visto un forte movimento «.
Descrizioni che Wertheimer riassume con le seguenti parole: «Io vedo un movimento, qui; non qualcosa che passa»[24].
Il movimento studiato dalla Sanpaio nelle condizioni descritte più sopra può essere avvicinato ai casi studiati da Wertheimer, e che e gli ha raccolto sotto la denominazione di «movimento f-puro».
In altri esperimenti della Sampaio, però, interviene una sottile differenza : come il movimento continua, non veduto, dietro, così l’oggetto continua ad esistere, dietro. La fase amodale, in questo caso, è costituita proprio da un mobile portatore di movimento.
Questo avviene quando trattiamo con oggetti estesi: la Sampaio prendeva due oggetti rettangolari A e B, di dimensioni simili (25.5 mm), uno rosso, l’altro nero. «A si muove verso B e nel momento in cui lo tocca la sua estremità anteriore, in contatto con B, s’immobilizza, mentre la sua estremità posteriore continua a muoversi con la stessa velocità e nella stessa direzione di prima. Alla fine, A accanto a B diminuisce sempre più fino a sparire completamente».
Ma il cento per cento degli osservatori vedono che A scivola dietro a B, mantenendo intatte tutte le sue proprietà cromatiche e figurali. Il fatto è visto con tale evidenza che «uno dei soggetti ha voluto esaminare l’apparecchio da vicino credendo - disse - che ci fossimo serviti di qualche «trucco» meccanico per produrlo».
Questo caso è identico a quello raccontato prima, riferendo le esperienze di Knops; solo procede in senso inverso. Anche qui, nel momento in cui A tocca B e immobilizza il lato a contatto con esso, il margine che fino a poco prima era di A diventa di colpo appartenente a B, e a B soltanto. A, dunque, non ha più il suo margine; dunque può «continuare dietro», e dato che gli altri tre lati si comportano esattamente come prima, proseguendo il loro spostamento, A va effettivamente dietro.
Ma questo esperimento dà esattamente i medesimi risultati se si sopprime la figura B, cioè il quadrato dietro al quale A può collocarsi.
Stando al buon senso, questo non dovrebbe accadere. Una figura sola collocata su uno sfondo omogeneo, dove può andare «dietro» a qualcosa? È come tentare di nascondersi nel deserto.
Pure, le leggi di organizzazione del campo funzionano così bene che una soluzione c’è.
Proiettiamo sul solito schermo un quadrato: facciamolo muovere da sinistra verso destra per un po’, poi arrestiamo bruscamente il suo lato di destra, in modo che - degli altri tre - i due orizzontali si scorcino con velocità uguale a quella dell’avanzamento, mentre il terzo prosegue il suo moto come prima. Avremo in questo modo un quadrato che - proiettivamente - diventa un rettangolo verticale sempre più sottile, fino a sparire.
Si vede qui quello che si vedeva nella situazione precedente: un quadrato avanza, e a un tratto, sempre avanzando, si infila in una specie di tasca, o di fessura invisibile che è sullo sfondo, e progressivamente sparisce in essa. Finché il quadrato procede tutti e quattro i suoi lati sono margini suoi, e solo suoi: passando, esso man mano scopre sempre nuove parti di sfondo, ricoprendone altre; lo sfondo è infatti continuo ed omogeneo. Nel momento in cui si arresta il suo lato di destra, questo lato istantaneamente cambia di funzione: diventa margine dello sfondo, non più del quadrato; pertanto il quadrato non trova più in esso un confine e prosegue oltre, dietro lo sfondo. E fino alla sua sparizione il quadrato è come un giornale infilato in tasca: tre lati visibili sono del giornale, il quarto è l’orlo della tasca.
La Sampaio ha trovato che in molte condizioni un accorciamento degli oggetti veduti appare come un progressivo nascondersi dietro a qualcosa. Poche volte quello che sulla retina è un rimpicciolimento è anche percettivamente una perdita di grandezza. Vale la pena di citare il caso di due tipi di oggetti i quali, per un solo particolare che li differenzia, si comportano a questo proposito in senso opposto. Prendiamo due figure fatte così:
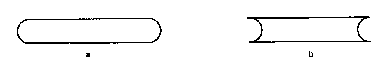
Fig.100
scorciandole progressivamente, cioè riducendo la loro lunghezza mediante l’avvicinamento contemporaneo delle due parti estreme, nel primo caso (a) abbiamo una riduzione delle dimensioni, e nel secondo (b) un intascamento delle estremità sotto lo sfondo, in questo modo:
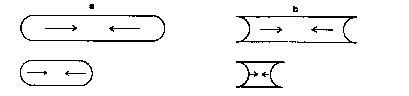
Fig.101
Consultando l’opera fondamentale di Rubin sull’articolazione in figura e sfondo [25] troveremo anche il perché di questo fatto: se una superficie omogenea viene divisa in due con un arco di cerchio o con una linea simile, una delle due parti sarà concava e l’altra convessa; orbene, è assai più facile vedere come figura la. parte convessa. È il caso, appunto, dell’esperimento della Sampaio: in tutte e due le situazioni il tratto di margine curvo contiene la figura nella sua concavità - e dall’altra parte, dunque, deve esserci lo sfondo.
Dopo che l’automobile del nostro esempio è entrata (proiettivamente) in contatto con la base del monumento ci sono, come ben si vede, tutte le ragioni perché prosegua intatta dietro ad esso, senza annullarsi nè perdere le sue caratteristiche cinetiche.
Ma potremmo aspettarci che, subito dopo essere sparita del tutto lì dietro, essa non faccia più parte del nostro campo dell’esperienza diretta.
Dietro ad ogni albero che vedo posso pensare che ci sia uno gnomo, ma non per questo avverto il mio mondo come popolato di gnomi; sotto il panno su cui poggia questa mia macchina da scrivere posso supporre che ci siano diversi bighetti da diecimila lire: ma certo non sono in grado di scambiare questa gradevole supposizione con la percezione di questi biglietti, qui sotto.
Così, adesso che la macchina è intieramente nascosta dalla base del monumento, potrei sostenere che io «penso», o «credo», o «immagino» che essa sia là, ma non che ne avverto la presenza.
Per decidere se veramente è così, occorre proseguire con gli esperimenti.
Il lettore ricorderà la situazione di Knops in cui il rettangolo bianco fuoriesce progressivamente dal quadrato rosso. Essa è esattamente il rovescio di quella della Sampaio in cui il quadrato bianco entra nel quadrato rosso.
Ora, praticando poche inessenziali modifiche, possiamo riunire queste due situazioni insieme, e costruire un evento fatto così: al centro del campo osservato vi è un quadrato rosso; da destra arriva un quadratino bianco che ha il lato lungo, diciamo, un terzo del lato dell’altro; esso entra in contatto col quadrato più grande, progressivamente sparisce dietro ad esso, e dopo un poco fuoriesce dall’altra parte; è proprio lui che fuoriesce, perché - uscendo - possiede un’esistenza fenomenica «a parte ante», mentre quando era entrato possedeva un’esistenza fenomenica «a parte post». Se l’intervallo temporale compreso tra l’entrata e l’uscita appartiene a un certo ordine di grandezza, dunque, non vi è soluzione di continuità nell’esistenza del quadratino bianco, mentre passa dietro a quello rosso.
Questa situazione complessa riveste un interesse notevolissimo, sia per la teoria che per le possibilità di sperimentazione. Come è facile vedere, passo per passo, siamo arrivati alla situazione tipica che aveva attratto l’attenzione degli empiristi inglesi: tanto Locke che Hume, infatti, avevano visto che il problema dell’identità si pone in termini drammatici quando vi è una interruzione spazio-temporale nello svolgersi di un evento. L’evento si spezza, e sono due eventi; in forza di che cosa possono venire ricomposti?
Essi avevano dato per scontato che l’interruzione non puo essere altro che interruzione a tutti gli effetti, e sotto tutti i punti di vista: un po’ più di empirismo, forse, li avrebbe condotti a scoprire che l’interruzione può avere una fenomenologia abbastanza varia e complessa. In un evento si può interrompere qualcosa senza interrompere altro: nel caso di cui ora ci occuperemo, ad es., noi interrompiamo la visibilità dell’oggetto, senza interrompere nè la sua esistenza né il suo moto.
Ma è abbastanza facile capire la logica del loro punto di vista; se, per intendere meglio l’evento complessivamente descritto con l’espressione «x passa dietro a y «, lo analizziamo suddividendolo in parti, non troveremo più nulla su cui fondare la continuità di esso. Infatti «x passa dietro a y» è fatto di tre pezzi: 1) un pezzo in cui si vedono «due» cose, e in cui c’è del movimento; 2) un pezzo in cui si vede «una» cosa, e in cui non vi è traccia di movimento; 3) un pezzo in cui ancora si vedono «due» cose, e in cm c è movimento. Dal punto di vista del numero degli oggetti discernibili le tre fasi sono diverse (due -uno - due); dal punto di vista delle proprietà cinetiche, pure (moto - quiete - moto). Una organizzazione unitaria appare impossibile. Dunque, concludevano gli empiristi, tutt’al più «giudichiamo» che vi è identità, senza alcuna buona base logica, e a dispetto di quello che i fatti permetterebbero di dire.
Ciò che abbiamo imparato seguendo i vari esperimenti fin qui riportati è che l’errore della tesi empirista sta nel fatto di non essere fondata su una analisi abbastanza dettagliata delle tre fasi ora dette. È in questioni come queste che si vede l’importanza dell’analisi fenomenologica: andando a vedere il mondo da vicino si finisce con lo scoprire i motivi per cui una tesi - svolta sul piano puramente teorico - può apparire paradossale, o contrastante coll’evidenza dei fatti quotidianamente esperiti. Tagliare la situazione dell’effetto tunnel in tre pezzi è possibile solo concettualmente; possiamo «astrarre» tre fasi, per comodità di discussione. In realtà, andando a vedere con i propri occhi ciò che succede nei momenti in cui vorremmo operare il taglio, scopriamo che essi sono caratterizzati da processi continui, i quali non consentono tagli di sorta, se non astratti, appunto. (Astratti significa questo: che trascurano volutamente qualche particolare importante).
§ 7. L’effetto «tunnel».
Luke Burke ha studiato, nel 1952, l’«effetto tunnel «, non tanto per la fenomenologia delle sue varie fasi (ciò era stato fatto, come abbiamo visto, dalla Sampaio e da Knops), ma per determinare le condizioni del fenomeno nel suo complesso. Proprio lavorando in questo modo possiamo scoprire le condizioni della continuità dell’oggetto nell’atto di passare dietro, e vedere in che modo la permanenza «a parte post» si integri con la permanenza «a parte ante».
L’attrezzatura utilizzata da Burke è molto semplice. Vi è uno schermo con una fenditura orizzontale, larga 5 mm e di lunghezza variabile. Dietro a questo schermo ruotano coassialmente due dischi, uno di 50 cm di diametro, e un altro che gli è appoggiato davanti, di 19 cm di diametro.
Supponete di avere davanti a voi questi due dischi, appoggiati l’uno sull’altro in posizione perfettamente concentrica. Se tracciate su di essi - passando dall’uno all’altro - una spirale opportunamente calcolata, partendo ad es. dal centro di quello più piccolo e finendo alla periferia di quello più grande, e poi ruotate di qualche grado quello tenendo fermo questo, potrete ottenere sia che la spirale del disco più piccolo anticipi, sia che posticipi, sia che collimi con il segmento di spirale tracciato sul disco più grande.
La coppia di dischi così confezionata è, dunque, dietro allo schermo, in posizione tale che la fenditura intagliata in esso permette di vedere - dei due dischi - una striscia disposta radialmente. Quando i dischi ruotano, oltre la fenditura si vede un oggetto più o meno quadrangolare che va verso destra o verso sinistra a seconda del verso della rotazione: questo oggetto è la porzione di spirale che la fenditura in quel momento lascia scoperta.
Quando i due dischi sono disposti tra loro in modo che i due segmenti di spirale si continuino, oltre la fenditura vediamo passare un oggetto solo; se sono disposti in fase anticipata, prima vediamo un oggetto, poi due insieme, poi solo il secondo (tutti e due in movimento); se la fase è posticipata, vediamo un oggetto in moto, poi per un momento nulla, poi un oggetto simile anch’esso in moto.
Il lettore potrà immaginare facilmente l’intera situazione guardando questo schema:
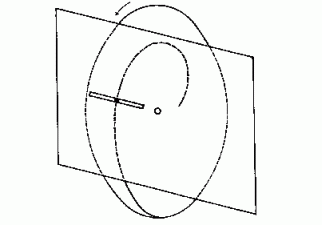
Fig. 102
Per realizzare l’esperimento, basta mettere sulla fenditura, a metà strada, un rettangolino opaco che la divida in due parti uguali: esso fa da «tunnel».
Nel caso di Burke l’oggettino in moto aveva le dimensioni di 10 per 5 mm. Appariva a sinistra, si muoveva verso destra e proseguiva la sua corsa fino al punto voluto, generalmente oltre la fine della fenditura.
Questo, press’a poco, è quanto l’osservatore poteva vedere:
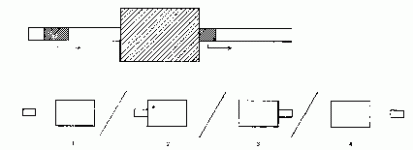
Fig.103
Lo sperimentatore poteva comandare tre aspetti della situazione:
a) modificare la lunghezza del tunnel - applicando al posto voluto un rettangolo più piccolo o più grande -;
b) modificare l’intervallo temporale tra l’entrata e l’uscita (intervallo EU) dell’oggetto in moto, sfasando opportunamente i due dischi;
c) modificare la velocità dell’oggetto in moto, regolando opportunamente la velocità di rotazione dell’asse al quale i due dischi erano fissati.
Burke ha lavorato generalmente così; ma in alcuni casi ha fatto ricorso alle proiezioni sullo schermo, mediante epidiascopi.
Per qualunque osservatore, senza eccezioni, il movimento dell’oggetto è perfettamente continuo e «reale» dietro allo schermo quando ha luogo con una velocità di 600 mm/sec., essendo il tunnel lungo 40 mm, e l’intervallo EU di circa 15 millisecondi.
«Se questo movimento viene confrontato con un caso di moto continuo ed uniforme senza tunnel, non vi è differenza tra le due impressioni, dal punto di vista cinematico. Inoltre, tutti gli osservatori sono d’accordo sul fatto che il movimento oltre il tunnel è tanto reale quanto è reale il movimento nelle due fasi visibili»[26].
Ma la cosa più interessante si scopre modificando queste condizioni.
Se lo sperimentatore, lasciando intatte le altre condizioni, accorcia il tunnel, o allunga l’intervallo EU, o aumenta la velocità del mobile nelle fasi visibili, la continuità ne risulta pregiudicata. Infatti, la continuità del moto non è una proprietà che o c’è o non c’è, come vorrebbe la sua definizione formale: ma «vi sono vari gradi di continuità, non solo nel senso che può nascere una tendenza alla discontinuità, ma anche per quanto riguarda la pregnanza e la purezza dell’impressione in quanto tale «.
È naturalmente possibile variare le condizioni non solo una alla volta, ma insieme. Facendo questo secondo un piano sperimentale esauriente, che il lettore certo è in grado di ricostruire da sé, emergono le seguenti relazioni.
Per avere le condizioni ottimali di continuità nella percezione amodale del movimento occorre:
1) se si allunga il tunnel, o allungare l’intervallo EU, o aumentare la velocità delle fasi visibili;
2) se si aumenta la velocità delle fasi visibili, o allungare il tunnel o diminuire l’intervallo EU;
3) se si aumenta l’intervallo EU, o allungare il tunnel o rallentare il moto delle fasi visibili.
Fuori di queste condizioni, abbiamo la discontinuità.
Come la continuità può presentare vari aspetti, così la discontinuità può assumere tutta una varietà di forme, mano a mano che ci si allontana dalle condizioni ottimali.
Aumentando l’intervallo EU di poco oltre i valori ottimali, il mobile, passando dietro allo schermo, ha un lieve sussulto, come se incontrasse un ostacolo. Molti osservatori hanno anche indicato, sul tunnel, il punto dietro il quale tale salto avviene. Aumentando ancora questo intervallo, il moto dietro il tunnel si realizza come in due fasi, «due movimenti - ha riferito un osservatore - senza intervallo di spazio o di tempo»: viene intaccata l’unità del processo, sia pure di poco. Oltre ancora, vi è la vera discontinuità: l’oggetto entra, si arresta, riparte. Questo pregiudica anche l’identità dell’oggetto, che al limite - può essere non più lo stesso quando esce.
Modificando la lunghezza del tunnel si ottengono press’a poco gli stessi effetti; in più, per tunnels molto lunghi (Burke ha impiegato tunnels lunghi fino a 70 cm), la continuità non viene neppure menzionata, né appare traccia di movimento entro il tunnel.
Quando la velocità degli oggetti nelle fasi visibili è tenuta molto bassa (62 mm/sec.), modificando l’intervallo EU o la lunghezza del tunnel, i risultati delle osservazioni parlano piuttosto della «tempestività» dell’uscita del mobile che degli aspetti di continuità ed uniformità del movimento: cioè gli osservatori dicono che l’oggetto è uscito «troppo presto» o «troppo tardi», oppure «al momento giusto», a seconda che le velocità dei mobili siano state maggiori, minori o uguali a quella ottimale per quelle condizioni.
È un’impressione che possiamo avere in svariate circostanze: quando una persona che cammina e noi stiamo osservando scompare dietro ad un edificio, ad es., e ci mettiamo ad attendere che esca dall’altra parte. Di solito, ci sembra che tardi molto, come se dietro si fosse fermata, o avesse preso un’altra strada per noi invisibile. In realtà, come Burke (e la Sampaio in un lavoro inedito) prova, tutto dipende dal fatto che nella relazione ottimale l’intervallo EU aumenta più lentamente dell’intervallo spaziale (tunnel)[27].
Utilizzando la medesima tecnica, possiamo andare a vedere che cosa succede quando il percorso di entrata e quello di uscita non sono allineati, come avveniva nei casi ora esposti.
Burke ha lavorato con due situazioni diverse, assai più facili da disegnare che da descrivere; eccole:
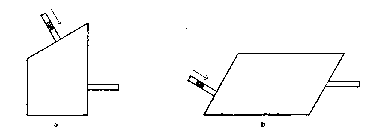
Fig.104
Presentando questi due casi, egli variava l’intervallo EU. Fin tanto che tale intervallo è vicino all’ottimalità, il percorso amodale dell’oggetto segue le leggi della buona curvatura (cfr. Cap. II), raccordando il punto di ingresso e quello di uscita non per la via più breve, che sarebbe un segmento di retta, ma in modo da non dover fare brusche svolte. Con l’aumentare di EU possiamo avere anche percorsi angolosi, dove l’angolo rappresenta quello che nella situazione descritta prima è il «sobbalzo» (serve a guadagnare un po’ di tempo). Alla fine, esagerando la distanza temporale tra E ed U, abbiamo la discontinuità.
A Burke dobbiamo, inoltre, qualche nuova osservazione che riguarda estremamente da vicino il problema dell’identità, nella forma in cui lo ha posto Cartesio con l’esempio della cera: che cosa dobbiamo cambiare delle proprietà visibili di un oggetto, affinché si possa dire «non è più quello?».
Nel caso del tunnel è facile compiere delle prove per tentar di dare qualche risposta: basta mandare dentro un oggetto fatto di un certo modo e fare che ne esca uno con caratteri differenti.
Ecco le esperienze di Burke a questo proposito:
a) l’oggetto A (quello che entra nel tunnel) è identico all’oggetto B (quello che esce) e sono cerchi luminosi di 4.25 cm di diametro;
b) gli oggetti A e B sono gli stessi di prima in tutto, tranne clic per il colore: A è bianco, B e color rosa;
e) A e B hanno stessa forma e stesso colore, ma dimensioni diverse: A ha il diametro di 4.25 cm e B di 5.60 cm;
d) A è il solito dischetto, B un quadrato bianco avente il lato pari al diametro di A.
Il tunnel era lungo 12 cm, lo spazio percorso visibilmente dai due oggetti di 10 cm per parte, la velocità degli oggetti nelle fasi visibili di 360 mm/sec.; quello che variava, era l’intervallo EU.
Ognuna delle quattro situazioni ora citate, infatti, veniva presentata agli osservatori una ventina di volte: ogni volta differiva dalle altre per l’intervallo EU, che poteva arrivare fino a circa 800 millisecondi, e al di sotto di questo valore variava regressivamente di 30-40 millisecondi ad ogni tappa, fino a raggiungere valori negativi (in cui, cioè, l’uscita dell’oggetto avviene prima della sua entrata). Queste presentazioni erano disposte in ordine casuale; volta per volta, l’osservatore doveva decidere di una cosa sola: se il movimento era apparso continuo oppure no. I risultati venivano debitamente registrati.
Alla fine delle presentazioni, gli osservatori dovevano dire se, secondo loro «i cambiamenti intervenuti nell’oggetto provocavano qualche differenza nell’impressione di continuità».
Occorre notare che gli osservatori utilizzati erano persone esercitate nell’analisi fenomenologica, quindi non - come malignamente si potrebbe dire - tiranneggiate da pregiudizi teoretici, ma anzi pronte a cogliere le minime differenze e sfumature intercorrenti tra una situazione e l’altra..
Per quanto riguarda il bilancio della prima prova, i risultati mostrano senza ombra di dubbio che i mutamenti qualitativi non pregiudicano neanche di poco l’autoidentità dell’oggetto; almeno, supponendo che un cedimento dell’autoidentità possa modificare le condizioni ottimali dell’effetto tunnel. Questa supposizione non è affatto irragionevole: se in condizioni normalmente ottimali uno di questi esperimenti non avesse funzionato, si poteva ben dire che l’insuccesso era dovuto all’impossibilità di identificare un oggetto con l’altro, essendo questa l’unica variabile toccata. Tutti gli osservatori, per tutte le diverse situazioni, hanno dato i medesimi risultati (in termini di intervallo EU), sia nello stabilire la continuità al 100% che la discontinuità al 100%.
In più, ci sono i commenti alle situazioni stesse. Un primo osservatore trova che i cambiamenti intercorrenti tra l’oggetto in entrata e quello in uscita non incidono sull’impressione di movimento. Tuttavia, se gli oggetti sono assai diversi, si può avere una impressione di identità interrotta; per cambiamenti piccoli (forma o colore) è netta l’impressione di autoidentità: pare che l’oggetto, passando nel tunnel, cambi progressivamente un suo aspetto. Un altro osservatore, ripetendo più volte l’esperimento, trova che le differenze incidono sull’autoidentità; ma poi, proseguendo nell’osservazione le differenze diventano poco importanti; ciò che appare chiaro è che il cambiamento avviene durante il passaggio nel tunnel. Un terzo osservatore sostiene che i cambiamenti di colore sono quelli capaci di disturbare maggiormente l’impressione di continuità in questo modo l’auto-identità dell’oggetto va perduta: si tratta di due oggetti, ma animati dallo stesso movimento. Un altro osservatore è d’accordo con lui (ma, osserva Burke, i risultati quantitativi non mostrano per nessuno di essi qualche differenza degna di nota). L’ultimo osservatore dice che la continuità del movimento implica sempre la continuità dell’identità, e non importa quali cambiamenti qualitativi siano intervenuti. Quando l’oggetto uscente ha colore diverso da quello entrato, non è tanto che il colore sia diventato un altro, ma piuttosto è che, uscendo, lo stesso oggetto è venuto a trovarsi in una luce diversa. In tutti i casi, più facilmente intacca l’identità il cambiamento di forma che quello di colore.
§ 8. L’identità come fatto e l’identità come giudizio.
Con questi ultimi esperimenti, siamo arrivati alla fine della nostra rassegna di ricerche concernenti l’identità come dato dell’esperienza diretta. Evidentemente i problemi aperti sono ancora molti, e riguardano soprattutto le situazioni in cui la resezione spazio-temporale, il «tunnel», anziché durare secondi o frazioni di secondo - come nei casi finora considerati -duri minuti, ore, o periodi di tempo assai più lunghi. Che sono, poi, i casi più frequenti tra le esperienze di ogni giorno: le chiavi che mi trovo qui in tasca sono quelle che vi ho messe un’ora fa? il tale che adesso è passato è quel mio vecchio compagno di scuola? i libri negli scaffali che ogni mattina ritrovo entrando nello studio, sono oggi quelli che ho lasciati ieri sera?
Domande come queste possono esprimere dei veri e propri dubbi, come la seconda. Possono esprimere dei dubbi puramente e sottilmente teoretici, come l’ultima; certo è una domanda inutile, e priva - al fondo - di un dubbio autentico: ma serve a mettere alla prova la resistenza del concetto di identità, così come è comunemente accettato. «E se invece, ecc., ecc.?». Posso perfino chiedermi se io stesso sono quello di ieri o di dieci minuti fa (domanda che in effetti aprirebbe un ampio discorso pieno di sorprese; il quale però, verrebbe svolto mediante una sintassi logica che dà tale autoidentità per scontata: provate).
Rimando il lettore, che volesse affrontare per suo conto alcuni di questi problemi aperti, all’ultima parte del saggio di Guido Petter già citato, dove troverà materiale per la riflessione ed idee quasi pronte per essere portate sul banco di prova dell’esperimento.
Qui, per chiudere, vorrei invece sottolineare due punti che mi sembrano essenziali:
1) come dagli esperimenti finora descritti emerga che non è il nostro giudizio a determinare il carattere di identità nelle cose, ma - caso mai - è quella proprietà delle cose, detta appunto «identità», a provocare il nostro giudizio;
2) come le situazioni presentate nel corso degli esperimenti non diano luogo a giudizi di identità perché assomigliano a situazioni della vita d’ogni giorno nelle quali siamo portati a pronunciarli; ma, al contrario, le situazioni occorrenti nell’esperienza quotidiana diano luogo a tali giudizi, in quanto possiedono la stessa struttura di quelle descritte riferendo gli esperimenti.
Si tratta di due questioni distinte, benché interdipendenti.
1) Non è il giudizio a produrre il carattere di identità nelle cose. Dire che negli episodi frazionabili in fasi di presenza e fasi di assenza di un determinato oggetto può nascere un’impressione di identità in quanto siamo convinti che si tratta «realmente» di uno stesso oggetto che appare e scompare, e tale nostro giudizio agisce sull’atteggiamento nostro nei confronti dell’evento osservato, equivale si badi bene - a sostenere che, se noi avessimo la convinzione contraria, non dovrebbe aver luogo tale impressione di identità.
Implicitamente vuol dire anche che, variando la convinzione dell’osservatore nei confronti dell’evento osservato, deve variare il tipo di impressione provata.
Ora, ciò non avviene per nessuno degli esperimenti riferiti da noi.
Nel caso degli esperimenti di von Schiller e di Ternus, vi sono alcune situazioni che possono venire influenzate dall’impostazione dell’osservatore; il che potrebbe voler dire che se l’osservatore nutre qualche convinzione aprioristica sull’andamento del fenomeno o si aspetta un fatto e non un altro, il suo giudizio crea un’identità che altrimenti, forse, non avrebbe avuto luogo; ma tali situazioni sono esclusivamente quelle in cui i fattori obbiettivi (inerenti, cioè, la costituzione degli oggetti) si trovano alla pari, o perché le alternative possibili sono fenomenicamente identiche, o perché ciascuna di esse è favorita da fattori antagonisti ed isostenici (forma contro colore, ad es.).
Questo fatto dimostra che l’ambito di decisione riservato al «giudizio» è quello in cui non gioca alcun fattore diverso dal giudizio stesso; e fuori di quest’ambito decide la struttura della situazione.
Negli esperimenti della scuola di Lovanio, quando le presentazioni siano effettuate in condizioni ottimali, tanto il soggetto «ingenuo» che l’osservatore al corrente della tecnica usata per realizzate l’evento osservato non rilasciano descrizioni diverse; del resto, quando la tecnica impiegata è quella delle proiezioni su uno schermo (Sampaio, Knops, ed anche Burke, a volte), nessun osservatore che rifletta un po’ può nutrire convinzioni circa l’identità «reale» degli oggetti veduti: i quali, in quanto sono ombre o luci proiettate, esistono e cessano di esistere esattamente nei limiti in cui sono visibilmente discernibili sullo schermo, ed hanno esclusivamente le dimensioni misurabili lì.
Quando la tecnica è diversa, è ugualmente possibile controllare se le credenze determinano un giudizio capace di influenzare la struttura. Prendiamo il caso dell’effetto «tunnel». La presentazione ottimale può essere realizzata servendosi di due oggetti, uno che entra, l’altro che esce a tempo debito da dietro lo schermo. Un osservatore che non conosce la tecnica della presentazione è invitato a guardare lo svolgimento dell’episodio, poi a sincerarsi del modo impiegato nell’eseguirlo, e quindi a guardarlo di nuovo per giudicare se l’impressione è ora diversa. Lasciamo al lettore il piacere di provare, e di togliersi da solo i dubbi.
2) Episodi sperimentali ed episodi della vita quotidiana. Quando si è agli inizi in questo genere di studi (il che può accadere anche dopo anni che uno se ne occupa) sembra di poter spiegare agevolmente il fatto che situazioni come quelle impiegate nelle ricerche sopra riferite diano luogo a giudizi di identità per il fatto che ricordano eventi della vita di ogni giorno in cui effettivamente emettiamo giudizi di identità - basati, però, su conoscenze in precedenza acquisite, o su prove indirette, ripetibili ed attendibili. L’effetto tunnel «assomiglia» al fatto che le automobili passano a volte dietro ai monumenti, al fatto che i treni attraversano gallerie, al fatto che la lepre, correndo nel bosco, appare e scompare tra i tronchi degli alberi. Dato che non ho ragioni per credere che automobili, treni e lepri possiedano la proprietà di cessar d’esistere a un tratto per riprendere la propria esistenza un po’ più in là - e, per giunta, tenendo conto della mia posizione di osservatore con una ben definita prospettiva sull’ambiente - sono ben convinto che esistono anche nei momenti in cui non mi sono visibili; così trasferisco questa covinzione su episodi anche assai semplificati, che però hanno il potere di ricordarmi casi del genere.
Questa interpretazione contiene un errore teorico importante; esso dipende dal fatto di non aver tratto tutte le conseguenze implicite nel concetto di «variabile», quando esso è applicato al campo percettivo.
Quando una ricerca è finita, si dice: il tale fenomeno dipende da questa, quest’altra e quest’ultima variabile (legate tra loro da questi e questi rapporti).
Prima di cominciare la ricerca probabilmente avevamo detfo: l’ipotesi è che il tale fenomeno dipenda da... e qui viene riferito l’elenco di quelle che riteniamo variabili possibili.
Nel corso della ricerca, provando a verificare i vari aspetti della nostra ipotesi, abbiamo trovato che certe voci del nostro elenco corrispondono effettivamente ad aspetti della situazione studiata, agendo sui quali il fenomeno presenta modificazioni sensibili o cessa d’aver luogo: e sono, cioè, variabili.
Ma, molto facilmente, avremo anche trovato che altre voci dello stesso elenco indicano aspetti della situazione studiata i quali per quanto siano stati da noi modificati, non hanno determinato alcun apprezzabile cambiamento nel fenomeno che stavamo studiando.
Queste non sono variabili. Supponevamo che lo fossero, ma a torto.
Per esempio, il seguente poligono irregolare appare come due figure una accanto all’altra, due esagoni:

Fig. 105
Ciò dipende dalla sua forma; non dipende dal suo colore, e non dipende dalla sua collocazione nello spazio rispetto all’osservatore (avremmo potuto supporre, un po’ ciecamente, che potesse dipendere anche da questo).
Non dipende da come la superficie interna è colorata nè dalla posizione spaziale nello stesso identico senso in cui potremmo dire che non dipende dal fatto di esser guardato ascoltando musica o in silenzio, o dal trovarsi stampato su un libro con la copertina blu o rossa, o dal fatto che oggi è giovedi, ecc. Certo è poco probabile che possa dipendere da cose come queste, mentre poteva, essere che dipendesse da quelle; ma dal momento che non dipende, non dipende nello stesso identico senso.
Generalmente si dà un gran peso all’esistenza di connessioni funzionali tra fatti, trascurando quel tipo particolare di relazione che è l’assenza di connessioni; eppure, nell’edificazione della teoria, questo aspetto dei problemi ha un’importanza decisiva.
Ora, torniamo al caso nostro.
Vedo un pullman che passa dietro ad una casa, uscendo subito dall’altra parte. Faccio l’ipotesi che l’impressione del «passare dietro» dipenda dal fatto che so - grazie al buon senso e a molte esperienze da me avute - che un pullman non si annienta per il solo fatto di non essere visto. Cosa vuol dire questo, in termini che ammettano una interpretazione operativa? che il fatto di vederlo «passare dietro» è legato al fatto che io, in quella sagoma colorata, riconosco un pullman.
Conseguenza: se tale tesi è vera, e se trasformo la situazione in modo da non riconoscere in quella sagoma un pullman, dovrebbe cessare l’impressione chiamata «passare dietro». Altrimenti, vuol dire che questa impressione non dipende da quel riconoscimento.
Posso dunque spogliare il pullman da tutti quei particolari (ruote, finestrini, ecc.) che me lo fanno riconoscere per tale, fino a ottenere un rettangolo blu. Ciò può essere eseguito in laboratorio, introducendo nell’oggetto progressivamente sempre nuove modificazioni. Ma l’impressione di «passare dietro» resta ancora. Dunque non dipende da, ecc. ecc.
Ma forse è perché riconosco nell’altro oggetto una casa. Un rettangolo blu può ben passare dietro ad una casa. Quindi procederò nello stesso modo nei confronti di essa, togliendo finestre, porte, tetto, fino ad avere un rettangolo bianco contro un certo sfondo. E il «passare dietro» resta.
Se temo che lo sfondo possa suggerirmi qualche riferimento a passate esperienze, o suscitare giudizi, modificherò anche quello fino a renderlo del tutto omogeneo; ma otterrò ancora lo stesso risultato.
Bisogna ricordare quello che ho detto poco fa: se continuo ad ottenere lo stesso risultato, cioè vedo ancora sempre il «passare dietro», vuol dire che finora non ho toccato alcuna condizione determinante, ma solo aspetti che credevo tali mentre tali non erano. Ho dunque solo apparentemente modificato la situazione: è come se avessi modificato la temperatura dell’ambiente, abbassato le tapparelle, messo sul giradischi una buona incisione del «Messia» o fatto altre cose ugualmente distanti dal merito della questione.
Ridotti a pure forme geometriche il pullman e la casa, e a grigio uniforme lo sfondo, può venirmi il dubbio che il «passare dietro» si realizzi a causa del fatto che tra il rettangolo-casa e lo sfondo è ancora avvertibile un certo spazio: il rettangolo azzurro può infilarvisi. Allora eliminerò anche questo spazio. Tutto giacerà su un unico piano; proietterò i rettangoli con un proiettore diascopico su di uno schermo, dove fisicamente non esiste alcun dietro e davanti, e le zone illuminate sono quanto di più complanare sia dato di immaginare.
Se anche qui vedrò che il rettangolo azzurro «passa dietro» al rettangolo bianco - come in effetti vedrò - allora è provato che il «passare dietro» non dipendeva dal riconoscere cose che possono aggirarsi tra loro, o dal fatto di percepire un ambiente tridimensionale che consente una simile operazione. È provato, se la logica conta qualche cosa.
Però, a furia di togliere particolari, sono arrivato al punto che ulteriori modifiche possono veramente intaccare o distruggere la struttura di cui mi sto occupando. Se modifico in un certo modo l’intervallo temporale entrata-uscita; se aumento oltre certi limiti la lunghezza del rettangolo-casa; se modifico le velocità e le traiettorie ecc. non vedo più il passaggio di un oggetto dietro all’altro.
Anche qui, se la logica conta qualche cosa, dovrò concludere che all’inizio vedevo passare il pullman dietro alla casa in quanto, in quella situazione, erano rispettati i rapporti spazio-temporali e cinetici che in questa situazione risultano essere le condizioni del «passare dietro».
Non è il riconoscimento di una situazione familiare che provoca la struttura del «passare dietro» ; piuttosto, le situazioni che ci sono familiari si realizzano così proprio perché riproducono (con una approssimazione abbastanza buona) le condizioni di base necessarie alla realizzazione di tale struttura.
Invito il lettore a riflettere bene su questo ragionamento, perché è assai facile perderlo di vista; lo dovremo riprendere e ci tornerà utilissimo nel prossimo capitolo, trattando della causalità.
Sommario dei Capitoli Terzo e Quarto
L’identità
È possibile affermare che l’identità è una proprietà degli oggetti esperibili, allo stesso titolo che i colori, le proprietà geometriche, il peso, ecc.? Stando al senso comune, una risposta affermativa appare inevitabile. Ogni volta che entriamo in una stanza a noi nota, ritroviamo gli «stessi» oggetti, o ne troviamo di «nuovi», o li troviamo «cambiati» - tutti aspetti direttamente connessi a qualcosa che è l’identità. Di attimo in attimo le cose circostanti restano «loro», anche quando sono interessate - almeno entro certi limiti - da trasformazioni. Possiamo intenderci parlando tra noi a proposito degli oggetti presenti proprio perché li riconosciamo come «quelli».
Ma anche questa tesi va ben presto incontro a notevoli difficoltà logiche.
La più radicale di esse è stata scoperta fin dagli inizi della storia della nostra cultura, e successivamente - in varie forme - è stata riproposta innumerevoli volte.
Per poter dire che veramente A è identico ad A, riferendo gli A a qualche tipo di oggetto, occorrerebbe che l’oggetto in questione fosse uno solo (si duo faciunt idem non est idem) e collocato in una realtà in cui manca totalmente il flusso temporale (se il tempo trascorre, A da un momento all’altro è diverso per il solo fatto di trovarsi associato a un diverso istante di quel tempo). Un criterio rigido dell’identità, dunque, rende impossibile l’applicazione di tale concetto agli oggetti dell’esperienza. E se è così, è vero che non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume.
Una assunzione di questo tipo rende particolarmente difficile la costruzione di una teoria del movimento, e in genere delle trasformazioni, come bene si accorsero i primi che tentarono di elaborare i concetti della meccanica. L’esistenza empirica del movimento, se vogliamo accettarla, induce inevitabilmente a compromessi: già Platone, nel Sofista, sottolineava che «il moto è identico e pure non è identico», avvertendo che «quando diciamo che esso è identico e non è identico, ciò non diciamo dal medesimo punto di vista»; ed Aristotile aggiungeva, ancora più radicalmente, che quando qualcosa è e non è, si tratta di un «equivoco»: vuol dire che stiamo applicando insieme due definizioni diverse di un concetto ad una stessa situazione.
Ad es.: se un colore rosso si sta trasformando in giallo attraverso una serie di arancioni, un pittore potrà dirmi - a un dato momento - che questo rosso non è più un rosso; mentre io, essendo un profano in fatto di colori, persisto a trovare adatto tale aggettivo. Non c’è contraddizione nel fatto; c’è divergenza nell’estensione attribuita al concetto utilizzato.
Una volta che sia abbandonata la definizione più rigorosa dell’identità che è applicabile solo ad oggetti ideali - ogni altra definizione risulta più o meno estensibile ed elastica. Occorre accettare questa spiacevole condizione, e studiare i metodi più adatti a generare meno equivoci: in pratica, andar a vedere quali trasformazioni può subire un oggetto senza che si possa dubitare della sua autoidentità. È il tema proposto da Cartesio con l’esempio della cera, che avvicinata al fuoco muta tutte le sue caratteristiche organolettiche pure restando - ma in che senso? - la «stessa» cera.
Simile a questo, è il problema di Locke: quali parti o elementi di un oggetto si possono sottrarre ad esso, senza che quell’oggetto diventi un altro?
Naturalmente, se assumiamo una interpretazione elementaristica dell’esperienza diretta, questi problemi diventano privi di senso. L’identità è un concetto che noi arbitrariamente applichiamo agli aggregati di sensazioni: si può dire solo che quando uno di tali aggregati perde o acquisisce progressivamente un certo numero di elementi, nella nostra mente avviene un passaggio «piano e facile», e allora «tendiamo a immaginare che noi stiamo considerando lo stesso oggetto»; così si esprime Hume. Se un aggregato di sensazioni (senza perdere né acquisire elementi) sparisce e si ripresenta alla coscienza più volte successivamente, noi spontaneamente «postuliaino» che si tratta dello stesso oggetto: gli attribuiamo una «identità fittizia», frutto di un giudizio di identità costruito inferenziaimente. Ma questa è una «conclusione che va al di là delle impressioni dei sensi «. È impossibile parlare sensatamente dell’identità come dato dell’esperienza.
Recentemente il filosofo W. V. O. Quine ha tentato di rispondere insieme alle esigenze della logica e a quelle dell’applicabilità empirica del concetto di identità. La sua teoria è fondata su un particolare uso della definizione ostensiva: mostrare un oggetto e pronunciare un nome, ma più volte e in diverse circostanze, in modo da circoscrivere più che è possibile l’inevitabile ambiguità che ogni definizione ostensiva ha. Un opportuno sistema di definizioni ostensive permetterà all’interlocutore («aiutato dalla propria tendenza. a favorire i raggruppamenti più semplici» - aggiunge Quine) di formarsi un’idea corretta dei limiti spaziotemporali dell’oggetto designato da quel nome: le varie ostensioni concorreranno a formare un concetto-classe unico, per es. «il fiume Caystro»; e allora si potrà dire che ci si può bagnare due volte in esso.
Ma è chiaro che questa soluzione di Quine presuppone l’esistenza e il funzionamento di almeno due meccanismi psicologici: il primo di essi è la «tendenza a favorire i raggruppamenti più semplici» che si suppone nell’interlocutore; il secondo è, senz’altro, la percezione dell’identità. Per poco che duri, un atto di ostensione si estende nel tempo; l’oggetto mostrato, per essere «definizione» della parola che accompagna il gesto, deve durare autoidentico almeno per tutto il tempo occupato dall’ostensione.
Anche in questo caso il fatto percettivo non è eliminato dalla analisi logica, ma piuttosto quest’ultima trova appoggio in esso. In definitiva: o l’identità viene accettata in forma di principio logicamente puro, e allora esso è valido solo per un mondo come quello delle idee di Platone. Oppure ha un senso il parlare d’identità anche in un mondo come il nostro, e allora si pone subito il problema del permanere dell’identità attraverso le trasformazioni, o in assenza di trasformazioni; e questi sono problemi di psicologia della percezione.
Sotto questo profilo, un primo problema psicologico di rilievo è quello dell’ «identicità».
Un oggetto direttamente percepito non muta finché non è visibilmente interessato da trasformazioni. Secondo il nostro «esse est percipi» metodologico, è errato dire che esso «in realtà» muta perché intanto il tempo fisico trascorre; questa è una varietà di «errore dello stimolo»; l’oggetto fenomenico è nel tempo fenomenico, e fintanto che quest’ultimo non influisce visibilmente sulla struttura dell’oggetto, l’oggetto resta veramente identico a se stesso.
Lo stesso va detto nel caso in cui le modificazioni degli stimoli non hanno conseguenze al livello percettivo, e l’oggetto resta autoidentico. Dire il contrario significa incorrere, anche in questo caso, nell’errore dello stimolo.
Un secondo problema psicologico è costituito dal mantenimento della identità degli oggetti durante gli spostamenti che essi compiono nello spazio: gli esperimenti di P. von Schiller illustrano diverse modalità del mantenimento dell’identità in tali situazioni, e in quale modo la tendenza all’identità degli oggetti determini - in particolari condizioni - la stessa traiettoria che l’oggetto compirà nel corso della traslazione, e il verso del suo moto.
Gli esperimenti di J. Ternus dimostrano che la tendenza alla conservazione dell’identità riguarda le organizzazioni percettive in toto; è la struttura del tutto che determina l’identità delle parti, e non viceversa.
Una terza ampia classe di fenomeni permette di studiare uno dei temi fondamentali proposti da Hume: il mantenimento dell’identità degli oggetti nei periodi di tempo in cui essi non sono direttamente visibili. Questi fenomeni sono stati ampiamente studiati dalla scuola di A. Micotte per mezzo di finissime analisi condotte sulla fenomenologia dell’«apparizione», della «sparizione», e dell’ «esistenza amodale» (Knops, Sampaio, Burke).
Se l’applicazione del concetto di identità al mondo dell’esperienza implica l’uso della definizione ostensiva, l’insieme dei fatti e delle leggi risultanti dalle indagini della scuola di Michotte rivestono un’importanza decisiva. Infatti, dal momento che i limiti di rottura. dell’identità fenomenica sono autonomi e largamente indipendenti dai nostri giudizi, e l’ambito di fatti chiamato in causa nel corso di ogni definizione ostensiva dipende proprio da tali limiti, occorre concludere che il risultato di tale operazione è determinato interamente dalle leggi che nel campo percettivo regolano i fenomeni di identità.
![]()
Note
[1] Ch. von Ehrenfels, Über Gestaltqualitätem, in «Das Primzahlengesetz «, Leipzig, 1922.
[2] Cfr. Cap. II, pag. 91 e pag. 115 e segg.
[3]J. Ternus, Experirnemtelle Untersuchung über phänomenale Identität, «Psych. Forsch.», 1926 (7), pag. 81 e segg.
[4] Cfr. Cap. III, alla fine del § 8.
[5] K. Koffka, Principles, pag. 299.
[6] L’autoidentità della struttura dell’oggetto può conservarsi anche attraverso movimenti nella terza dimensione (cioè di avvicinamento o di allon tanamento rispetto al luogo dove l’osservatore si trova), come nel caso studiato da von Schiller e riportato poco prima.
Ecco due esempi da Ternus:
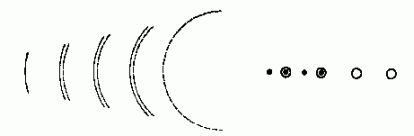
Il primo è ottenuto con linee luminose ricurve; il secondo con i soliti punti. Nel primo caso abbiamo lo spostamento in toto degli archi di cerchio, con movimento nella terza dimensione, dovuto ad esigenze di costanza di grandezza; nell’altro, un avanzamento brusco dei punti verso l’osservatore, dovuto allo stesso motivo.
[7] K. Koffka, Principles, pag. 180.
[8] Per una trattazione esauriente di questo tema vedi: R. Piovesan, Analisi filosofica e fenomenologia linguistica, Padova, 1961, pagg. 45-102. e 107-115.
[9] E. G. Tolman, Gestalt and Sign-Gestalt, in « Collected Papers in Psychology «. Berkeley-Los Angeles, 1951, pag. 84, l’argomento è trattato da pag. 82 a pag. 87.
[10] K. Koffka, Principles, pag. 186.
[11] E.Rubin, Visuell wahrgenommene Figuren, Copenhagen, 1921, pag. 69.
[12] F.Metelli, Oggettualità, stratificazione e risalto nell’organizzazone percettiva di figura e sfondo, «Ar. di Psic. Neur. e Psich.», 1941, IV, pag. 831 e segg.
[13] A patto di semplificare il problema forse oltre i limiti del lecito (cfr. W.Köhler, Gestalt Psychology, ed. cit., pagg. 180 e 186).
[14] Benché il silenzio, a volte, possa considerarsi ininterrotto: per questo si può parlare di «rumori nel silenzio della notte», ad es., ed altre volte dire « il silenzio fu interrotto da un rumore improvviso».
[15] Giovanni Vicario, L’effetto tunnel acustico, «Riv. di Psic.», 1960 (2), pagg. 41 e segg. L’espressione «effetto tunnel» è stata coniata da Wertheimer per indicare un caso di salto stroboscopico in cui il movimento si realizza «dietro» a uno schermo, essendo visibili solo il suo punto di partenza ed il suo punto d’arrivo.
[16] D. Hume nel Treatise scrive: «supponiamo che io vegga i piedi e le gambe di una persona in movimento, e che qualche ostacolo mi nasconda il resto del suo corpo: è certo che l’immaginazione riempie la figura tutt’intera, dandole la testa e le spalle, il petto e il collo, ecc.: io concepisco e credo che essa possiede queste membra. Ora, niente è più evidente che tutto questo lavoro è eseguito soltanto dal pensiero, ossia dall’immaginazione, perché il passaggio è immediato e le idee ci colpiscono sul punto stesso: la loro abituale connessione con l’impressione presente le modifica in un certo modo, ma non per questo produce un atto della mente distinto da questa concezione particolare. Ognuno esamini se stesso, e vedrà che questa è la verità».
[17] F. Kenkel, Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Erscheinungungsgrösse und Erscheinungsbewegung bei einigen sogennanten optischen Täuschungen, «Zts. f. Psych.», 1913 (67), pagg. 358 e segg.; M. R. Harrower, Some experiments on the nature of g movement, «Psych. Forsch.», 1929 (13), pagg. 55 e segg.; E. Lindemann, Experimentelle Untersuchungen über das Entstehen und Vergehen von Gestalten , « Psych. Forsch.», 1922 (2), pagg. 5 e segg.
[18] L. Knops, Contribution à l’étude de la «naissance» et de la « permanence» phénoménales dans le champ visuel, in «Causalité, permanence et réalité phénoménales» , Paris, 1962, pagg. 299 e segg.
[19] A. Michotte, L. Burke, Une nouvelle énigme de la psychologie de la perception: Le «donné amodal « dans l’experience sensorielle. Atti deI 13 Congresso Internazionale di Psicologia: « Proceedings and Papers «, Stockholm, 1951, pag. 179.
[20] A. C. Sampaio, La translation des objets comme facteur de leur permanence phénoménale, Louvain, 1943; L.Burke, On the tunnel effect, «The Quart. J. of Exper. Psych.», 1952 (4), pagg. 121 e segg.
[21] K. Koffka, Principles, pag. 292.
[22] M. Wertheimer, Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung, «Ztsch. f. Psych.», 1912, pagg. 222 e segg.
[23] M. Wertheimer, Op. cit.. pag. 223.
[24] M. Wertheimer, Op. cit., pag. 227.
[25] E. Rubin, Visuell wahrgenommene Figuren, Copenhagen, 1921.
[26] L. Burke, Op. cit. pag. 379.
[27] L. Burke, Op. cit., pag. 389.