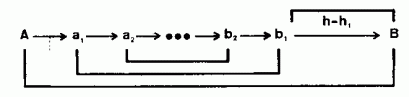
|
Capitolo Quinto La causalità |
§ 1. Introduzione
Ricorrendo, dunque, determinate condizioni nell’ambito dell’esperienza attuale, le regioni in essa discernibili godono di una proprietà ben definita e indipendente dalle convinzioni o dall’impostazione dell’osservatore, che è normalmente associata all’uso di vocaboli come «stesso», «medesimo», «uguale», «identico», oppure ad espressioni più ampie ed articolate che rimandano all’astrazione «identità». La fenomenologia della identità, intesa in questo senso, è ricca di problemi particolari, i quali possono venire affrontati senza che sia ogni volta necessario andare a vedere da vicino quale parentela intercorra tra essi e una definizione logicamente pura dell’identità; benché tale parentela - come abbiamo cercato di indicare - esista, e a sua volta possa essere assunta a oggetto di indagine.
Lo stesso discorso potrebbe essere fatto per la causalità. Anche il problema dell’analisi del rapporto causale possiede una dimensione logico-epistemologica, ed una dimensione fenomenologica; per comodità di studio è possibile vederle come faccende staccate, ma non c’è dubbio che il linguaggio d’ogni giorno contiene espressioni di tipo causale le quali, essendo da una parte riconducibili a strutture logiche ben definite, sono dall’altra (tanto grammaticalmente che intenzionalmente) descrizioni di avvenimenti, o comunque frasi che parlano di rapporti tra fatti.
Ed anche qui, in un senso spinge l’esigenza dell’analisi logica: cioè a trascurare le varietà dell’esperienza immediata in vista di una loro riducibilità ad una formula univocamente definita; mentre in direzione opposta trae l’analisi del linguaggio comune e l’analisi fenomenologica, interessate proprio a quelle varietà.
Non vi sarebbero dilemmi se la famosa pagina di Lalpace potesse essere considerata come una corretta ed esauriente rappresentazione della realtà: «Dobbiamo considerare lo stato presente dell’universo come effetto del suo stato antecedente, e causa di quello che seguirà. Un’intelligenza che, per un istante dato, conoscesse tutte le forze da cui la natura è animata e la collocazione rispettiva di tutti gli esseri che la compongono, e che fosse abbastanza grande da poter sottomettere questi dati al calcolo, abbraccerebbe nella stessa formula i movimenti dei più grandi corpi dell’universo e quelli del più leggero atomo: niente sarebbe incerto per essa, e l’avvenire, come il passato, sarebbe presente ai suoi occhi»[1]. Questo è il senso che un matematico di centocinquanta anni fa poteva dare alla «causa seu ratio» di Spinoza. In un universo di questo tipo (che può assomigliare al nostro oppure no; non lo sappiamo con sicurezza) «ordo et connexio rerum idem est ac ordo et connexio idearum «, nel senso specifico che ai legami fattualmente intercorrenti tra gli eventi suscettibili di osservazione corrispondono altrettanti passaggi logici di una deduzione; anzi, come è stato sostenuto in modo coraggiosamente radicale proprio da Spioza, non vi è corrispondenza: si tratta della stessa cosa.
Dal momento che, per gli scopi che questo libro si propone, è essenziale tenere distinti gli aspetti relazionali dell’esperienza diretta (che dobbiamo considerare come proprietà qualitative dei dati osservabili) dalle relazioni logiche che eventualmente sono capaci di rappresentarli, eviteremo di fare nostro questo punto di vista; fermo restando che esso è perfettamente possibile, non contiene - per quel che ne sappiamo finora - contraddizioni, ed è anzi raccomandato da più di uno studioso di scienze naturali. Brown e Ghiselli, per esempio[2], affermavano pochi anni or sono che «in qualunque modo tale concetto sia accettato dai singoli studiosi di scienze, resta tuttavia vero che se la natura non è assunta come uniforme non vi può essere scienza «, e che «il determinismo è essenziale alla scienza». Può essere vero. D’altra parte, chi sostiene l’opposto può appoggiarsi al fatto che, almeno nelle scienze empiriche, è indispensabile formulare criteri di verifica per gli enunciati generali; ora, non rientra nelle nostre possibilità dare la descrizione di un metodo che permetta di controllare se la natura segue sempre un corso costante, e se le leggi di questo corso troveranno una conferma anche negli eventi del futuro. È una questione complessa, come è noto da secoli, che però riguarda assai più il nostro modo di immaginare il mondo transfenomenico, che non l’esplorazione delle strutture del mondo esperibile.
La questione che ci tocca da vicino, invece, è un’altra:
Posto che il linguaggio quotidianamente adoperato contiene espressioni di tipo causale, e che quando descriviamo con esso il mondo circostante o le nostre esperienze, non possiamo fare a meno di usarle (almeno, senza ricorrere ad un parlare artificioso), le relazioni che vogliamo indicare esprimendoci così sono sempre solo connessioni logiche da noi imposte agli eventi, o sono a volte anche proprietà che gli eventi stessi possiedono e che noi, da spettatori, rileviamo in essi?
Nel corso del presente capitolo esporremo un certo numero difatti che dànno ragione a quest’ultima tesi.
Non potremo, però, esimerci dal prendere in considerazione anche alcune tra le ragioni avanzate da chi crede nella tesi opposta, che ci risulta tuttora condivisa dalla maggior parte degli studiosi di logica e di epistemologia. Perciò, prima di entrare nell’argomento che ci riguarda più da vicino, occorrerà dire qualcosa sulla causalità intesa come un modo di parlare a proposito di fatti che intendiamo connettere in un modo definito (o perché ripetute osservazioni ci hanno convinti che non sono indipendenti, o perché la riflessione ci ha indotti a credere nell’esistenza di qualche rapporto tra essi), indipendentemente dall’assunzione che il rapporto causale possa essere o no un dato d’osservazione.
Tale «modo di parlare» può essere considerato a differenti livelli di esattezza. Qui, per non allungare troppo il discorso, ci limiteremo a discutere una possibile interpretazione del rapporto causale al livello del senso comune, e, subito dopo, due interpretazioni formalizzabili, che possono entrare in gioco nella formulazione delle teorie scientifiche.
§ 2. Evento e rapporto.
Incominciamo coll’esaminare un esempio: ci succede di leggere su un quotidiano il seguente titolo: «Un pneumatico scoppia e causa la morte di tre persone «. Questa proposizione, a prima vista, sembra che non contenga gravi ambiguità. Eppure è abbastanza evidente che lo scoppio del pneumatico non ha «causato» la morte delle tre persone. Se chiediamo ad un lettore di riflettere bene, egli non avrà difficoltà a riconoscere che lo scoppio di un pneumatico non comporta - a rigore - la morte di nessuno; ma tale scoppio, nel caso in questione, ha causato uno sbandamento dell’automobile, mentre la morte del conducente, ad esempio, è stata causata da alcune gravi lesioni interne.
Questa riflessione ci induce a credere che lo sbandamento e le lesioni interne siano legate tra loro da una nuova e più stretta relazione causale, dato che sono eventi tramite i quali il primo evento (lo scoppio della gomma: A) è legato all’ultimo (la morte delle persone: B).
Ora abbiamo a che fare con una nuova proposizione: «lo sbandamento di una automobile causa lesioni interne alla tale persona», che non vuol dire la stessa cosa detta nel titolo di prima. Anche qui c’è il verbo «causa»: viene dunque da pensare, ancora una volta, a qualcosa che è avvenuto t r a questi altri due fatti: «sbandamento», «lesioni». Potrebbero essere altri due fatti, per es. l’urto della macchina contro un albero, e l’urto del piantone del volante contro lo sterno del guidatore (per le altre persone, l’urto contro altre parti della stessa vettura). Abbiamo così una nuova proposizione: «l’urto di un automobile contro un albero causa l’urto dello sterzo contro lo sterno ecc. «. Procedendo in questo modo, otteniamo altrettanti eventi che, presi a due a due, possono essere descritti come relazioni causali «interne» alla relazione causale A - B, e via via più interne: «a1 - b1» «a2 -b2» «a3 - b3» elementi, dunque, della catena causale compresa tra il fatto A ed il fatto B che compaiono nel titolo del giornale:
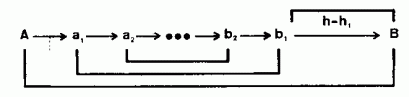
Ma non basta. Prendiamo in considerazione un solo anello di questa catena, ad es.: «le lesioni interne hanno causato la morte del conducente». Anche questa affermazione è suscettibile di essere analizzata nella stessa maniera. Lo sfondamento dello sterno può aver provocato un collasso polmonare; in questo caso la «causa» della morte è una, mentre sarebbe un’altra se lo stesso evento avesse provocato la rottura dell’aorta. Potremmo di questo passo risolvere ogni relazione causale parziale in un certo numero di relazioni analoghe, ma individuabili ad un livello più interno, cioè comprese tra i due estremi costituiti dai termini della relazione assunta come primitiva.
Il procedimento può essere applicato una quantità indeterminata di volte. Ad un certo punto, con ogni probabilità, troveremo un rapporto tra fatti che si presta assai difficilmente ad una ulteriore scissione interna. Sappiamo che deve essere ben accaduto qualcosa, ma non siamo in grado di dire esattamente che cosa. In tale frangente, potremmo assumere questo rapporto come primitivo e non ulteriormente scomponibile; ma in realtà quando diciamo «un rapporto non ulteriormente scomponibile» intendiamo dire - come prima - che al posto della parola «causa» potrebbero venir collocati altri «fatti», o coppie di «fatti»; solo non siamo in grado di dire quali.
Ciò che nell’espressione «A causa B» appare come una relazione, in tale modo, risulta essere non una relazione, ma un gruppo di accadimenti più o meno definitamente esteso.
Si possono trovare facilmente molti esempi analoghi a quello ora citato, essendo probabilmente quest’uso delle espressioni causali quello a cui più spontaneamente pensiamo quando ci vengono posti degli interrogativi sulla forma della connessione causa-effetto. Possiamo analizzare allo stesso modo espressioni come «la lettera ricevuta causò a X un grande piacere «, «non ho potuto muovermi da casa causa il cattivo tempo»; o, in altra forma: «è stato bocciato perché non si era preparato bene «, «la chiave si è rotta, così non ho potuto aprire il portone».
Ma prima o poi, abbiamo detto, si presenta il rapporto non ulteriormente scomponibile.
Finché possiamo sostituire alla parola «causa» qualche altra relazione tra due termini ad un livello più interno, siamo autorizzati a dire che, nella frase detta, «causa» stava al posto di quei termini: era cioè un modo di sottintenderli, una abbreviazione per connettere «A ... B» per mezzo degli altri elementi della catena[3]. Ma cosa significa l’indicazione «causa» quando non siamo in grado di citare i fatti in questione?
Qui potrebbero esserci non più fatti, ma la vera e propria (e misteriosa) relazione. Ma non crediamo che al livello del senso comune possa avvenire questo brusco cambiamento qualitativo. Piuttosto, è credibile che qui la presenza della parola «causa» indichi l’esistenza di una ipotesi circa la presenza di qualche altro fatto; ipotesi che per il momento non può essere confermata, e forse neppure formulata in modo soddisfacente. Può voler dire «che ne so io? qualcosa ovviamente deve essere intervenuto «
In breve, «A causa B» può servire a indicare la storia dei fatti tra A e B, i quali possono essere noti, poco noti, o puramente ipotizzati.
Parrebbe, a prima vista, che questo modo di intendere il rapporto causale conduca alla conclusione che le cause esistono fattualmente, dato che la parola «causa» viene ridotta - volta per volta - all’enumerazione di alcuni accadimenti. Ma sarebbe una conclusione sbagliata: nel processo di riduzione ciò che ogni volta sparisce è la causalità come relazione : i fatti enumerati sono fatti, o termini, come A e B, t r a i quali potranno essere poste relazioni di causa più interne, destinate a dissolversi ancora in fatti, e così via. La causa è un fatto, o tanti fatti, ma tali fatti non sono la relazione causale.
§ 3. Causalità e implicazione.
Il senso comune talvolta s’imbatte in circostanze meno complesse, nelle quali è difficile ipotizzare qualche altro fatto in mezzo alla causa e all’effetto, data l’elementarità del rapporto. In questi casi esiste la possibilità di fare un primo passo verso una formulazione rigorosa della dipendenza causale; che nondimeno sottintende ancora una concezione fattuale (non puramente formale, cioè) di tale rapporto. Siamo di fronte a connessioni causali, in questo senso, tutte le volte che decidiamo di descrivere un dato gruppo di osservazioni svolte su certi fenomeni per mezzo di una particolare funzione costruita teoricamente, piuttosto che con altre.
Ad esempio: ognuno sa che un aumento della temperatura ambientale «causa» l’innalzamento della colonna di mercurio o di alcool nel termometro; l’idea di causazione, in questo caso, è un modo un po’ mitico di immaginare quello che succede in realtà quando sentiamo che fa più caldo e nello stesso tempo vediamo che la colonna del termometro sale.
Sostituendo tale mitologia con qualche nozione di fisica elementare, verremo a sapere che la nostra generica causa è un rapporto che lega (supponendo costante la pressione) l’energia cinetica e potenziale delle molecole di un dato corpo con il suo volume complessivo.
Per rappresentare esattamente questo rapporto occorre prima di tutto un metodo adatto a rilevare le condizioni cinetiche delle molecole in questione; poi occorre una scala (costruita con uno dei molti criteri disponibili, oppure arbitrariamente) che permetta di esprimere in numeri e con la maggiore finezza possibile quelle condizioni; inoltre, ci vuole un criterio per misurare il volume, e, anche qui, una scala adatta a esprimerlo quantitativamente.
Fatte le rilevazioni necessarie, dobbiamo scegliere tra le tante funzioni a due variabili a nostra disposizione quella capace di rappresentare correttamente le variazioni dei valori di una delle due scale con la variazione dei valori dell’altra. Questa scelta è naturalmente condizionata dalla lettura della esperienza: in questo caso, dal metodo impiegato nella rilevazione dei valori che ci interessano.
Siamo, a questo punto, già abbastanza lontani dalla primitiva idea di causalità esemplificata sopra; nessuno però ci vieta di chiamare la funzione così trovata col nome di «descrizione di un rapporto causale». Se accettiamo questa definizione, ogni volta che vorremo determinare analoghi sistemi di relazioni la struttura del nostro «rapporto causale» risulterà cambiata, e il cambiamento verrà a dipendere dalle osservazioni eseguite:da dati, dunque, di fatto. La soluzione del problema causale sarà decisa sulla base di letture dell’esperienza.
Questo non vuol dire, si badi, che nel mondo fisico esistono senz’altro relazioni causali che noi scopriamo facendo esperimenti; non vuoi dire, d’altra parte, neppure che tali relazioni non ci sono. L’esempio citato mostra solo in che modo la nozione più comune di causa si trasforma quando impariamo un po’ di fisica elementare, e poi l’applichiamo a circostanze di fatto molto semplici, o ad osservazioni più esatte di quelle con cui abbiamo a che fare nella vita corrente.
A questo punto diventa più facile distinguere nel rapporto causale l’aspetto fattuale (o presunto tale) dall’aspetto formale: da una parte vi è una funzione che è stata scelta, dall’altra è innegabile che quella funzione è stata scelta a preferenza di altre dipendentemente da quanto è stato trovato per mezzo delle rilevazioni empiriche.
Un successivo passo può essere ora compiuto.
Quale è la forma generale, lo scheletro degli enunciati con i quali intendiamo sottolineare il rapporto in questione?
Non intendiamo dire, evidentemente, che i fatti A e B -quali che essi siano - vanno semplicemente legati l’uno all’altro in qualche modo, né che sono disposti uno dopo l’altro, o uno vicino all’altro ecc.; ma piuttosto che sono connessi in una maniera peculiare, la quale non risulta né esaminando la formula (caso secondo), nè moltiplicando l’enumerazione degli eventi intermedi (caso primo, § 2).
Sappiamo che è accaduto il fatto A e che è accaduto il fatto
B. In effetti, possiamo supporre che se non fosse accaduto il fatto A non sarebbe accaduto neppure il fatto B. Possiamo anche supporre che il fatto B sarebbe potuto accadere senza che prima, avesse avuto luogo il fatto A. Ma - se siamo convinti che A ha «causato» B - no n possiamo supporre che poteva succedere A senza che B avesse luogo.
In altre parole: dire che realmente A ha causato B è come dire che A non poteva succedere senza che succedesse anche B.
Un esempio ancora: nel nostro paese non avvengono alluvioni senza che aumentino le tasse. Ciò non significa solo che quando da qualche parte vi è una alluvione le tasse aumentano: vuol dire anche che le tasse possono aumentare (come è noto) senza che ci siano state alluvioni; che può succedere che non avvengano alluvioni e che le tasse restino invariate; ma che è impossibile una alluvione senza aumento di tasse.
In questo modo il rapporto causale non è semplicemente la descrizione di una connessione tra A e B, ma piuttosto la tabulazione di quattro possibili ipotesi, delle quali una viene scartata. Ecco la tabella:
1. A-si B-si
2. A-no B-si
3. (A-si B-no) no
4. A-no B-no
La terza ipotesi è quella che viene rifiutata.
La tabella ora riportata è quella che definisce il rapporto di implicazione, quale compare di solito nei trattati di logica:
p q p É q
V V V
F V V
V F F
F F V
in cui «p» e «q» sono proposizioni qualunque («arde il fuoco», «sale il mercurio», «tre muoiono», «pneumatico scoppia»), V ed F indicano valori di verità, cioè «vero» e «falso» questi ultimi, nelle prime due colonne si riferiscono alle singole proposizioni «p» e «q», nella terza colonna si riferiscono alla frase complessiva «p implica q», che deve esser falsa se «p» è vera e «q» falsa.
Dunque, se accade realmente che quando diciamo «A causa B» intendiamo dire che non potrebbe aver luogo A senza anche B, c’è una parentela tra la causalità e l’implicazione; ecco dove poggia l’idea di Laplace e la «causa seu ratio» di Spinoza. Vale la pena di vedere questo punto da vicino. Fin qui, si tratta di parentela, non ancora di identità di rapporti: ma basta ancora poco perché la causalità diventi deducibilità.
Che fin qui si tratti solo di parentela, risulta dall’esame di quelli che i logici chiamano «paradossi dell’implicazione materiale». Consideriamo la matrice qui sopra, e cerchiamo di cavare da essa (e solo da essa, senza aiutarci con l’intuizione) tutte le conseguenze a cui porta.
La matrice dice che sono implicazioni tutti i rapporti tra proposizioni - prese a due a due nell’universo delle proposizioni sensate possibili - quando non ricorra la seguente condizione: che la prima proposizione sia vera e la seconda falsa. Questo, e solo questo, dice la matrice. Ed ecco i paradossi:
a) tutte le proposizioni vere immaginabili sono implicate tra loro;
b) tutte le proposizioni false sono implicate tra loro ed inoltre implicano tutte le proposizioni vere; difatti, l’unica condizione richiesta dalla matrice perché si possa dire che «p» implica «q» è che non sia vero che «p» sia vera mentre «q» è falsa; dunque, tranne che in questo caso, in tutti gli altri si può parlare di implicazione.
Vuol dire che, a rigore, «Tizio è alto» implica «la neve è bianca» oppure «Maria Stuarda era un uomo» implica «la Terra ha un satellite», oppure «Socrate scrisse molte opere» implica «le pietre sono commestibili»[4].
A questo punto la parentela tra causalità ed implicazione è assai tenue; nessuno direbbe che la Terra ha un satellite per il fatto che Maria Stuarda era un uomo.
Le cose però cambiano quando si passa dall’implicazione materiale all’implicazione «stretta» o «modale». L’implicazione materiale è quella rappresentata dalla matrice di prima. La implicazione stretta è stata definita da Lewis[5], e, per le particolarità che la contraddistinguono, connette tra loro proposizioni in modo tale che è facilissimo riconoscere in esse sensati rapporti causali, quando enunciano stati di fatto.
Diamo qui al lettore che abbia qualche confidenza con il calcolo logico elementare una derivazione della definizione di implicazione stretta, e della definizione del concetto di «è possibile che... «, dalla normale forma dell’implicazione materiale. È contraddittorio dire che « ’p’ e non ’q’ « è vero e contemporaneamente è falso; dunque, negare questa contraddizione dà luogo ad una tautologia.
![]()
Questa espressione, essendo una taugologia, è logicamente vera, cioè èvera per qualsiasi possibile valore di ’p’ e ’q’.
Ora, quando le proposizioni sono legate da congiunzioni il loro ordine è indifferente e possono venire raggruppate in parentesi a piacere (come nell’algebra elementare); adotteremo quest’ordine

ottenendo così una nuova tautologia. Considerando l’espressione sottolineata nella parentesi quadra come un’unità, siamo di fronte ad una implicazione, dato che
![]()
dunque
![]()
A sua volta, per la stessa ragione, la parte qui sottolineata può essere scritta come implicazione, così:
![]()
questa è naturalmente ancora una tautologia, e va letta nel seguente modo:» se p è vero, e ’p implica q’, allora q è vero ossia: « è contraddittorio che p sia vero, che ’p implichi q’, e che insieme q sia falso «.
L’intiera espressione viene abbreviata da Lewis con l’introduzione di un nuovo segno,
![]()
che va letto « implica strettamente «, e scritta così
![]()
Che differenza c’è tra ![]() e
e ![]() ? che è possibile negare la prima, mentre è impossibile negare la seconda, dato che ciò conduce ad una contraddizione.
? che è possibile negare la prima, mentre è impossibile negare la seconda, dato che ciò conduce ad una contraddizione.
Ma dal comune calcolo delle proposizioni sappiamo che
![]()
(vedi sopra); questo vuol dire che una relazione equivalente dovrà potersi scrivere per
![]()
tenendo presente che non può essere negata: metteremo un segno particolare accanto alla negazione, dunque, e scriveremo:
![]()
cioè: « ’p implica strettamente q’ è equivalente a dire ’non è possibile che p sia vero ed insieme q falso». Dal che risulta che il segno
![]()
vuol dire «è possibile che... ».
Nella costruzione delle matrici viene introdotta l’espressione «è possibile che...» seguita dalla proposizione a cui si riferisce. Usando opportunamente il segno di negazione, da questa espressione si possono ricavare le seguenti altre:
(a) non è possibile che «p»
(b) è possibile che non «p»
(c) non è possibile che non «p»
Il significato di (a) è chiaro: la proposizione «p» è data come certamente falsa; l’espressione (b) ammette che si possa pensare «p» come vera oppure come falsa; (c) invece esprime una condizione che a noi importa soprattutto: cioè che la proposizione «p» è necessariamente vera, e non è possibile pensare che non sia vera.
L’espressione «è possibile che... « è rappresentata da ![]() la necessità, dunque, potrà essere indicata da
la necessità, dunque, potrà essere indicata da
![]()
Ciò si evince direttamente dall’espressione scritta prima
![]()
applicando ad essa la regola della negazione
![]()
che invece di essere prolissamente letta come « non è possibile che non sia vero che non si dà p vero e q falso insieme», può essere letta così: «è necessario che non si diano insieme p vero e q falso».
Ecco un metodo per escludere dal concetto di necessità qualunque traccia di sapore metafisico. Ora siamo in grado di attribuire un significato definito alla «conseguenza necessaria» da premesse date. L’implicazione può essere scritta nella forma
![]()
e letta così: «non è possibile dire che non sia vero che la proposizione p implica la proposizione q».
Queste nuove condizioni non possono più essere esemplificate da asserzioni come «'Tizio è alto' implica 'la neve è bianca'»; la negazione di tale espressione non conduce a contraddizioni. Un esempio adatto sarà invece solo una affermazione di questo genere: «'il quadrato X è rosso' implica 'il quadrato X è colorato'». Qui realmente non è ammissibile che sia vera la prima delle due affermazioni ed insieme falsa la seconda.
Se paragoniamo questa forma di implicazione con la struttura del rapporto causale, ora risulterà evidente la parentela accennata prima. Kant, ad esempio - raccogliendo una interpretazione della causalità che già ai suoi tempi era considerata classica - scrive che il rapporto tra causa ed effetto consiste nel fatto che «se è posto A, debba esser contraddittorio non porre B», e che in ciò sta la «necessità della connessione tra A come causa e B come effetto»[6].
A dispetto di questa parentela, però, esiste una importantissima differenza tra l’implicazione della logica modale ed il rapporto causale, sia pure nella forma descritta da Kant, ed è bene che la teniamo presente: l’implicazione connette tra loro affermazioni, mentre la causalità (esista essa o no come relazione constatabile) serve solo a connettere eventi. Si può però abbastanza facilmente capire come molti studiosi, in passato, abbiano trattato la causalità come deducibilità, sia in sede filosofica che nella formulazione delle teorie scientifiche; non intendiamo dire che l’abbiano fatto per le considerazioni da noi svolte in queste ultime pagine, ma certo la somiglianza che in questo senso risulta tra 1’«ordo rerum» e 1’«ordo idearum» può costituire, al limite, un ottimo fondamento per ritenere che tra le due cose non ci sia differenza alcuna.
§ 4. L’espressione probabilistica di connessioni causali.
La più vistosa fra le differenze che è possibile citare sta forse nel fatto che ben pochi tra gli eventi che l’uomo può osservare e studiare presentano connessioni tanto rigide da poter essere paragonate alle articolazioni di una deduzione logica, con la sola eccezione possibile della meccanica classica. È vero che si può sempre supporre che là dove noi troviamo connessioni non del tutto rigorose agisca una legge logicamente pura, disturbata occasionalmente dall’azione di altre leggi mentre noi andiamo a fare le nostre osservazioni. Ma non sappiamo fino a che punto questo modo di pensare sia una razionalizzazione del mondo, e fino a che punto una teoria della realtà. Hans Reichenbach, per esempio, ha insegnato che la causalità dei deterministi ha un «travestimento di principio apriori»[7], consistente appunto nella forma di rapporto di deduzione logica A É B. Non esiste alcun A che implica B; esistono solo, tra i fatti osservabili, relazioni del tipo «A implica B con il grado di probabilità p», che Reichenbach scrive in questo modo:
![]()
«Da questa relazione, empiricamente verificabile, passiamo poi ad una relazione ideale, considerando gli stati ideali A’ e B’, e stabilendo fra essi un’implicazione logica A’É B’ che rappresenta una legge della meccanica». Possiamo rendere questa probabilità sempre più prossima alla certezza se allarghiamo l’elenco delle condizioni del verificarsi del fatto, misurandone l’entità, e calcolando la loro portata nel verificarsi dell’evento complessivo A-B; «più precisa è tale caratterizzazione, più aumenta la probabilità della previsione».
È da notare che così viene a cadere il carattere della necessità, e che, nondimeno, causalità ed implicazione continuano formalmente ad assomigliarsi: il rapporto causale, nell’interpretazione riferita prima, diceva che B può aver luogo senza che abbia luogo A, ma non viceversa.; nell’implicazione probabile di Reichenbach ritroviamo espressa la medesima asimmetria del rapporto, in questa forma: dato B, il grado di probabilità che A si sia verificato è molto più basso di quanto non lo sia quello di B, dato A.
Uno dei modi formalmente più eleganti di esprimere per mezzo di rapporti probabilistici diverse forme di causalità è dovuto all’economista inglese J. M. Keynes.
Poco fa, citando Reichenbach, dicevamo che il grado di probabilità della connessione causale - secondo lo schema dell’implicazione probabile - aumenta col numero delle variabili concernenti il fatto A che vengono prese in considerazione (oltre che col numero di volte che la misurazione è stata ripetuta su una variabile, coll’accuratezza. dello strumento di misura, ecc.). Keynes muove da un’impostazione analoga, per dedurre diverse definizioni del concetto di causa utilizzabili nell’ambito delle scienze empiriche.
Secondo Kant, che seguiremo fedelmente attraverso tutto il suo ragionamento, la probabilità è sempre una relazione tra almeno due termini, cioè tra una o più proposizioni note e date per certe, e la proposizione che descrive l’evento probabile. Infatti (come è intuitivamente ovvio) non ha alcun senso dire è probabile», più di quanto possa averne il dire «X è maggiore» o «X è uguale»; X è probabile solo rispetto a qualcosa di sicuramente noto. Su questa base possiamo introdurre una definizione assai semplice. Supponiamo che a sia una proposizione, e h una o più altre proposizioni: «se una conoscenza di h giustifica una credenza razionale («a rational belief») in a di grado a diremo che vi è una relazione di probabilità tra a ed h»[8]; tale relazione si scrive a/h=a
Le proposizioni date per sicure, che stanno al denominatore, possono essere più d’una, come abbiamo detto: se vogliamo che compaiano nell’espressione, dobbiamo aggiungerle accanto ad h.
Un primo passo da fare è il seguente: supponiamo di sapere, a un dato momento, che a/h=a, e, in un secondo momento - grazie ad una nuova notizia h’ giunta a nostra conoscenza - che a/hh’= b. Potremo dire che la notizia h’ è probabilisticamente rilevante se è vero che b>a. Invece, h’ è irrilevante rispetto ad a sulla base dell’evidenza di h soltanto, se la probabilità di a sulla base dell’evidenza di hh’ è la stessa che la sua probabilità sulla sola base di h : cioè se a = b
In breve, le nuove conoscenze k ,l, m, ecc. che si accumulano accanto ad h aumentano la probabilità di a se nelle espressioni
a/h =a
a/hk =a’
a/hkl =a’’
a/hklm =a’’’
il numero (che è sempre una frazione propria, come normalmente si usa nel calcolo delle probabilità) è via via più prossimo al valore 1.
A volte può darsi che l’assenza di una condizione costituisca un dato rilevante nello stabilire la probabilità di a. In questo caso, per esprimere tale assenza, ci si serve della negazione della proporzione che descrive quella condizione: ad esempio, se c’è la descrizione di quella condizione, il segno c starà a indicare che essa è assente.
Le notizie, o conoscenze di condizioni, che - una volta sapute - ci permettono di attribuire una certa probabilità a un determinato avvenimento descritto dalla proposizione a non sono necessariamente sempre conoscenze di fatto. Qualche volta si tratta di enunciati appartenenti alla pura teoria, i quali possono darci il modo di interpretare un dato di fatto noto in un modo più corretto, determinando in noi una «credenza razionale» più intensa o meno intensa nei suoi confronti: se so che i gas possono avere una densità maggiore, uguale, ma anche minore di quella dell’aria, sarò certo portato ad accettare con minor scetticismo l’affermazione di qualcuno che mi racconti di aver visto salire un oggetto verso l’alto, anziché cadere a terra, dopo che era stato lasciato andare.
In altre parole, la conoscenza di leggi condiziona il grado di credenza in qualcosa esattamente come la conoscenza di fatti. Vi sono conoscenze «ontologiche» (fatti accaduti) e conoscenze «nomologiche» (leggi note), dice Keynes. Tutti e due questi tipi di conoscenze possono concorrere nella determinazione di una probabilità.
Proprio servendoci di essi possiamo procedere ad una classificazione precisa delle diverse varietà di rapporti causali che si nascondono sotto il concetto volgare di causa.
Il procedimento è questo:
- ci sono due fatti A e B, tra i quali corre la relazione che vogliamo specificare; essi sono descritti dalle proposizioni a e b;
- possediamo un certo numero di conoscenze utili a tale riguardo, «nomologiche» (scrive Keynes: «consistenti in proposizioni il cui contenuto prescinde da qualunque riferimento a particolari momenti del tempo») e «ontologiche», cioè di fatto; le prime sono espresse dalla proposizione k, le seconde dalla proposizione l;
- servendoci solo di a, b e k, potremo così definire un primo tipo di connessione causale:
![]()
Tenendo conto delle spiegazioni riferite più sopra, si può leggere questa espressione così: «data la legge k, è certo (probabilità = 1) che la verità di a comporta la verità di b»; cioè abbiamo una «credenza razionale» di grado 1, vale a dire siamo certi, che se a è vero anche b è vero.
In questo modo, si viene a dire che A è la causa sufficiente di B: infatti (sapendo la legge k) basta sapere che a è vera per poter dire che b è vera. So che le spese necessarie a ripare i danni provocati da una calamità pubblica vengono sempre addebitate ai contribuenti (k), e so che c’è stata una alluvione (a): ciò è sufficiente perché io sappia con certezza che le tasse saliranno.
Prendiamo un’altra espressione:
![]()
(dove a con trattino sovrascritto, come abbiamo detto, sta per la negazione di a). Leggendo questa espressione secondo le spiegazioni già date, essa dice che «data la legge k, è certo che b è falsa (probabilità = 0) se a non è vera)): occorre, cioè, che a sia vera affinché si possa almeno supporre che b sia vera - dal momento che se a non è vera certamente non è vera neppure b. A - in questo caso - è la causa necessaria di B. Sappiamo che solo coloro i quali consegnano le schedine riempite e pagano una certa quota possono vincere al totocalcio (k), e so di non aver giocato una schedina (a): posso stare sicuro che non vincerò nulla («vincere» è b). Giocare è necessario per poter vincere, benché non sufficiente.
Fin qui, non abbiamo fatto uso nè di conoscenze fattuali accessorie (l) nè di valori compresi tra 0 e 1 a destra del segno =.
Introducendo questi nuovi elementi, possiamo schematizzare nuove e più complesse varietà di rapporti causali.
Ad esempio, supponiamo di avere insieme la seguente coppia di espressioni:
![]()
Sappiamo cioè: 1) che essendo vera una legge k, ed essendo accaduti i fatti descritti da a ed l, b è sicuramente vera; mentre 2) in base alla sola legge k e il fatto menzionato da l, b può essere vera o no. In base a questa coppia di espressioni, veniamo a sapere - grazie a quanto detto prima - che A è causa sufficiente di B, a patto che si realizzi anche il fatto descritto da l; se b/kl fosse = 1, la causa sufficiente di b sarebbe l stesso, ed a risulterebbe irrilevante; ma in base a k ed l sappiamo solo che b può essere vera o no, mentre l’aggiunta di a al denominatore porta alla certezza. In breve, A è la causa di B, che però opera solo se c’è la condizione desctitta da l.
Oppure:
![]()
prese insieme, dicono che A è la causa necessaria di B sotto la condizione di fatto l; infatti, sapendo k ed l, può essere che b sia vera oppure no: ma certamente non è vera se è falsa a, come nel caso (ii) - dunque è necessario che a sia vera purché valga la legge k e si realizzi la condizione l.
Servendosi di questo modo di esprimere le varietà delle relazioni causali, Keynes dà la seguente interpretazione a quell’immagine dell’universo che Laplace ha delineato nel passo da noi citato nel § 1: supponiamo che k sia il corpo delle leggi che regolano interamente il corso dei fatti nell’universo; noi siamo autorizzati a dire che uno di tali fatti (A) è la causa sufficiente di un altro (B), solo ed esclusivamente nel caso in cui valga la relazione già discussa b/ak = 1. Noi crediamo nella validità del corpo di leggi k ed ammettiamo che una qualunque proposizione b sia vera (cioè correttamente riferita a un certo fatto B): se è cosi, deve esistere qualche altra proposizione vera a «che afferma l’esistenza di qualcosa di antecedente rispetto a B, in modo che b/ak = 1»[9]. Questo è il significato formale dell’asserzione secondo cui ogni cosa esistente possiede rispetto a qualche cosa che è già esistita in precedenza un rapporto di tipo causa sufficiente-effetto; e questa affermazione può esser sostenuta senza alcun appoggio fattuale, senza ricorso a conoscenze empiriche - infatti, nell’espressione non compaiono dati «ontologici» l. Non è dunque possibile verificare di fatto se la natura ha un corso costante o no. La tesi di Laplace è inverificabile.
§ 5. Esistono «fatti» causali?
È importante sottolineare che queste interpretazioni del nesso causale fornite da Keynes (tranne l’ultima, riguardante la Causalità Universale) comportano tutte un riferimento ai fatti; è altrettanto importante sottolineare che, d’altra parte, il rapporto causale non è mai trattato come un fatto: le sue caratteristiche compaiono solo nella forma degli enunciati. Sotto questo punto di vista possiamo dire che neppure in Keynes vi è traccia di una interpretazione della connessione tra le cause e gli effetti, che in qualche modo rimandi all’esperienza.
È anzi da notare che, essendo A e B gli eventi, nelle formule che esprimono le varietà dei rapporti causali tali lettere non compaiono mai; vi si trovano invece le lettere «a» e «b», che sono proposizioni descrittive, e si intendono riferite ai fatti A e B. Ciò che il linguaggio comune esprimerebbe dicendo «A accade», oppure «A non accade», è tradotto da Keynes in termini di verità o falsità della proposizione «a». Questo modo di trattare il problema delle connessioni causali accomuna la teoria di Keynes agli altri due punti di vista, esposti nei §§ 2 e 3.
Infatti, nell’analisi da noi fatta al § 2 di una possibile interpretazione delle frasi causali nell’ambito del linguaggio comune, il rapporto «A causa B» compariva come un modo di dire che rimanda ad accadimenti i quali fungono da tramite in mezzo ad A e B, o ad ipotesi riguardanti accadimenti aventi tale funzione. La causalità, dunque, presentava un aspetto fattuale, non però identificabile con un rapporto, ma solo con uno o più eventi; eventi allo stesso titolo che A e R. Lo stesso vale per le frasi causali quando vengano risolte in un rapporto di implicazione: A e B restano tutto ciò che vi è di fattuale nel significato della frase; il rapporto di implicazione è un segno che indica l’esclusione di una ipotesi su quattro possibili, riguardanti l’accadere o il non accadere di A e di B. Questo è il caso discusso al § 3, sia nella forma É
che nella forma ![]() .
.
Dunque, in ogni caso dei tre discussi, risulta chiaro che la connessione causale è detta di accadimenti, di fatti, senza che perciò si intenda dire che il rapporto causale è identificabile con un fatto, e meno che meno con una possibile esperienza.
È bene avvertire subito che queste tre interpretazioni non escludono la possibilità che si diano esperienze di rapporti causali; se nell’esperienza umana ci sono - come appunto ci sono- tutto va bene lo stesso. D’altra parte, deve essere chiaro che andrebbe ugualmente bene nel caso che tali esperienze non si dessero mai. Il rapporto causale potrebbe risolversi esclusivamente in un «modo di parlare» a proposito delle cose, il quale trova sul solo piano logico e linguistico una o più interpretazioni autonome, e che può dunque avere un senso ben definito senza che si supponga nulla intorno alla costituzione dell’ esperienza diretta.
Si può supporre che proprio questo sia uno dei motivi per cui fin dalla nascita della speculazione filosofica e della ricerca scientifica ci sia stata, a proposito della causalità, una oscillazione analoga a quella rilevata nei capitoli precedenti a proposito dell’unità e della identità: da una parte, la giustificata aspirazione a ridurre le varietà dei rapporti causali ad una struttura formale (non importa, qui, se puramente logica o anche metafisica); dall’altra, la naturale curiosità per le diverse forme in cui il rapporto causale può essere descritto, pensato e (così sosteniamo noi) addirittura osservato.
§ 6. Alcune tesi di Aristotile.
Anche in questo capitolo la rassegna dei punti di vista rintracciabili in autori appartenenti ad un passato più o meno lontano da noi sarà sommaria e in più punti lacunosa; ma non è nostro compito - come abbiamo spiegato all’inizio - fare della storia, bensì mostrare che possibile vedere il problema fenomenologico in una dimensione che permette connessioni con punti di vista lontani nel tempo.
Aristotile, anche a proposito di questo argomento, che nel suo sistema del
mondo occupa una posizione centrale, offre una straordinaria ricchezza di prospettive,
non solo a paragone degli uomini di scienza della sua epoca, ma di ogni epoca,
probabilmente. La «polarità» del problema delle cause (rapporto
logico - modo di essere delle cose) è formulata chiaramente da lui in
più luoghi. Nella lunga trattazione riguardante le forme del rapporto
causale che occupa gran parte del secondo libro degli Analitici Secondi è
chiaramente detto (98 b, 10) che il termine medio - nel sillogismo -
è la «causa» della conclusione, come si vede dal seguente
esempio: le piante con foglie larghe perdono le foglie - la vite ha foglie larghe:
la vite perde le foglie. «Aver foglie larghe» è il termine
medio, ed esso è indicato come la causa del fatto che la vite perde le
foglie. Questa concezione è sottintesa attraverso tutto il secondo libro
degli Analitici Secondi, e negli altri luoghi dell’Organon dove si tratta del
termine medio, o del concetto di «medio» (![]() )
)
Ma le più varie forme di connessioni tra eventi possono essere ricondotte a questa struttura ideale; e, leggendo Aristotile senza una preparazione specialistica, come è il caso di chi scrive, si ha l’impressione che l’Autore provasse una predilezione particolare per la ricerca delle varietà degli esempi e dei loro caratteri peculiari, rispetto all’istanza di una unificazione in termini rigorosi ed astratti. «Perché i Medi fecero guerra agli Ateniesi? Risposta: perché gli Ateniesi fecero una irruzione in Sardi, assieme agli Eretriesi»: in questo caso la ricerca del medio, cioè della causa, spinge Aristotile alla formulazione di un principio: è causa di guerra chi attacca per primo; «si fa guerra, infatti, contro chi ha fatto per primo ingiustizia «. I vari elenchi delle quattro cause sono spesso corredati da esempi diversi, in genere molto interessanti. Le quattro cause (materiale, formale, efficiente e finale) sono presentate più volte da Aristotile, e in contesti sempre diversi: nella Metafisica (1013 a, 2), nel secondo libro della Fisica (195 a, 5-b, 16), nel «De generatione animalium» (715 a, 4), nel «De Somnio» (455 b, 15) ecc., oltre che nel già citato punto degli Analitici Secondi. Ogni volta l’esposizione è ripensata in vista dell’argomento che le fa da ambiente, l’ordine stesso di esposizione è diverso volta per volta: occasione opportuna per trovare nuovi esempi, e mettere in luce altri aspetti delle connessioni causali. L’analisi della causa efficiente, naturalmente, presenta il maggior numero di aspetti interessanti.
Vale la pena di elencarne brevemente alcuni: (i) le catene causali possono
chiudersi in un circolo: « il lavorare è causa di buona salute,
la buona salute del lavorare» (Metaph. 1013 e) - ma nell’Organon
cita un esempio meno opinabile: l’evaporazione delle acque forma le nubi, le
nubi danno la pioggia, che causa la nuova formazione di acque; (ii) causa di
qualcosa può essere l’assenza di qualcosa: la nave capovolta per mancanza
del nocchiero; (iii) l’espressione « ciò per cui «, che può
avere «tanti sensi quanti la causa», è suscettibile anche
di un significato puramente spaziale e motorio: « si dice per indicare
la posizione: poniamo, ciò per cui uno sta o cammina»; (iv) la
causa non ha da essere una ragione generica, «come se uno chiedesse perché
c’è l’uomo» (a seconda delle lezioni ![]() )
«poiché detta la cosa cosi, semplicemente, non si determina nulla..,
si rischia di chieder qualcosa e insieme non chieder nulla» (1041 b,
2); occorre che essa esprima un rapporto tra qualcosa e qualcosa; (v) nei
fenomeni naturali, causa efficiente e causa finale possono agire insieme: in
questi casi la causa efficiente rivela il suo carattere di necessità:
necessità che può essere « per natura « o «
per costrizione «, e la costrizione è definita come la forza
che contrasta la necessità naturale (Anal. Post. 95 a, 1):
questo luogo è di estremo interesse per noi, per due motivi: primo, perché
la « necessità della causa efficiente non compare affatto come
una necessità logica, ma come una forza naturale; secondo, perché
costituisce il punto di connessione tra la teoria della causalità e la
teoria della trasmissione del moto, di cui dovremo occuparci più volte
in questo capitolo.
)
«poiché detta la cosa cosi, semplicemente, non si determina nulla..,
si rischia di chieder qualcosa e insieme non chieder nulla» (1041 b,
2); occorre che essa esprima un rapporto tra qualcosa e qualcosa; (v) nei
fenomeni naturali, causa efficiente e causa finale possono agire insieme: in
questi casi la causa efficiente rivela il suo carattere di necessità:
necessità che può essere « per natura « o «
per costrizione «, e la costrizione è definita come la forza
che contrasta la necessità naturale (Anal. Post. 95 a, 1):
questo luogo è di estremo interesse per noi, per due motivi: primo, perché
la « necessità della causa efficiente non compare affatto come
una necessità logica, ma come una forza naturale; secondo, perché
costituisce il punto di connessione tra la teoria della causalità e la
teoria della trasmissione del moto, di cui dovremo occuparci più volte
in questo capitolo.
Particolare importanza hanno le riflessioni aristoteliche sulle condizioni temporali del rapporto tra causa ed effetto; occorre aggiungere al nostro elenco a questo proposito, ancora i seguenti problemi: (vi) causa ed effetto possono essere rigorosamente contemporanei, e durare insieme nel tempo (l’eclisse, in cui causa è la frapposizione di un’astro tra altri due; oppure: scende la temperatura, l’acqua diventa ghiaccio) (Anal. Post. 95 a, 13); (vii) se invece vi è successione tra causa ed effetto, deve esserci un intervallo: può essere definito oppure è indefinito? Cioè, devono essere la causa e l’effetto temporalmente in contatto? La difficoltà nasce per molti motivi, non ultimo il seguente: una causa passata può provocare un effetto futuro? (95 a, 24-29 b, 37). Ciò che Aristotile scrive a questo proposito rasenta prospettive scettiche, vicine a quelle di Hume: «sia che l’intervallo di tempo tra la causa e l’effetto risulti indeterminato, sia che risulti definito, non sarà mai possibile giungere alla conclusione che, in quanto è vero l’affermare che un certo oggetto è divenuto, risulta pure vero l’affermare che un altro oggetto è divenuto in un tempo posteriore». Questa difficoltà conduce Aristotile dal problema della connessione causale al problema della continuità: la tesi che egli sembra proporre è riassumibile (forse) in questi termini: un rapporto causale va inteso nella sua interezza, perché gli avvenimenti devono essere considerati come oggetti indivisibili, una volta accaduti. Mentre una trasformazione avviene può essere considerata attimo per attimo, ma una volta accaduta non più. Questa teoria va ricondotta a quella esposta nel capitolo terzo intorno alle (antiche) teorie dell’identità. Scrive infatti Aristotile: «all’oggetto che diviene sono infatti immanenti infiniti oggetti che sono divenuti», e rimanda il lettore (o ascoltatore) ai libri della Fisica, vedi i passi da noi commentati altrove. Per quanto riguarda il futuro, inoltre (viii) vi può essere azione dal futuro verso il passato: la causa finale agisce in questo senso: «perché costui passeggia? - al fine di godere buona salute «.
Due altri punti di rilievo: (ix) esistono connessioni causali meramente probabili (che si verificano « per lo più «), e (x) oltre alle cause, esistono concause. Con questa ammissione (che risale almeno a Platone, però, vedi il « Politico «, 281 a) ci si avvicina di molto al moderno concetto di variabile, mentre viene indicata con chiarezza la natura asimmetrica del rapporto di causalità: « sussistendo la causa è necessario che si presenti l’effetto, ma sussistendo l’effetto, non è necessario che si presenti tutto ciò che ne è la causa « (98 b,-29). (Trad. G. Colli).
In proporzione, è ben poco ciò che è stato fatto dopo Aristotile, se si pensa a quanto gli è riuscito di dire già allora, in materia di cause e di effetti. Ciò che più di tutto sorprende, è che ogni aspetto da lui attribuito a qualche forma di rapporto causale è suscettibile di esemplificazione: è, in breve, un aspetto del mondo tuttora rintracciabile nelle nostre esperienze, e spesso ostensibile. E non ha alcuna importanza se l’Autore in tendeva parlare di quanto noi oggi chiameremmo il mondo della fisica, anziché di ciò che classifichiamo come dato fenomenologico: la fisica non era nata, tranne che per poche proposizioni, e per tutto il resto finiva coll’essere appunto una descrizione del mondo esperito.
Dato che nel prossimo capitolo dovremo trattare delle ricerche di Michotte sulla causalità meccanica, occorre aggiungere a queste tesi generali sui rapporti causali alcune tesi particolari sulla natura e la trasmissione del moto che ad esse si collegano.
Nella «Fisica» viene esposta la teoria dell’«antiperistasi»; è una teoria connessa al moto degli oggetti, classificato nelle due forme di moto naturale e moto forzato, o violento: tale classificazione dipende dalla distinzione già citata poco fa dagli Analitici Secondi (95 a, 1) ed è trattata nel quarto libro della Fisica (215 a, 1). Un mobile si muove secondo natura quando percorre la traiettoria più breve verso il suo luogo naturale: il fuoco verso i cieli, cioè verso l’alto, i corpi verso la terra. Si muove di moto violento quando percorre qualsiasi altra traiettoria differente, venendosi dunque a trovare in contrasto con le forze del moto naturale.
Come si danno questi casi? Fondamentalmente in due modi: la spinta, e il lancio.
La spinta (Phys. 258 a, 6 - 258 b, 3). Un esempio è questo: spingo con una mano un oggetto per un certo tratto di strada; i cavalli che tirano il carro; l’uomo che spinge una slitta, ecc. Vi è qui un trasferimento di forze da ciò che muove a ciò che è mosso: vi è, dei due mobili che formano un tutto solidale, uno che agisce, l’altro che subisce l’azione: «È manifesto scrive Aristotile; e questo ![]() ce lo dovremo ricordare parlando degli esperimenti di Michotte - che il tutto si muove non perché ciascuna delle sue parti ha la facoltà di muovere se stessa, ma si muove tutto insieme da sé, il mosso e il motore, perché vi è quello che muove e quello che è mosso. Non è la totalità della cosa, che è mossa, nè la totalità della cosa che è motrice: ma da una parte soltanto A muove, e, dall’altra parte, solo B è mosso» (258 a 21-27)[10].
ce lo dovremo ricordare parlando degli esperimenti di Michotte - che il tutto si muove non perché ciascuna delle sue parti ha la facoltà di muovere se stessa, ma si muove tutto insieme da sé, il mosso e il motore, perché vi è quello che muove e quello che è mosso. Non è la totalità della cosa, che è mossa, nè la totalità della cosa che è motrice: ma da una parte soltanto A muove, e, dall’altra parte, solo B è mosso» (258 a 21-27)[10].
Finché i due oggetti sono in contatto, dunque, uno dei due comunica il movimento all’altro, che lo subisce. Questo ultimo si muove perché viene mosso. Già Platone aveva indicato nella polarità attivo-passivo una caratteristica della connessione causale, nell’«Eutifrone» (10 a, b, c) analizzando l’uso del participio attivo e del participio passivo, e nell’«Ippia Maggiore» (297 a, 2 - b, 6) sostenendo che gli eventi non possono mai essere causa di se stessi, dato che la causalità è un rapporto tra un agente e un paziente. Nel caso della spinta, attività e passività sono contemporanee, e la seconda dura finché dura la prima.
Il lancio (Phys., 266 b, 28 - 267 a, 20). Il lancio è difficile da capire, perché in esso il movimento passivo dura anche dopo che il movimento attivo (causa) è estinto. Occorrerebbe dunque introdurre un nuovo principio. Oppure, e questa è la soluzione prospettata, bisogna ridurre il lancio alla teoria della spinta.
Per fare questo occorre postulare che: a) il lancio sia possibile solo attraverso un mezzo (acqua, aria), non nel vuoto; b) che il moto durante la traiettoria sia in realtà discontinuo, mentre è apparentemente continuo; c) che nel passaggio dal motore al mosso una parte della forza motrice vada perduta - affinché si possa giustificare, alla fine, l’estinzione del movimento.
L’oggetto lanciato, dunque, una volta che si è staccato dalla mano che l’ha spinto non è più in contatto con una sorgente di movimento attivo; però, muovendosi, comprime l’aria davanti a sé e crea una depressione dietro a sé; la depressione di colpo si riempie d’aria, a spese della compressione, e il corpo riceve un nuovo urto - dietro - paragonabile a quello che aveva ricevuto all’inizio dalla mano. Nello stesso tempo urta lui stesso, cioè comprime, l’aria davanti.
Cosi, è un moto discontinuo, ma sembra continuo (267 a,13): è fatto da una serie di controspinte. Dato che a un certo momento finisce, si deve supporre che le spinte diventino progressivamente più deboli, finché ve n’è una talmente debole che il successivo oggetto (sia esso il mezzo, o il proiettile) non si sposta per nulla: vuoi dire che il penultimo motore «non rende il successivo motore, ma soltanto mosso».
In questo modo viene giustificato l’arresto.
La spinta può del resto manifestarsi in altri modi diversi, oltre che come spinta e lancio: cioè come trazione e come attrazione (per cui viene usato un curioso esempio: il pezzo di legno che attira il fuoco). Quest’ultimo tipo di rapporto causale presuppone - forse - l’idea di azione a distanza.
Queste teorie avanzate da Aristotile nel campo della cinematica sembrano sottendere un punto di vista per il quale le connessioni causali esistono «in rerum natura». Nel caso della spinta, vi è un attuale trasferimento di forze dall’agente al paziente; nel caso del lancio, addirittura è possibile analizzare concettualmente tutto un gioco di simili forze, rapidamente alternantisi, che però non appaiono all’osservatore.
Il fatto che Aristotile dica che in questo caso «non appare»
la discontinuità, fa pensare che nel caso della spinta il rapporto attivo-passivo
appaia; e questo rafforza il significato del ![]() citato prima.
citato prima.
§ 7. Sesto Empirico.
In breve, dall’insieme delle cose riassunte in queste ultime due pagine, ci sembra che sia possibile dire - senza tradire troppo la verità - che le connessioni causali, per Aristotile, non solo esistono come fatti, ma certe volte possono perfino apparire, ed altre no. E che, dal punto di vista della dinamica, la loro caratteristica fondamentale è il rapporto tra attività e passività quello che caratterizza la posizione dell’effetto rispetto alla sua causa.
Al polo opposto si trova senza dubbio Sesto Empirico. Tra gli Autori antichi è, dopo Aristotile, quello che più direttamente può interessare lo studioso d’oggi, per la netta distinzione che egli fa tra l’ordine dei dati esperibili e quello degli oggetti transfenomenici. Può darsi che le sue critiche al concetto di causa dipendano dal puro e semplice desiderio di corrodere ogni opinione professata dai dogmatici; ma il fatto che abbia affermato che tuttavia forse qualche forma di causalità c’è, nel mondo (Lib. III, 17) - dopo aver escogitato o raccolto dai maestri alcune critiche molto serie a tale concetto - fa pensare che le sue riflessioni al proposito non fossero sempre solo un esercizio di raffinata sofistica. Ciò che a noi interessa soprattutto, è che nello svolgimento delle sue critiche Sesto fa più volte riferimento ad una divisione ben netta tra rapporti causali esistenti fra dati sensibili, quelli esistenti fra fatti che non cadono sotto i sensi, e quelli che collegano qualche membro appartenente a uno di questi due ordini difatti all’altro. Nel primo libro degli «Schizzi Pirroniani» egli riferisce gli otto argomenti di Enesidemo contro la causalità; tra essi, il primo dice che addurre cause le quali non siano dati sensibili vuoi dire sottrarsi alla possibilità di trovare conferme attendibili per le proprie ipotesi; il quarto, che i dogmatici «percependo come accadano le cose sensibili credono di aver percepito, anche, come accadano quelle che non cadono sotto i sensi, mentre le cose che non cadono sotto i sensi forse si compiono in modo uguale alle cose sensibili, e, forse, in modo non uguale»[11]; il settimo dice che i dogmatici «spesso adducono delle cause che contrastano non solo con i fenomeni, ma anche con le loro proprie ipotesi». Queste tesi sono importanti dal punto di vista che ci interessa come studiosi dell’esperienza immediata, e soprattutto non vanno sottovalutate quando si tenga presente che per Sesto Empirico di ogni cosa è possibile dubitare, tranne che dei dati sensibili, reali in quanto apparenze. Se nella sua concezione del mondo c’è un minimo di logica (e sembra che veramente ci sia) occorre concludere che a volte possa darsi una conoscenza delle cause, ma limitatamente alle cause intercorrenti tra dati sensibili, senza che queste ci offrano la possibilità di risalire ad ordini di cause tranfenomenici, costitutivi della «sostanza» del mondo. Ciò che conduce all’errore è il fatto di pensare il mondo al di là dei dati esperibili come se fosse tenuto insieme da legami uguali a quelli che si possono rintracciare tra questi.
Dunque Sesto Empirico prende di mira soprattutto la possibilità di formare concetti causali attendibili e generalmente applicabili. Nel terzo libro degli «Schizzi» [12] (20-21) vi è, a questo proposito, una critica di notevole interesse: capire il rapporto di causa ed effetto diventa impossibile analizzando a parte ciascuno dei due: la causa infatti è tale solo in rapporto al suo effetto, e l’effetto è tale solo per l’esistenza della causa. Ma per capire il rapporto, sostiene Sesto, occorre prima capire i suoi termini. Naturalmente, lo sbaglio sta qui[13]; l’antico scettico però non lo poteva sapere.
Infine (Adv. Dogm., III, 233-236), un motivo per non credere all’esistenza di rapporti causali fuori del mondo delle apparenze viene trovato nella difficoltà - già incontrata da Aristotile, ma da lui aggirata seppure non senza sforzo - di stabilire le connessioni temporali tra causa ed effetto: se hanno luogo contemporaneamente, come si fa a sapere quale è la causa e quale l’effetto? Se la prima precede intieramente il secondo, dato che quando questo comincia quella non e già più, come potrà causarlo? Quanto alla causa finale, «è sciocco pretendere che ciò che ancora non è, sia causa di ciò che ormai è».
Critiche indubbiamente assai penetranti, e formulate con lucidità eccezionale; le quali, a dispetto dei millecinqueceuto anni di dispute intorno alla causalità giacenti nel mezzo, ci mettono in grado di affrontare subito le idee di Davide Hume, altrettanto notevoli per drasticità e chiarezza.
8. La critica di Hume.
Le affinità intercorrenti tra Hume e Sesto Empirico riguardano tre punti che dovremo tenere presenti: 1) la distinzione netta e senza sfumature come del resto deve essere tra l’ordine dei dati immediati e l’ordine delle cose o degli eventi che possono essere pensati al di là di essi; 2) il fatto che il rapporto causale, se ha qualche parvenza di plausibilità quando è riferito ai dati sensibili, quando sia riferito agli eventi del mondo transfenomenico, più lo si considera e meno persuade; e 3) il fatto che secondo tutti e due, la critica alla possibilità di trovare il rapporto causale è fondata sull’assunzione elementaristica secondo cui l’evento «causa» e l’evento «effetto» debbono essere analizzati separatamente; il che - naturalmente conduce a non scoprire alcuna connessione.
Però, tanto il pensiero di Sesto è scheletrico, schematico e probabilmente in più punti non originale, tanto le idee di Hume sono duttili, ricche di risvolti e di originalità. In qualche punto, si presentano in modo lievemente contraddittorio; ma è sempre - come nel caso della discussione sull’identità svolta all’inizio del terzo capitolo - per tenere ferma da una parte la coerenza della teoria, riconoscendo dall’altra che le esperienze non sono del tutto congruenti con essa.
Non è qui il luogo adatto per ripetere gli argomenti di Hume che permettono una divisione netta tra tutto ciò che è attribuibile al mondo transfenomenico (o ciò che crediamo di esso) e gli eventi che sono oggetto di esperienza (impressioni e idee): il lettore può trovarli nella Sezione Seconda della quarta parte del Trattato. Ciò che importa a noi, nell’economia della presente trattazione, è il fatto che tale distinzione si riflette nella teoria humiana della causalità: infatti, Hume tratta separatamente il problema della connessione causale come rapporto riferibile agli eventi futuri, trascorsi o accadenti altrove, cioè, in breve, fuori dalla portata di un osservatore, rispetto al problema della causalità tra dati attuali dell’esperienza, o tra idee, ecc.
La soluzione che egli dà al primo problema è celebre, e può essere riassunta in breve, anche se nella sua opera è trattata con dovizia di dettagli. Se si ammette che la mente umana non sa già tutto, ma viene imparando via via qualcosa dall’esperienza per mezzo di osservazioni - naturalmente eseguite in determinati momenti, nel tempo - ; e posto che nell’universo vi siano due classi infinite di fatti A e B, con per membri rispettivamente «a1,a2 a3, a4, a5...an...», e «b1, b2, b3 b4, b5... bn...» la constatazione ripetuta quante volte si voglia di successioni del tipo «a1-b1», «a2-b2», «a3-b3», ecc. non permette di concludere che tutti gli «a» sono invariabilmente seguiti da qualche cioè non autorizza la generalizzazione
![]()
in breve, gli enunciati circa il futuro, circa il passato, e, in genere, a proposito di eventi diversi da quelli realmente osservati, non risultano inferenzialmente fondati. Questa è la tesi che svegliò Kant dal suo «sonno dogmatico «, e che lo indusse a cercare se e come siano possibili i giudizi sintetici a priori. Da notare che ancora oggi molti studiosi sono d’accordo nel ritenere che la difficoltà avanzata da Hume è insuperabile, per lo meno nella forma ora esposta, e che dunque le leggi riguardanti gli eventi transfenomenici debbono sempre possedere la forma di leggi probabilistiche, anche quando sono suscettibili di una generalizzazione astratta di tipo ipotetico-deduttivo.
Questa tesi di Hume poggia, naturalmente, sul fatto che l’uomo può compiere osservazioni, e, in particolare, sul fatto che può compiere osservazioni di coppie di eventi del tipo «a-b», muovendo dalle quali poi è tentato di generalizzare. Questo è il punto in cui il problema episteinologico si identifica con il problema psicologico. Hume svolge una teoria della conoscenza ed una psicologia delle operazioni mentali escludendo del tutto ogni possibilità di conoscenze, o idee, innate. Per questo, se un’idea astratta che l’uomo utilizza è sensata, deve trovare la sua base nell’esperienza. L’esperienza, qui, va intesa in senso abbastanza largo, come si vedrà; ma la sua regione più attendibile ed epistemologicamente privilegiata è l’esperienza sensoriale: modello delle idee: «le idee complesse possono, forse, esser bene conosciute per via di definizione, la quale non è se non l’enumerazione di quelle parti o di quelle idee semplici che la compongono; ma quando avremo spinto le definizioni fino alle idee più semplici, e troviamo ancora delle oscurità e ambiguità, qual espediente mai possediamo? Quale mezzo inventeremo per illuminare queste idee e renderle precise e determinate interamente per la vista del nostro intelletto? Non vi è altro che presentare le impressioni e le sensazioni originali dalle quali sono copiate le idee «. La struttura della percezione è dunque trattata come il banco di prova dell’attendibilità dei concetti: per questo «derivando le idee da impressioni, ossia da percezioni, noi non possiamo avere un’idea di potere o efficacia, a meno che uno non ci metta innanzi un esempio in cui quel potere lo si percepisca nel suo attuarsi»[14]. L’epistemologia della causalità si pone dunque, all’inizio, come un problema di psicologia sperimentale: c’è o non c’è l’impressione del rapporto causale, nell’esperienza immediata?
La risposta di Hume a tale quesito viene a dipendere assai più dai principii generali della sua teoria della sensazione, che non dall’osservazione. Per questo la risposta è negativa. Abbiamo illustrato quei principii nella prima parte di questo libro, e nel primo capitolo della seconda parte. Secondo una teoria elementaristica delle sensazioni, la percezione di un rapporto è un controsenso: i rapporti sono pensati, saputi, ed eventualmente proiettati con maggiore o minore utilità sulle sensazioni di per sé irrelative. Illusoriamente crediamo che siano un dato d’esperienza. La logica di questi assunti permetterebbe di concludere subito che non vi è esperienza diretta di rapporti causali.
L’analisi di Hume però procede per più tappe, di modo che in esse possiamo vedere l’illustrazione di un metodo di lavoro, oltre che i passaggi obbligati legati a date premesse.
Come Sesto Empirico, Hume prova a scoprire l’esistenza del rapporto causale analizzando separatamente il fatto A che potrà diventare «causa» e il fatto B che potrà diventare «effetto» isolandoli, perciò, ed annullando l’eventuale rapporto che si potrebbe scoprire tra essi. Naturalmente conclude: «non c’è niente in un oggetto che ci possa persuadere ch’esso debba sempre esser lontano o contiguo a un altro»[15]; «non esiste nulla nell’oggetto nè esternamente nè internamente, che non si possa considerare come causa o come effetto, sebbene sia evidente che non c’è nessuna qualità che appartenga universalmente a tutte le cose e dia loro diritto a questa denominazione» [16]. In sé, gli oggetti non sono né cause nè effetti: li chiamiamo così solo per una certa collocazione spaziotemporale che possono reciprocamente assumere : la contiguità: uno di essi infatti non potrebbe agire su un altro «se tra essi ci fosse il minimo intervallo di tempo o di spazio»[17]. Se tale contiguità non è constatabile, «presumiamo che esista». Oltre alla contiguità, è necessario che la causa preceda temporalmente l’effetto. Hume non ammette situazioni di causalità come quelle discusse da Aristotile, in cui causa ed effetto sono contemporanei, come la spinta, la trazione, l’acqua che è ghiaccio finché la temperatura è bassa. Analizzati bene, anche questi casi rivelerebbero un rapporto «prima-dopo»; ma Hume aggiunge che ha poca importanza se ci si trova o no d’accordo con lui su questo punto.
Tranne questa collocazione spaziotemporale, non c’è altro che possa esser chiamato «rapporto causale». «Il movimento di un corpo è considerato come la causa, in seguito a un urto, del movimento di un altro corpo. Considerati questi oggetti con la massima attenzione, trovo che l’uno si avvicina all’altro, e che il suo movimento precede quello dell’altro, sebbene senza un sensibile intervallo. Inutile torturarsi con ulteriori pensieri e riflessioni : qui è tutto quello che si può osservare in questo caso»[18]; «osservare»: non c’è dubbio che Hume si stia riferendo ai dati dell’esperienza diretta, cioè non c’è dubbio che stia ponendo un problema di psicologia; nei «Saggi morali, di politica e di letteratura» egli scrive: «quando guardiamo intorno a noi gli oggetti esterni (we look about us towards external objects) e consideriamo l’operazione causa-effetto... troviamo solo che un evento effettivamente, in realtà, (actually, in fact), segue l’altro. Il colpo di una palla da biliardo è accompagnato dal movimento dell’altra. Questo è tutto ciò che appare nei sensi esterni (outward senses). La mente non avverte intanto alcun sentimento, o impressione interna, da tale successione di oggetti» (V, II, 52).
Questo è il punto di capitale importanza. Ci soffermiamo a sottolinearlo affinché si veda bene che il problema empirico («cosa c’è, fenomenicamente, nel rapporto detto causale? la causalità fa parte dei dati d’osservazione?») è direttamente connesso con il problema epistemologico, benché torni a volte comodo considerarli come separati. Il problema di Hume - e in genere di chi voglia elaborare un punto di vista epistemologico che tenga conto dell’atto di osservazione - è un puro problema di psicologia della percezione; ma indistinguibile da un problema di teoria della conoscenza.
Questa soluzione negativa - secondo la quale nell’osservazione non vi è nulla più che contiguità - è del tutto personale, di Hume, e nasce più dalla teoria che dall’osservazione. Per caso, un altro filosofo interessato al problema della causalità non meno di Hume, cioè Malebranche, ha lasciato una testimonianza del tutto opposta, e proprio a proposito delle palle da biliardo. Nel quindicesimo «Eclarcissement», alla «Recherche de la Verité» (Libro XVI, 2, III) ebbe a scrivere: «quando vedo una palla che urta un’altra i miei occhi mi dicono, o sembra mi dicano, che essa è veramente c a u s a del movimento che le imprime». Come teoria generale, Malebranche sosteneva che la materia, per sé, è inerte: ma il fatto che i suoi vari pezzi risultino connessi da legami causali sta a dimostrare che c’è una causa iniziale, al principio. Egli aveva tutto l’interesse a sostenere che la causalità si vede: esattamente come Hume, il quale aveva tutto l’interesse a dire che tale rapporto, per i sensi, non c’è. Non, con questi argomenti, che l’uno o l’altro sarebbero riusciti a dimostrare che la causalità metafisica esiste o meno; ma era sempre un po’ d’acqua al mulino. Però, hanno posto un problema di fatto, e tale da poter essere risolto; un problema di fatto, inoltre, che sottende alcune conseguenze, proprio per essere nato da una tesi teorica.
A Hume, tuttavia, non basta stabilire che non si vede nulla. Che cosa si sarebbe dovuto vedere? Per esempio, l’esercizio di una forza, un passaggio di energia (efficacia, azione, potenza: tutti sinonimi, dice Hume). Ma, date le premesse, non è possibile dare esempi di «percezione della forza», e «possiamo con-chiudere che è impossibile mostrare con un esempio quel principio in cui è riposta la forza e l’azione di una causa»[19].
Un barlume di successo si incontra tentando di definire la natura della «necessità», intesa come carattere distintivo del rapporto causale. Non, naturalmente, della necessità obiettiva (è escluso che questa ci sia); ma piuttosto della «necessità» come dato psicologico non percettivo, interiore: «non possiamo farci la più lontana idea di essa, considerata come qualità dei corpi «, «non esiste un’impressione, trasmessa dai sensi, che possa dar luogo a quest’idea»[20]; è, invece, uno stato d’animo che accompagna l’atto di assistere a un certo evento.
Questo atteggiamento interno ha luogo quando si siano constatate molte volte connessioni del tipo «a-b». I sensi ci mostrano un caso alla volta; ma «la memoria ci presenta una moltitudine di quei casi nei quali troviamo sempre ugualmente corpi, movimenti o qualità simili in rapporti simili». E «l’intelligenza o l’immaginazione può trarre conseguenze dall’esperienza passata senza rifletterci su, anzi, senza bisogno di formulare nessun principio in proposito o ragionare su di esso»[21].
Si tratta della formazione di una abitudine. Questa abitudine ha però una conseguenza importante, sull’atto stesso dell’osservazione; infatti, da essa nasce l’attesa.
Questo è uno di quei punti in cui Hume brilla per la sua onestà di osservatore: dopo aver ripetuto parecchie volte che le connessioni «a-b» possono ripetersi innumerevoli volte senza che ad esse si aggiunga nulla di nuovo, ripresentandosi identiche (e ciò è essenziale alla sua teoria), ora dice: «la ripetizione non è sempre la stessa (dopo molti casi), ma produce un impressione nuova e, in questo modo, l’idea che si cerca (l’impressione originale di «necessità»). Infatti, dopo frequenti ripetizioni vedo che dall’apparire di uno degli oggetti la mente viene determinata dall’abitudine a rappresentarsi quelIo che suole accompagnarlo, e a considerarlo tanto più fortemente nel suo rapporto col primo oggetto. È, dunque, quest’impressione o determinazione che mi dà l’idea di necessità»[22].
Tanti più sono i casi constatati, tanto più forte è l’impressione; diminuisce la sua intensità se, accanto a casi positivi se ne presenta anche qualcuno negativo, oppure se la somiglianza tra i casi non è esatta, oltre che per lacune nella memoria[23]. In rapporto a questo problema, ci si imbatte anche in una tesi piuttosto sconcertante: secondo Hume, due serie di ripetizioni con eguale numero di connessioni «a-b» non dànno la medesima impressione di necessità soggettiva se una di esse è costituita da casi incontrati casualmente, involontariamente, e l’altra da casi volontariamente prodotti dal soggetto. Un’esperienza riprodotta più volte per volontà di chi la prova, ha, secondo Hume, il valore dimostrativo di una esperienza sola. Non che un’esperienza sola non dimostri nulla; anzi: «Noi possiamo giungere alla conoscenza di una causa particolare coll’esperienza anche di un unico caso, se procediamo con accorgimento e dopo una accurata rimozione dì tutte le circostanze estranee e superflue»[24]. Ma con o senza questi accorgimenti, la ripetizione provocata ha il valore di un caso solo. Quella non provocata, aumenta l’attendibilità della legge. L’epistemologia di Hume è indubbiamente notevole.
Dunque, in qualche modo l’esperienza della causalità esiste. Evidentemente Hume non è quel pensatore lineare che una lettura affrettata potrebbe far credere. Esclusa la causalità metafisica, esclusa la causalità come esperienza immediata, resta l’impressione di attesa, che può assumere la forma di «impressione di necessità»; il fatto atteso non è necessario che si presenti, ma l’attesa si; a un certo punto l’idea del fatto «a» è necessariamente connessa con l’idea del fatto «b», segua o no la realtà la traccia indicata da questo legame.
Alla fine del Trattato infatti, Hume dà atto al lettore della legittimità di un tale sospetto. «In quanto alla causalità, sì noti che lo spirito umano è veramente da considerare come un sistema di differenti percezioni, o differenti esistenze, legate insieme dal rapporto di causa ed effetto, le quali si generano reciprocamente, si distruggono, influenzano e modificano l’una l’altra. Le nostre impressioni fanno sorgere idee corrispondenti, e queste alla lor volta generano altre impressioni. Un pensiero ne caccia un altro, trascina con sé un terzo, dal quale è a sua volta espulso». «Qualunque cambiamento (l’anima) subisca, le sue parti sono sempre connesse dal rapporto di causalità «.
La critica di Hume, dunque, non esclude la causalità in modo assoluto dal mondo delle esperienze. Il rapporto causale non ha luogo tra eventi percepiti, ma potrebbe aver luogo tra impressioni e idee, e certamente ha luogo tra idee e idee. Le accuse di Maine de Biran, che vedremo, sono in parte certamente infondate. Vero è che la natura di questa connessione non è specificata in alcun luogo, nell’opera del filosofo inglese; ma se ne potrebbe inferire, forse, che per lui non c’era alcun bisogno di spiegare il rapporto causale tra stati interni: per capirne la natura, basterà osservarlo. È infatti quello che è.
§ 9. Maine de Biran.
Questa conclusione, se è giusta, colloca Hume in una posizione meno lontana di quello che a prima vista può sembrare, rispetto agli oppositori suoi contemporanei (come Charles Bonnet) o di poco successivi (come Engel o M. de Biran): per essi infatti, è l’esperienza interna - trovata introspettivamente - che fornisce il modello del rapporto causale, il quale poi può venire ravvisato nel mondo esterno.
Nel capitolo sedicesimo del Philaléthe Charles Bonnet scrive: «So intimamente che posso muovere, e difatti muovo, il mio corpo o le sue differenti parti, che posso spostarmi e mi sposto da un luogo all’altro, e posso vincere e a volte vinco la resistenza opposta da differenti corpi. Da questa varietà di azioni - di cui ho conoscenza - inferisco la noziolie generale di causa ed effetto». La stessa tesi, con grande ricchezza di argomenti, fu sostenuta da Engel in una memoria letta nel 1801 all’Accademia di Berlino, sull’origine dell’idea di forza; Engel dice che Hume ha cercato la percezione della causalità in una direzione sbagliata: non è tra i dati visivi o acustici che intercorre il legame di causa ed effetto: esso ha, infatti, un suo «proprio senso», che è quello «muscolare» (cioè, diremmo oggi, una parte del sistema propriocettivo). Un rapporto di causa ed effetto direttamente esperibili si instaura quando esercitiamo una azione contro un oggetto esterno resistente : la causa è il senso dell’azione, e l’effetto il senso della reazione, ambedue presenti come dati sensibili; la «vera essenza» della forza consiste nel fatto di avvertire e valutare una forza esterna, nel mettersi in conflitto «d’azione» con una forza esterna che oppone resistenza. Mentre rompiamo un bastone nelle mani, noi avvertiamo benissimo - senza la mediazione di ragionamenti, misurazioni, ecc. - la resistenza della forza di coesione dell’oggetto di fronte allo sforzo muscolare esercitato, ed anche il fatto che a poco a poco la prima cede a quest’ultimo. Un rapporto analogo non è, però, esperibile tra l’atto di volontà che guida l’esecuzione materiale di una azione e lo sforzo muscolare impiegato in essa: «noi abbiamo la rappresentazione di una determinazione della volontà, in sé; l’abbiamo anche del movimento dei muscoli, in sé... la sola cosa che ci manca è la rappresentazione della connessione o complicazione delle due cose «.
Maine de Biran non è d’accordo, qui, ed anzi la sua tesi si sviluppa esattamente in opposizione a quella di Engel. L’argomento è trattato in vani luoghi delle sue opere, ma in particolare nel Saggio sui fondamenti della Psicologia, e sui suoi rapporti con lo studio della Natura[25]. Ciò su cui egli è d’accordo con Engel e Bonnet è la tesi di fondo: accettare o no l’opinione di Hume non dipende dall’accettare una teoria o un’altra; se la causalità sia un dato esperibile è un problema empirico. Assumere fin dall’inizio una definizione astratta della causalità equivale a «mettere una specie di entità logica al posto di un fatto»; d’altra parte limitare la definizione della causalità come connessione tra fatti a un sistema di rapporti di contiguità spaziotemporale significa svisare «il valore che tale principio conserva sempre, sia pure a nostro dispetto, in fondo alle nostre esperienze interne». La teoria di Hume non va discussa, su questo punto, perché quello delle connessioni causali è un problema di mostrare, non di dimostrare. Se non si è accorto dell’esistenza percettiva dei rapporti causali «occorrerà rendergli l’uso di un senso che ha perduto».
Lo sbaglio di Engel, invece, va trovato nel fatto che egli identifica il paradigma del rapporto causale in una connessione esperibile (sforzo-resistenza) che già per conto suo deriva tale carattere da un’esperienza più elementare, appunto quella del rapporto tra volontà ed esecuzione.
Il primo esempio di sforzo consiste nel vincere con la volontà l’inerzia dell’apparato muscolare; ma è sbagliato parlare di volontà in sé e di risultato motorio in sé: «non esiste alcuna apperceziorie interna di una determinazione della volontà in sé al di fuori dal suo esercizio... come non vi è alcuna percezione di movimenti volontari in quanto tali, al di fuori dal senso della forza che li determina.., solo il loro composto è percepito».
Questo paradigma è poi applicabile a relazioni intercorrenti tra le
nostre membra e gli oggetti esterni, e successivamente, anche all’azione intercorrente
tra oggetti esterni : «Un essere che non avesse mai compiuto uno sforzo
non potrebbe avere, in realtà, alcuna idea della forza, né, per
conseguenza, della causa efficiente; vedrebbe i movimenti succedersi l’uno all’altro,
per esempio una biglia toccare e spostare un’altra biglia, senza concepire né
poter applicare a questo seguito di movimenti la nozione di causa efficiente,
o di forza in atto, che noi crediamo necessaria a che la serie possa avere inizio
e seguito». La percezione del rapporto causale come connessione tra fatti
giacenti nel mondo esterno è possibile, dunque, ma è sempre la
proiezione di una esperienza che all’inizio si è prodotta tra regioni
del nostro mondo interiore, in occasione di un atto volontario; «è
da tale impressione originaria di sforzo che nasce ogni idea di forza o di causazione».
§ 10. Bergson e Sommer.
Può essere interessante far notare quanto d’accordo con Maine di Biran si sia trovato, un secolo dopo, Bergson. È difficile dire se Bergson, mentre scriveva le riflessioni che citeremo tra poco avesse presente il punto di vista del suo illustre predecessore; in ogni caso, non menziona il suo nome: e dato che sarebbe stato ovvio farlo, a proposito di un tale argomento, siamo autorizzati a credere che le sue idee siano il frutto di osservazioni occasionalmente compiute da lui stesso sull’accadere delle connessioni causali. Come intorno a parecchi altri argomenti, il filosofo francese anche in quest’occasione sembra segnare l’esatto punto di trapasso tra teoria psicologica non ancora sperimentalmente controllata e la fase dei possibili controlli sperimentali; va notato, inoltre, che egli non si limita a dire che la percezione della causalità esiste ed ha le tali e talaltre caratteristiche, ma chiaramente accenna alla possibile genesi del concetto formalizzabile di causalità dal dato direttamente esperito, percorrendo in ciò la tesi della «prefigurazione» di Michotte (vedi Cap. VI § 13).
Non è, secondo Bergson, il giudizio a imporre connessioni causali tra i fatti osservabili[26], ma «la relazione dinamica che corre tra la causa e l’effetto, e la determinazione necessaria dell’effetto da parte della causa, sono sentite e vissute ancora prima di essere pensate».
«Ma una volta che si sia instaurata tale relazione stabile tra la forma visibile dell’oggetto ed il suo eventuale contatto con il nostro corpo, come non conservare una identica relazione tra tale forma visibile e il suo possibile contatto con i corpi in generale? Il nostro corpo, dopo tutto, è un oggetto come tutti gli altri. Quando l’oggetto che noi vediamo andrà a toccare un altro oggetto visibile attribuiremo a tale contatto lo stesso significato dinamico, e al movimento risultante la stessa determinazione necessaria che hanno luogo quando l’oggetto tocca il nostro corpo, quando eccita la nostra attività motoria e provoca ... una reazione attesa e necessaria. La legge della causalità, nella sua originaria spontaneità e semplicità, non dice altro che questo. Dice che ogni oggetto è una causa, intendendo con ciò che ogni forma visiva determinata è suscettibile di prolungarsi in un contatto, in una resistenza e in un impulso determinati, essendo il rapporto tra il primo ed il secondo termine lo stesso di quello che intercorre tra le nostre sensazioni visive e i nostri movimenti - essendo, insomma, una connessione sensorio-motrice. Così si spiegano tutte le caratteristiche percepibili (caractères apparents) della causalità tra oggetti e fenomeni esterni».
La percezione di un tale rapporto, aggiunge Bergson, è il supporto più elementare di una «credenza pratica» grazie alla quale abbiamo certe aspettative nei confronti dell’ambiente in cui viviamo, e tale credenza «è comune all’uomo ed agli animali superiori: credenza vissuta, diciamo, piuttosto che pensata. È proprio dell’uomo, e dell’uomo soltanto, il riflettere su di essa. Da tale riflessione nascerà la rappresentazione propriamente detta della legge di causalità». La riflessione spoglia il rapporto causale dei suoi caratteri visibili o tangibili, e può renderlo astratto quanto si voglia: «si avvicinerà, cosi, al rapporto che corre tra la premessa e la conseguenza, o meglio ancora, al rapporto che lega due variabili tra loro, quando sono funzione l’una dell’altra. La causalità in tal modo implicherà un grado di necessità via via sempre più rigorosa, sempre più matematica «.
Dopo tali affermazioni, non restava più altro che armarsi di metodologica pazienza, mettere a punto qualche teoria più rigorosamente formulata e - soprattutto - più ricca di dettagli controllabili, per procedere allo studio scientifico della fenomenologia del rapporto causale, e delle conseguenze che se ne possono trarre in merito all’origine dell’idea di causa.
In questo senso, il primo passo importante fu certamente compiuto dallo psicologo Robert Sommer al V Congresso di Psicologia Sperimentale, a Berlino, nel 1912. Sommer presentò una comunicazione - che, per quanto mi risulta, rimase senza echi - intitolata «La rappresentazione della causalità e le sue turbe»[27]. Per la prima volta nella storia, probabilmente, le due famose palle da biliardo citate da Cartesio, Malebranche, Hume, Maine de Biran e chissà quanti altri teorici della conoscenza, sono state accuratamente osservate da uno studioso interessato al loro comportamento visibile; non che gli altri autori ne avessero parlato senza mai averle viste: certamente avranno avuto innumerevoli occasioni di guardare i giocatori, le loro mosse e i movimenti delle sfere d’avorio sul tappeto verde. Ma una cosa è vedere e parlare di ciò che si è visto, rivolgendosi al lettore con un tono che dà per scontate analoghe osservazioni da parte sua, e rilevando in tali osservazioni (non attuali) diversi aspetti che il lettore è certo a sua volta di aver notati, sia perché effettivamente sono osservabili, sia perché l’eloquenza di chi teorizza è tale da indurre all’assenso; e altra cosa è assumere la situazione in questione ad oggetto di una osservazione accurata, durante la quale si cerca attentamente di soppesare quello che si sta guardando, in modo da poter dividere con sicurezza quanto in essa c’è e potremmo mostrare ad un altro osservatore accanto a noi, da ciò che ci aspettavamo di scorgere e invece non appare chiaramente.
Sommer non ha compiuto esperimenti, ma solo osservazioni. Egli si proponeva di passare in seguito anche a controlli più precisi, oltre che ad analisi differenziali (la rappresentazione della causalità in normali, subnormali e geniali), sulle quali dà qualche indicazione preliminare. Quanto ci interessa direttamente, però, è detto nella parte della relazione rubricata dall’Autore come applicazione del metodo di autoosservazione, o introspezione.
«Quando si colpisce una palla da biliardo con la stecca e la si manda a battere contro un’altra, l’introspezione ci offre quanto segue: 1) al momento del colpo dato con la stecca, un complesso di sensazioni muscolari; 2) dopo tale colpo alla prima palla, una percezione di essa con tutte le sue parti costitutive, margini, illuminazione, colore e movimento: ma oltre a tutto ciò avvertiamo nella palla percepita, che è in moto, un impressione di attività (Aktivitätsgefühl) come stato soggettivo, qualcosa che ha gli stessi caratteri qualitativi della sensazione muscolare dataci poco prima dall’introspezione. Nell’essenza, è una forma di partecipazione affettiva, è la proiezione di qualche aspetto soggettivo-motorio nella percezione della biglia. Intanto, viene il momento del secondo urto: con questo, sparisce all’improvviso dalla percezione della prima biglia la già detta impressione di attività: questo è un evento affatto simile alla sospensione momentanea di una impressione sensoriale. Nello stesso tempo ne deriva una peculiare qualità espressiva, che manifestamente proviene dal campo dei dati tattili, e si avverte come uno spiacevole contraccolpo; 3) quando, subito dopo questo urto, si mette in moto anche la seconda biglia, si vede daccapo anche in questa - accanto alle altre sue particolari caratteristiche percettive - quel tratto espressivo di attività già accennato. Per esempio: se quest’altra biglia sta ferma contro la sponda del biliardo senza muoversi minimamente in seguito all’urto, tale impressione di attività manca del tutto e noi avvertiamo, nel momento del colpo, in prossimità di essa, soltanto la sensazione della pressione che viene a subire per quell’attimo».
Riassumendo, Sommer parla di una prima proiezione delle sensazioni muscolari nel movimento della prima biglia, e della successiva proiezione di questa impressione nel movimento della seconda biglia (se ha luogo un nuovo movimento).
Che si tratti di un processo di proiezione è forse discutibile, e bisognerebbe vedere in che senso; infatti lo stesso Sommer, poco dopo, scrive: «anche quando non siamo noi stessi a colpire con la stecca la prima palla, ma solo seguiamo il suo movimento con lo sguardo, troviamo lo stesso senso di partecipazione (Einfühlung) ed ha luogo la medesima proiezione nei vari momenti descritti, lungo il percorso in cui le biglie vengono colpite «. Le stesse impressioni si avrebbero, secondo Sommer, anche non percependo un evento di questo tipo, ma solo immaginandolo nei dettagli. Ma va notato che la psicologia dell’espressività, fino alle ricerche condotte in questo settore nell’ambito della teoria della forma, ha abusato largamente del concetto di proiezione, tentando di ricondurre ad esso quanti più fatti fosse possibile, anche a costo di allentare i suoi confini oltre i limiti richiesti da una buona epistemologia; e in questo caso, forse, non si tratta di scarsa precisione da parte di Sommer, ma di un’improprietà caratteristica del linguaggio psicologico - e della teoria - di allora.
Comunque, il realizzarsi di questi caratteri percettivi nell’intero evento descritto da Sommer è, secondo l’Autore, del tutto indipendente dal giudizio «logico» di causalità (nel 1912 il problema della causalità e dei giudizi causali faceva ancora parte, per molti studiosi, della teoria logica; specialmente per gli studiosi di lingua tedesca); d’altra parte, è un processo che senza dubbio va etichettato come esempio di connessione causale realizzabile a un livello elementarissimo dell’esperienza psicologica. Che esso sia indipendente dalla nostra convinzione in un reale processo causale in atto tra oggetti fisici è dimostrato, per Sommer, dal fatto che le impressioni di causazione descritte conservano la stessa forza e vivacità qualora vengano riprodotte su uno schermo dopo essere state assunte con una cinepresa.
Il giudizio di causalità, nel quadro teorico abbozzato da Sommer, va considerato come un processo di pensiero in cui i caratteri della relazione causale percepibile, pure restando gli stessi, sono potenziati e affinati («die in vergleichenden Scharfsinn potenzierte logischen Vorgänge»), e l’uso che si fa di concetti causali, sia a proposito di eventi appartenenti al mondo dell’esperienza diretta che al mondo transfenomenico, comporta sempre un riferimento alla struttura degli eventi causali elementari, dati nella percezione; come scrive Sommer, «è in accordo (im Uebereinstimmung)» con essa.
Resterebbe da vedere se la percezione della causalità nel mondo esterno sorge come conseguenza di una «astrazione da qualche ordine di connessioni causali vissute come interne (al modo di Engel e Biran), e passate sotto il controllo della critica logica, oppure se si possa individuarla come un elemento psichico originario che si realizza in date condizioni, e che è possibile ritrovare nei più svariati campi della attività psicologica».
Sommer afferma di non essere in grado di scegliere tra le due alternative. Le ricerche immediatamente successive dimostreranno che senza dubbio quella giusta è la seconda.
In armonia con le teorie del pensiero logico correnti al suo tempo, Sommer ritiene che ci sia un’entità mentale come il «concetto» di causalità, che possiede caratteristiche simili a quelle della relazione percepita, le quali possono essere scoperte mediante l’introspezione; e questo concetto, così definito, può agire sull’organizzazione dell’esperienza. Non possiamo qui aprire una discussione sui pregi e i difetti che ha un tale punto di vista. Indubbiamente si può parlare del «concetto» di causalità in molti sensi: ad es., possiamo fare esempi di connessioni causali ed esempi di assenza di tali connessioni, costruendo con ciò una classificazione che implicitamente rimanda ad un criterio; possiamo decidere che la tale connessione non è causale, perché manca del tale requisito, e possiamo specificare la natura del requisito che manca; possiamo stabilire un rapporto di stretta somiglianza tra la struttura di una data relazione logica più o meno complessa (l’implicazione di Lewis, o il rapporto di Keynes) e la struttura «causa-effetto»; possiamo analizzare la natura delle circostanze in cui spontaneamente siamo portati a parlare in termini causali - indipendentemente dall’assunzione di un criterio rigoroso; ecc. Ma è difficile essere d’accordo sul fatto che tale «concetto» sia un oggetto mentale, un «oggetto del pensiero», visibile all’atto dell’introspezione. Sotto questa idea sta probabilmente l’eco della antica tesi empiristica delle idee «copia» delle sensazioni, e forse anche l’eco della più recente tesi idealistica del pensiero che riflette su se stesso, obbiettivandosi come «pensato». Per questo motivo la caratterizzazione del concetto di causalità data da Sommer lascia perplessi: vi è del giusto, in essa, e vi è una parte su cui ci sarebbe da discutere.
Vi è del giusto, nel senso che determinate strutture percettive richiamano direttamente un certo uso linguistico, e questo, a sua volta, è suscettibile di analisi logica; e, inoltre, una dipendenza genetica (lo vedremo poi, parlando della «prefigurazione» di Michotte) tra dati percettivi e concetti sembra oggi come oggi innegabile. Vi è del discutibile, nel senso che ben raramente troviamo in noi - sia pure prestando molta attenzione a ciò che accade nella nostra mente in date occasioni - una adaequatio intellectus ad rem che assomigli ad una riproduzione della realtà esterna, sia pure pallidissima e fatta con elementi impalpabili: piuttosto, agiamo in un dato modo in quelle date occasioni, o almeno traiamo conseguenze di un certo tipo tra le molte possibili, e soprattutto parliamo usando alcuni vocaboli e costrutti sintattici piuttosto che altri.
§ 11. L’interpretazione di Duncker.
Nell’ambito di questo problema, è particolarmente interessante la tesi presentata da Karl Duncker nel 1935. Il 1935 è l’anno in cui gli esponenti della teoria della forma - sulla traccia di Köhler, come vedremo - presero di petto il problema della causalità. Duncker trattò l’argomento nel suo libro sul pensiero produttivo[28], e Kurt Koffka in un capitolo dei «Principles»[29]. Con queste pagine si passa dall’avvicinamento puramente ipotetico (Bergson) e descrittivo (Sommer) del problema, alla formulazione di una teoria della causalità fenomenica articolata in modo da potersi inserire naturalmente nel contesto più ampio di una teoria psicologica della conoscenza, quella appunto gestaltistica.
Duncker sviluppa l’argomento a partire dalla seguente domanda: come è possibile concepire connessioni costanti tra fatti del tutto esterni gli uni agli altri, cioè connessioni «in se stesse totalmente non intelligibili»?
Per comprendere bene il senso di questa domanda occorre rifarsi al modello del mondo fornito da Hume, nel «Treatise» (Duncker lo menziona espressamente, a questo proposito). Secondo questo modello, le cose e gli eventi da cui sono interessate sono rispettivamente segmenti di esperienza connessi tra loro da niente, cioè dal solo fatto di stare accanto nello spazio e nel tempo in un dato modo, e modificazioni nella distribuzione di tali posizioni. Hume, in realtà, non fu sempre così radicale; ma è certo che egli voleva vedere il mondo fatto in tale modo, e lo schema di fondo era quello.
Supponiamo per un momento che le cose stiano proprio in questa maniera. Possiamo costruire delle generalizzazioni di connessioni costanti tra fatti? Certo, a condizione che alcune giustapposizioni tra un dato oggetto spaziotemporale ed un altro ricorrano più volte «accanto» nello stesso modo. Dopo averne incontrata qualcuna più volte, viene il momento in cui uno dice: «Ah, ho capito: A sempre con B». L’astrazione teorizzata da Bacone e Mill si forma spontaneamente cosi, nella vita quotidiana dell’uomo, «solo meno sistematicamente che nella scienza»[30]. Vi è un processo grazie al quale (epistemologicamente fondata o no che sia) troviamo a un dato momento la generalizzazione già costituita: si è formata da sola; ed è accettata come una scoperta, pure senza che si capisca nient’altro, di A-B, tranne il fatto che stanno insieme. Se noi accettiamo tale generalizzazione come una legge, naturalmente, si tratterà di una legge probabilistica. Come raccontava Hume: più volte vediamo A-B, e più salda diventa la nostra convinzione, che non può mai essere certezza.
Il nostro mondo, quello delle reali esperienze qui e adesso, non corrisponde intieramente a tale modello. In parte sì (siamo costretti spesso a fare generalizzazioni cieche, sulla base della pura frequenza); ma in parte no. Quante volte dobbiamo scoprire in figure come questa

Fig.106.
che l’area del quadrato circoscritto al cerchio di raggio r è 4r2? Ma, si dirà, è un giudizio analitico, perciò generale. Psicologicamente non è così[31], ma ammettiamolo pure. Escludiamo esempi di tipo deduttivo. Quante volte occorre far succedere l’accordo di tonica alla sensibile perché si «afferri» che la sensibile «si risolve» sulla tonica? Quante volte occorre risollevare una valigia piena di libri ben rilegati per scoprire che essa pesa, e fa tendere i muscoli del braccio?
Secondo Duncker, si possono classificare diversi gradi di intelligibilità delle connessioni, tra quelle assolutamente chiare di primo acchito e quelle del tutto cieche ed esterne. Tralascieremo questa classificazione, che riguarda piuttosto lo studio dei processi di pensiero, che non la fenomenologia della causalità. Gli estremi di essa sono assai efficacemente fissati da Duncker così: «'se A, allora B' è intelligibile, non se è colto come un principio comune a un certo numero di dati dai quali può essere derivato, ma se (e nella misura in cui), più facilmente che da altre possibili circostanze, B è direttamente «favorito» da A, o ricavabile da A».
Questa gamma di connessioni, dalla pura concomitanza all’azione di un fatto su un altro, è rilevabile anche a proposito dei movimenti che interessano l’ambiente percepito intorno a noi. Vi è, in linea generale, l’esperienza del fatto che una cosa può muovere un’altra cosa, entrando in contatto con essa; vi sono, naturalmente, eccezioni: le onde, le luci e le ombre, ecc. possono incontrarsi e compenetrarsi (cfr. il Cap. III di questo libro, a proposito di Leibniz). Ma quasi sempre gli oggetti che appaiono come tali - solidi, stereometrici, resistenti - possono trasmette e ricevere movimento per contatto. Che una connessione meccanica di questo tipo sia «necessaria», tra due corpi solidi, o tra due tipi di movimento, può essere scoperto accumulando osservazioni su osservazioni; ma può essere anche avvertito, in particolari altri casi, direttamente: «l’effetto dipende dalla natura del reagente. Anche un bambino, picchiando e scalciando dentro al suo recinto, avverte bene che vi è differenza se si picchia contro la coperta o contro lo steccato di legno».
In questo modo, anche il movimento di un dato corpo può passare nel movimento di un altro: quando un oggetto «spinge» un altro il movimento del primo «si continua» nel secondo[32].
Le condizioni della causalità fenomenica sono indicate da Duncker: a) nella coincidenza spaziale e temporale degli eventi, e b) in ciò che egli chiama «corrispondenza di forma».
a) Il luogo dell’effetto è il luogo dove spontaneamente tanto gli uomini che gli animali cominciano a cercare la causa. Il luogo dell’effetto d e ve essere legato alla causa; anche se vogliamo definire «causa» un avvenimento lontano, vi sarà un qualunque aspetto di esso che in una qualunque forma arriva ad agire nel luogo dove l’effetto è stato registrato. Ricordiamo i motivi addotti da Aristotile per sostenere che la causa - in qualche modo - deve essere sempre contemporanea all’effetto: bene, Duncker avanza lo stesso argomento per quanto riguarda lo spazio.
La connessione causale è inoltre intelligibile grazie alla coincidenza temporale. «Un tale rincasa di sera. Un colpo di vento sbatte la porta dietro a lui chiudendola, e nello stesso istante, dall’altra parte del corridoio, si accende la luce in una stanza che ha la porta socchiusa: benché si sappia perfettamente che non vi è connessione causale tra lo sbattere della porta e l’accendersi della luce - che senz’altro qualcuno ha acceso per caso in quell’istante - sarà difficilissimo sottrarsi all’impressione che tra i due fatti c’è una connessione di causa-effetto [33]».
Tale connessione, nell’esperienza diretta, consiste nell’intersezione di due «sviluppi uniformi», o «Weltlinien». Una «Weltlinie» è un ordine di fatti che si sviluppa nel tempo e può spostarsi, per connessioni strettamente contigue (cfr. la tesi di B. Russell sull’identità, nel Cap. III § 5), attraverso lo spazio[34]. L’intersezione ha luogo in un punto che appartiene insieme allo spazio ed al tempo. «La causalità fenomenica, nel nostro mondo, deriva dalla legge dell’azione contigua una notevole semplicità rispetto allo spazio ed al tempo. Almeno per quanto riguarda le loro posizioni in tali dimensioni dell’esperienza, causa ed effetto sono connessi non casualmente, ma in modo intelligibile: il momento e il posto della causa coincide col momento e il posto dell’effetto»[35].
b) A questa forma di pregnanza, secondo Duncker, se ne aggiunge un’altra: «causa aequat effectum», dal punto di vista qualitativo. Come - per quanto riguarda spazio e tempo - i momenti in cui il campanello squilla sono i momenti in cui esercitiamo la pressione con il dito su un pulsante, e il posto dove si vedono adesso le orme è quello in cui si sono prima posati i piedi del viandante; così qualche aspetto qualitativo della causa generalmente passa nell’effetto («many properties tend to pass unaltered from the cause into the effect»): l’umidità della pioggia è la stessa umidità del marciapiede bagnato, il colore della sorgente luminosa è il colore dell’illuminazione che essa dà all’ambiente; e, da un punto di vista quantitativo, più un oggetto pesa e più rumore fa cadendo, ecc. «Causa ed effetto sono collegati intelligibilmente non solo rispetto alla posizione ma anche, in alto grado, rispetto al contenuto: proprietà di forma, carattere, dimensione, materiale, ecc., passano - sotto i nostri occhi - direttamente dalla causa all’effetto».
L’evidenza di questi rapporti varia di intensità da caso a caso, come abbiamo detto, da una totale intelligibilità a una totale inintelligibilità. L’universo è parzialmente come lo voleva Hume: in quanto inintelligibile, può essere studiato mediante l’applicazione di procedimenti statistici, e se otterremo correlazioni soddisfacenti potremo parlare di rapporti causali; in quanto parzialmente intelligibile «certi aspetti di un effetto possono essere, di fatto, almeno supposti (conjectured) a partire da quelli della causa». Infine, l’evidenza del rapporto causale, la sua perfetta intelligibilità già al livello fenomenico, è paragonabile alla «totale evidenza» [36] della tautologia, e in generale dei processi logici elementari.
In genere, le connessioni causali che collegano gli eventi naturali sono solo parzialmente intelligibili, secondo Duncker; in esse rimangono sempre alcuni aspetti puramente giustapposti: per esempio, nell’utilizzare un bastone come arnese per rimuovere oggetti (qui Duncker si riferisce evidentemente agli studi di Köhler sulle scimmie antropoidi) «i due fatti fondamentali rappresentati dalla mobilità delle cose e dalla loro impenetrabilità sono qualcosa che deve essere accettato come un mero dato di fatto. Se qualcuno volesse obiettare che l’impenetrabilità degli oggetti ci è stata palese più volte, e ci è chiara perché abbiamo visto come essi si comportano tutte le volte che li abbiamo toccati e maneggiati, si dovrà rispondere: certo, ma dopo tutto il loro comportamento consiste in nient’altro che la stessa esperienza dell’impenetrabilità, benché in altra forma; questa esperienza appunto non permette alcuna ulteriore riduzione razionale».
Perfino la caratteristica costituita dalla «sensibilità del reagente» possiede un certo grado di inintelligibilità. Parrebbe, a prima vista, che in questo caso si abbia a che fare con una struttura («category») intieramente intelligibile: l’intensità dell’effetto visibile è proporzionale all’intensità della causa, e tale connessione è - per l’osservatore - esplicita. In effetti, tale intelligibilità è limitata al fatto che ciò che chiamiamo un buon reagente risponde alla azione di certe condizioni (causa) con una maggiore ricchezza di graduazioni discernibili rispetto ad altri possibili oggetti, che reagirebbero anche essi in qualche modo, sia pure meno manifesto; anzi, qualunque oggetto reagirebbe, a suo modo. Dunque, «solo il fattore della contiguità costituisce, qui, la relazione intelligibile. Se no, un mondo nel quale di regola l’effetto dipendesse unicamente dall’agente sarebbe intieramente concepibile». Prendiamo l’affermazione «l’effetto dipende dalla sensibilità del reagente»: che cosa vuol dire, qui, la parola «sensibilità»? Essa sta per indicare «ciò che, nel reagente, co-determina, l’effetto»[37], cioè la proprietà per cui un reagente è un reagente. Si tratta di una. tautologia, naturalmente. Ma innumerevoli giudizi che sembrano cogliere la realtà nell’essenza, dice Duncker, sono fondati su questa esplicabilità puramente analitica.
Gli aspetti inintelligibili del rapporto causale, del resto, possono essere dominati grazie all’apprendimento, alla classificazione e all’astrazione compiuta induttivamente - come dicemmo. Duncker sottolinea, però, come anche in questo seguito di operazioni tanto cieche quanto utili siamo guidati dalla parziale intelligibilità delle relazioni causali «in un mondo nel quale, per esempio, gli effetti non avessero alcuna forma di «coincidenza» con le cause, ma fossero legati ad esse mediante relazioni spaziotemporali di altro tipo costanti o variabili - l’apprendere e il generalizzare sarebbero operazioni estremamente difficili ed infruttuose».
Le tesi di Duncker, come è facile vedere, permettono di impostare il problema dei rapporti correnti tra esperienze di tipo causale e formulazione di giudizi causali, evitando del tutto lo schema dell’idea che riproduce le fattezze delle cose, conservandone pallidamente qualcuna, come la prospettava Sommer. Si tratta, per Duncker, di un legame funzionale congegnato press’a poco cosi: là dove il rapporto causale è direttamente visibile non occorre pensarlo, «scoprirlo»: è colto e direttamente utilizzato; altre volte è meno facile vederlo: in questi casi ci aiutiamo con un mezzo diverso da quello costituito dall’intuizione sensibile, usiamo cioè il pensiero; il rapporto causale pensato supplisce là dove manca il rapporto causale percepito. Inoltre, il rapporto causale pensato consiste in inferenze fondate su collezioni di fatti ed è definibile in termini di operazioni logiche di un certo tipo: non coglie, dunque, l’essenza del rapporto, ma registra la costanza di una giustapposizione cieca, il puro bilancio di dati.
Diversamente da Sommer, Duncker presenta l’idea di causalità non come copia di una relazione reale, ma come una attività in grado di supplire ad essa quando manca nella forma di dato immediato.
Occorre, naturalmente, tenere presente che Duncker ha accostato il problema nel corso delle sue ricerche sulla psicologia del pensiero. Dal punto di vista dell’analisi fenomenologica le sue osservazioni, pure molto penetranti, sono limitate a quegli aspetti degli eventi causali che rendono facile o difficile - a seconda della loro visibilità - la formulazione di un giudizio, la scoperta (concettuale) di una connessione che permetterà di risolvere un problema[38].
§ 12. L’interpretazione di Koffka.
Anche per Koffka il problema della causalità come dato dell’esperienza presenta due facce: quella fenomenologica e quella cognitiva. Quest’ultima, però, a differenza del caso di Duncker, non è prospettata come un problema di formazione di concetti causali, ma come il problema dei rapporti tra causalità fisica e causalità percepita: cioè, che cosa ci dice l’esistenza di una connessione causale nell’esperienza a proposito delle connessioni causali tra elementi corrispondenti nel mondo transfenomenico?
Assumendo anche qui il solito esempio del biliardo, Koffka illustra il suo problema così: 1) vi è il punto di vista dell’osservatore ingenuo, digiuno di fisica, il quale vede che una biglia è spinta da un’altra; 2) vi è il punto di vista della fisica prepositivistica (possiamo pensare a Maupertuis o Lagrange), per il quale, nel mondo fisico, vi è un reale passaggio di forze da un corpo all’altro. Si potrebbe dunque concludere che la causalità percettiva è un dato dell’esperienza diretta che denuncia la presenza di un rapporto causale nel mondo fisico. Come i sensi registrano la forma e il peso delle cose - si potrebbe sostenere - così registrano i passaggi d’energia.
Contro questo punto di vista si oppone l’epistemologia del positivismo. Nell’interpretazione di Koffka, la critica positivista allo schema ora illustrato è la seguente: l’osservatore ingenuo non può vedere un tale trasferimento di moto o di forze perché le condizioni di stimolazione (nel caso della visione, le onde elettromagnetiche dello spettro visibile) non contengono nulla che possa trasportare questa informazione all’occhio, e possano poi produrre una percezione di questo tipo: «le forze non emettono né riflettono onde luminose; ciò possono fare solo i corpi; e perciò tutto quello che ci è dato di vedere è che una palla si muove fino a che tocca l’altra, e da quel momento in avanti resta ferma al suo posto mentre la seconda comincia a muoversi. Così, avendo detto che non potremmo vedere nient’altro, dobbiamo sostener di vedere tanto, e niente di più»[39].
Naturalmente, utilizzando la medesima logica, potremmo dire che il «movimento» stesso è qualcosa che non riflette raggi; e dunque non è possibile che vediamo il movimento. Questa tesi appare più paradossale dell’altra solo perché l’affermazione «non vediamo il movimento dei corpi» appare inaccettabile per il suo stridente contrasto con l’esperienza d’ogni attimo della nostra vita. Solo per questo, si badi: infatti, la forma dei due ragionamenti è identica.
Se, per giustificare l’esistenza del movimento nell’esperienza, accettiamo il principio che qualcosa può essere veduto anche se non ha nel mondo fisico uno stimolo specifico e corrispondente, diventa anche possibile ammettere che l’esperienza di rapporti causali può avere luogo. Il mondo visibile del resto è pieno di cose che possiedono una data struttura alla quale non corrisponde, dal punto di vista della stimolazione, alcuna azione locale sugli organi di senso. Vediamo, per esempio, che una freccia «punta» in una data direzione; sentiamo gli intervalli musicali intercorrenti tra note successive (salti di terze, seste, ottave ecc.) :l’orecchio, naturalmente, registra le note, cioè le corrispondenti frequenze, ma non gli intervalli; lo stesso fatto di vedere la simmetria non ha una stimolazione corrispondente: la simmetria non riflette raggi[40].
Dato che non possiamo escludere dall’ambito di una teoria scientifica della percezione fatti importanti come la simmetria o i rapporti tonali, vi dovremo includere anche la percezione della causalità, che certo non ha una base fisica in qualche stimolazione specifica, ma che può essere considerata (se si dimostra empiricamente la sua esistenza) come una configurazione gestaltica insorgente a date condizioni. Non c’è - in breve - uno stimolo specifico capace di provocare una impressione di causalità, però ci possono essere condizioni di stimolazione più o meno complesse che, combinate insieme, generano una struttura di questo tipo.
Supponiamo ora che il problema «esiste la percezione della causalità?» ammetta una soluzione positiva, come infatti avviene. Resta ancora non affrontato il problema cognitivo della causalità: quest’ultimo, dice Koffka, presenta due diversi aspetti, a seconda che sia considerato sul piano puramente fisico, o su quello psicofisico.
Primo. Come spesso la presenza del movimento nel campo dell’esperienza diretta è indice della presenza di un movimento nel campo fisico (per certe condizioni note), così la presenza di un rapporto causale direttamente avvertito può essere indicativa del realizzarsi di un rapporto causale tra oggetti appartenenti allo spazio e al tempo della fisica.
Cosa può significare questa ammissione? Se accettiamo le tesi di Mach e Kirchhoff - secondo cui nel mondo fisico non vi sono rapporti causali stricto sensu, ma solo sequenze regolari di eventi - possiamo supporre che la percezione della causalità possa a volte essere il segno, nel mondo della percezione, della presenza di uno di tali rapporti A-B, regolare. Accettare che c’è la percezione del rapporto causale nell’esperienza umana non vuol dire accettare una teoria generale della realtà in cui si dice che anche nel mondo fisico c’è la causalità. In quest’ultimo la causalità può non esserci, ma ci saranno - secondo la tesi positivistica - sequenze regolari. La causalità fenomenica è indice di queste.
Oppure - e questa tesi sembra particolarmente gradita a Koffka [41] - vi è una possibilità ancora più importante, «la possibilità che la causalità percepita sia un indice veritiero di un aspetto della costituzione del mondo fisico». Forse il positivismo è stato troppo scettico nello scegliere i dati percettivi su cui ha costruito la sua immagine del mondo fisico: può darsi che la percezione della «forza» (o dello sforzo) ci dia l’esatta impressione di ciò che realmente, nel mondo fisico, è una forza. (Un punto di vista come questo è stato sostenuto da Alfred N. Whitehead, che Koffka appunto cita a questo proposito[42]).
Secondo. L’altro lato del problema cognitivo della causalità può essere esposto così: quando nell’esperienza diretta percepiamo l’azione di una cosa su di un’altra, assumendo l’ipotesi isomorfica nel senso di Köhler (ad ogni aspetto discernibile del mondo esperito corrisponde - quale che sia la sua natura e la sua localizzazione anatomica - un processo nel cervello) possiamo dire che il processo cerebrale A, corrispondente alla cosa agente, causa qualcosa nel processo B, corrispondente alla cosa paziente? Questa domanda ammette una risposta sperimentale. Infatti, se il processo B resta immutato in seguito all’azione di A - cioè se la seconda biglia non si sposta minimamente né in altra forma minimamente cambia - la questione è indecidibile; ma se la seconda biglia entra in movimento, cioè se il processo B si modifica in seguito al processo A, la questione diventa decidibile utilizzando la seguente ipotesi: il movimento della seconda biglia dovrà possedere caratteristiche peculiari (almeno nei primi istanti) quando sia dovuto all’urto della prima; se non è dovuto a tale urto, dovrà avere semplicemente le caratteristiche di un moto spontaneo, come se la biglia si fosse mossa da sola. In termini psicofisici: se il processo B (moto della seconda biglia) ha le solite caratteristiche dei processi che sottostanno alla percezione del movimento, allora non si potrà dire che il processo A (urto) ha agito su di esso; ma se il processo B in tali condizioni presenta modificazioni sensibili e caratteristiche, ciò significa che il processo A ha effettivamente agito.
Koffka non ha fatto l’esperimento che discende da queste proposizioni; lo ha fatto, però, Michotte, come vedremo: e l’esito è stato positivo. Il secondo movimento ha veramente il carattere di essere per un certo tratto «passivo».
Pur senza avere a disposizione l’esito dell’esperimento Koffka sviluppa, dagli esiti che si potrebbero ottenere, ancora un piccolo brano di teoria: «vi sono tre possibilità: l’esperienza di una connessione causale tra A e B può essere (a) un segno che c’è una reale relazione causale dinamica tra l’organizzazione dei due processi psicofisici A’ e B’; oppure: (b) un segno di qualche altra interrelazione fra essi; oppure: (c) non c’è alcuna relazione tra A’ e B’, e l’esperienza della causalità deriva da altre condizioni secondarie. Il secondo membro di questa disgiunzione appare, oggi come oggi, tanto improbabile che lo escluderemo dalle nostre successive considerazioni. Daremo la preferenza alla soluzione (a) o (c), oppure lasceremo la questione ancora completamente aperta? (c) è la soluzione tradizionale, strettamente connessa all’associazionismo, che più volte abbiamo rigettato con buone ragioni. (a) è perfettamente compatibile coll’intiera nostra teoria dell’organizzazione, e nello stesso tempo sarebbe un esempio eccellente di ciò che è l’isomorfismo... perfettamente consapevole che il verdetto finale spetta solo all’esperimento, io intanto accetto la soluzione (a).
§ 13. La teoria di Köhler.
Dobbiamo guardarci dall’idea che questo problema tocchi solo il nostro modo di percepire e di concettualizzare le relazioni meccaniche tra oggetti. L’esempio del biliardo, prediletto dai filosofi per la sua elementarità e chiarezza, costituisce l’apertura di un discorso notevolmente ampio, il cui aspetto più suggestivo e difficile è rappresentato dal nostro comportamento nei confronti di parti dell’ambiente che ci circonda. Il problema della causalità meccanica serve a introdurre il problema dell’azione. Tenendo d’occhio appunto questa prospettiva Hume e Maine de Biran avevano trattato delle forme più elementari della causalità.
Un esempio. Secondo Hume, evitiamo le scottature perché «ci ricordiamo di aver visto quella specie di oggetto che chiamiamo fiamma, e di aver sentito quella specie di sensazione che chiamiamo calore. Noi ricordiamo parimenti il loro costante congiungimento in tutti i casi passati. Senza tante cerimonie chiamiamo la prima causa ed il secondo effetto, e inferiamo l’esistenza di questo dall’esistenza di quella. In tutti i casi particolari di quel congiungimento, tanto la causa quanto l’effetto furono percepiti dai sensi e insieme presenti alla memoria. Ma quando ci mettiamo a ragionare su essi, noi percepiamo o rammentiamo soltanto uno dei termini, e suppliamo all’altro in conformità dell’esperienza passata»[44]. Questo empirismo è squisitamente intellettualistico: i fatti accadono, spariscono, lasciano una traccia - traccie separate, «impressioni più pallide «, appunto - e ciò che attualmente ha luogo sono solo operazioni della mente su di esse; la mente calcola sulla fiamma e sul calore, e costruisce una relazione che le congiunge, utile in seguito. Per questa via diventa difficile vedere in che modo la relazione causale possa assumere l’aspetto di una interrelazione concreta tra l’osservatore e il suo mondo di esperienze: egli potrà essere, al più, un sottile argomentatore seduto al tavolino, che pensa e ripensa alle proprie esperienze trascorse, variamente connettendole, restando ben isolato da quelle attuali.
Leggiamo Köhler, ora: «Una bella mattina mi trovo seduto in pieno sole, tutto soddisfatto. Ma dopo un po’ di tempo sento troppo caldo; contetmporaneamente, avverto una tendenza ad allontanarmi dal posto dove sono. Un posto all’ombra di un albero, poco discosto, mi ha un’ aria allettante; e l’impulso ad allontanarmi dalla luce diretta del sole diventa immediatamente una tentazione, quella di ripararmi all’ombra. Proprio come prima le caratteristiche di un primo posto mi inducevano ad allontanarmene, così ora le proprietà di un secondo fanno sorgere l’impulso di avvicinarmi... sentiamo come, nel primo caso, dalla natura della situazione data si sviluppi una certa tendenza, e come poi un’altra parte del campo determini ulteriormente la direzione dell’impulso»[45]. La connessione, qui, non è il risultato di un bilancio effettuato su due classi di impressioni, impressioni visive ed impressioni termiche, ma un aspetto realmente esperito in una situazione, un aspetto di essa che si svolge in essa connettendo dinamicamente l’episodio iniziale con quello che la conclude. Quasi ogni nostra azione nei confronti del mondo esterno, e quasi ogni azione del mondo esterno esercitata su di noi contiene qualche rapporto dinamico di questo tipo. Il piacere che dà un buon tabacco non è una sensazione di piacere più la presenza del sapore di tabacco, unite da un giudizio di causa ed effetto che ci rende consapevoli che la prima dipende dal secondo; il crescente disagio provocato dalla presenza di una persona noiosa non è un senso di disagio più l’atto di includere logicamente quella persona nell’insieme non vuoto degli importuni; correre essendo inseguiti non è semplicemente correre, e in più sapere che qualcuno dietro a noi corre a sua volta. Il profano di psicologia e di calcolo delle probabilità avverte queste situazioni per quelle che sono, senza essere indotto a creare teorie psicologiche dell’associazione tra esperienze, e senza soprattutto fare conti sull’attendibilità della connessione tra un dato aspetto e un altro della situazione totale, quando si presenta così. «Ma - scrive Köhler - il genere di esperienza che il profano sostiene di avere non ha alcuna parte esplicita nella psicologia scientifica del nostro tempo (1929); io sento di dover prendere le parti del profano; sento che una volta tanto è lui, piuttosto che la nostra scienza, a rendersi conto di una verità fondamentale. Poiché probabilmente la sua convinzione diverrà una chiave di volta nella psicologia, nella neurologia e nella fllosofia del futuro»[46].
La connessione intelligibile (verständlicher Zusammenhang) che intercorrendo tra fatti diversi dall’esperienza attuale rende sensato ai nostri occhi tanto il comportamento nostro che quello altrui può aver luogo nell’una e nell’altra delle due forme, oggetto di controversie così interessanti da Aristotile in poi: nella forma di un evento costituente una sequenza temporale da A a B, e nella forma di due stati contemporanei esperiti attualmente insieme, oltre che legati dallo specifico rapporto causale. Questo secondo tipo di situazioni permette di mettere bene in evidenza la diversità radicale che c’è tra i giudizi di dipendenza funzionale ricavati dall’analisi sperimentale degli eventi, e la percezione della connessione causale, senz’alcun intervento dell’atto di giudicare. Riportiamo l’esempio di Köhler. Provare ammirazione è sempre provare ammirazione per qualcosa, e mai sorge il dubbio circa l’oggetto al quale l’ammirazione è diretta. Davanti ai quadri esposti in una galleria l’ammirazione è per qualcuno di essi, non per qualcuno a caso, o per qualcuno non sappiamo quale. «Ieri sera, per esempio, nella sala dei concerti vi era una voce di contralto che suonava «mirabilmente» grave, calma e sicura: che l’oggetto della mia ammirazione fosse questa voce e non il naso del mio vicino o la schiena del direttore d’orchestra o che altro mai delle migliaia di oggetti e di eventi che avevo davanti a me, è del tutto fuori questione. Come altri atteggiamenti, così l’ammirazione si dirige verso qualcosa: qui, era diretta verso la persona donde proveniva il canto. Ora, intendo dire con ciò che l’ammirazione si estendeva a quella persona e vi si fermava accanto, come se fosse un bastone proteso fra me e quel luogo?»[47]. Non sarebbe, questa, una descrizione adeguata dello stato di cose: la relazione tra A e B non è in questo esempio un «terzo oggetto tra» A e B: il legame consiste intieramente nel modo in cui il fatto A si connette a B: «la mia ammirazione era la risposta naturale a un tale modo di cantare. Di conseguenza, non mi occorsero criteri indiretti, non ricerche scientifiche, non coefficienti di correlazione, al fine di conoscere la connessione vigente fra il canto e la mia ammirazione. È un fatto che la mia esperienza in proposito mi disse più di quanto potrebbe mai dirmi qualsiasi induzione scientifica; dato che l’induzione tace, non azzarda nulla intorno alla natura della relazione funzionale che predica, mentre in quel caso un determinato evento causale psicologico era direttamente vissuto nell’esperienza come una relazione comprensibile «.
La circostanza descritta da Köhler è paragonabile a questa: vedo un quadro, e nel mezzo di esso c’è una suggestiva chiazza di colore rosso; bene attrezzato come sono dal punto di vista della preparazione metodologica, mi munisco di un colorimetro, o quanto meno di un campionario di colori, contenente tutte le sfumature visibili su certi pezzetti di plastica con attaccato un cartellino su cui c e il nome del colore e una serie di altri simboli adatti a indicarne ogni sfumatura. Avvicino uno alla volta questi pezzetti di plastica colorata alla macchia dipinta, cominciando coi colori del verde, poi del blu, del rosso e così via; dato che come ogni ricercatore ho anche pazienza, alla fine troverò un campione di colore molto simile a quello della macchia, e - utilizzando la sola nozione di «somiglianza» e la classificazione convenzionale assunta - leggerò sul cartellino la parola «rosso» e gli altri simboli; così potrò concludere scientificamente che in mezzo al quadro ho visto una macchia rossa. Sarà inutile obbiettare che con ciò ho compiuto un lavoro superfluo, perché nulla, nella ricerca scientifica, è superfluo, purché sia esatto. Non sfugga, desidero insistere, che questo esempio è identico a quello di Köhler: anche li la scoperta che l’ammirazione è dovuta a quella voce della cantante può essere raggiunta pazientemente eliminando volta per volta qualche particolare della situazione complessiva per vedere se, tolto quello, anche l’ammirazione cessa: si dovrebbero rimuovere uno alla volta i mobili e gli altri pezzi di arredamento presenti nella sala da concerto, far uscire uno alla volta gli altri ascoltatori, modificare tutte le strutture visibili e udibili li dentro: certo prima o poi si arriverebbe a rimuovere la voce della cantante, e sentendo in quel momento cessare la «ammirazione», dopo aver ripetuto più volte la prova si potrebbe concludere che c’è un’alta probabilità che tale ammirazione dipenda da quella voce.
Raggiunta questa conclusione (non corretta, perché vi si parla di probabilità a proposito di un fatto direttamente constatabile da parte di un dato osservatore, in un momento storicamente determinato: fatto, dunque, che c’è o non c’è; e che c’è dato che da esso ha preso le mosse l’indagine) non resta che sottolineare l’aspetto più macroscopico dell’insensatezza del procedimento. Nel caso di Köhler, delle varie condizioni rimosse, tale procedimento ci autorizza a dire che abbiamo trovato una dipendenza - ma cosa significa, appunto, dire che B «dipende da A»? Se significa esclusivamente l’esito delle operazioni compiute seguendo dati criteri, è chiaro che dire alla fine «B dipende da A» vuol dire semplicemente constatare che è stato raggiunto un risultato; risultato che sarebbe stato diverso se le convenzioni scelte fossero state diverse, e se le regole fossero state costruite differentemente. Sotto questo punto di vista, non è che facendo i conti troviamo una correlazione significativa, e poi diciamo: «ecco, B dipende da A»: le due cose sono la stessa cosa. Non scopriamo la dipendenza per mezzo della correlazione, dato che questa è quella e nient’altro.
Ma supponiamo di seguire il buon senso, e di assumere che ciò di cui andiamo in cerca è una dipendenza, qualcosa di reale che lega i due fenomeni: allora esisterà una relazione che conosciamo indipendentemente dai calcoli operati sui dati, e che tutt’al più certe volte viene rintracciata coll’aiuto ditali calcoli. La tesi di Köhler è che tale relazione è un dato direttamente osservabile, e come tale obbedisce a leggi di organizzazione paragonabili a quelle che reggono tutti gli altri fenomeni di cui si occupa la teoria della percezione. La causalità esiste, e può essere studiata per via sperimentale. Quando tale relazione non è facilmente discernibile, possiamo darle la caccia con i mezzi offerti dall’inferenza probabilistica, essendo per lo meno superfluo farlo quando la relazione appare da sé, prima ancora che si pensi ai mezzi indiretti capaci di provarla.
Nell’esempio della macchia rossa accade lo stesso: non ho bisogno di impiegare le sottili armi della fotometria per decidere che là c’è una macchia rossa, né una serie di confronti alla cieca tra colori etichettati, sperando di incontrare una relazione cli somiglianza priva di implicazioni intorno alla natura fenomenologica del colore rosso. Là c’è quella macchia, e l’uso di procedimenti indiretti non ci farà scoprire niente di più, sia pure con ineccepibile rigore.
§ 14. Un’interpretazione «storica» della cansalità.
Un interessante sviluppo delle tesi di Köhler ci sembra sia quello tratteggiato dallo storico inglese Edward H. Carr in un volume sulla teoria della storia pubblicato pochi anni or sono[48]. Evidentemente non si tratta di uno sviluppo voluto, che prenda esplicitamente le mosse da quanto ha scritto Köhler: Carr non menziona lo psicologo tedesco, non si esprime utilizzando il gergo della gestalt, e con ogni probabilità non è minimamente interessato ai problemi di teoria psicologica, essendo il suo campo di studi ben lontano da tali temi. La cosa non ha alcuna importanza del resto. Quando un’idea è veramente un’idea poco importa sapere entro i limiti di quale scienza sia nata, dato che prima o poi produce conseguenze anche altrove.
L’intera posizione di Edward H. Carr di fronte al problema della causalità storica meriterebbe di essere discussa ampiamente, e risulterebbe istruttiva, credo, non solo per coloro che coltivano la sua materia, ma per chiunque si dedichi allo studio di qualche scienza che ha per oggetto l’uomo e il suo comportamento. Qui non possiamo farlo, e dunque raccomandiamo al lettore psicologo di farlo per conto suo. Ciò che si collega alla teoria dell’ «insight» di Köhler è il punto seguente: è giusto sostenere che, in una situazione abbastanza complessa (una combinazione di diverse circostanze, o come dicevano i vecchi positivisti, una intersezione di linee causali), tutti gli eventi che ne fanno parte, e tolti i quali un certo altro evento E non avrebbe certo avuto luogo, devono essere considerati cause di esso? In altre parole: è legittimo sostenere, a un certo livello di complessità dell’oggetto considerato, che causa e condizione devono essere considerati come sinonimi?
Esaminiamo un esempio di Carr[49]. Il signor Jones, tornando un poco alticcio da una festa, guidando una macchina con i freni non più efficienti, e imboccando una curva, non segnalata come si dovrebbe e poco illuminata, investe e uccide il signor Robinson, il quale stava attraversando la strada in quel punto per comprare sigarette dal tabaccaio di fronte.
Un’inchiesta sul fatto consiste nell’appurare quelle che comunemente sono dette le cause dell’incidente. Ogni persona sensata ammette che esistono le cause di un incidente, senza sottoporre previamente tale concetto a un confronto con altri forniti dalle diverse filosofie della causalità (» in quanto storico-- scrive Carr - sono pronto a rinunciare a parole come «inevitabile», «necessario» e perfino «ineluttabile» ; la vita sarà più monotona, ma lasciamole pure ai metafisici e ai poeti «).
L’incidente è stato provocato dalla condizione di semi-intossicazione in cui si trovava il guidatore? Per questo, egli potrebbe essere portato davanti ai tribunali. O erano le cattive condizioni dei freni? In questo caso bisognerebbe rintracciare chi li ha revisionati per l’ultima volta. Una causa potrebbe essere la scarsa visibilità, l’assenza di una segnaletica adeguata; la responsabilità grava in questo caso sull’assessore al traffico di quel comune. Tutte e tre possono essere cause, insieme e con diverso peso.
Ma qualcuno dice: se Robinson non fosse uscito in cerca di sigarette quella sera non avrebbe attraversato la strada e non sarebbe stato travolto. La causa sta nel fatto che Bobinson aveva voglia di sigarette: essa deve essere seriamente tenuta in considerazione.
Quale che sia la nostra idea sul determinismo e sul libero arbitrio, sentiamo bene che quest’ultima tesi contiene qualcosa di stonato. È indubbiamente vero che se Robinson non fosse andato a comprare sigarette non gli sarebbe successo niente. Tolto questo evento, l’evento E non ha luogo. Esattamente come tolta l’ubbriachezza, tolto il cattivo funzionamento dei freni, o messa una opportuna segnaletica sul posto del sinistro; il bisogno di sigarette di Robinson conta, in astratto, quanto questi altri eventi. Chi argomentasse nel modo appena riferito avrebbe sotto questo punto di vista ragione: «Robinson è stato ucciso perché era un fumatore... è perfettamente vero e logico, di una logica che ricorda quella, spietata, di Alice nel paese delle Meraviglie, e di Attraverso lo Specchio; ma, pur non essendo io secondo a nessuno nell’ammirare questi maturi esempi di dottrina oxoniense, preferisco tenere separati i vari tipi di logica». Questa condizione non è una causa. «Se voi dite all’uomo comune che Robinson fu ucciso perché il guidatore era ubriaco o perché i freni della macchina non funzionavano, o perché la strada aveva in quel punto una cattiva visibilità, egli troverà il vostro discorso perfettamente sensato, e lo accoglierà come una spiegazione razionale»[50]. Molto meno facilmente accetterà che la voglia di fumare fu la causa della sua morte.
La differenza tra causa e condizione non è definibile sul piano puramente logico. Ogni condizione fa parte delle cause che concorrono a far essere un certo stato di cose; Stuart Mill ha sostenuto esattamente questa tesi, nel decimo capitolo del terzo libro del «System of Logic», e il suo punto di vista non va considerato come una pura curiosità storica dato che oggi è accettato da chiunque abbia a che fare con problemi che richiedono il ricorso alla sperimentazione; B. Russell ha spiegato molto bene il modo in cui il tradizionale concetto di causa di scolastica memoria si dissolve nel concetto di funzione[51], sostenendo con ciò la medesima tesi. La causa di qualcosa (cognizione approssimativa e prescientifica) è - se viene analizzata bene - una condizione o un insieme di condizioni. Alla luce di questi argomenti si sarebbe indotti a decidere per la espulsione della parola «causa» da ogni linguaggio che voglia parlare della realtà con cui l’uomo ha a che fare.
L’esempio di Carr, e la sua discussione, mostrano che non è così; c’è ancora posto per la parola causa, nel linguaggio impiegato nel descrivere le situazioni in cui l’uomo si muove. Qualche condizione agente in una situazione data è più «causa» di un’altra; l’uomo della strada, dice Carr, è portato a parlare a volte della «vera causa» di qualcosa. In definitiva, tra le diverse condizioni di un fenomeno va chiamata causa quella che è legata ad esso da una relazione intelligibile, nel senso di Köhler: il fatto, cioè, descritto il quale ci si aspetta che debba succedere proprio quello che succede. Tutti gli eventi di cui possiamo essere spettatori si realizzano grazie a un numero incalcolabile di condizioni concomitanti, che non ci passano neanche lontanamente per la testa: chi pensa che la nostra vita quotidiana è organizzata così come è perché esiste la forza di gravità e perché ha un dato valore e non un altro? o perché c’è una atmosfera intorno a noi? o perché alcuni particolari del sistema nervoso sono fatti in un modo piuttosto che in un altro perfettamente ed ugualmente possibile? In mezzo a questo ricco bazar di condizioni, alcuni fatti assumono il ruolo di causa, e ciò è sbagliato da un punto di vista puramente logico, ma è giusto, dal momento che essi godono di un rilievo particolare: «rovistando nel groviglio dei fatti già noti (la mente umana) sceglie, rappezza e riunisce insieme i fatti importanti, scartando quelli irrilevanti, finché non è riuscita a cucire un tessuto logico e razionale di conoscenza»[52]. I rapporti causali intesi in questo senso sono, con buona approssimazione, «connessioni intelligibili» nel senso di Köhler, grazie alle quali diventa superfluo fare un accurato bilancio di tutte le condizioni pensabili in una situazione data, al fine di comprendere la sua dinamica.
Carr, inoltre, suggerisce un interessante criterio per capire quali aspetti nelle varie circostanze possano esser chiamati in tale senso cause. Un evento che è condizione di un altro evento può essere chiamato sua causa quando si possono costruire con esso enunciati generali di tipo causale che non suonino assurdi. Potete dire «i cattivi freni causano incidenti stradali «, ma non potete dire - senza rischio di apparire ridicoli - «l’andar a comprare sigarette è causa dell’esser travolti dalle automobili». Anche se è vero il fatto del naso di Cleopatra, Carr sottolinea che questo non ci autorizza a dire «i generali perdono le battaglie perché si innamorano delle belle regine «, o, pensando al caso accaduto a Re Alessandro di Grecia nel ’20, «le guerre scoppiano perché i re allevano le scimmiette».
Questa ci sembra una proprietà molto interessante delle relazioni intelligibili; quando esse ci si presentano nella forma di organizzazioni dell’esperienza diretta non abbiamo bisogno di alcun ulteriore criterio per sapere con sicurezza che abbiamo a che fare con un rapporto causale: esso è li, e non potremmo fare che sia diverso; ma quando le situazioni sono abbastanza ampie e complesse da travalicare i limiti della esperienza attuale, il criterio di Carr ci sembra il migliore per stabilire se una connessione tra condizioni ed effetti è una causa oppure no. Certo, il criterio della generalizzazione sensata fa appello al senso comune, e si potrebbe dire per questo che il problema è solo rimandato. Carr scrive: «Tutto ciò può sconcertare ed urtare i filosofi, e forse anche qualche storico: eppure questo modo di procedere è perfettamente familiare alla gente comune che cerca di risolvere i propri problemi nella vita di ogni giorno».
![]()
Note
[1] Laplace Essai philosophique sur les probabilités (1814), in « Oeuvres completes «, Paris, 1878-1912, vol. VII, pag. 4.
[2] Brown e Ghiselli, Scientific Method in Psychology, N. Y.-London, 1955, pag. 16 e pag. 20.
[3] Cfr. L. Wittgenstein, Lezioni sull’estetica, §§ 22-30, in « Lezioni e Conversazioni «, trad. Ranclietti, Milano, 1967; pagg. 75-78.
[4] Cfr. M. Wertheimer, Il pensiero produttivo, Firenze, 1965, pag. 276. Cfr. anche pag. 273.
[5] C. J. Lewis, C. H. Langford, Symbolic Logic, N. Y., 1959, pagg. 235 e segg.
[6] E. Kant, Critica della ragion Pratica, trad. it. Capra, Bari, 1937, pag. 61 e pag. 64.
[7] H. Reichenbach, Philosophical Foundations of Quantum Mechanics, Berkeley and Los Angeles, 1942, §§ 1-2. Trad. it. di A. Caracciolo; Torino, 1954.
[8] J. M. Keynes, A Treatise on Probability, London, 19576, pag. 4 e pagg. 275-77.
[9] J. M. Keynes, Op. cit., pag. 276.
[10] Cfr. la desrizione di Michotte, riferita a pag.363.
[11] Sextus Empiricus, ed. Bury, London, Cambridge (Mass), 1955: lib. I, 182 (pag. 104):
![]() Trad. it. di O. Tescari; Bari, 1926.
Trad. it. di O. Tescari; Bari, 1926.
[12] Ed. Bury, vol. I, pag. 338.
[13] Vedi, nelle pagine seguenti, le tesi di K. Duncker. Vedi anche, nel prossimo capitolo, la teoria dell’ «ampliamento del moto» di A. Michotte (§ 12).
[14] Citiamo sempre il Treatise dalla traduzione di Carlini, già indicata, pag. 199.
[15] Op. cit., pag. 99.
[16] Op. cit., pag. 101.
[17] Op. cit., pag. 101.
[18] Op. cit., pag. 102.
[19] Op. cit., pag. 195.
[20] Op. cit., pag. 207.
[21] Op. cit., pag. 136.
[22] Op. cit., pag. 194.
[24] Op. cit., pag. 137.
[25] In «Oeuvres de Maine de Biran» Paris, 1932; le citazioni da noi utilizzate si trovano nel vol. VIII, § II del Cap. IV dell’ «Essai» (pagg. 225 e segg.).
[26] H. Bergson, Écrits et Paroles, Paris, 1955, pagg. 87 e segg.
[27] R. Sommer, Die Kausalitätvorstellung und ihre Störungen, «Bericht über den V. Kongress für experimentelle Psychologie», Berlin, Barth, Leipzig 1912.
[28] Karl Duncker, Zur Psychologie des Produktiven Denkens, 1935. Trad. inglese di L. S. Lees, con il titolo «On Problem Solving», in « Psychological Monographs», 1945, vol. 58, V.
[29] Kurt Koffka, Principles of Gestalt Psychology, N. Y.-London, 19554
[30] Op. cit., trad. Lees, pag. 64.
[31] Cfr. M. Wertheimer, Ueber Schlussprozesse im produktiven Denken in Drei Abhandlungen zur Gestalttheorie, Erlangen, 1925; vedi anche P. Bozzi, Su alcune condizioni necessarie per lo studio sperimentale della fenomenologia del pensiero. Atti del XIV Congresso di Psicologi Italiani, Napoli, 1962-Firenze, 1965.
[32] K. Duncker, ibid., pag. 65.
[34] Cfr. W. Metzger, Psychologie, Darmstadt 19633, pagg. 124-125.
[35] K. Duncker, ibid., pag. 67.
[36] Ibid., pag. 68.
[37] Ibid., pag. 69.
[38] Del resto, sullo stesso piano dell’analisi fenomenologica dell’esperienza diretta, la posizione di Duncker è stata ripresa nel 1941 da W. Metzger, che identifica le leggi della causalità percettiva nelle tre condizioni della coincidenza spaziale, di quella temporale, e del passaggio di una proprietà qualitativa dal primo termine nel secondo.
[39] K. Koffka, Principles, pag. 378.
[40] Ibid., 397. Cfr. anche E. Mach, Analyse der Empfindungen, Jena, 19229, VI, §§ 4, 5, 6; XII, § 2, 7.
[41] Ibid., 380.
[42] In «Science and the Modem World» , N. Y. London, 1926.
[43] Ibid., pag. 381.
[44] Ed. cit., pag. 115.
[45] W. Köhler, Gestalt Psychology, N. Y., 1947, pagg. 349-50.
[46] W. Köhler, Gestalt Psychology, ed. cit., pag. 322 (dalla trad. it. di De Toni, Milano, 1961, pag. 245).
[47] Op. cit., trad. it., pagg. 245-246.
[48] E. H. Carr, What is History?, London, 1961, trad. it. di C. Ginzburg, «Sei lezioni sulla storia», Torino, 1966.
[49] Op. cit., ed. it., pag. 113 e segg.
[50] Op.cit., ed. it., pagg. 114-115.
[51] B. Russell, The Concept of Cause, «Proceedings of Aristotelian Society», 1912-13, pagg. 7 e segg.
[52] L. Paul, citato da Carr, vedi pag. 143.