|
Interpretazione del «Tractatus» di
Wittgenstein
|
Capitolo I | Giovanni Piana |
I
Fatto, immagine, proposizione
1.
Vi è un modo molto elementare per illustrare la nozione astrattamente generale di mondo con cui si apre il Tractatus.
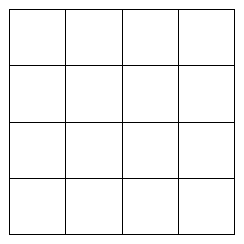
Su questo reticolo siano disposte alcune cose. Chiamiamole oggetti. La loro configurazione stato di cose. Con fatto intenderemo, in generale, uno o più stati di cose. Diciamo infine che il mondo è la totalità dei fatti [1] .
Tenendo sotto gli occhi questa immagine risultano immediatamente le ulteriori nozioni che caratterizzano ciò che potremmo chiamare 1’ontologia del Tractatus, cioè la sua teoria degli oggetti.
In primo luogo: gli oggetti sono ciò di cui il mondo, in ultima analisi, è costituito, quindi la sua sostanza. Alla sostanza del mondo attribuiremo i caratteri della permanenza, della fissità e dell’immutabilità. Di mutamento avrà senso parlare, solo in rapporto alle configurazioni degli oggetti (2.027). Gli oggetti, invece, restano quello che sono. «La sostanza è ciò che sussiste indipendentemente da ciò che accade» (2.024). E ciò che accade è il fatto.
Per lo stesso motivo gli oggetti debbono ricevere una caratterizzazione anche in rapporto alla forma di mondo: se sono dati gli oggetti, con ciò non è dato un mondo, ma solo la sua possibilità. Ciò che è comune ad ogni mondo possibile, dunque La forma di mondo, «consta di oggetti» (2.023 e 2.031).
Inoltre gli oggetti saranno semplici, e qui certamente L’immagine illustrativa di cui ci siamo serviti appare inadeguata. Stando a questo modo di presentare le cose, infatti, la semplicità degli oggetti potrebbe essere niente altro che un’assunzione; mentre gli oggetti sono i nuclei sostanziali della realtà (2.063), non sono qualcosa di simile ai pezzi di un gioco. La semplicità di cui parliamo non potrà essere intesa come un’assunzione; e neppure come una determinazione relativa ad un qualche contesto che la renda in qualche modo intelligibile. La semplicità posta dal Tractatus è una semplicità in sé. Quindi, a quanto sembra, un rompicapo senza soluzione.
D’alto lato, la semplicità degli oggetti è già posta nel momento in cui si è indicato in essi il carattere della sostanza: che vi sia una sostanza della realtà significa la stessa cosa del sussistere di suoi costituenti ultimi. E per mostrare che deve esserci una sostanza, argomenteremo così: assumiamo che una proposizione che verte su un complesso possa essere analizzata in proposizioni che vertono sulle parti di cui quel complesso consiste. Allora è chiaro che si può decidere la verità o la falsità della prima solo se si è decisa la verità o la falsità delle seconde. Ma è altrettanto chiaro che per decidere la verità di una proposizione che verte su un complesso è necessario che si giunga, in questa analisi, a proposizioni che non vertono su complessi. Ciò è quanto dire che ogni complesso deve consistere infine in costituenti semplici. E quindi che le proposizioni possono avere un senso, cioè possono essere vere o false, solo se esiste una «sostanza del mondo». Il sussistere di proposizioni non analizzabili in alte proposizioni e, correlativamente, di fatti non decomponibili in alti fatti è dunque una condizione della sensatezza delle proposizioni.
Scopo di questo argomento - che in Wittgenstein si presenta in realtà in una forma più tortuosa (2.0201 e 2.0211) - è in ogni caso quello di indicare che 1’«atomismo» che stiamo sostenendo trae il suo senso dal rinvio al terreno logico-linguistico, che a partire da questo terreno debbono essere determinati, per così dire, i caratteri dell’ontologia.
Del resto, oltre che in rapporto alla semplicità degli oggetti, di «atomismo» potremmo parlare anche in rapporto agli stati di cose, alla posizione della loro reciproca indipendenza.
Ad essa si accenna sin dalle prime frasi: «Qualcosa può accadere o non accadere e tutto il resto rimanere eguale» (1.21); si spiega poi che di indipendenza si parla in rapporto agli stati di cose, e non ai fatti in genere, e che essa va intesa, nel, senso che dal sussistere o non sussistere di uno stato di cose non si può concludere al sussistere o non sussistere di un altro stato di cose (2.061 e 2.062).
Non è difficile rendersi conto in che modo questa indipendenza sia connessa con la tematica della semplicità: dalla posizione della semplicità degli oggetti segue senz’altro la possibilità difatti non scomponibili in altri - di fatti che non includono nessun altro fatto e dai quali, dunque, non si può concludere a nessun alto. Perciò anche 1’ indipendenza reciproca degli stati di cose va senz’altro annoverata tra le condizioni della sensatezza: essa fa tutt’uno con il postulato che la scomposizione di ogni complesso nei suoi costituenti debba giungere a un termine.
2.
Nelle prime proposizioni del Tractatus si parla spesso, in luogo di oggetto (Gegenstand), di cosa (Ding). I commenti indicano di solito che Wittgenstein usa questi due termini come sinonimi. Questa circostanza suggerisce comunque la possibilità di illustrare la nozione di oggetto, che ha ormai per noi il carattere di una nozione «tecnica», facendo riferimento alle cose che ci stanno intorno. Certamente, non ci è lecito considerare alcuna di esse come un oggetto: a quanto sembra, esse mancano di tutti i requisiti che caratterizzano l’oggetto, anzitutto della semplicità, Per non dire dell’immutabilità e della permanenza. E caratteristico del modo di procedere di Wittgenstein che il rapporto tra gli oggetti e le cose che ci stanno intorno non venga nemmeno posto; e tanto meno si cerca di indicare un modo di accesso agli oggetti che non sia la loro postulazione «logica». Qualsiasi tentativo di concretizzare esemplificativamente la nozione di oggetto, e quindi quella di stato di cose, non potrà che essere fuorviante. Né avrà senso pone il problema se gli oggetti nell’accezione di Wittgenstein possano presentarsi, cioè se si possa dare il caso che io giunga di fronte a qualcosa e dica: ecco, questo è un oggetto!
Tuttavia, una certa fluttuazione dall’oggetto alla cosa e dalla cosa all’oggetto ci può essere utile e talora persino necessaria, se vogliamo procedere a qualche sviluppo.
Di ciò approfittiamo senz’alto per introdurre la nozione di forma degli oggetti.
Come esempi di forme degli oggetti vengono indicati lo spazio, il tempo e il colore (2.0251). Si tratta appunto di determinazioni che non possiamo far alto che riferire alla nozione generica e comune di cosa. Notiamo allora che le cose si differenziano in generale secondo le forme di cui sono partecipi e che in base a queste forme esse possono o non possono entrare fra loro in determinati rapporti. Ad esempio, se due cose hanno forma spaziale, può accadere che l’una si trovi alla desta dell’altra; mentre non sembra che abbia senso parlare di un suono che si trova alla destra di un libro.
Non c’è dubbio che si possa intravvedere qui l’avvio di un discorso essenzialistico: la cosa ha un’«essenza», una «natura» (2.0123) dalla quale è «pregiudicata» ogni sua possibile occorrenza in stati di cose (2.012). Non vi è la cosa stessa e poi la possibilità, che si aggiunge in un secondo tempo, imprevista e imprevedibile, di entrare in questo stato di cose (2.021 e 2.0121). «Non si può trovare in un secondo tempo una nuova possibilità» (2.0123 (e)). Oppure, in un’altra formulazione: «Se posso pensare l’oggetto nel contesto dello stato di cose, non posso pensarlo al di fuori della possibilità di questo contesto» (2.0121(e)).
Tuttavia non si vuole sostenere che vi sia una forma e le possibilità relazionali in essa fondate: in realtà non abbiamo altro mezzo per determinare la forma se non quello di rinviare a queste possibilità. Effettuiamo, in altri termini, questo rovesciamento: in quanto una cosa ha queste e quelle possibilità relazionali, noi diciamo che essa ha una certa forma. La forma della cosa è l’ambito delle sue sintassi possibili.
Quando chiediamo, ad esempio, che cosa significhi dire che la tal cosa ha la forma del tempo oppure del colore dovremmo rispondere all’incirca così: diciamo che una cosa è temporale se essa può entrare con alte nella relazione dell’essere prima o dopo, che è colorata se può entrare con alte nella relazione dell’essere più chiara o più scura, e così via. Wittgenstein non vuol dire certo che qualcosa, combinandosi con altre cose, divenga, ad esempio, colorata, ma che determinare un colore è determinare una relazione.
Se questa lettura è corretta, non avremo difficoltà ad intendere la definizione generale della forma che suona: «La forma è la possibilità della struttura » (2.033) - una volta che si sia precisato che con struttura di uno stato di cose intendiamo il modo in cui gli oggetti sono connessi gli uni agli altri nello stato di cose (2.036). Cosicché la forma di un oggetto non sarà niente altro che l’insieme dei modi in cui esso può stutturarsi con altri oggetti.
Il punto su cui fa leva tutto ciò è la distinzione tra la possibilità di una sintassi e la sua realizzazione. La cosa è interamente descritta, nella sua forma determinata, dall’ambito determinato delle sue possibili occorrenze in stati di cose. Conoscere una cosa è conoscere in quali stati di cose può occorrere (e in quali non lo può). «Se conosco l’oggetto, conosco anche tutte le possibilità del suo occorrere in stati di cose» (2.0123).
Di conseguenza, dovremo affermare ad un tempo l’indipendenza dell’oggetto rispetto allo stato di cose e la relatività di questa indipendenza. Una cosa non deve necessariamente presentarsi in questo o in quello stato di cose, ma non può non presentarsi in uno stato di cose (2.0122). «È essenziale alla cosa il poter essere la parte costitutiva di uno stato di cose» (2.011). Non vi sono cose indipendenti in assoluto, cose che non rinviano a nessi possibili di stati di cose.
E se da un lato la possibilità di entrare in certe strutture determina l’oggetto in quanto è un oggetto temporale, la possibilità di entrare in altre strutture in quanto è un oggetto colorato, e così via, la possibilità in generale di strutturarsi in stati di cose determina ciò che è l’oggetto in quanto è soltanto un oggetto - senza altre qualificazioni. La possibilità di occorrere in stati di cose è «la forma dell’oggetto» (2.0141). Gli oggetti contengono la possibilità di tutte le situazioni (2.014). E se sono dati tutti gli oggetti sono dati tutti gli stati di cose (2.0124).
Ovviamente l’oggetto come oggetto sarà «incolore», quindi atemporale, ecc., dal momento che queste caratterizzazioni circoscrivono ambiti determinati di sintassi possibili, all’interno dell’ambito delle sintassi possibili in generale. Quest’ultimo è a sua volta circoscritto e delimitato, ma l’unica restrizione, qui, è una restrizione logica. Le connessioni escluse sono le connessioni logicamente impossibili.
La metafora dello «spazio» illustra tutto ciò quasi in ogni dettaglio. In tedesco «Raum» significa, oltre che «spazio», anche «stanza». In italiano, comunque, ci intendiamo se parliamo dello spazio di questa stanza. Diciamo, ad esempio, che lo spazio di questa stanza è occupato da certi oggetti, da cose. Diciamo anche che una cosa occupa una posizione o un luogo in esso. Lo spazio è un insieme di luoghi che possono essere occupati da cose, l’occupazione di un luogo è la realizzazione di una possibilità di localizzazione.
Questi luoghi saranno determinati relazionalmente - come ogni punto nella rappresentazione cartesiana. Perciò lo spazio come insieme di luoghi sarà nello stesso tempo l’insieme delle relazioni che li determinano. Determinare un luogo è niente altro che determinare una relazione.
Kant diceva, avendo di mira tutt’altro problema, che «non si può mai formare la rappresentazione che non vi sia spazio, sebbene si possa benissimo pensare che in esso non si trovi nessun oggetto»[2]: affermazione che Wittgenstein riecheggia, piegandola al proprio uso analogico, in questo modo:
«Ogni cosa è come in uno spazio di possibili stati di cose. Questo spazio posso pensarlo vuoto, ma non posso certo pensare la cosa senza lo spazio» (2.013). Ed ancora: «Come non possiamo affatto pensare oggetti spaziali fuori dello spazio, oggetti temporali fuori del tempo, così non possiamo pensare alcun oggetto fuori della possibilità del suo nesso con altri» (2.0121(d)).
Non vi sono, ad esempio, suoni isolati, suoni che non occupano un luogo nello spazio sonoro. Determinare un suono significa fissare la posizione di quel suono rispetto ad ogni altro suono che può occupare un luogo nello spazio. Parlare di un suono fuori dello spazio sonoro non ha senso esattamente come non lo ha il parlare di un punto fuori del piano. Così io posso concepire lo spazio sonoro vuoto, «privo di suoni». Il silenzio è silenzio solo nello spazio sonoro, o meglio: il silenzio è lo spazio sonoro vuoto, esso contiene tutte le possibilità sonore, ma come possibilità non realizzate. E se un suono è posto, è posto anche l’insieme delle sue sintassi possibili.
Come in precedenza abbiamo parlato di forme diverse, così parleremo ora di spazi diversi, e tra essi potranno sussistere relazioni molteplici. Una superficie nel campo visivo non può non avere un colore, «ha, per così dire, lo spazio cromatico intorno a sé» (2.0131). Lo spazio sonoro giace interamente nello spazio temporale (il tempo deve essere una delle sue coordinate). Lo spazio cromatico giace interamente al di fuori dello spazio sonoro.
Infine: ogni spazio giace nello spazio logico. Tutte le configurazioni di oggetti, le configurazioni cromatiche, sonore, temporali, ecc., debbono essere anche configurazioni logiche. Perciò possiamo affermare che nulla di illogico può accadere, che tutti i fatti sono nello spazio logico (1.13); oppure che «la logica è trascendentale» (6.13(b)), se vogliamo usare questo termine per indicare che nella logica sono contenute le condizioni di possibilità di ogni fatto, o inversamente: se vi sono condizioni di possibilità dei fatti queste sono da ricercare soltanto nella logica, e in null’altro. (Naturalmente, il reticolo che abbiamo presentato all’inizio era già un immagine dello «spazio logico».)
3.
La maggior parte delle difficoltà che si incontrano nei commenti riguardanti la teoria dell’immagine (2.1* e 2.2*), che forma il punto di congiunzione tra la tematica ontologica e quella linguistica, deriva dall’accoglimento senza critica del suggerimento che Wittgenstein stesso presenta in un passo dei Quaderni, nel quale ci viene proposta questa figura
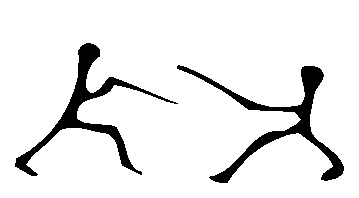
accompagnata dall’osservazione che «in riferimento ad essa deve potersi dimostrare tutto l’essenziale» (Q, p. 92).
Si è stati così indotti a speculare più dello stretto necessario sui disegni, tacendo spesso il secondo filo conduttore che sta alla base delle considerazioni di Wittgenstein: «Io ho ereditato questo concetto di immagine da due lati: in primo luogo dall’immagine come disegno e in secondo luogo dall’immagine del matematico che è già un concetto più generale. Infatti il matematico parla di raffigurazione anche nei casi in cui il pittore non userebbe questa espressione»[3].
Volendo attenerci strettamente agli sviluppi del Tractatus, il nostro problema si presenterà semplicemente come un tentativo di risposta alla domanda che chiede in che modo un fatto possa diventare l’immagine di un altro fatto. Il rapporto di immagine è anzitutto un peculiare rapporto tra fatti: da un lato vi è il fatto raffigurante, dall’altro quello raffigurato. Il fatto raffigurante consterà di oggetti non meno del fatto che esso raffigura - ma l’introduzione di un nuovo termine è, in questo caso, senz’altro opportuna. Gli oggetti che occorrono nel fatto raffigurante li chiameremo elementi dell’immagine, ed essi saranno coordinati agli oggetti di cui consta il fatto raffigurato. Nell’immagine, gli elementi stanno per gli oggetti. Questa relazione di coordinamento tra elemento e oggetto la chiameremo relazione raffigurativa (2.13 e 2.153).
Nell’immagine deve trovare rappresentazione, in particolare, il modo in cui gli oggetti si trovano riferiti l’uno all’altro nel fatto raffigurato, cioè la sua struttura. In una naturale estensione terminologica potremmo allora parlare di struttura dell’immagine per indicare la connessione tra gli elementi dell’immagine in quanto raffigura la connessione degli oggetti di cui consta il fatto. Struttura dell’immagine è dunque la configurazione dei suoi elementi nella misura in cui essa svolge una funzione raffigurativa.
A questo punto il passaggio dalla nozione di struttura dell’immagine a quella di forma della raffigurazione si impone da sé. Infatti non facciamo che ripetere un cammino già noto. La forma della raffigurazione è la possibilità della struttura dell’immagine (2.15(b)). Il colore, ad esempio, sarà una forma della raffigurazione se l’ambito delle possibili configurazioni cromatiche viene utilizzato in una funzione rappresentativa.
In generale le forme degli oggetti divengono forme della raffigurazione nella misura in cui si presentano come veicoli per immagini possibili.
Chiediamo ora: che cosa debbono avere in comune l’immagine e ciò che essa raffigura, dal momento che il rapporto di immagine richiede in ogni caso qualcosa di comune tra i suoi termini (2.161)? Noi sappiamo che un immagine cromatica può raffigurare un fatto cromatico, una immagine spaziale un fatto spaziale (2.171). Ma questa omogeneità del veicolo è inessenziale: è possibile, ad esempio, raffigurare mediante un fatto spaziale (una «figura») un fatto sonoro (una «melodia»). Ciò che rende possibile il rapporto di immagine in questi casi come nei precedenti è - osserva Wittgenstein - l’identità di forma logica (2.18).
Potremmo spiegare: le relazioni tra gli elementi dell’immagine debbono avere le stesse «proprietà logiche» delle relazioni tra gli oggetti del fatto. Questa identità è la condizione essenziale del rapporto di raffigurazione. La forma logica della raffigurazione è «ciò che ogni immagine, di qualunque forma essa sia, deve avere in comune con la realtà per poterla raffigurare» (2.18).
Benché Wittgenstein parli di immagine logica come un immagine la cui forma di raffigurazione è quella logica (2.181), tuttavia non bisogna ritenere che la forma logica sia una forma della raffigurazione accanto alle altre forme e l’immagine logica un’immagine accanto ad immagini di altra forma. Questo non può essere il rapporto tra la forma logica di raffigurazione e le altre forme, tra immagini logiche e immagini cromatiche, spaziali, sonore, ecc., per le stesse ragioni per le quali lo spazio logico non è uno spazio accanto agli altri spazi. L’affermazione: «Ogni immagine è anche un immagine logica. (Invece, ad esempio, non ogni immagine è un immagine spaziale)» (2.182) dovrebbe essere integrata così: nessuna immagine è soltanto un’immagine logica. L’immagine logica è ciò che tutte le immagini (spaziali, cromatiche, sonore, ecc.) dello stesso fatto hanno in comune.
Come è chiaro, la somiglianza nel senso usuale, per la quale si dice che un disegno è più o meno simile all’originale che esso raffigura non può rappresentare una buona guida per una simile impostazione, che richiede unicamente la trasposizione, su questo nuovo terreno, dello schema elementare proposto nel quadro della teoria degli oggetti. È vero tuttavia che nel Tractatus la posizione della proposizione come immagine avviene accentuando proprio questo aspetto della somiglianza nell’accezione consueta; in esso si ripete ciò che si era già detto nei Quaderni:«Per comprendere l’essenza della proposizione pensiamo alla grafia geroglifica che raffigura i fatti che descrive» (4.016). «A prima vista la proposizione - quale, ad esempio, è stampata sulla carta - non sembra sia un’immagine della realtà della quale tratta». Eppure essa può essere considerata come un ’immagine di ciò che rappresenta «anche nel senso consueto del termine» (4.01 1). Ma anche in contesti come questi il discorso non può che concludersi sulla comunanza di forma logica, sulla sussistenza di «regole di proiezione» che sono le sole a rendere possibile l’istituzione di un rapporto rappresentativo (4.9141).
L’insistenza sulla somiglianza nel senso consueto sembra tuttavia avere una spiegazione abbastanza precisa: anzitutto si tratterà di non rinunciare ad un’analogia illustrativa che può risultare in qualche caso particolarmente efficace. In secondo luogo, tentando, anche a costo di qualche forzatura, di approssimare al massimo l’immagine in una accezione astratta («matematica») e l’immagine in senso consueto, nella quale io vedo letteralmente la situazione che essa raffigura, si vuol suggerire che l’opposizione tra la visione di qualcosa come immagine e l’applicazione di regole potrebbe non essere un’opposizione effettiva. In fondo anche in rapporto ad un dipinto potremmo dire: solo se vi è l’applicazione di qualche regola il dipinto si mostra come immagine di qualche cosa. In se stesso, esso non è che un aggregato di macchie di colore.
4.
Per illustrare le cose dette potremmo riferirci al metodo usuale di notazione musicale, facendo liberamente uso di tutte le semplificazioni opportune in modo da non essere vincolati a particolarità estranee allo scopo.
Il rigo

rappresenta lo spazio sonoro. Tutti i fatti possibili del mondo dei suoni debbono poter essere raffigurati mediante questo segno, benché esso non rappresenti alcun suono, e quindi non appartenga all’immagine allo stesso titolo di un suo elemento. Il rigo contrassegna piuttosto le coordinate del mondo dei suoni, e quindi, nello stesso tempo, le proprietà che ogni suono deve possedere. L’altezza, ad esempio, è una di queste proprietà, ed il rigo presenta anzitutto una scala di altezze; senza porre limiti ad essa. Lo spazio sonoro è, teoricamente, infinito.
Non solo «ogni cosa è come in uno spazio di possibili stati di cose» (2.013), ma anche: «L’oggetto spaziale deve giacere nello spazio infinito (il punto dello spazio è un posto di argomento)» (2.0131). «Nessuno può concepire i limiti di una qualche estensione o spazio senza concepire oltre essi altri spazi che lo seguano immediatamente»[4].
Un suono sarà rappresentato da un punto sul rigo, un insieme di suoni da un insieme di punti. Che un punto sia sufficiente per la rappresentazione del suono è già un indizio del fatto che per noi i suoni sono «semplici». Ogni altra figura risulterebbe inutilmente complessa (benché possa svolgere la stessa funzione rappresentativa). Un punto rappresenta un suono solo se occupa una certa posizione sul rigo. Un punto fuori del rigo
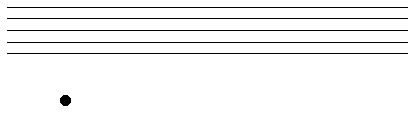
è privo di significato nella notazione musicale. La determinazione del suono è puramente relazionale: disporre un punto sul rigo è fissare un grado nella scala delle altezze.
Riconsideriamo sulla base di questo riferimento illustrativo ciò che si era detto a proposito della relazione raffigurativa e della struttura dell’immagine. Si trattava da un lato di operare un coordinamento tra elemento e oggetto, dall’altro di fissare una regola in base alla quale una determinata relazione tra elementi fungesse da rappresentazione di una determinata relazione tra gli oggetti. Guardiamo ora all’esempio. Noi non coordiniamo un punto ad un suono e poi lo disponiamo sul rigo. Come potemmo farlo se ogni punto è identico ad ogni altro? I due momenti non possono essere intesi come separati l’uno dall’altro: l’istituzione di una relazione raffigurativa presuppone già lo spazio, cioè il sistema di tutte le possibili configurazioni sonore (benché nel segno dello spazio sonoro debba in ogni caso essere indicata l’«origine»).
Quanto alla struttura della raffigurazione, limitando l’esempio alla rappresentazione del rapporto di simultaneità e di successione, ci si potrà attenere alla regola secondo la quale a punti spazialmente successivi da sinistra a destra corrisponderanno suoni temporalmente successivi, alla sovrapposizione dei punti la simultaneità dei suoni. In questo modo la struttura dell’immagine mostra la struttura del fatto che essa raffigura, cioè il modo in cui gli elementi sono configurati tra loro nell’immagine mostra in che modo gli oggetti sono strutturati tra loro nei tatto.
Notiamo infine che in questo caso, come del resto in quello delle immagini nel senso usuale, troviamo ovvio che una relazione tra gli oggetti raffigurati venga rappresentata da una relazione tra i segni, e non da un segno di relazione (mentre troviamo altrettanto ovvio che ciò non accada nel nostro linguaggio).
5.
Nel momento in cui ci accingiamo a parlare del senso dell’immagine e della sua verità e falsità (2.2*) abbiamo in realtà la sensazione di trovarci già sul terreno delle proposizioni, trattandosi di nozioni che sappiamo in qualche modo applicare anzitutto in riferimento ad esse. Il richiamo all’immagine, questa volta nel senso consueto, tende ora a riprendere il carattere di una semplice e utile analogia.
Si tratta di un punto che, pur con le precisazioni già in dicate, non deve essere perduto di vista: restiamo colpiti dal fatto che, in fondo, una proposizione è qualcosa di simile ad un immagine nel senso consueto, che in luogo di parole potremmo usare delle figure, e ci appigliamo a questa analogia utilizzandola nella misura del possibile. Del resto non vi sono forse grafie geroglifiche «dove ogni parola presenta il proprio significato» (Q, p. 92)?
In particolare un’immagine può essere una copia più o meno fedele dell’originale, e allora potremmo forse parlare di verità e falsità dell’immagine, portandoci ad un passo dalla tematica della proposizione.
Considerando le cose da questo punto di vista, ci rendiamo subito conto di una certa imprecisione nella nostra esposizione precedente: abbiamo parlato di immagine come un rapporto tra fatti, senza sottolineare che, se 1’ analogia tra proposizione e immagine deve in qualche modo funzionare, non dobbiamo concepire l’immagine come un calco del fatto, come qualcosa che lo riproduce nello stesso modo in cui uno specchio riflette ciò che ha di fronte (altrimenti non vi sarebbero immagini «false»).Si impone cioè la distinzione, in precedenza trascurata, tra il fatto che l’immagine intende presentare e il fatto che l’immagine presenta. Ciò introduce un elemento di complicazione che, in realtà, le poche cose che Wittgenstein dice in proposito riescono a stento a dominare.
Vogliamo illustrare questa distinzione elaborando l’esempio dell’incidente stradale ricordato da Wittgenstein nei Quaderni (Q, p. 91).
Supponiamo dunque di dover ricostruire mediante un modello come sono andate le cose in un incidente stradale di cui siamo stati testimoni. La presentazione di un modello può fare le veci di un discorso che descrive le circostanze del fatto, una volta che si siano istituite certe relazioni raffigurative e certe regole della raffigurazione.
Può accadere ora che due testimoni descrivano il fatto in modi diversi, ed entrambe le descrizioni pretenderanno di corrispondere al modo in cui sono andate effettivamente le cose. Se parliamo di «ciò che l’immagine raffigura» questa espressione sarebbe perciò equivoca. Con essa si può intendere, da un lato, il fatto che si ha di mira nel produrre l’immagine, dall’altro, il fatto che l’immagine prodotta presenta. Nel produrre l’immagine entrambi i testimoni hanno di mira lo stesso fatto (l’incidente stradale a cui hanno assistito); ma lo presentano in modo diverso, presentano cioè immagini diverse. Se con senso dell’immagine intendiamo «ciò che l’immagine presenta» (2.221), allora dobbiamo distinguere nettamente tra questo senso e la «realtà», il fatto inteso, o, come dice una volta Wittgenstein, usando il termine ovviamente in un’accezione lata, 1’ «oggetto» dell’immagine. Tra l’immagine e il suo «oggetto» vi è un rapporto di reciproca esteriorità (2.172): per questo l’immagine può essere vera o falsa. E la diremo vera se si accorda con la realtà; altrimenti falsa (2.222).
L’immagine è provvista di senso se può essere vera o falsa, ed in questo modo la sensatezza è connessa con la verità e falsità. Può essere che le cose siano andate così:
l’immagine ha senso, cioè «presenta una situazione possibile nello spazio logico» (2.202). La questione della sensatezza è una questione logica proprio nella misura in cui rinvia ad una possibilità (2.021(c)); e se diciamo che essa può essere decisa a priori, ciò significa soltanto che 1’ accertamento della possibilità della situazione presentata dalla immagine potrà essere effettuata sull’immagine stessa, mentre l’accertamento della sua verità o falsità richiede il confronto con la realtà (2.223).
Ma fino a che punto possiamo spingerci nell’uso di questa analogia? Un’immagine, se ha senso, può, in particolare, essere falsa: noi ammettiamo cioè che a un’immagine possa non corrispondere nulla nella realtà. Del resto, oltre che di proposizioni positive, ci serviamo anche di proposizioni negative, nelle quali presentiamo il non sussistere di stati di cose (2.11). È chiaro che qui vi è un problema che richiede qualche spiegazione: «Le cose non stanno così, eppure possiamo dire come non stanno» (Q, p. 120).
Ritorniamo al nostro esempio. Abbiamo detto che l’immagine presenta il suo «oggetto» dal di fuori, che essa è un «punto di vista» sul fatto. E può accadere che due testimoni non presentino soltanto modelli diversi dello stesso fatto, ma anche inconciliabili. Un’immagine contrasta con l’altra. Forse potremmo dire: la nega. Tuttavia non è questo il modo in cui parliamo di solito di «proposizione che nega una proposizione». Una proposizione è vera, se è falsa la proposizione che la nega, e inversamente. Nel caso delle immagini che descrivono in modo contrastante lo stesso fatto, se l’una è vera, l’altra è falsa, ma non necessariamente vale l’inverso. Possono essere entrambe false. Inoltre il loro rapporto è un rapporto di contrasto, ma prese isolatamente esse sono dirette positivamente alla realtà: i testi descrivono come stanno le cose, e non come esse non stanno. Se parlassimo di uno dei due modelli come negazione dell’altro, non potremmo mantenere l’unicità della negativa di una proposizione, che sembra essere un requisito essenziale per la trasposizione di questa tematica al terreno delle proposizioni.
Vi è un numero indefinito di immagini che escludono una certa immagine. E un’immagine presenta ciò che presenta, e non le immagini con le quali entra in contrasto. Non posso vedere da un immagine di due persone che non tirano di scherma che esse non tirano di scherma. Se lo vedo, ciò significa che in qualche modo proietto in essa un’alta immagine - quella delle persone che tirano di scherma (così come posso vedere in una fotografia l’assenza di Pietro solo se ne proietto la presenza).
In effetti, non dobbiamo confondere «ciò che non è con ciò che è in sua vece» (Q, p. 122).
La negazione di un’immagine la potremmo definire per astrazione da tutte le immagini che la negano - essa è ciò che hanno in comune tutte le immagini da cui essa è esclusa. Non si tratta di un’immagine accanto all’immagine negata, ma della sua esclusione. Perciò la negazione di una immagine non si realizza mediante un’altra immagine, ma mediante l’immagine che essa nega.
Come nel caso delle proposizioni: la proposizione negata fa parte della proposizione negante, il segno di una proposizione negativa deve essere formato mediante il segno di quella positiva, perché anche se convenissi che il non sussistere di un certo rapporto tra segni esprimesse il non sussistere di un certo fatto, anche in questo caso l’insussistenza di quel rapporto può essere colta solo nella proiezione della sua sussistenza (5.5151).
Nei Quaderni veniva proposta questa alternativa: «Che due persone non lottino lo si può rappresentare rappresentandole che non lottano ed anche rappresentandole che lottano e dicendo che l’immagine mostra come le cose non stanno» (Q, p. 111).
L’alternativa viene decisa nella seconda direzione: «Si potrebbe ad esempio mostrare come non tirare di scherma per mezzo di pupazzi che tirano di scherma» (Q, p. 115).
Ma con ciò illustriamo anche una circostanza particolarmente interessante. Per mostrare come non tirare di scherma per mezzo di pupazzi che tirano di scherma si dovrà, appunto, dire qualcosa su di essi. Oppure: se mediante un segno apposto all’immagine vogliamo indicare la sua esclusione, questo segno non appartiene all’immagine nello stesso modo degli altri segni che compaiono in essa come sue componenti raffigurative.
Proprio il fatto che la negazione non può che essere «fuori» dell’immagine richiama la nostra attenzione su questo punto: se nella proposizione si presenta il segno della negazione, esso deve avere un carattere da cui è contraddistinto rispetto a tutti gli altri segni che appartengono ad essa.
6.
Con la decisione di considerare la proposizione come una specie particolare di immagine è già segnata la via che Wittgenstein seguirà nello sviluppo di questo tema.
Non terremo anzitutto in nessun conto la struttura della proposizione in senso ordinario, nemmeno a titolo di iniziale filo conduttore per la posizione del problema. Il nostro scopo, infatti, non è quello di rendere ragione di essa, ma di caratterizzare quella che deve essere la struttura della proposizione in quanto essa è, in generale, l’espressione linguistica di un fatto. Abbandoniamo dunque la strada inizialmente seguita da Russell dove la grammatica del linguaggio ordinario deve essere assunta «se non come maestra, almeno come nostra guida» [5] e ci accingiamo invece ad un’illustrazione che abbia di mira la messa in chiaro della struttura teorica della proposizione, in uno sviluppo che si attenga strettamente alle semplici determinazioni acquisite nel quadro della teoria dell’immagine.
In realtà, si tratterà essenzialmente di fissare una nuova terminologia.
Gli elementi della proposizione come specie particolare di immagine li chiamiamo nomi. Il nome è dunque, nella proposizione, il rappresentante dell’oggetto (3.22). Il modo della connessione dei nomi, quindi la struttura della proposizione, mostra la struttura del fatto che essa presenta, quindi il suo senso (3.21). Ed anche in questo caso, come per le immagini in genere, una relazione verrà presentata da una relazione, e non da un segno di relazione[6].
I nomi di cui parla Wittgenstein non sono certamente le «parole» di cui constano le proposizioni ordinarie; non sono nemmeno ciò che nella grammatica ordinaria chiamiamo «nomi propri». La loro nozione è unicamente definita dalla funzione di rappresentanza degli oggetti, essendo questi a loro volta astrattamente caratterizzati nel modo che si è visto. Tuttavia, se vogliamo continuare a tener d’occhio le proposizioni ordinarie potremo anche pensare, quando si parla di nomi, alle parole - ma in nessun caso ci è lecito confondere i primi con le seconde. Ciò dipende dal modo in cui è stato impostato il problema. L’origine della nostra nozione di proposizione, e quindi quella di nome, deve essere puramente «logica». Affinché la proposizione possa essere l’espressione di un fatto, essa deve constare di nomi.
I nomi, poi, dovranno essere segni semplici, ed è chiaro che sorgeranno qui le stesse difficoltà nelle quali ci siamo imbattuti a proposito della semplicità degli oggetti. Essa non viene posta come relativa ad un contesto linguistico, e quindi fatta dipendere da qualche assunzione. Wittgenstein tenta invece di vincolare 1’ «indefinibilità» del nome alla sua semplicità, richiamandosi al postulato secondo cui il processo di scomposizione di ogni complesso deve giungere ad un termine. Il segno di un complesso può essere «definito» dai segni delle parti di cui esso consta: l’indefinibilità del nome fa allora tutt’uno con la sua semplicità. I nomi debbono essere segni semplici in quanto sono segni di semplici. La ripetizione dell’argomento sulla determinatezza del senso della proposizione servirà, d’alta parte, a mostrare la necessità dei nomi come costituenti ultimi della proposizione. Il senso di una proposizione è effettivamente determinato solo se esso consta di segni che designano senza alcun tramite linguistico. Essi, non possono essere segni «definiti», dal momento che questi designano attraverso i segni da cui sono definiti (3.261(b)). Perciò il nome occupa, nel linguaggio, una posizione limite. Esso è situato, per così dire, al margine del linguaggio e si spinge al di là di esso (2.1515).
Fisseremo la netta distinzione tra nome e proposizione anche sul piano terminologico dicendo che il nome denomina o significa l’oggetto, mente la proposizione descrive il fatto. Parleremo perciò di significato (Bedeutung) del nome, riservando il termine di senso (Sinn) alla proposizione. Nessun fatto potrà allora essere denominato e nessun oggetto essere descritto (3.144; 3.203; 3.221; 4.023(c)).
D’alto lato, le nozioni di nome e di proposizione si presuppongono l’un l’altra. Abbiamo già osservato che il senso della proposizione risulta dal modo di connessione dei nomi; ora aggiungiamo: «Solo nella connessione della proposizione un nome ha un significato» (3.3).
Frege diceva che «il significato di una parola non va spiegato considerando questa parola isolatamente, ma considerandola nel contesto di una proposizione»[7]. Ma vi è una differenza non certo irrilevante: nella formulazione di Frege si tratta di parole, in quella di Wittgenstein di nomi. Perciò in Frege ci si riferisce al linguaggio ordinario, in Wittgenstein ad un linguaggio che non può essere quello ordinario. La dipendenza del significato del nome dalla sintassi della proposizione non rappresenta altro che una trasposizione sul piano linguistico della tesi della sintatticità dell’oggetto sostenuta su quello ontologico. Come un oggetto non può sussistere isolatamente, indipendentemente dal suo occorrere in stati di cose, lo stesso si dovrà dire per i segni degli oggetti, per i nomi. Perciò si anticipava, nel contesto delle considerazioni ontologiche, e proprio come commento all’indipendenza relativa dell’oggetto rispetto allo stato di cose, che «è impossibile che le parole occorrano in due modi diversi: da sole e nella proposizione» (2.0122).
Proprio per riaffermare questo principio Wittgenstein ricorre ad un modo abbastanza tortuoso per introdurre la nozione di espressione (3.3*).
La proposizione consta di parti; queste parti contribuiscono a determinare il suo senso, e le chiamiamo espressioni. L’indicazione di un’espressione richiede perciò che sia indicato il riferimento all’unità proposizionale di cui essa è parte, e ciò può essere fatto mantenendo costante 1’ espressione nel contesto proposizionale in cui essa occorre e facendo variare tutto il resto (3.112). Otteniamo così una forma proposizionale come «carattere comune di una classe di proposizioni» (3.311).Questa forma la chiamiamo espressione, se vogliamo sottolineare in essa la presenza di una parte costante, oppure variabile proposizionale, se vogliamo invece sottolineare in essa la presenza di una parte variabile. Disponiamo così di due termini per designare una «funzione proposizionale».Il loro uso si divarica interamente, ed essi caratterizzano un’opposizione solo nei due casi estremi, in cui nessuna parte della proposizione è stata resa variabile oppure sono state rese variabili tutte le sue parti. Nel primo caso abbiamo un’espressione che è soltanto un’espressione: in essa ogni costituente è caratterizzato nella sua forma e nel suo contenuto (3.31(d)); nel secondo abbiamo invece una variabile proposizionale che è soltanto una variabile proposizionale, uno schema logico nel quale ogni costituente è contrassegnato solo formalmente (3.315).
Cosicché possiamo dire: non solo:«La proposizione stessa è un’espressione» (3.31(b)), ma anche: la proposizione stessa è soltanto un’espressione. Attraverso l’equivocità dei termini di espressione e di variabile proposizionale al di fuori dei casi limite si ribadisce dunque la tesi iniziale: «Solo la proposizione ha senso. Solo nella connessione della proposizione il nome ha un significato» (3.3)[8].
7.
Nonostante ciò che abbiamo detto, il rapporto tra proposizione wittgensteiniana come concatenazione di nomi e le proposizioni ordinarie resta in ogni caso il punto dolente.
Nel corso della trattazione si rafforza la nostra impressione di muoverci lungo una direttrice puramente astratta che tuttavia si interseca di continuo con considerazioni di tutt’altro ordine, con il risultato che la coerenza dello sviluppo non basta a dissolvere le oscurità che incontriamo ad ogni passo.
Anche dopo che si è insistito sul carattere teorico della nozione di proposizione in Wittgenstein, resta aperto il problema della connessione tra questa nozione teorica e le proposizioni ordinarie - qualche connessione vi deve pur essere.
È certo che le proposizioni nella loro formulazione usuale assolvono di volta in volta con maggiore o minore adeguatezza la funzione di essere portatrici di un senso, quindi di raffigurare fatti possibili. Dovremmo allora indicare nella forma della proposizione come concatenazione di nomi la sua reale forma logica che sarebbe, per così dire, nascosta dalla sua forma grammaticale consueta?
Wittgenstein pensa, in ogni caso, che il senso delle proposizioni nella loro formulazione ordinaria sia relativamente indeterminato perché esse contengono in realtà segni che designano complessi. In certo modo una proposizione ordinaria è il risultato di una fusione, di una sintesi di proposizioni: perciò di fronte ad essa si propone il compito di un’analisi che deve rendere chiaro il suo senso dispiegando le proposizioni in essa implicitamente contenute. Al termine di questa analisi dovremo giungere a proposizioni che rinviano direttamente alla realtà mediante nomi oppure, come ora diciamo, a proposizioni elementari. Il senso di una proposizione interamente risolta in proposizioni elementari è completamente ed esattamente determinato (4.023). Qui nessun equivoco della designazione può sorgere. E inversamente: se non tutto è completamente determinato dalla proposizione, allora un qualche suo elemento designa un complesso, e la proposizione non è interamente analizzata (3.24).
Perciò l’analisi deve mettere in chiaro in che modo la proposizione sia articolata dal punto di vista logico: l’articolazione logica della proposizione è infatti la condizione che rende la proposizione capace di esprimere un senso, e di esprimerlo in modo chiaro e ben determinato (3.251 e 4.032). Nel caso delle proposizioni elementari, senso e articolazione debbono addirittura coincidere: poiché esse vanno intese come concatenazioni di nomi, possiamo dire che proposizioni elementari che hanno un’articolazione logica diversa hanno anche un senso diverso.
Ma in che modo poi da questa chiarezza si procede alle sintesi che la oscurano sino a giungere alla proposizione ordinaria? Questo problema non viene nemmeno sfiorato e di conseguenza deve restare relativamente vaga e indeterminata quella possibilità di chiarificazione analitica di cui Wittgenstein non offre né un esempio di applicazione concreta né qualche indicazione che mostri in che modo essa possa in generale essere effettuata. Ed il rimando alla teoria russelliana delle descrizioni, che suggerisce l’intero discorso, non può certo essere considerato sufficiente a colmare queste lacune.
8.
Poche cose vanno aggiunte a proposito del senso della proposizione e della sua connessione con le nozioni di verità e falsità.
Nel Tractatus si insiste più volte, e secondo varie formulazioni, sul fatto che una proposizione ha senso se essa può essere vera o falsa, quindi sulla necessità di distinguere nettamente tra il modo in cui si accerta la sensatezza di una proposizione e il modo in cui si decide la sua verità o falsità. Si può comprendere una proposizione anche «senza sapere se essa è vera», poiché comprendere una proposizione non significa altro che sapere che cosa accade se essa è vera (4.024). Sullo sfondo, come obiettivo polemico, vi è la posizione di Frege - la concezione delle proposizioni come nomi di valori di verità.
Il primo punto della critica è l’irriducibilità della nozione di proposizione a quella di nome. Wittgenstein insinua che la considerazione della proposizione come «nome composto» sia da annoverare tra gli errori suggeriti dalle apparenze del linguaggio ordinario; o addirittura che in questo caso si sia stati tratti in inganno dalla consueta presentazione grafica del segno proposizionale che lo fa apparire come un segno «che non pare essenzialmente diverso dalla parola» (3.143). Ma il segno proposizionale è esso stesso un fatto, e l’irriducibilità della proposizione al nome è fondata ontologicamente nell’irriducibilità del fatto all’oggetto (3.14 e 3.1431).
Proprio operando una chiara distinzione tra nomi e proposizioni possiamo comprendere quella peculiarità di «comunicare con espressioni vecchie un senso nuovo» (4.03) che caratterizza un sistema di segni come un linguaggio in senso pieno e proprio.
Noi diciamo infatti che la proposizione mostra il suo senso (4.032). Ma ciò vuol forse dire altro se non che il senso di una proposizione deve poter essere compreso senza «spiegazioni» (4.021)? Accade qui esattamente come nel caso di un dipinto, dal quale vediamo, e senza spiegazioni, ciò che esso raffigura. Le parole, invece, hanno bisogno di spiegazioni (4.026), i nomi non sono immagini. In un linguaggio in cui ogni fatto sia rappresentato da un segno, il senso di ogni segno può essere compreso solo se ci viene spiegato, ed avremo a che fare con un sistema di segnali, piuttosto che con un linguaggio[9].
Tanto meno la proposizione potrà essere intesa come nome del vero e del falso. Verità e falsità indicano direzioni possibili della proposizione verso la realtà, indicano la possibilità di un confronto (4.05). Il nome non viene confrontato con la realtà: esso potrebbe essere assimilato ad un punto; la proposizione, invece, ad una freccia (3.144). Se concepissimo la proposizione come nome del vero e del falso non potremmo evitare di assumere il vero e il falso come oggetti - ed a questa conseguenza arriva coerentemente. Frege: vero e falso sono oggetti, oggetti logici. Ma che cosa significa qui questo aggettivo? E che cosa, del resto, il termine di oggetto?
In questa critica Wittgenstein presenta anche una sorta di argomento il cui scopo dovrebbe essere quello di mostrare come, assumendo l’opinione di Frege, si debba cadere in un circolo vizioso.
Ammettiamo che i valori di verità siano oggetti, e precisamente il significato delle proposizioni intese come nomi. In tal caso il significato di una proposizione resta indeterminato finché non le sia assegnato l’uno o l’altro dei valori di verità. Ma per assegnare ad una proposizione un valore di verità debbo confrontarlo con la realtà, e per effettuare questo confronto debbo anzitutto intendere ciò che essa dice (altrimenti non saprei che cosa confrontare). Per determinare il significato di una proposizione dobbiamo attribuire ad essa un valore di verità; ma possiamo attribuire un valore di verità alla proposizione solo se il suo significato è determinato.
Così per poter dire che un punto è bianco o nero debbo prima sapere in quali circostanze il punto si chiama «bianco» e in quali «nero»; per poter dire che una proposizione è vera o falsa debbo sapere come stanno le cose se essa è vera (4.063).
Sulla bontà dell’argomento non è il caso di insistere. Ciò che importa è la tesi complessiva di Wittgenstein: la posizione della verità e della falsità come oggetti confonde il modo in cui la verità e la falsità sono connesse alla sensatezza della proposizione. E ciò non sembra essere altro che una conseguenza dell’errore iniziale consistente nel ritenere che una proposizione sia qualcosa di simile ad un «nome composto».
Wittgenstein contesta anche la distinzione proposta da Frege tra «giudizio» in senso vero e proprio e «contenuto giudicativo», inteso come un’«assunzione proposta al giudizio»: tenendo conto del nostro riferimento analogico, si tratterebbe di qualcosa di simile ad un’immagine di cui non si dice se essa presenta come stanno le cose o come esse non stanno. A ciò Wittgenstein contrappone che non vi è «qualcosa di preliminare alla proposizione» (4.063(d)), che «ogni proposizione deve avere già un senso, l’ affermazione non glielo può dare, poiché essa anzi afferma il senso. E lo stesso vale della negazione, ecc.» (4.064). In realtà, il problema soggiacente a questa posizione richiama ancora una volta l’interpretazione del rapporto istituito dalla negazione.
Questo problema lo potremmo ora formulare così: la proposizione negante deve avere qualcosa in comune con la proposizione negata, eppure non deve avere nulla in comune. La via seguita da Wittgenstein non è quella che l’ammissione di un «contenuto giudicativo» sembra suggerire.
Ricorriamo ancora una volta alla nostra metafora dello spazio logico. Una proposizione individua in esso un luogo ed il rapporto istituito dalla negazione potremmo considerarlo come un rapporto tra luoghi. Ma allora è chiaro che non basta dire che la proposizione negante individua un luogo logico diverso da quello della proposizione negata, ma anche che il luogo logico della proposizione negante è determinato mediante quello della proposizione negata in modo tale che l’uno giace interamente al di fuori dell’altro (4.0641). Suggeriamo, in altri termini, di prendere in seria considerazione l’analogia tra questa situazione e quella della visione di una figura e del suo sfondo (Q, p. 119).
Figura e sfondo hanno certamente qualcosa in comune.
In che senso tuttavia hanno qualcosa in comune

la croce nera e lo sfondo bianco oppure la croce bianca e lo sfondo nero o semplicemente: la croce nera e la croce bianca? Il fatto è che noi possiamo vedere l’una o l’altra figura, e non entrambe nello stesso tempo. Perciò la linea che hanno in comune appartiene all’una o all’altra, e non ad ambedue (esse non hanno nulla in comune).
Note
[1] A mio avviso la spiegazione che Wittgenstein dà, in una lettera a Russell, intorno ai termini «fatto» (Tatsache) e «stato di cose» (Sachverhalt) (cfr. LR, p. 252) non preclude l’uso di «fatto» per indicare uno «stato di cose». Perciò uso il termine «fatto» come il termine più generale.
[2] I. Kant, Critica della ragione pura, trad. it. a cura di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Bari 1949, I, p. 69.
[3] Wittgenstein und der Wiener Kreis, Gespräche aufgezeichnet von F. Waismann hrsg. von B. F. McGuiness. Frankfurt a. M. 1967, p. 185.
[4] B. Spinoza, Principi della filosofia cartesiana, trad. it. a cura di E. de Angelis, Torino 1962, p. 164.
[5] B. Russell, I principi della matematica, trad. it. a cura di L. Geymonat, Milano 1963, p. 87.
[6] A questo proposito Wittgenstein azzarda anche un esempio: «Non il segno complesso ' aRb' dice che a sta nella relazione R a b, ma: che 'a' sia in una certa relazione a 'b' dice che aRb» (3.1432). In altri termini: il segno «R» può essere eliminato istituendo una regola relativa alla disposizione dei segni «a» e «b» tale per cui a quella relazione tra i segni corrisponde la relazione R tra i designati (2.15).
L’esempio di Wittgenstein è naturalmente un esempio ad hoc e va preso per quella che vale. Notiamo a questo proposito che affermare che la proposizione wittgensteiniana ha forma «a-b-c-d» (come accade spesso di leggere) o non ha senso o ha un senso molto peregrino: nel caso migliore non si dice di più di quanto dica l’affermazione che la proposizione deve essere una concatenazione di nomi e lo si dice male (come se esemplificassi la forma delle frasi musicali con quattro punti).
[7] G. Frege, I fondamenti dell’aritmetica, in Logica e aritmetica, Scritti raccolti a cura di C. Mangione, Torino, Boringhieri, 1965, p. 345.
[8] La lettura della prop. 3.3* è molto controversa. La proposta di interpretazione qui indicata sembra comunque rendere conto nel modo più semplice dell’uso che Wittgenstein fa dei termini di espressione e di variabile proposizionale oltre che delle sue ragioni.
[9] Wittgenstein und der Wiener Kreis, op. cit., p. 235.