Democrito ride del mondo
(particolare da Bramante, Democrito ed Eraclito)
Lezione zero
1. Il tema del corso di quest'anno - Problemi di filosofia della percezione - è, come vedete, piuttosto vago e non circoscrive se non in modo approssimativo il tema che intende affrontare. Parleremo appunto della percezione, e ci soffermeremo in modo particolare sulla natura dell'oggetto che le è proprio, immergendoci in una serie di problemi che hanno alle loro spalle una storia complessa: discuteremo gli argomenti volti a mostrare il carattere illusorio della percezione, mostreremo che cosa si intende quando si parla di rappresentazionalismo e, infine, cercheremo di chiarire che cosa siano gli oggetti della percezione in un approccio realistico fenomenologico.
Sulla natura di questi problemi avremo modo in seguito di chiarirci le idee e di cogliere quale sia il nesso che li attraversa e che li rende meno distanti gli uni dagli altri di quanto si possa pensare. E tuttavia prima di addentrarci nei temi che ci accompagneranno in questi mesi è forse opportuno porsi una domanda cui il titolo del corso sembra implicitamente negare un effettivo interesse. Questa domanda potremmo formularla così: vi sono davvero problemi filosofici della percezione?
Sul significato di questa domanda è necessario soffermarsi un poco. Che una teoria della percezione si imbatta in molti problemi complessi è un fatto indiscutibile ed è altrettanto certo che le risposte che oggi sappiamo dare per far luce sulla natura dei processi percettivi non sono tutte pienamente soddisfacenti e alcune verranno in seguito corrette o senz'altro rifiutate. Problemi dunque vi sono, - ma sono problemi filosofici?
Su questo si deve essere chiari: la percezione non è un oggetto che appartenga alla riflessione filosofica e proporre una teoria filosofica dei processi che determinano la percezione del colore, dei suoni o dello spazio sarebbe, credo, altrettanto insensato quanto scrivere un trattato filosofico sull'assimilazione degli zuccheri. E ciò è quanto dire che la percezione appartiene di diritto al terreno della ricerca scientifica: i problemi di una teoria della percezione sono dunque problemi di natura psicologica, fisiologica, chimica e fisica.
Ma se le cose stanno così, che senso ha parlare di problemi filosofici della percezione? E se una teoria filosofica della percezione non c'è perché parlare in generale di una filosofia della percezione? Si tratta di domande legittime, cui vorrei cercare di rispondere innanzitutto richiamando un passo delle Ricerche filosofiche che ha per oggetto la percezione visiva. Qui Wittgenstein osserva che ciò che gli interessa non è la natura dei processi percettivi, ma è il concetto di visione e il posto che esso occupa nel contesto degli altri concetti d'esperienza. Che cosa ciò significhi è presto detto: tra le parole del nostro linguaggio vi sono verbi come vedere, udire, sentire, osservare, ascoltare, avvertire, e questi - così come altri termini di natura percettiva - hanno un loro impiego ben definito nel linguaggio: li usiamo in circostanze che possiamo descrivere, in contesti che possono assumere una valenza paradigmatica e che proprio per questo possono permetterci di scorgere la regola d'uso che è loro propria e che li differenzia gli uni dagli altri. Non tutto ciò che si sente lo si ascolta e non tutto ciò che si vede lo si può toccare con la punta delle dita, anche se vi sono casi in cui è possibile ascoltare ciò che si sente e vedere ciò che si tocca. E ancora: il la che ora risuona nell'aria stringe con il flauto da cui proviene la stessa relazione che lega lo stridere del treno alle ruote pesanti che mordono il ferro delle rotaie? I nostri problemi sono questi, e sono filosofici perché concernono la dimensione dell'analisi concettuale: ciò che ci interessa sono i concetti della percezione ed il posto che occupano nel vocabolario della nostra esperienza.
Da questa prospettiva generale di fatto non ci allontaneremo, e tuttavia la nettezza con cui Wittgenstein circoscrive quello che, a suo avviso, è il terreno di una filosofia della percezione non deve farci troppo presto distogliere lo sguardo dall'intreccio dei problemi che ci si pongono non appena cerchiamo di chiarire meglio come e dove debba essere tracciato il discrimine che separa la percezione come processo reale di cui fisica, fisiologia e psicologia debbono rendere conto dalla percezione come concetto che occupa un posto nel dizionario della nostra esperienza.
È anche per cercare di tracciare in modo più persuasivo questa distinzione che il corso prenderà l'avvio dalla discussione di un classico della riflessione filosofica che si muove in una prospettiva interamente diversa da quella che abbiamo appena indicato - cominceremo infatti a ragionare sui nostri problemi leggendo il Saggio sull'intelletto umano (1690) di John Locke. Ora, di questo lungo e complesso libro non leggeremo che poche pagine, e tuttavia è importante fin da principio indicare in che modo ci avvicineremo a questo e ai pochi altri testi che discuteremo insieme nelle lezioni del corso. Una prima osservazione è relativamente ovvia: questo non è un corso di storia della filosofia, e questo significa che possiamo risparmiarci almeno in parte la fatica di contestualizzare le pagine di Locke all'interno della filosofia del suo tempo e che non ci soffermeremo più di tanto a rendere conto del dibattito filosofico che pure è chiaramente implicato dalla lettura di quel testo. Un libro si può leggere anche così: facendo attenzione solo, o almeno prevalentemente, a ciò che dice e al modo in cui lo dice - agli argomenti che danno una dimensione filosofica ed uno spessore teorico alle decisioni che vengono di volta in volta prese. Theodor Lipps scriveva nella sua Estetica che le opere d'arte è come se fossero cadute dal cielo, ed io vi invito a fare qualcosa di simile con un testo filosofico: per noi tutti il Saggio deve essere anche un libro caduto dal cielo e precipitato nell'aula 510 il 15 febbraio del 2001.
Certo, noi tutti sappiamo che Saggio sull'intelletto umano è stato pubblicato molti anni fa - nel 1690, per essere precisi - e non è possibile leggere queste pagine senza avvertire di pagina in pagina la distanza che ci separa da quel tempo lontano. Questa distanza la si avverte in molti modi: la si legge nello stile espositivo, nei riferimenti agli autori e ai dibattiti vivi nell'ultimo scorcio del xvii secolo, ma la si avverte e, soprattutto, la si misura quando ci si stupisce del fatto che Locke non dica ciò che ci aspetteremmo dicesse o che lo dica seguendo un sentiero di cui non conoscevamo l'accesso o confidando in argomenti che traggono la loro plausibilità da un insieme di certezze che non sappiamo più condividere. Ma ciò è quanto dire che vi è un senso in cui la distanza storica di un testo non si coglie quando si sa pronunciare il nome del suo autore accanto a quello dei suoi contemporanei, ma si manifesta quando lo prendiamo sul serio e cerchiamo di ripensare i suoi problemi come se fossero nostri.
Di qui il modo in cui ci accosteremo alle pagine del secondo volume del Saggio sull'intelletto umano: leggeremo queste pagine così ragionate e belle assumendoci innanzitutto il compito di coglierne i problemi per ripensarli dall'interno, seguendo non la loro forma espositiva, ma quello che mi sembra essere il filo obiettivo dei ragionamenti che Locke ci propone. Ora, che questo non sia sufficiente per comprendere un libro importante come il Saggio è un fatto di cui dobbiamo essere consapevoli: molte (e forse troppe) cose mancano in ciò che dirò su questi primi nove capitoli del secondo volume del Saggio, ed è un fatto che molte cose possono dirsi soltanto se ci si dispone nella prospettiva dello storico delle idee e del pensiero. Si può forse dire di più: si può sostenere che cercare di ripensare da capo ciò che Locke dice senza dar troppo peso al contesto o alle molte pieghe in cui il suo argomentare si arricchisce e inviluppa, vuol dire necessariamente fermarsi ad un livello elementare di analisi, e se qualcuno avanzasse proprio questa obiezione ai nostri discorsi io non saprei davvero che cosa rispondere e non avrei nulla da ridire se non questo - che le cose elementari vanno tuttavia fatte, e per prime.
Lezione prima
Il Saggio sull'intelletto umano è un libro che è stato scritto da più di tre secoli - i quattro volumi di cui consta vengono pubblicati nel 1690 - e tuttavia, come abbiamo osservato nella precedente lezione, vorremmo egualmente cercare di trarre dalle sue pagine qualcosa che ci aiuti a comprendere meglio che cosa sia la percezione. In modo particolare, dalle pagine di Locke vorremmo trarre uno stimolo per riflettere su alcuni problemi che sorgono quando il fenomenologo si confronta con il fatto che la percezione è anche una relazione reale che lega gli organismi viventi al mondo esterno, - a quell'insieme di cose che sono diverse da come ci appaiono nelle nostre percezioni, anche se ne sono la causa.
Su questo Locke è chiaro. Noi uomini percepiamo così perché siamo fatti così e ciò che vediamo dipende dal modo in cui i nostri organi di senso e il nostro cervello reagiscono alla determinatezza fisica e chimica degli stimoli. Così, se questo mondo ci appare nel gioco mutevole e vario dei colori che si dispiegano alla vista, ciò accade perché la nostra retina è sensibile alla luce e sa discriminare alcune delle sue lunghezze d'onda - quelle site tra 400 e 700 nanometri (un nanometro è pari a un miliardesimo di metro). Di questo nostro privilegio - che tra i mammiferi dividiamo solo con i primati ma che ci accomuna ad animali assai meno nobili come gli insetti o i pesci - è forse lecito rallegrarsi, anche se non possiamo per questo dimenticare che della smisurata quantità di informazione che la luce veicola solo una piccola parte supera la barriera dei nostri occhi: tutto il resto cade semplicemente al di là di ciò che possiamo avvertire. E ciò è quanto dire che il modo in cui il mondo sensibilmente ci appare è del tutto contingente: lo spettacolo avrebbe potuto essere diverso, anche se non possiamo davvero immaginare come avrebbe potuto essere. Vi è dunque un senso in cui è davvero legittimo sostenere che il mondo che i sensi ci dischiudono è soltanto nostro e che quello che ci sembra essere il teatro delle nostre vicende e quindi lo spazio entro cui si costituisce ogni nostro avere a che fare con il mondo non è che l'eco della relazione reale che la totalità delle cose stringe con una sua parte: l'organismo umano.
Si tratta appunto di un fatto indiscutibile, e tuttavia non è facile dire quale sia la posizione che di fronte a questo fatto si deve assumere e quali le conseguenze filosofiche che è lecito trarne. Non vi è dubbio, infatti, che se ci poniamo in una prospettiva di stampo naturalistico la percezione deve apparirci proprio così - come un evento di natura causale che ha origine in un processo di natura fisica e fisiologica e che termina in un fatto mentale.
E tuttavia riconosce la natura causale dell'evento percettivo non significa ancora aver deciso qualcosa sul senso che attribuiamo alla nostra esperienza quando osserviamo non il processo da cui dipende il suo esserci, ma il modo in cui si presenta il suo contenuto. L'esperienza non è solo un evento, ma ha anche una sua dimensione fenomenologica che è accessibile prima di quanto non lo sia una considerazione puramente obiettiva del nesso percettivo: prima ancora di essere effetti sulla cui causa ci si possa interrogare, le nostre percezioni sono manifestazioni fenomeniche immediate. Ma ciò è quanto dire che è in linea di principio possibile sostenere che le percezioni sono immediatamente accessibili solo nella loro dimensione contenutistica e soggettiva e non nel loro porsi come eventi obiettivi che accadono in un mondo la cui conoscenza poggia evidentemente sui contenuti della nostra esperienza. Di qui sembra derivare una conclusione che può apparirci plausibile: se si vuole parlare della percezione come di un evento causale attruibuendo a queste considerazioni qualcosa di più che il valore di una ragionevole ipotesi sembra necessario riconoscere una qualche priorità alla dimensione fenomenologica, per vedere poi se, muovendo da questo terreno, non sia possibile trovare le ragioni che giustifichino una simile intepretazione dei fenomeni percettivi.
Locke di fatto ragiona proprio così, e nel secondo volume del Saggio getta le basi di una concezione causalistica della percezione che, tuttavia, non intende disporsi sul terreno delle scienze naturali, poiché ritiene necessario prendere le mosse da un'indagine descrittiva, - da quel metodo "storico e piano" che è caratteristico del Saggio.
Questa scelta teorica si annuncia fin nella premessa del Saggio, che ci invita a legare la forma del trattato alla finzione discorsiva di un dialogo tra amici: incerti su molti temi, Locke i suoi compagni avrebbero infine riconosciuto la necessità di un'indagine sulle forme e sui limiti della conoscenza, e quest'indagine ci viene presentata pagina dopo pagine in una forma letteraria che vuole essere coerente con questa finzione e che per questo adegua il suo stile al tono sommesso e pacato di chi immagina di parlare ad una cerchia ristretta di persone scelte ed amiche.
Ma sarebbe riduttivo cogliere in questa finzione soltanto lo sfondo immaginativo di uno stile filosofico che rifugge da forme linguistiche artefatte e che ci invita a pensare alla ricerca della verità come ad una prassi che si gioca in una comunità che, essendo animata da una passione che supera l'egoismo dei punti di vista, può proprio per questo reggersi soltanto sul legame di un'amicizia intessuta dei valori dell'intelletto. In quella finzione letteraria vi è altro: nel suo porre l'origine del Saggio nel chiuso di una stanza, Locke ci invita a considerare l'indagine filosofica come un'attività che non ha bisogno di indagini empiriche e sperimentali e che non rimanda ad altro che all'analisi e alla descrizione attenta di ciò che comunque ci è dato - la nostra esperienza. La filosofia del Saggio non è una filosofia da salotto, ma è pur sempre filosofia in un salotto, e non ha davvero bisogno di altro se non di ciò che ci è immediatamente accessibile: la ricca varietà delle idee che ci sono date e che possiamo comunque descrivere.
Ne segue che anche per Locke, la riflessione filosofica sulla natura della percezione deve innanzitutto muovere da una prospettiva descrittiva e deve prefiggersi il compito della chiarificazione concettuale: ne segue che se della percezione si deve discorrere come di una relazione causale ciò non accade in un contesto di natura fisica o fisiologica, ma a partire da considerazioni che vorrebbero di fatto muoversi sul terreno della descrizione di ciò che è propriamente dato alla coscienza. Per dirla in breve: se la percezione viene intesa come un evento che si spiega disponendolo sullo sfondo della relazione reale tra le cose e la dimensione sensibile della corporeità questo non accade per motivazioni che appartengono al terreno della fisica e della fisiologia, ma per un insieme di ragioni cui sembra possibile accedere senza abbandonare il piano dell'analisi della nostra esperienza percettiva.
Di quest'orientamento complessivo le prime battute del secondo libro del Saggio ci offrono un'illustrazione esemplare, poiché il dato primo su cui ci invitano a riflettere non è la posizione del corpo nel contesto del mondo e quindi delle relazioni causali che lo determinano, ma è il fatto innegabile della nostra consapevolezza. Noi siamo di fatto consapevoli di ciò che esperiamo o, come potremmo altrimenti esprimerci, abbiamo molteplici esperienze che ci sono immediatamente date e che costituiscono il punto di partenza per ogni ulteriore considerazione. Così la prima questione su cui Locke ci invita a riflettere è il fatto che siamo consapevoli delle nostre esperienze o, come nel Saggio solitamente ci si esprime, che abbiamo idee - questi oggetti filosofici, sulla cui natura dobbiamo venire in chiaro. Locke ritiene che si possa farlo così:
Idea is the object of thinking. Every man being conscious to himself that he thinks; and that which his mind is applied about whilst thinking being the ideas that are there, it is past doubt that men have in their minds several ideas,- such as are those expressed by the words whiteness, hardness, sweetness, thinking, motion, man, elephant, army, drunkenness, and others (Essay, II, i, 1).
Quello che ci viene qui proposto è davvero un curioso intreccio di tesi che vanno dipanate.
Vi è innanzitutto una sorta di definizione: Locke ci invita a chiamare idea ciò che è oggetto della nostra mente, e questa proposta che fa da titolo al primo paragrafo del secondo libro del Saggio viene di fatto illustrata osservando che vi sono molte cose di cui siamo consapevoli e che possiamo chiamare idee ciò di cui abbiamo coscienza quando per esempio comprendiamo il significato dei nomi del nostro linguaggio. Di qui lo strano elenco ("whiteness, hardness, sweetness, thinking, motion, man, elephant, army, drunkenness, and others ") che Locke ci propone e che ha evidentemente il compito di mostrare che cosa siano le idee invitandoci a riflettere su esempi che alludono a oggetti molto diversi gli uni dagli altri.
Non si tratta di una mossa casuale e nemmeno particolarmente nuova: di fatto Locke ci invita a comprendere che cosa siano le idee chiedendoci di riflettere sul significato delle parole, e nel proporci questo cammino sembra volersi richiamare all'articolazione classica delle Logiche di un tempo e così - dato che nel quarto libro del Saggio si parla del giudizio e nel terzo della forma linguistica - nel secondo si dovrà necessariamente discorrere di ciò su cui il giudizio verte - sul significato dei nomi. Di fatto, le idee ci sono presentate proprio così: le idee sono il significato di nomi come bianco, movimento, uomo, elefante, e così via. Parlare della nostra esperienza vorrà dire allora rivolgere lo sguardo alle idee e cogliere in esse, qualunque sia la loro natura, il significato dei termini che il giudizio connette in unità proposizionali. Giudicare del resto significa proprio questo, per Locke: connettere nome a nome nell'unità di una proposizione che potrà dirsi vera se gli oggetti che ciascun nome significa sono tra loro connessi proprio come lo sono i nomi nell'unità proposizionale ("if it so unites or separates them as in reality things are, it is right judgment" (ivi, iv, xiv, 3).
Di qui la prima ragione che Locke ci offre per aderire alla sua proposta teorica: dire che le idee sono oggetti significa in primo luogo osservare che le idee ci riconducono non a contenuti che ci siano dati in una forma logica qualsiasi, ma a contenuti nominali o nominalizzati dell'esperienza. Se le idee sono un modo per porgerci un determinato contenuto, allora è fin da principio opportuno osservare che la forma logica di questo porre è la stessa forma che è propria dei nomi. In altri termini: dire che le idee sono oggetti significa anche sostenere che la forma di rappresentazione che è propria delle idee è la forma nominale - quella forma che pone l'oggetto in quanto oggetto.
Questa prima constatazione generalissima non è tuttavia sufficiente per comprendere davvero perché si possa parlare delle idee come oggetti dell'intelletto. Ma se dagli esempi e dalla loro piega linguistica torniamo al nesso tra idee e consapevolezza su cui Locke ci invita a riflettere è possibile indirizzarsi verso una seconda, importante tesi. Nella proposizione che abbiamo dianzi citato si legge che vi sono idee nella mente e questa tesi viene affermata al di là di ogni ragionevole dubbio fondandosi su due differenti constatazioni: da un lato Locke ci invita a constatare che siamo consapevoli di pensare (questo termine preso nella sua accezione più vaga e più ampia) mentre dall'altro rammenta che il pensiero deve necessariamente esercitarsi su qualcosa, per proporci poi di chiamare questo qualcosa idee. In questo concatenarsi implicito di ragionamenti vi è un presupposto che dobbiamo mettere in luce perché ci permette di addentrarci ulteriormente nel problema che ci sta a cuore: Locke ritiene che sia lecito chiamare idea solo ciò di cui siamo direttamente consapevoli. Potremmo forse esprimerci così: Locke ci propone di chiamare idee solo ciò su cui il pensiero si esercita e ci invita insieme a legare in un unico nodo la consapevolezza, il percepire (il pensare) e l'avere idee (ivi, II, i, 9). Comprendere che cosa siano le idee significa allora necessariamente coglierle come correlato di un atto percettivo, di un pensiero di cui siamo consapevoli.
Di qui naturalmente si può muovere per comprendere che cosa ancora Locke voglia dire quando osserva che le idee sono oggetti del nostro intendimento - una tesi questa che può sembrarci così condivisibile da non meritare tutto il rumore che stiamo facendo intorno ad essa. E tuttavia, e nelle pagine dei filosofi questo capita più di quanto non si creda, le decisioni più importanti sembrano mosse scontate: decidiamo di chiamare idee ciò di cui abbiamo esperienza, e poi diciamo che le idee sono l'oggetto del nostro consapevole intendimento - che cosa potrebbe esserci di più ovvio? Ma la semplicità è talvolta soltanto apparente, e in questo caso la difficoltà si annida proprio nella parola "oggetto" che può significare almeno due cose diverse: si può parlare inaffi di oggetto, in una prima accezione del termine, per indicare qualcosa in quanto è il correlato di una relazione conoscitiva, ma si può anche parlarne, in una seconda accezione del termine, per intendere ciò che di fatto esperiamo.
Si tratta di una differenza sottile, ma non per questo meno avvertibile, e nella vita quotidiana tracciamo mille volte simili distinzioni. Così, se dico che mio fratello ha due figli dico qualcosa di una persona indicandola attraverso una relazione particolare che tuttavia non è affatto chiamata esplicitamente in causa dal senso di ciò che affermo: potrei non essere nato e quella persona che oggi è mio fratello potrebbe egualmente avere due figli. Ma se, indicandoli, dico di quei due bambini che sono miei nipoti le cose cambiano, perché in questo caso il fatto che mio fratello sia mio fratello non è un fatto accidentale ma è la ragione che mi autorizza a parlare di quei bambini come dei miei nipoti. Di qui la necessità di comprendere in che senso le idee siano oggetti del nostro intelletto, - se siano cioè le cose in quanto le esperiamo o le cose che di fatto esperiamo.
Ora, se ci poniamo nella prospettiva di Locke non vi dubbio che le idee siano oggetti nella prima ma non nella seconda (e più propria) accezione del termine. Di un oggetto nella seconda accezione del termine è sensato dire che c'è anche se non lo vediamo, e fa parte della grammatica dei nostri giochi linguistici più elementari la certezza che le molte cose che sfuggono ora al nostro sguardo esistano egualmente e siano del tutto indipendenti dal fatto che qualcuno ne abbia o meno coscienza. Questa naturalmente non è una tesi filosofica di stampo realistico: non sto in altri termini affermando che le cose del mondo ci sono e che non si curano delle nostre attenzioni. Sto semplicemente invitandovi ad osservare che il nostro concetto di cosa - di oggetto in seconda accezione - è fatto in questo modo e che è così che lo usiamo nel nostro intricato intreccio di giochi linguistici.
Ma che dire se invece degli oggetti parliamo delle idee? Per Locke non vi sono dubbi: le idee sono necessariamente il correlato di un atto soggettivo e non è pensabile che si possa disgiungerle dalla coscienza attuale che ne abbiamo. Dire che le idee sono oggetto della mente significa allora sostenere almeno questo: che è lecito parlare di idee solo per intendere oggetti soltanto in quanto sono oggetti per noi. Nel Saggio questa tesi è pronunciata in una forma ancor più impegnativa di quello che vorremmo sin qui asserire, perché Locke dice a chiare lettere che le idee "non sono null'altro che percezioni attuali nella mente e che cessano di essere alcunché non appena non abbiamo più percezione di esse" (ivi, II, x, 2).
Si tratta di un'affermazione più forte di quello che abbiamo detto sin qui: nel passo che abbiamo citato è racchiusa infatti una tesi di natura ontologica sulle idee, poiché di esse ci si dice che sono oggetti nella mente e che esistono solo nel loro essere percepiti. Ma anche nella sua forma più debole - anche se ci limitiamo a sostenere che sia opportuno contraddistinguere con il termine "idea" solo gli oggetti in quanto sono ora conosciuti e percepiti da noi - questa tesi potrebbe suscitare qualche perplessità: potremmo infatti dubitare che sia lecito parlare di idee solo per indicare qualcosa in quanto è un oggetto attualmente dato al nostro pensiero.
All'origine di queste perplessità vi sono innanzitutto alcune considerazioni che si legano alla natura del ricordo. Vado a trovare un amico e quando entro in casa sua vedo come tutto nella sua stanza è cambiato e mi rammento di come erano un tempo disposti i mobili; alla scena presente si affianca la scena passata che riemerge dalle profondità della memoria. Certo, possiamo esprimerci così, ma forse non saremmo disposti a prendere alla lettera quest'immagine, che pure ha tante ragioni dalla sua parte, quasi che si possa davvero pensare alla memoria come ad un vecchio armadio in cui, stipati in qualche modo, i ricordi aspettino pazientemente di farsi nuovamente strada verso la coscienza. Per Locke quest'immagine è falsa e questo perché ricordare non significa affatto ritrovare un'idea che si era persa, ma costruirne una nuova:
And in this sense it is that our ideas are said to be in our memories, when indeed they are actually nowhere;- but only there is an ability in the mind when it will to revive them again, and as it were paint them anew on itself, though some with more, some with less difficulty; some more lively, and others more obscurely. And thus it is, by the assistance of this faculty, that we are said to have all those ideas in our understandings which, though we do not actually contemplate, yet we can bring in sight, and make appear again, and be the objects of our thoughts, without the help of those sensible qualities which first imprinted them there (ivi, II, x, 2).
Ora, sostenere nel caso del ricordo che le nostre idee "non sono null'altro se non percezioni attuali nella mente di chi le vive" è una tesi abbastanza persuasiva. Non vi è dubbio tuttavia che la tesi dell'attualità possa talvolta diventare difficilmente sostenibile. Certo, vi sono casi in cui, quando chiamiamo in causa la soggettività, ci avvaliamo di espressioni che assumono un senso solo se le interpretiamo come affermazioni che dicono qualcosa di un determinato stato di coscienza: così chi dice di aver mal di denti intende dire che prova ora un dolore particolare in un luogo ben determinato del suo corpo. E a chi ci comunica questo suo stato ha certo senso domandare da quando avverte quel dolore e se si tratta di un male che non dà tregua o di un fastidio che va e viene. Ma le cose non stanno sempre così: chi afferma di avere letto venerdì sera l'Apologia e di sapere da allora che Socrate era un cittadino ateniese non intende per questo affermare di essere stato sempre animato da questa profonda verità, e non avrebbe certo senso domandargli se è riuscito egualmente a dormire o a distrarsi almeno per un attimo. Queste domande sono evidentemente fuori luogo, poiché chi afferma di sapere chi era Socrate non ci dice nulla sui suoi vissuti, ma ci informa su una sua capacità: ci dice che, se ora glielo chiedessimo, saprebbe raccontarci varie cose su quel famoso filosofo.
Non vi è dubbio che il linguaggio della riflessione lockeana tenda a cancellare questa distinzione: nella prospettiva del Saggio dire che qualcuno sa qualcosa significa sempre asserire che è animato da un determinato vissuto, da un'idea - e le idee "non sono null'altro se non percezioni attuali nella mente di chi le vive". Ora, puntare l'indice su questa difficoltà (che in una prospettiva diversa doveva colpire la mente acuta di Leibniz) non è forse particolarmente opportuno, poiché è un fatto che l'attenzione alla dimensione disposizionale del linguaggio della soggettività è una delle caratteristiche della riflessione teorica del xx secolo: se il problema fosse soltanto l'assenza in Locke della consapevolezza di una distinzione che sarebbe stata tracciata solo nella seconda metà del Novecento, allora sarebbe opportuno dimenticarsi di queste considerazioni.
Ma il punto è un altro. Se richiamiamo l'attenzione sul privilegio accordato all'attualità delle idee è perché a partire di qui si può scorgere un tratto che caratterizza la concezione lockeana della mente e che si riverbera sulla sua teoria della percezione. Il lettore del Saggio non può infatti non scorgere come l'accentuazione della tematica dell'attualità si leghi ad una concezione della mente che si disegna in opposizione alla concezione cartesiana della res cogitans, - di una sostanza che ha nel pensiero il suo tratto essenziale, proprio come la res extensa ha nel suo occupare spazio la sua proprietà inalienabile. Ora, che la mente percepisca e abbia una vita cosciente è un fatto indubitabile, almeno per Locke; ciò tuttavia non significa che sia davvero sostenibile che l'anima pensi sempre:
I know it is an opinion, that the soul always thinks, and that it has the actual perception of ideas in itself constantly, as long as it exists; and that actual thinking is as inseparable from the soul as actual extension is from the body [...]. For, by this account, soul and its ideas, as body and its extension, will begin to exist both at the same time. The soul thinks not always; for this wants proofs. But whether the soul be supposed to exist antecedent to, or coeval with, or some time after the first rudiments of organization, or the beginnings of life in the body, I leave to be disputed by those who have better thought of that matter. I confess myself to have one of those dull souls, that doth not perceive itself always to contemplate ideas; nor can conceive it any more necessary for the soul always to think, than for the body always to move: the perception of ideas being (as I conceive) to the soul, what motion is to the body; not its essence, but one of its operations (ivi, II, i, 10-11).
Ora, le ragioni di questa presa di posizione ci sono già note: se il percepire fa tutt'uno con il suo essere consapevole è necessario sostenere che l'anima pensa e percepisce solo quando è consapevole di farlo - una percezione inconsapevole sarebbe infatti una vera e propria contradictio in adjecto. Di qui la conclusione che Locke ci invita a trarre: vi è in ciascuno di noi qualcosa - l'anima o la mente - che ha la facoltà di percepire, ma sarebbe un errore immaginare che il percepire in atto sia essenziale alla coscienza stessa. Il percepire deve apparirci allora non come una proprietà inalienabile dell'io, ma come una sua possibile operazione.
Talvolta, e forse anche molto spesso, la mente percepisce e pensa. Ma il pensiero e la percezione non sono una proprietà della mente. Il pensiero non sta all'anima come il colore sta alla superficie cui aderisce; l'immagine da cui occorre lasciarsi guidare è un'altra, almeno per Locke: dobbiamo pensare al rapporto tra la mente e le sue percezioni richiamandoci piuttosto alla relazione che lega il corpo al suo movimento. Un corpo ora si muove ed ora è fermo, ed è per questo che non diremmo che il movimento è una proprietà di quel corpo, ma solo un suo possibile stato che proprio per la sua occasionalità ci spinge a cercarne le ragioni. Così stanno le cose anche per il nostro esperire, e ciò è quanto dire che la percezione non è una proprietà sostanziale e come tale indisgiungibile dall'io ma un evento che accompagna la vita della soggettività.
Per dimostrare che le cose stanno così Locke si spinge un passo più avanti, anticipando un tema su cui dovrà in seguito ritornare - il tema dell'identità personale. Se ci interroghiamo sulle condizioni di identità di un uomo dovremo probabilmente sostenere che la sua identità è vincolata alla continuità nel tempo del suo corpo vivo. Non si tratta di un'affermazione banale, perché Locke è ben consapevole che questa cosa che ci accompagna da sempre muta nel tempo e che forse di quel mucchietto di materia che eravamo tanti anni non è rimasto proprio più nulla. Il corpo nel tempo cresce, le sue parti si alterano e la sostanza che le compone viene sostituita da nuove molecole. Il nostro corpo è come la nave di Teseo: tratto a riva come ricordo di un gesto memorabile, quel vecchio legno attraversa gli anni, grazie alle cure degli ateniesi che ora sostituiscono un asse di legno marcita, ora ricuciono le vele, ora cambiano l'albero maestro inguaribilmente tarlato. Così di quella nave, nel tempo, non resta nemmeno una piccola parte, ma noi ci ostiniamo a chiamarla sempre con il suo nome perché non è mai venuta meno quella disposizione ordinata di parti e quell'unità peculiare che vale per noi come fondamento della sua identità. Anche per il nostro corpo le cose stanno così: nulla resta di ciò che un tempo costituiva il suo essere, e tuttavia questo è ancora il nostro corpo poiché lo attraversa da sempre un'identica organizzazione vitale.
Ora, queste considerazioni sono interessanti perché ci mostrano come l'identità sia, per Locke, una categoria che si applica non alle cose in se stesse, ma alle cose così come sono intese da noi. Il nostro corpo è fatto di molecole sempre differenti, ma in quanto corpo è lo stesso corpo: identità e differenza si scambiano il posto a seconda del modo in cui l'oggetto è oggetto per noi. Richiamare l'attenzione su questo punto è importante perché ci invita a riflettere sul fatto che ciò che diciamo essere un identico uomo potrebbe non essere più un'identica persona, poiché in questo caso ciò che determina le condizioni di identità non è più la continuità nel tempo e nello spazio di una stessa vita animale, ma è l'unità della trama di un racconto - il racconto della coscienza che rammenta ciò che è stato e che crea così in seno all'individualità del corpo l'unità e la singolarità di una persona, di quest'entità narrativa che di fatto abbraccia - per Locke - solo ciò di cui ha memoria ed è consapevole. Così, supponiamo che vi siano
two distinct incommunicable consciousnesses acting the same body, the one constantly by day, the other by night; and, on the other side, the same consciousness, acting by intervals, two distinct bodies: I ask, in the first case, whether the day and the night- man would not be two as distinct persons as Socrates and Plato? And whether, in the second case, there would not be one person in two distinct bodies, as much as one man is the same in two distinct clothings? (ivi, II, xxvii, 25).
Ora, sull'effettiva percorribilità di una simile tesi vi sarebbero certo molte cose da dire e forse non saremmo così disposti a ritenere che della nostra persona non facciano parte anche le cose che abbiamo dimenticato e quindi anche ciò che della nostra infanzia ci raccontano i genitori o gli amici. In altri termini: non siamo forse disposti a ritenere che nella grammatica del concetto di persona non sia in qualche modo racchiusa la possibilità di apprendere qualcosa dagli altri. Sulla persona che sono, sulla storia che mi appartiene, gli altri hanno anche per me una voce in capitolo, e non è affatto detto che io non possa imparare molte cose su di me parlando con gli altri. Possiamo anzi spingerci un passo in avanti e riconoscere che proprio là dove la riflessione su ciò che noi siamo diviene importante - nelle pagine di un'autobiografia o di un diario - l'esigenza stessa di scrivere nasce dalla convinzione che la mobilità del ricordo di ciò che sono debba confrontarsi con i molti volti della mia persona che il tempo allinea l'uno dopo l'altro.
Su questo tema si potrebbe discutere a lungo, ma ciò che ora ci interessa è osservare che a partire di qui non è difficile comprendere il senso della breve digressione cui Locke ci invita, anticipando un tema che gli sta molto a cuore. Il motivo è chiaro: Locke vuole costringerci a vedere l'insensatezza di una concezione che, per rendere percorribile la tesi metafisica dell'inseparabilità della res cogitans dal suo effettivo pensare, ci invita a chiudere gli occhi sui problemi che reca con sé l'ipotesi di una percezione inconsapevole o di una vita di esperienza che possa interamente dissolversi senza lasciare tracce nella memoria. Una simile ipotesi scardina il nesso tra soggettività ed identità personale e deve essere come tale abbandonata. Una percezione inconscia, una percezione che non lasciasse traccia nella coscienza è una percezione che alla lettera non appartiene alla mia vita di coscienza e che non ha un posto nella mia vita d'esperienza - poiché il soggetto dell'esperire non è l'uomo inteso come corporeità, ma la persona intesa appunto come trama unitaria e ripetibile nel ricordo di ciò che è consapevolmente vissuto.
Ma ciò significa insieme riconoscere che il percepire non è per la soggettività uno stato che faccia tutt'uno con la sua natura, ma è un fare e un reagire cui l'io è spesso chiamato. Su questo punto è necessario soffermarsi. Come abbiamo dianzi osservato, per Locke la percezione di idee si rapporta alla mente come il movimento si rapporta ai corpi: non ha a che fare con la sua essenza, ma è una delle sue operazioni (ivi, II, i, 10-11).
Ora, nel caso del movimento i corpi ricevono da altro la spinta che li costringe a muoversi, e qualcosa di simile sembra essere vero anche per la soggettività che nel percepire è eminentemente passiva:
In the reception of simple ideas, the understanding is for the most part passive. In this part the understanding is merely passive; and whether or no it will have these beginnings, and as it were materials of knowledge, is not in its own power. For the objects of our senses do, many of them, obtrude their particular ideas upon our minds whether we will or not; and the operations of our minds will not let us be without, at least, some obscure notions of them. No man can be wholly ignorant of what he does when he thinks. These simple ideas, when offered to the mind, the understanding can no more refuse to have, nor alter when they are imprinted, nor blot them out and make new ones itself, than a mirror can refuse, alter, or obliterate the images or ideas which the objects set before it do therein produce. As the bodies that surround us do diversely affect our organs, the mind is forced to receive the impressions; and cannot avoid the perception of those ideas that are annexed to them (ivi, II, i, 25).
Riconoscere che nel percepire la soggettività è passiva e che le idee si impongono alla coscienza che lungi dall'essere sempre percipiente è costretta a ricevere ciò che le si dà proprio come uno specchio non può fare a meno di riflettere i raggi di luce che lo colpiscono, significa porsi nella prospettiva migliore per chiedersi che cosa determini nell'io una risposta percettiva.
Nel riconoscimento della natura essenzialmente cosciente della percezione e nel suo carattere di passività Locke sembra dunque scorgere il fondamento teorico cui ricondurre una domanda che è in realtà già carica di presupposti - la domanda concernente la causa delle nostre percezioni. La classificazione della nostra vita di coscienza nelle sue diverse forme diviene così fin da principio in Locke una domanda sulle fonte da cui derivano le nostre idee.
2. Le considerazioni che abbiamo appena proposto ci spingono a guardare con uno sguardo mutato un'osservazione su cui ci eravamo brevemente soffermati e che concerneva il senso che si deve attribuire alla tesi secondo la quale le idee sono oggetti dell'intelletto. Su questo tema centrale eravamo giunti ad una prima delimitazione di campo: avevamo osservato come, in Locke, le idee fossero necessariamente poste come oggetti di un atto della coscienza e concernessero quindi una nozione di oggettività in cui l'essere oggetti per un soggetto non è un predicato accidentale, ma una proprietà essenziale. E tuttavia, per comprovare questa tesi avevamo citato un passo del Saggio che autorizzava una lettura più impegnativa: in quelle poche righe Locke non ci invitava soltanto a considerare le idee come correlati della soggettività, ma ci chiedeva di pensarle come entità mentali, il cui esse si riduce al percipi. Anche qui ci imbattiamo in una differenza sottile che deve essere colta: non è infatti la stessa cosa sostenere che le idee sono entità mentali o credere invece che con il termine "idea" si alluda agli oggetti in quanto sono colti dalla soggettività. Per dirla con un esempio: un conto è interessarsi di un paesaggio reale, in quanto è stato dipinto da un pittore, un altro interessarsi del paesaggio dipinto, del paesaggio che è sulla tela per opera di quel pittore.
Ora, non vi è dubbio che le riflessioni che abbiamo proposto sulla natura di evento dei processi percettivi ci spingono insensibilmente verso la conclusione che traspare nella citazione di Locke che abbiamo proposto. Accostare le idee ad eventi che hanno una causa vuol dire infatti fare un significativo passo nella direzione della tesi secondo la quale le idee sono oggetti che esistono nella mente sin quando la mente ne è consapevole. Del resto, verso questa conclusione ci spingono anche le affermazioni che seguono immediatamente l'incipit del secondo libro del Saggio sull'intelletto umano. Qui Locke non ci invita soltanto a constatare che ogni uomo ha nella sua mente molte idee, ma richiama la nostra attenzione su una domanda che da questo fatto discende e che chiede di essere discussa per prima: Locke si chiede infatti da dove vengano le idee che animano la soggettività. Vorrei che ci rendessimo conto fin da principio che non si tratta di una domanda ovvia, poiché non è affatto detto che ci si debba chiedere da dove le idee vengano. Questa domanda ovvia se ci chiediamo che cosa determini il fatto che io ora percepisca così e così: in questo caso diremmo che percepiamo x perché vi è uno stato di cose y che agisce causalmente sui nostri organi di senso, provocando un comportamento percettivo che ha appunto quella forma. Ma le cose cambiano se con percezione non intendiamo l'evento percettivo che si dà in noi, ma ciò che percepiamo - l'oggetto del nostro percepire. Così. se qualcuno per esempio ci domandasse da dove viene questa stanza che percepiamo noi non sapremmo davvero come rispondere. Diremmo semplicemente che la vediamo e che la vediamo perché siamo in questa stanza - e questa non sarebbe affatto una risposta, ma solo un invito a non farci domande oziose. In altri termini: dire che l'esperienza deve avere una causa non significa ancora affermare che, dal punto di vista descrittivo, il contenuto di senso della nostra esperienza debba essere inteso come un effetto, come un segno tracciato sulla pagina bianca della coscienza da una realtà che sta di là da essa. Questa conclusione dà per scontati almeno due passaggi intermedi:
che il nesso causale che nella percezione si esplica possa davvero chiamare in causa qualcosa di diverso da una serie di modificazioni temporanee dei nostri organi di senso e delle aree cerebrali ad essi preposte e che si possa davvero spingere sino a considerare come un effetto anche la nostra descrizione nel linguaggio quotidiano di ciò che esperiamo;
che sia comunque necessario porre la nostra descrizione del senso della nostra esperienza sotto l'egida del concetto di causa, quasi che il nostro esser consapevoli dell'origine causale della percezione sia un argomento sufficiente per modificare il vocabolario concettuale di cui comunque ci avvaliamo per parlarne.
Nel Saggio, tuttavia, le cose stanno diversamente e alla strana domanda che abbiamo appena formulato Locke ritiene di poter dare una risposta che leggiamo in tutti i manuali di filosofia e che sembra persuasiva perché stringe in un unico nodo il tema dell'origine delle idee con il compito di una loro classificazione:
All ideas come from sensation or reflection. Let us then suppose the mind to be, as we say, white paper, void of all characters, without any ideas: - How comes it to be furnished? Whence comes it by that vast store which the busy and boundless fancy of man has painted on it with an almost endless variety? Whence has it all the materials of reason and knowledge? To this I answer, in one word, from experience. In that all our knowledge is founded; and from that it ultimately derives itself. Our observation employed either, about external sensible objects, or about the internal operations of our minds perceived ad reflected on by ourselves, is that which supplies our understandings with all the materials of thinking. These two are the fountains of knowledge, from whence all the ideas we have, or can naturally have, do spring (ivi, II, i, 2).
Si tratta di una risposta che lascia perplessi per più di un motivo. In primo luogo ciò che ci colpisce è la tendenza ad affiancare, e quindi poi a contrapporre, le idee della sensazione e le idee della riflessione. Di queste due fonti da cui deriva ogni nostra esperienza si può parlare, per Locke, lasciandosi interamente guidare dalla metafora dello sguardo interiore come eco mentalistica dello sguardo in senso proprio - dello sguardo rivolto all'esterno: possiamo rivolgere l'attenzione al di fuori di noi e la sensazione nelle sue diverse forme ci offre una molteplicità di idee che rimandano ad oggetti esterni, ma possiamo anche rivolgere lo sguardo in noi stessi ed avremo allora molte e diverse idee che ci parlano delle operazioni (o delle passioni) della soggettività. Per dirla con Locke:
First, our Senses, conversant about particular sensible objects, do convey into the mind several distinct perceptions of things, according to those various ways wherein those objects do affect them. And thus we come by those ideas we have of yellow, white, heat, cold, soft, hard, bitter, sweet, and all those which we call sensible qualities; which when I say the senses convey into the mind, I mean, they from external objects convey into the mind what produces there those perceptions. This great source of most of the ideas we have, depending wholly upon our senses, and derived by them to the understanding, I call sensation. [...]. Secondly, the other fountain from which experience furnisheth the understanding with ideas is,- the perception of the operations of our own mind within us, as it is employed about the ideas it has got;- which operations, when the soul comes to reflect on and consider, do furnish the understanding with another set of ideas, which could not be had from things without. And such are perception, thinking, doubting, believing, reasoning, knowing, willing, and all the different actings of our own minds;- which we being conscious of, and observing in ourselves, do from these receive into our understandings as distinct ideas as we do from bodies affecting our senses. This source of ideas every man has wholly in himself; and though it be not sense, as having nothing to do with external objects, yet it is very like it, and might properly enough be called internal sense. But as I call the other sensation, so I Call this reflection, the ideas it affords being such only as the mind gets by reflecting on its own operations within itself (ivi, II, i, 3-4).
Da una parte abbiamo così le idee sensibili del giallo, della dolcezza o della solidità, dall'altra gli oggetti della riflessione e quindi le idee del percepire, del desiderare, del volere, e così via. Ora, che si possa parlare di idee diverse quasi che sia possibile distinguere esperienze che hanno per oggetto un colore (il bianco di questa pagina) ed altre che hanno per loro tema un'operazione della mente (il mio vedere, per esempio) è un fatto tutt'altro che ovvio, ed io credo che la descrizione lockeana sia sotto questo profilo falsante.
Ma appunto: Locke non intende immergersi in questi problemi e l'asimmetria descrittiva tra le idee della riflessione e le idee della sensazione cede subito il campo al parallelismo che sembra possibile istituire non appena ci si dispone sul terreno della presunta origine delle idee. Se ci si pone in questa prospettiva si deve riconoscere infatti che la mente può essere "messa in movimento" da una duplice fonte: dagli oggetti esterni e dalle sue operazioni, e cioè a dire dalla sensazione che convoglia gli stimoli sensibili sino all'intelletto che li comprende e dalla riflessione che riverbera nella mente le sue stesse operazioni, determinando così le idee che loro corrispondono.
A ben guardare, tuttavia, anche se ci poniamo nella prospettiva dell'origine, il senso esterno deve rivendicare una sua priorità sul senso interno: prima ancora di imparare a rivolgere l'attenzione alla dimensione dell'interiorità, la mente si è infatti già da sempre interessata alle cose esterne, a quegli oggetti che la circondano e che agiscono su di essa. Possiamo non riflettere sulle operazioni della mente, ma non possiamo sottrarci all'azione dei sensi:
hence we see the reason why it is pretty late before most children get ideas of the operations of their own minds; and some have not any very clear or perfect ideas of the greatest part of them all their lives. Because, though they pass there continually, yet, like floating visions, they make not deep impressions enough to leave in their mind clear, distinct, lasting ideas, till the understanding turns inward upon itself, reflects on its own operations, and makes them the objects of its own contemplation. Children when they come first into it, are surrounded with a world of new things, which, by a constant solicitation of their senses, draw the mind constantly to them; forward to take notice of new, and apt to be delighted with the variety of changing objects. Thus the first years are usually employed and diverted in looking abroad. Men's business in them is to acquaint themselves with what is to be found without; and so growing up in a constant attention to outward sensations, seldom make any considerable reflection on what passes within them, till they come to be of riper years; and some scarce ever at all (ivi, II, i, 8).
Di qui la posizione complessiva che traspare dalle pagine del Saggio sull'intelletto umano. Certo, per Locke vi sono due differenti fonti delle nostre idee: la riflessione e la sensazione; ciò non toglie tuttavia che sia la seconda e non la prima la causa originaria dell'attività della nostra mente che deve apparirci così come il luogo in cui gli stimoli fisici convogliati dagli organi di senso si traducono in un'immagine cosciente.
Di per sé lo stimolo fisico non è ancora esperienza; quest'ultima nasce soltanto quando la mente si rivolge alla sollecitazione che i nervi le conducono, prendendone atto:
whatever alterations are made in the body, if they reach not the mind; whatever impressions are made on the outward parts, if they are not taken notice of within, there is no perception. Fire may burn our bodies with no other effect than it does a billet, unless the motion be continued to the brain, and there the sense of heat, or idea of pain, be produced in the mind; wherein consists actual perception (ivi, II, ix, 3).
Il nodo del problema è proprio qui: comprendere la natura della percezione significa, per Locke, richiamare l'attenzione sulla natura della soggettività, sul suo constare di una mente che non ha nel pensiero un attributo inalienabile, ma il suo modo di reagire ad un'azione esterna di natura meccanica. Sulla natura di questo "prendere atto" Locke non si sofferma a lungo, ed il lettore può rimanere perplesso nel ravvisare se non una contraddizione, almeno una differenza di accento tra l'immagine della passività del percepire da cui Locke si spesso si lascia guidare ed il linguaggio razionalistico che sembra talvolta farsi strada quando Locke ci invita a rammentare che percezione vi è soltanto quando la mente dà udienza alle sue sensazioni:
How often may a man observe in himself, that whilst his mind is intently employed in the contemplation of some objects, and curiously surveying some ideas that are there, it takes no notice of impressions of sounding bodies made upon the organ of hearing, with the same alteration that uses to be for the producing the idea of sound? A sufficient impulse there may be on the organ; but it not reaching the observation of the mind, there follows no perception: and though the motion that uses to produce the idea of sound be made in the ear, yet no sound is heard (ivi, II, ix, 4).
Ma il senso complessivo del discorso è chiaro: Locke intende distinguere con nettezza la meccanicità degli stimoli dalla consapevolezza della mente, ma intende farlo senza recidere per questo l'evidenza del nesso causale da cui dipende il nostro esperire sensibilmente. Questo nesso deve essere tenuto presente, ed è per questo che la riflessione sulla consapevolezza delle idee e sulla radicale inconcepibilità di un percepire che non sia anche conscio si traduce, in Locke, da un lato nel rifiuto di una concezione cartesiana dell'anima, dall'altro nella constatazione che il percepire è per la mente non una proprietà da descrivere, ma un evento di cui rendere conto. Così, non è davvero un caso se il fatto originario della coscienza ("it is past doubt that men have in their mind several ideas") vale, per Locke, come un invito ad interrogarsi sulla fonte da cui tale idee hanno origine: se le idee sono percezioni e le percezioni sono eventi mentali, allora è del tutto lecito muovere dalla constatazione della loro presenza alla domanda concernente la loro origine. La riflessione sull'esperienza percettiva si dispone così fin da principio sul terreno di un'indagine causalistica.
Del resto che sia questa la concezione da cui Locke muove si manifesta con relativa chiarezza nelle immagini che egli ci propone per venire a capo della natura della coscienza, - immagini che sono senz'altro tradizionali ma che meritano di essere rammentate. Così, nella lettura del Saggio ci imbattiamo nell'immagine della mente come uno specchio che sulla sua superficie riflette le immagini delle cose che la luce gli consegna, e se quest'analogia viene talvolta messa da parte per richiamare alla mente l'immagine di un foglio di carta bianca su cui l'esperienza traccia i suoi segni (II, i, 2), ciò accade soltanto perché l'io non è privo di memoria e le idee, che pure scompaiono dalla mente per essere sempre di nuovo riproposte, non abbandonano la scena della coscienza senza lasciare un segno del loro passaggio: la rappresentazione immemore dello specchio (II, i, 15) o la fuggevolezza del segno che si imprime sulla sabbia per essere poi cancellato al primo alito di vento (II, i, 15) debbono cedere il campo alla stabilità cognitiva del foglio di carta che trasforma il riflesso in traccia, promettendo così quella permanenza delle idee nel tempo cui è affidata la possibilità della conoscenza e di ogni esperienza sensata.
E tuttavia, che sia foglio di carta o specchio, l'immagine della mente che prende forma in queste similitudine è la stessa: ciò che le accomuna è il loro intendere la mente come il luogo in cui un'azione fisica si trasforma in un messaggio, in una realtà di un nuovo tipo. Sul foglio di carta bianca e sulla superficie dello specchio qualcosa si disegna e si fa visibile, ma al di là dell'uno e dell'altro vi è un evento che si pone come il presupposto causale di quell'apparire:
For the objects of our senses do, many of them, obtrude their particular ideas upon our minds whether we will or not; and the operations of our minds will not let us be without, at least, some obscure notions of them. No man can be wholly ignorant of what he does when he thinks. These simple ideas, when offered to the mind, the understanding can no more refuse to have, nor alter when they are imprinted, nor blot them out and make new ones itself, than a mirror can refuse, alter, or obliterate the images or ideas which the objects set before it do therein produce. As the bodies that surround us do diversely affect our organs, the mind is forced to receive the impressions; and cannot avoid the perception of those ideas that are annexed to them (ivi, II, i, 25).
Così, le riflessioni lockeane sull'origine delle idee si sono trasformate sotto i nostri occhi in un'immagine della mente come un luogo peculiare in cui gli stimoli fisici si trasformano in effetti di natura psicologica. La classificazione delle idee che Locke ci propone nelle prime battute del secondo volume del Saggio diviene il luogo per invitarci a pensare all'esperienza come ad un evento che capita alla soggettività. E come per ogni altro evento, anche per l'esperienza percettiva dovrà assumere un'importanza centrale il rimando alle cause da cui innanzitutto dipende.
Il Saggio sull'intelletto umano è un libro che è stato scritto da più di tre secoli - i quattro volumi di cui consta vengono pubblicati nel 1690 - e tuttavia, come abbiamo osservato nella precedente lezione, vorremmo egualmente cercare di trarre dalle sue pagine qualcosa che ci aiuti a comprendere meglio che cosa sia la percezione. In modo particolare, dalle pagine di Locke vorremmo trarre uno stimolo per riflettere su alcuni problemi che sorgono quando il fenomenologo si confronta con il fatto che la percezione è anche una relazione reale che lega gli organismi viventi al mondo esterno, - a quell'insieme di cose che sono diverse da come ci appaiono nelle nostre percezioni, anche se ne sono la causa.
Su questo Locke è chiaro. Noi uomini percepiamo così perché siamo fatti così e ciò che vediamo dipende dal modo in cui i nostri organi di senso e il nostro cervello reagiscono alla determinatezza fisica e chimica degli stimoli. Così, se questo mondo ci appare nel gioco mutevole e vario dei colori che si dispiegano alla vista, ciò accade perché la nostra retina è sensibile alla luce e sa discriminare alcune delle sue lunghezze d'onda - quelle site tra 400 e 700 nanometri (un nanometro è pari a un miliardesimo di metro). Di questo nostro privilegio - che tra i mammiferi dividiamo solo con i primati ma che ci accomuna ad animali assai meno nobili come gli insetti o i pesci - è forse lecito rallegrarsi, anche se non possiamo per questo dimenticare che della smisurata quantità di informazione che la luce veicola solo una piccola parte supera la barriera dei nostri occhi: tutto il resto cade semplicemente al di là di ciò che possiamo avvertire. E ciò è quanto dire che il modo in cui il mondo sensibilmente ci appare è del tutto contingente: lo spettacolo avrebbe potuto essere diverso, anche se non possiamo davvero immaginare come avrebbe potuto essere. Vi è dunque un senso in cui è davvero legittimo sostenere che il mondo che i sensi ci dischiudono è soltanto nostro e che quello che ci sembra essere il teatro delle nostre vicende e quindi lo spazio entro cui si costituisce ogni nostro avere a che fare con il mondo non è che l'eco della relazione reale che la totalità delle cose stringe con una sua parte: l'organismo umano.
Si tratta appunto di un fatto indiscutibile, e tuttavia non è facile dire quale sia la posizione che di fronte a questo fatto si deve assumere e quali le conseguenze filosofiche che è lecito trarne. Non vi è dubbio, infatti, che se ci poniamo in una prospettiva di stampo naturalistico la percezione deve apparirci proprio così - come un evento di natura causale che ha origine in un processo di natura fisica e fisiologica e che termina in un fatto mentale.
E tuttavia riconosce la natura causale dell'evento percettivo non significa ancora aver deciso qualcosa sul senso che attribuiamo alla nostra esperienza quando osserviamo non il processo da cui dipende il suo esserci, ma il modo in cui si presenta il suo contenuto. L'esperienza non è solo un evento, ma ha anche una sua dimensione fenomenologica che è accessibile prima di quanto non lo sia una considerazione puramente obiettiva del nesso percettivo: prima ancora di essere effetti sulla cui causa ci si possa interrogare, le nostre percezioni sono manifestazioni fenomeniche immediate. Ma ciò è quanto dire che è in linea di principio possibile sostenere che le percezioni sono immediatamente accessibili solo nella loro dimensione contenutistica e soggettiva e non nel loro porsi come eventi obiettivi che accadono in un mondo la cui conoscenza poggia evidentemente sui contenuti della nostra esperienza. Di qui sembra derivare una conclusione che può apparirci plausibile: se si vuole parlare della percezione come di un evento causale attruibuendo a queste considerazioni qualcosa di più che il valore di una ragionevole ipotesi sembra necessario riconoscere una qualche priorità alla dimensione fenomenologica, per vedere poi se, muovendo da questo terreno, non sia possibile trovare le ragioni che giustifichino una simile intepretazione dei fenomeni percettivi.
Locke di fatto ragiona proprio così, e nel secondo volume del Saggio getta le basi di una concezione causalistica della percezione che, tuttavia, non intende disporsi sul terreno delle scienze naturali, poiché ritiene necessario prendere le mosse da un'indagine descrittiva, - da quel metodo "storico e piano" che è caratteristico del Saggio.
Questa scelta teorica si annuncia fin nella premessa del Saggio, che ci invita a legare la forma del trattato alla finzione discorsiva di un dialogo tra amici: incerti su molti temi, Locke i suoi compagni avrebbero infine riconosciuto la necessità di un'indagine sulle forme e sui limiti della conoscenza, e quest'indagine ci viene presentata pagina dopo pagine in una forma letteraria che vuole essere coerente con questa finzione e che per questo adegua il suo stile al tono sommesso e pacato di chi immagina di parlare ad una cerchia ristretta di persone scelte ed amiche.
Ma sarebbe riduttivo cogliere in questa finzione soltanto lo sfondo immaginativo di uno stile filosofico che rifugge da forme linguistiche artefatte e che ci invita a pensare alla ricerca della verità come ad una prassi che si gioca in una comunità che, essendo animata da una passione che supera l'egoismo dei punti di vista, può proprio per questo reggersi soltanto sul legame di un'amicizia intessuta dei valori dell'intelletto. In quella finzione letteraria vi è altro: nel suo porre l'origine del Saggio nel chiuso di una stanza, Locke ci invita a considerare l'indagine filosofica come un'attività che non ha bisogno di indagini empiriche e sperimentali e che non rimanda ad altro che all'analisi e alla descrizione attenta di ciò che comunque ci è dato - la nostra esperienza. La filosofia del Saggio non è una filosofia da salotto, ma è pur sempre filosofia in un salotto, e non ha davvero bisogno di altro se non di ciò che ci è immediatamente accessibile: la ricca varietà delle idee che ci sono date e che possiamo comunque descrivere.
Ne segue che anche per Locke, la riflessione filosofica sulla natura della percezione deve innanzitutto muovere da una prospettiva descrittiva e deve prefiggersi il compito della chiarificazione concettuale: ne segue che se della percezione si deve discorrere come di una relazione causale ciò non accade in un contesto di natura fisica o fisiologica, ma a partire da considerazioni che vorrebbero di fatto muoversi sul terreno della descrizione di ciò che è propriamente dato alla coscienza. Per dirla in breve: se la percezione viene intesa come un evento che si spiega disponendolo sullo sfondo della relazione reale tra le cose e la dimensione sensibile della corporeità questo non accade per motivazioni che appartengono al terreno della fisica e della fisiologia, ma per un insieme di ragioni cui sembra possibile accedere senza abbandonare il piano dell'analisi della nostra esperienza percettiva.
Di quest'orientamento complessivo le prime battute del secondo libro del Saggio ci offrono un'illustrazione esemplare, poiché il dato primo su cui ci invitano a riflettere non è la posizione del corpo nel contesto del mondo e quindi delle relazioni causali che lo determinano, ma è il fatto innegabile della nostra consapevolezza. Noi siamo di fatto consapevoli di ciò che esperiamo o, come potremmo altrimenti esprimerci, abbiamo molteplici esperienze che ci sono immediatamente date e che costituiscono il punto di partenza per ogni ulteriore considerazione. Così la prima questione su cui Locke ci invita a riflettere è il fatto che siamo consapevoli delle nostre esperienze o, come nel Saggio solitamente ci si esprime, che abbiamo idee - questi oggetti filosofici, sulla cui natura dobbiamo venire in chiaro. Locke ritiene che si possa farlo così:
Idea is the object of thinking. Every man being conscious to himself that he thinks; and that which his mind is applied about whilst thinking being the ideas that are there, it is past doubt that men have in their minds several ideas,- such as are those expressed by the words whiteness, hardness, sweetness, thinking, motion, man, elephant, army, drunkenness, and others (Essay, II, i, 1).
Quello che ci viene qui proposto è davvero un curioso intreccio di tesi che vanno dipanate.
Vi è innanzitutto una sorta di definizione: Locke ci invita a chiamare idea ciò che è oggetto della nostra mente, e questa proposta che fa da titolo al primo paragrafo del secondo libro del Saggio viene di fatto illustrata osservando che vi sono molte cose di cui siamo consapevoli e che possiamo chiamare idee ciò di cui abbiamo coscienza quando per esempio comprendiamo il significato dei nomi del nostro linguaggio. Di qui lo strano elenco ("whiteness, hardness, sweetness, thinking, motion, man, elephant, army, drunkenness, and others ") che Locke ci propone e che ha evidentemente il compito di mostrare che cosa siano le idee invitandoci a riflettere su esempi che alludono a oggetti molto diversi gli uni dagli altri.
Non si tratta di una mossa casuale e nemmeno particolarmente nuova: di fatto Locke ci invita a comprendere che cosa siano le idee chiedendoci di riflettere sul significato delle parole, e nel proporci questo cammino sembra volersi richiamare all'articolazione classica delle Logiche di un tempo e così - dato che nel quarto libro del Saggio si parla del giudizio e nel terzo della forma linguistica - nel secondo si dovrà necessariamente discorrere di ciò su cui il giudizio verte - sul significato dei nomi. Di fatto, le idee ci sono presentate proprio così: le idee sono il significato di nomi come bianco, movimento, uomo, elefante, e così via. Parlare della nostra esperienza vorrà dire allora rivolgere lo sguardo alle idee e cogliere in esse, qualunque sia la loro natura, il significato dei termini che il giudizio connette in unità proposizionali. Giudicare del resto significa proprio questo, per Locke: connettere nome a nome nell'unità di una proposizione che potrà dirsi vera se gli oggetti che ciascun nome significa sono tra loro connessi proprio come lo sono i nomi nell'unità proposizionale ("if it so unites or separates them as in reality things are, it is right judgment" (ivi, iv, xiv, 3).
Di qui la prima ragione che Locke ci offre per aderire alla sua proposta teorica: dire che le idee sono oggetti significa in primo luogo osservare che le idee ci riconducono non a contenuti che ci siano dati in una forma logica qualsiasi, ma a contenuti nominali o nominalizzati dell'esperienza. Se le idee sono un modo per porgerci un determinato contenuto, allora è fin da principio opportuno osservare che la forma logica di questo porre è la stessa forma che è propria dei nomi. In altri termini: dire che le idee sono oggetti significa anche sostenere che la forma di rappresentazione che è propria delle idee è la forma nominale - quella forma che pone l'oggetto in quanto oggetto.
Questa prima constatazione generalissima non è tuttavia sufficiente per comprendere davvero perché si possa parlare delle idee come oggetti dell'intelletto. Ma se dagli esempi e dalla loro piega linguistica torniamo al nesso tra idee e consapevolezza su cui Locke ci invita a riflettere è possibile indirizzarsi verso una seconda, importante tesi. Nella proposizione che abbiamo dianzi citato si legge che vi sono idee nella mente e questa tesi viene affermata al di là di ogni ragionevole dubbio fondandosi su due differenti constatazioni: da un lato Locke ci invita a constatare che siamo consapevoli di pensare (questo termine preso nella sua accezione più vaga e più ampia) mentre dall'altro rammenta che il pensiero deve necessariamente esercitarsi su qualcosa, per proporci poi di chiamare questo qualcosa idee. In questo concatenarsi implicito di ragionamenti vi è un presupposto che dobbiamo mettere in luce perché ci permette di addentrarci ulteriormente nel problema che ci sta a cuore: Locke ritiene che sia lecito chiamare idea solo ciò di cui siamo direttamente consapevoli. Potremmo forse esprimerci così: Locke ci propone di chiamare idee solo ciò su cui il pensiero si esercita e ci invita insieme a legare in un unico nodo la consapevolezza, il percepire (il pensare) e l'avere idee (ivi, II, i, 9). Comprendere che cosa siano le idee significa allora necessariamente coglierle come correlato di un atto percettivo, di un pensiero di cui siamo consapevoli.
Di qui naturalmente si può muovere per comprendere che cosa ancora Locke voglia dire quando osserva che le idee sono oggetti del nostro intendimento - una tesi questa che può sembrarci così condivisibile da non meritare tutto il rumore che stiamo facendo intorno ad essa. E tuttavia, e nelle pagine dei filosofi questo capita più di quanto non si creda, le decisioni più importanti sembrano mosse scontate: decidiamo di chiamare idee ciò di cui abbiamo esperienza, e poi diciamo che le idee sono l'oggetto del nostro consapevole intendimento - che cosa potrebbe esserci di più ovvio? Ma la semplicità è talvolta soltanto apparente, e in questo caso la difficoltà si annida proprio nella parola "oggetto" che può significare almeno due cose diverse: si può parlare inaffi di oggetto, in una prima accezione del termine, per indicare qualcosa in quanto è il correlato di una relazione conoscitiva, ma si può anche parlarne, in una seconda accezione del termine, per intendere ciò che di fatto esperiamo.
Si tratta di una differenza sottile, ma non per questo meno avvertibile, e nella vita quotidiana tracciamo mille volte simili distinzioni. Così, se dico che mio fratello ha due figli dico qualcosa di una persona indicandola attraverso una relazione particolare che tuttavia non è affatto chiamata esplicitamente in causa dal senso di ciò che affermo: potrei non essere nato e quella persona che oggi è mio fratello potrebbe egualmente avere due figli. Ma se, indicandoli, dico di quei due bambini che sono miei nipoti le cose cambiano, perché in questo caso il fatto che mio fratello sia mio fratello non è un fatto accidentale ma è la ragione che mi autorizza a parlare di quei bambini come dei miei nipoti. Di qui la necessità di comprendere in che senso le idee siano oggetti del nostro intelletto, - se siano cioè le cose in quanto le esperiamo o le cose che di fatto esperiamo.
Ora, se ci poniamo nella prospettiva di Locke non vi dubbio che le idee siano oggetti nella prima ma non nella seconda (e più propria) accezione del termine. Di un oggetto nella seconda accezione del termine è sensato dire che c'è anche se non lo vediamo, e fa parte della grammatica dei nostri giochi linguistici più elementari la certezza che le molte cose che sfuggono ora al nostro sguardo esistano egualmente e siano del tutto indipendenti dal fatto che qualcuno ne abbia o meno coscienza. Questa naturalmente non è una tesi filosofica di stampo realistico: non sto in altri termini affermando che le cose del mondo ci sono e che non si curano delle nostre attenzioni. Sto semplicemente invitandovi ad osservare che il nostro concetto di cosa - di oggetto in seconda accezione - è fatto in questo modo e che è così che lo usiamo nel nostro intricato intreccio di giochi linguistici.
Ma che dire se invece degli oggetti parliamo delle idee? Per Locke non vi sono dubbi: le idee sono necessariamente il correlato di un atto soggettivo e non è pensabile che si possa disgiungerle dalla coscienza attuale che ne abbiamo. Dire che le idee sono oggetto della mente significa allora sostenere almeno questo: che è lecito parlare di idee solo per intendere oggetti soltanto in quanto sono oggetti per noi. Nel Saggio questa tesi è pronunciata in una forma ancor più impegnativa di quello che vorremmo sin qui asserire, perché Locke dice a chiare lettere che le idee "non sono null'altro che percezioni attuali nella mente e che cessano di essere alcunché non appena non abbiamo più percezione di esse" (ivi, II, x, 2).
Si tratta di un'affermazione più forte di quello che abbiamo detto sin qui: nel passo che abbiamo citato è racchiusa infatti una tesi di natura ontologica sulle idee, poiché di esse ci si dice che sono oggetti nella mente e che esistono solo nel loro essere percepiti. Ma anche nella sua forma più debole - anche se ci limitiamo a sostenere che sia opportuno contraddistinguere con il termine "idea" solo gli oggetti in quanto sono ora conosciuti e percepiti da noi - questa tesi potrebbe suscitare qualche perplessità: potremmo infatti dubitare che sia lecito parlare di idee solo per indicare qualcosa in quanto è un oggetto attualmente dato al nostro pensiero.
All'origine di queste perplessità vi sono innanzitutto alcune considerazioni che si legano alla natura del ricordo. Vado a trovare un amico e quando entro in casa sua vedo come tutto nella sua stanza è cambiato e mi rammento di come erano un tempo disposti i mobili; alla scena presente si affianca la scena passata che riemerge dalle profondità della memoria. Certo, possiamo esprimerci così, ma forse non saremmo disposti a prendere alla lettera quest'immagine, che pure ha tante ragioni dalla sua parte, quasi che si possa davvero pensare alla memoria come ad un vecchio armadio in cui, stipati in qualche modo, i ricordi aspettino pazientemente di farsi nuovamente strada verso la coscienza. Per Locke quest'immagine è falsa e questo perché ricordare non significa affatto ritrovare un'idea che si era persa, ma costruirne una nuova:
And in this sense it is that our ideas are said to be in our memories, when indeed they are actually nowhere;- but only there is an ability in the mind when it will to revive them again, and as it were paint them anew on itself, though some with more, some with less difficulty; some more lively, and others more obscurely. And thus it is, by the assistance of this faculty, that we are said to have all those ideas in our understandings which, though we do not actually contemplate, yet we can bring in sight, and make appear again, and be the objects of our thoughts, without the help of those sensible qualities which first imprinted them there (ivi, II, x, 2).
Ora, sostenere nel caso del ricordo che le nostre idee "non sono null'altro se non percezioni attuali nella mente di chi le vive" è una tesi abbastanza persuasiva. Non vi è dubbio tuttavia che la tesi dell'attualità possa talvolta diventare difficilmente sostenibile. Certo, vi sono casi in cui, quando chiamiamo in causa la soggettività, ci avvaliamo di espressioni che assumono un senso solo se le interpretiamo come affermazioni che dicono qualcosa di un determinato stato di coscienza: così chi dice di aver mal di denti intende dire che prova ora un dolore particolare in un luogo ben determinato del suo corpo. E a chi ci comunica questo suo stato ha certo senso domandare da quando avverte quel dolore e se si tratta di un male che non dà tregua o di un fastidio che va e viene. Ma le cose non stanno sempre così: chi afferma di avere letto venerdì sera l'Apologia e di sapere da allora che Socrate era un cittadino ateniese non intende per questo affermare di essere stato sempre animato da questa profonda verità, e non avrebbe certo senso domandargli se è riuscito egualmente a dormire o a distrarsi almeno per un attimo. Queste domande sono evidentemente fuori luogo, poiché chi afferma di sapere chi era Socrate non ci dice nulla sui suoi vissuti, ma ci informa su una sua capacità: ci dice che, se ora glielo chiedessimo, saprebbe raccontarci varie cose su quel famoso filosofo.
Non vi è dubbio che il linguaggio della riflessione lockeana tenda a cancellare questa distinzione: nella prospettiva del Saggio dire che qualcuno sa qualcosa significa sempre asserire che è animato da un determinato vissuto, da un'idea - e le idee "non sono null'altro se non percezioni attuali nella mente di chi le vive". Ora, puntare l'indice su questa difficoltà (che in una prospettiva diversa doveva colpire la mente acuta di Leibniz) non è forse particolarmente opportuno, poiché è un fatto che l'attenzione alla dimensione disposizionale del linguaggio della soggettività è una delle caratteristiche della riflessione teorica del xx secolo: se il problema fosse soltanto l'assenza in Locke della consapevolezza di una distinzione che sarebbe stata tracciata solo nella seconda metà del Novecento, allora sarebbe opportuno dimenticarsi di queste considerazioni.
Ma il punto è un altro. Se richiamiamo l'attenzione sul privilegio accordato all'attualità delle idee è perché a partire di qui si può scorgere un tratto che caratterizza la concezione lockeana della mente e che si riverbera sulla sua teoria della percezione. Il lettore del Saggio non può infatti non scorgere come l'accentuazione della tematica dell'attualità si leghi ad una concezione della mente che si disegna in opposizione alla concezione cartesiana della res cogitans, - di una sostanza che ha nel pensiero il suo tratto essenziale, proprio come la res extensa ha nel suo occupare spazio la sua proprietà inalienabile. Ora, che la mente percepisca e abbia una vita cosciente è un fatto indubitabile, almeno per Locke; ciò tuttavia non significa che sia davvero sostenibile che l'anima pensi sempre:
I know it is an opinion, that the soul always thinks, and that it has the actual perception of ideas in itself constantly, as long as it exists; and that actual thinking is as inseparable from the soul as actual extension is from the body [...]. For, by this account, soul and its ideas, as body and its extension, will begin to exist both at the same time. The soul thinks not always; for this wants proofs. But whether the soul be supposed to exist antecedent to, or coeval with, or some time after the first rudiments of organization, or the beginnings of life in the body, I leave to be disputed by those who have better thought of that matter. I confess myself to have one of those dull souls, that doth not perceive itself always to contemplate ideas; nor can conceive it any more necessary for the soul always to think, than for the body always to move: the perception of ideas being (as I conceive) to the soul, what motion is to the body; not its essence, but one of its operations (ivi, II, i, 10-11).
Ora, le ragioni di questa presa di posizione ci sono già note: se il percepire fa tutt'uno con il suo essere consapevole è necessario sostenere che l'anima pensa e percepisce solo quando è consapevole di farlo - una percezione inconsapevole sarebbe infatti una vera e propria contradictio in adjecto. Di qui la conclusione che Locke ci invita a trarre: vi è in ciascuno di noi qualcosa - l'anima o la mente - che ha la facoltà di percepire, ma sarebbe un errore immaginare che il percepire in atto sia essenziale alla coscienza stessa. Il percepire deve apparirci allora non come una proprietà inalienabile dell'io, ma come una sua possibile operazione.
Talvolta, e forse anche molto spesso, la mente percepisce e pensa. Ma il pensiero e la percezione non sono una proprietà della mente. Il pensiero non sta all'anima come il colore sta alla superficie cui aderisce; l'immagine da cui occorre lasciarsi guidare è un'altra, almeno per Locke: dobbiamo pensare al rapporto tra la mente e le sue percezioni richiamandoci piuttosto alla relazione che lega il corpo al suo movimento. Un corpo ora si muove ed ora è fermo, ed è per questo che non diremmo che il movimento è una proprietà di quel corpo, ma solo un suo possibile stato che proprio per la sua occasionalità ci spinge a cercarne le ragioni. Così stanno le cose anche per il nostro esperire, e ciò è quanto dire che la percezione non è una proprietà sostanziale e come tale indisgiungibile dall'io ma un evento che accompagna la vita della soggettività.
Per dimostrare che le cose stanno così Locke si spinge un passo più avanti, anticipando un tema su cui dovrà in seguito ritornare - il tema dell'identità personale. Se ci interroghiamo sulle condizioni di identità di un uomo dovremo probabilmente sostenere che la sua identità è vincolata alla continuità nel tempo del suo corpo vivo. Non si tratta di un'affermazione banale, perché Locke è ben consapevole che questa cosa che ci accompagna da sempre muta nel tempo e che forse di quel mucchietto di materia che eravamo tanti anni non è rimasto proprio più nulla. Il corpo nel tempo cresce, le sue parti si alterano e la sostanza che le compone viene sostituita da nuove molecole. Il nostro corpo è come la nave di Teseo: tratto a riva come ricordo di un gesto memorabile, quel vecchio legno attraversa gli anni, grazie alle cure degli ateniesi che ora sostituiscono un asse di legno marcita, ora ricuciono le vele, ora cambiano l'albero maestro inguaribilmente tarlato. Così di quella nave, nel tempo, non resta nemmeno una piccola parte, ma noi ci ostiniamo a chiamarla sempre con il suo nome perché non è mai venuta meno quella disposizione ordinata di parti e quell'unità peculiare che vale per noi come fondamento della sua identità. Anche per il nostro corpo le cose stanno così: nulla resta di ciò che un tempo costituiva il suo essere, e tuttavia questo è ancora il nostro corpo poiché lo attraversa da sempre un'identica organizzazione vitale.
Ora, queste considerazioni sono interessanti perché ci mostrano come l'identità sia, per Locke, una categoria che si applica non alle cose in se stesse, ma alle cose così come sono intese da noi. Il nostro corpo è fatto di molecole sempre differenti, ma in quanto corpo è lo stesso corpo: identità e differenza si scambiano il posto a seconda del modo in cui l'oggetto è oggetto per noi. Richiamare l'attenzione su questo punto è importante perché ci invita a riflettere sul fatto che ciò che diciamo essere un identico uomo potrebbe non essere più un'identica persona, poiché in questo caso ciò che determina le condizioni di identità non è più la continuità nel tempo e nello spazio di una stessa vita animale, ma è l'unità della trama di un racconto - il racconto della coscienza che rammenta ciò che è stato e che crea così in seno all'individualità del corpo l'unità e la singolarità di una persona, di quest'entità narrativa che di fatto abbraccia - per Locke - solo ciò di cui ha memoria ed è consapevole. Così, supponiamo che vi siano
two distinct incommunicable consciousnesses acting the same body, the one constantly by day, the other by night; and, on the other side, the same consciousness, acting by intervals, two distinct bodies: I ask, in the first case, whether the day and the night- man would not be two as distinct persons as Socrates and Plato? And whether, in the second case, there would not be one person in two distinct bodies, as much as one man is the same in two distinct clothings? (ivi, II, xxvii, 25).
Ora, sull'effettiva percorribilità di una simile tesi vi sarebbero certo molte cose da dire e forse non saremmo così disposti a ritenere che della nostra persona non facciano parte anche le cose che abbiamo dimenticato e quindi anche ciò che della nostra infanzia ci raccontano i genitori o gli amici. In altri termini: non siamo forse disposti a ritenere che nella grammatica del concetto di persona non sia in qualche modo racchiusa la possibilità di apprendere qualcosa dagli altri. Sulla persona che sono, sulla storia che mi appartiene, gli altri hanno anche per me una voce in capitolo, e non è affatto detto che io non possa imparare molte cose su di me parlando con gli altri. Possiamo anzi spingerci un passo in avanti e riconoscere che proprio là dove la riflessione su ciò che noi siamo diviene importante - nelle pagine di un'autobiografia o di un diario - l'esigenza stessa di scrivere nasce dalla convinzione che la mobilità del ricordo di ciò che sono debba confrontarsi con i molti volti della mia persona che il tempo allinea l'uno dopo l'altro.
Su questo tema si potrebbe discutere a lungo, ma ciò che ora ci interessa è osservare che a partire di qui non è difficile comprendere il senso della breve digressione cui Locke ci invita, anticipando un tema che gli sta molto a cuore. Il motivo è chiaro: Locke vuole costringerci a vedere l'insensatezza di una concezione che, per rendere percorribile la tesi metafisica dell'inseparabilità della res cogitans dal suo effettivo pensare, ci invita a chiudere gli occhi sui problemi che reca con sé l'ipotesi di una percezione inconsapevole o di una vita di esperienza che possa interamente dissolversi senza lasciare tracce nella memoria. Una simile ipotesi scardina il nesso tra soggettività ed identità personale e deve essere come tale abbandonata. Una percezione inconscia, una percezione che non lasciasse traccia nella coscienza è una percezione che alla lettera non appartiene alla mia vita di coscienza e che non ha un posto nella mia vita d'esperienza - poiché il soggetto dell'esperire non è l'uomo inteso come corporeità, ma la persona intesa appunto come trama unitaria e ripetibile nel ricordo di ciò che è consapevolmente vissuto.
Ma ciò significa insieme riconoscere che il percepire non è per la soggettività uno stato che faccia tutt'uno con la sua natura, ma è un fare e un reagire cui l'io è spesso chiamato. Su questo punto è necessario soffermarsi. Come abbiamo dianzi osservato, per Locke la percezione di idee si rapporta alla mente come il movimento si rapporta ai corpi: non ha a che fare con la sua essenza, ma è una delle sue operazioni (ivi, II, i, 10-11).
Ora, nel caso del movimento i corpi ricevono da altro la spinta che li costringe a muoversi, e qualcosa di simile sembra essere vero anche per la soggettività che nel percepire è eminentemente passiva:
In the reception of simple ideas, the understanding is for the most part passive. In this part the understanding is merely passive; and whether or no it will have these beginnings, and as it were materials of knowledge, is not in its own power. For the objects of our senses do, many of them, obtrude their particular ideas upon our minds whether we will or not; and the operations of our minds will not let us be without, at least, some obscure notions of them. No man can be wholly ignorant of what he does when he thinks. These simple ideas, when offered to the mind, the understanding can no more refuse to have, nor alter when they are imprinted, nor blot them out and make new ones itself, than a mirror can refuse, alter, or obliterate the images or ideas which the objects set before it do therein produce. As the bodies that surround us do diversely affect our organs, the mind is forced to receive the impressions; and cannot avoid the perception of those ideas that are annexed to them (ivi, II, i, 25).
Riconoscere che nel percepire la soggettività è passiva e che le idee si impongono alla coscienza che lungi dall'essere sempre percipiente è costretta a ricevere ciò che le si dà proprio come uno specchio non può fare a meno di riflettere i raggi di luce che lo colpiscono, significa porsi nella prospettiva migliore per chiedersi che cosa determini nell'io una risposta percettiva.
Nel riconoscimento della natura essenzialmente cosciente della percezione e nel suo carattere di passività Locke sembra dunque scorgere il fondamento teorico cui ricondurre una domanda che è in realtà già carica di presupposti - la domanda concernente la causa delle nostre percezioni. La classificazione della nostra vita di coscienza nelle sue diverse forme diviene così fin da principio in Locke una domanda sulle fonte da cui derivano le nostre idee.
2. Le considerazioni che abbiamo appena proposto ci spingono a guardare con uno sguardo mutato un'osservazione su cui ci eravamo brevemente soffermati e che concerneva il senso che si deve attribuire alla tesi secondo la quale le idee sono oggetti dell'intelletto. Su questo tema centrale eravamo giunti ad una prima delimitazione di campo: avevamo osservato come, in Locke, le idee fossero necessariamente poste come oggetti di un atto della coscienza e concernessero quindi una nozione di oggettività in cui l'essere oggetti per un soggetto non è un predicato accidentale, ma una proprietà essenziale. E tuttavia, per comprovare questa tesi avevamo citato un passo del Saggio che autorizzava una lettura più impegnativa: in quelle poche righe Locke non ci invitava soltanto a considerare le idee come correlati della soggettività, ma ci chiedeva di pensarle come entità mentali, il cui esse si riduce al percipi. Anche qui ci imbattiamo in una differenza sottile che deve essere colta: non è infatti la stessa cosa sostenere che le idee sono entità mentali o credere invece che con il termine "idea" si alluda agli oggetti in quanto sono colti dalla soggettività. Per dirla con un esempio: un conto è interessarsi di un paesaggio reale, in quanto è stato dipinto da un pittore, un altro interessarsi del paesaggio dipinto, del paesaggio che è sulla tela per opera di quel pittore.
Ora, non vi è dubbio che le riflessioni che abbiamo proposto sulla natura di evento dei processi percettivi ci spingono insensibilmente verso la conclusione che traspare nella citazione di Locke che abbiamo proposto. Accostare le idee ad eventi che hanno una causa vuol dire infatti fare un significativo passo nella direzione della tesi secondo la quale le idee sono oggetti che esistono nella mente sin quando la mente ne è consapevole. Del resto, verso questa conclusione ci spingono anche le affermazioni che seguono immediatamente l'incipit del secondo libro del Saggio sull'intelletto umano. Qui Locke non ci invita soltanto a constatare che ogni uomo ha nella sua mente molte idee, ma richiama la nostra attenzione su una domanda che da questo fatto discende e che chiede di essere discussa per prima: Locke si chiede infatti da dove vengano le idee che animano la soggettività. Vorrei che ci rendessimo conto fin da principio che non si tratta di una domanda ovvia, poiché non è affatto detto che ci si debba chiedere da dove le idee vengano. Questa domanda ovvia se ci chiediamo che cosa determini il fatto che io ora percepisca così e così: in questo caso diremmo che percepiamo x perché vi è uno stato di cose y che agisce causalmente sui nostri organi di senso, provocando un comportamento percettivo che ha appunto quella forma. Ma le cose cambiano se con percezione non intendiamo l'evento percettivo che si dà in noi, ma ciò che percepiamo - l'oggetto del nostro percepire. Così. se qualcuno per esempio ci domandasse da dove viene questa stanza che percepiamo noi non sapremmo davvero come rispondere. Diremmo semplicemente che la vediamo e che la vediamo perché siamo in questa stanza - e questa non sarebbe affatto una risposta, ma solo un invito a non farci domande oziose. In altri termini: dire che l'esperienza deve avere una causa non significa ancora affermare che, dal punto di vista descrittivo, il contenuto di senso della nostra esperienza debba essere inteso come un effetto, come un segno tracciato sulla pagina bianca della coscienza da una realtà che sta di là da essa. Questa conclusione dà per scontati almeno due passaggi intermedi:
che il nesso causale che nella percezione si esplica possa davvero chiamare in causa qualcosa di diverso da una serie di modificazioni temporanee dei nostri organi di senso e delle aree cerebrali ad essi preposte e che si possa davvero spingere sino a considerare come un effetto anche la nostra descrizione nel linguaggio quotidiano di ciò che esperiamo;
che sia comunque necessario porre la nostra descrizione del senso della nostra esperienza sotto l'egida del concetto di causa, quasi che il nostro esser consapevoli dell'origine causale della percezione sia un argomento sufficiente per modificare il vocabolario concettuale di cui comunque ci avvaliamo per parlarne.
Nel Saggio, tuttavia, le cose stanno diversamente e alla strana domanda che abbiamo appena formulato Locke ritiene di poter dare una risposta che leggiamo in tutti i manuali di filosofia e che sembra persuasiva perché stringe in un unico nodo il tema dell'origine delle idee con il compito di una loro classificazione:
All ideas come from sensation or reflection. Let us then suppose the mind to be, as we say, white paper, void of all characters, without any ideas: - How comes it to be furnished? Whence comes it by that vast store which the busy and boundless fancy of man has painted on it with an almost endless variety? Whence has it all the materials of reason and knowledge? To this I answer, in one word, from experience. In that all our knowledge is founded; and from that it ultimately derives itself. Our observation employed either, about external sensible objects, or about the internal operations of our minds perceived ad reflected on by ourselves, is that which supplies our understandings with all the materials of thinking. These two are the fountains of knowledge, from whence all the ideas we have, or can naturally have, do spring (ivi, II, i, 2).
Si tratta di una risposta che lascia perplessi per più di un motivo. In primo luogo ciò che ci colpisce è la tendenza ad affiancare, e quindi poi a contrapporre, le idee della sensazione e le idee della riflessione. Di queste due fonti da cui deriva ogni nostra esperienza si può parlare, per Locke, lasciandosi interamente guidare dalla metafora dello sguardo interiore come eco mentalistica dello sguardo in senso proprio - dello sguardo rivolto all'esterno: possiamo rivolgere l'attenzione al di fuori di noi e la sensazione nelle sue diverse forme ci offre una molteplicità di idee che rimandano ad oggetti esterni, ma possiamo anche rivolgere lo sguardo in noi stessi ed avremo allora molte e diverse idee che ci parlano delle operazioni (o delle passioni) della soggettività. Per dirla con Locke:
First, our Senses, conversant about particular sensible objects, do convey into the mind several distinct perceptions of things, according to those various ways wherein those objects do affect them. And thus we come by those ideas we have of yellow, white, heat, cold, soft, hard, bitter, sweet, and all those which we call sensible qualities; which when I say the senses convey into the mind, I mean, they from external objects convey into the mind what produces there those perceptions. This great source of most of the ideas we have, depending wholly upon our senses, and derived by them to the understanding, I call sensation. [...]. Secondly, the other fountain from which experience furnisheth the understanding with ideas is,- the perception of the operations of our own mind within us, as it is employed about the ideas it has got;- which operations, when the soul comes to reflect on and consider, do furnish the understanding with another set of ideas, which could not be had from things without. And such are perception, thinking, doubting, believing, reasoning, knowing, willing, and all the different actings of our own minds;- which we being conscious of, and observing in ourselves, do from these receive into our understandings as distinct ideas as we do from bodies affecting our senses. This source of ideas every man has wholly in himself; and though it be not sense, as having nothing to do with external objects, yet it is very like it, and might properly enough be called internal sense. But as I call the other sensation, so I Call this reflection, the ideas it affords being such only as the mind gets by reflecting on its own operations within itself (ivi, II, i, 3-4).
Da una parte abbiamo così le idee sensibili del giallo, della dolcezza o della solidità, dall'altra gli oggetti della riflessione e quindi le idee del percepire, del desiderare, del volere, e così via. Ora, che si possa parlare di idee diverse quasi che sia possibile distinguere esperienze che hanno per oggetto un colore (il bianco di questa pagina) ed altre che hanno per loro tema un'operazione della mente (il mio vedere, per esempio) è un fatto tutt'altro che ovvio, ed io credo che la descrizione lockeana sia sotto questo profilo falsante.
Ma appunto: Locke non intende immergersi in questi problemi e l'asimmetria descrittiva tra le idee della riflessione e le idee della sensazione cede subito il campo al parallelismo che sembra possibile istituire non appena ci si dispone sul terreno della presunta origine delle idee. Se ci si pone in questa prospettiva si deve riconoscere infatti che la mente può essere "messa in movimento" da una duplice fonte: dagli oggetti esterni e dalle sue operazioni, e cioè a dire dalla sensazione che convoglia gli stimoli sensibili sino all'intelletto che li comprende e dalla riflessione che riverbera nella mente le sue stesse operazioni, determinando così le idee che loro corrispondono.
A ben guardare, tuttavia, anche se ci poniamo nella prospettiva dell'origine, il senso esterno deve rivendicare una sua priorità sul senso interno: prima ancora di imparare a rivolgere l'attenzione alla dimensione dell'interiorità, la mente si è infatti già da sempre interessata alle cose esterne, a quegli oggetti che la circondano e che agiscono su di essa. Possiamo non riflettere sulle operazioni della mente, ma non possiamo sottrarci all'azione dei sensi:
hence we see the reason why it is pretty late before most children get ideas of the operations of their own minds; and some have not any very clear or perfect ideas of the greatest part of them all their lives. Because, though they pass there continually, yet, like floating visions, they make not deep impressions enough to leave in their mind clear, distinct, lasting ideas, till the understanding turns inward upon itself, reflects on its own operations, and makes them the objects of its own contemplation. Children when they come first into it, are surrounded with a world of new things, which, by a constant solicitation of their senses, draw the mind constantly to them; forward to take notice of new, and apt to be delighted with the variety of changing objects. Thus the first years are usually employed and diverted in looking abroad. Men's business in them is to acquaint themselves with what is to be found without; and so growing up in a constant attention to outward sensations, seldom make any considerable reflection on what passes within them, till they come to be of riper years; and some scarce ever at all (ivi, II, i, 8).
Di qui la posizione complessiva che traspare dalle pagine del Saggio sull'intelletto umano. Certo, per Locke vi sono due differenti fonti delle nostre idee: la riflessione e la sensazione; ciò non toglie tuttavia che sia la seconda e non la prima la causa originaria dell'attività della nostra mente che deve apparirci così come il luogo in cui gli stimoli fisici convogliati dagli organi di senso si traducono in un'immagine cosciente.
Di per sé lo stimolo fisico non è ancora esperienza; quest'ultima nasce soltanto quando la mente si rivolge alla sollecitazione che i nervi le conducono, prendendone atto:
whatever alterations are made in the body, if they reach not the mind; whatever impressions are made on the outward parts, if they are not taken notice of within, there is no perception. Fire may burn our bodies with no other effect than it does a billet, unless the motion be continued to the brain, and there the sense of heat, or idea of pain, be produced in the mind; wherein consists actual perception (ivi, II, ix, 3).
Il nodo del problema è proprio qui: comprendere la natura della percezione significa, per Locke, richiamare l'attenzione sulla natura della soggettività, sul suo constare di una mente che non ha nel pensiero un attributo inalienabile, ma il suo modo di reagire ad un'azione esterna di natura meccanica. Sulla natura di questo "prendere atto" Locke non si sofferma a lungo, ed il lettore può rimanere perplesso nel ravvisare se non una contraddizione, almeno una differenza di accento tra l'immagine della passività del percepire da cui Locke si spesso si lascia guidare ed il linguaggio razionalistico che sembra talvolta farsi strada quando Locke ci invita a rammentare che percezione vi è soltanto quando la mente dà udienza alle sue sensazioni:
How often may a man observe in himself, that whilst his mind is intently employed in the contemplation of some objects, and curiously surveying some ideas that are there, it takes no notice of impressions of sounding bodies made upon the organ of hearing, with the same alteration that uses to be for the producing the idea of sound? A sufficient impulse there may be on the organ; but it not reaching the observation of the mind, there follows no perception: and though the motion that uses to produce the idea of sound be made in the ear, yet no sound is heard (ivi, II, ix, 4).
Ma il senso complessivo del discorso è chiaro: Locke intende distinguere con nettezza la meccanicità degli stimoli dalla consapevolezza della mente, ma intende farlo senza recidere per questo l'evidenza del nesso causale da cui dipende il nostro esperire sensibilmente. Questo nesso deve essere tenuto presente, ed è per questo che la riflessione sulla consapevolezza delle idee e sulla radicale inconcepibilità di un percepire che non sia anche conscio si traduce, in Locke, da un lato nel rifiuto di una concezione cartesiana dell'anima, dall'altro nella constatazione che il percepire è per la mente non una proprietà da descrivere, ma un evento di cui rendere conto. Così, non è davvero un caso se il fatto originario della coscienza ("it is past doubt that men have in their mind several ideas") vale, per Locke, come un invito ad interrogarsi sulla fonte da cui tale idee hanno origine: se le idee sono percezioni e le percezioni sono eventi mentali, allora è del tutto lecito muovere dalla constatazione della loro presenza alla domanda concernente la loro origine. La riflessione sull'esperienza percettiva si dispone così fin da principio sul terreno di un'indagine causalistica.
Del resto che sia questa la concezione da cui Locke muove si manifesta con relativa chiarezza nelle immagini che egli ci propone per venire a capo della natura della coscienza, - immagini che sono senz'altro tradizionali ma che meritano di essere rammentate. Così, nella lettura del Saggio ci imbattiamo nell'immagine della mente come uno specchio che sulla sua superficie riflette le immagini delle cose che la luce gli consegna, e se quest'analogia viene talvolta messa da parte per richiamare alla mente l'immagine di un foglio di carta bianca su cui l'esperienza traccia i suoi segni (II, i, 2), ciò accade soltanto perché l'io non è privo di memoria e le idee, che pure scompaiono dalla mente per essere sempre di nuovo riproposte, non abbandonano la scena della coscienza senza lasciare un segno del loro passaggio: la rappresentazione immemore dello specchio (II, i, 15) o la fuggevolezza del segno che si imprime sulla sabbia per essere poi cancellato al primo alito di vento (II, i, 15) debbono cedere il campo alla stabilità cognitiva del foglio di carta che trasforma il riflesso in traccia, promettendo così quella permanenza delle idee nel tempo cui è affidata la possibilità della conoscenza e di ogni esperienza sensata.
E tuttavia, che sia foglio di carta o specchio, l'immagine della mente che prende forma in queste similitudine è la stessa: ciò che le accomuna è il loro intendere la mente come il luogo in cui un'azione fisica si trasforma in un messaggio, in una realtà di un nuovo tipo. Sul foglio di carta bianca e sulla superficie dello specchio qualcosa si disegna e si fa visibile, ma al di là dell'uno e dell'altro vi è un evento che si pone come il presupposto causale di quell'apparire:
For the objects of our senses do, many of them, obtrude their particular ideas upon our minds whether we will or not; and the operations of our minds will not let us be without, at least, some obscure notions of them. No man can be wholly ignorant of what he does when he thinks. These simple ideas, when offered to the mind, the understanding can no more refuse to have, nor alter when they are imprinted, nor blot them out and make new ones itself, than a mirror can refuse, alter, or obliterate the images or ideas which the objects set before it do therein produce. As the bodies that surround us do diversely affect our organs, the mind is forced to receive the impressions; and cannot avoid the perception of those ideas that are annexed to them (ivi, II, i, 25).
Così, le riflessioni lockeane sull'origine delle idee si sono trasformate sotto i nostri occhi in un'immagine della mente come un luogo peculiare in cui gli stimoli fisici si trasformano in effetti di natura psicologica. La classificazione delle idee che Locke ci propone nelle prime battute del secondo volume del Saggio diviene il luogo per invitarci a pensare all'esperienza come ad un evento che capita alla soggettività. E come per ogni altro evento, anche per l'esperienza percettiva dovrà assumere un'importanza centrale il rimando alle cause da cui innanzitutto dipende.
1. Le conclusioni cui siamo provvisoriamente giunti ci hanno mostrato come, per Locke, la percezione sia posta sin da principio sotto l'egida di una considerazione causalistica che spinge in modo sempre più evidente la nozione di oggetto dell'intelletto nell'ambito delle mere entità mentali.
Non credo che sia opportuno disporci fin d'ora nella prospettiva dell'indagine critica e tuttavia è giusto rammentare che le osservazioni che abbiamo appena proposto non hanno il rigore di una vera e propria argomentazione e che la tesi, così difficilmente discutibile, secondo la quale esperiamo solo perché gli oggetti agiscono causalmente sui nostri organi di senso non è una premessa sufficiente per dedurre che le nostre idee debbano avere una natura mentale.
Locke tuttavia sembra orientarsi in questa direzione e il Saggio sull'intelletto umano ci propone una concezione dell'esperienza percettiva che muove dalla tesi secondo la quale le idee sono segni tracciati nell'anima dagli oggetti esterni. Questa tesi, lo abbiamo osservato, è resa soltanto plausibile dalle considerazioni sulla natura della mente su cui Locke ci ha suggerito di riflettere nelle prime pagine del secondo volume del Saggio, e tuttavia una tesi filosofica può guadagnare in persuasività non soltanto allineando le ragioni che ci costringono a considerarla vera, ma anche mostrando la sua effettiva percorribilità e la facilità con cui si integra con le altre convinzioni che condividiamo. Ed un fatto è certo: Locke crede al di là di ogni ragionevole dubbio che il percepire sia un evento psichico che ha una causa reale e che le nostre percezioni non siano un'immagine fedele della realtà, ma dipendano dal modo in cui i nostri organi di senso dapprima e la mente poi traducono nel linguaggio delle idee gli stimoli fisici che ci giungono dalle cose.
Di qui, da queste convinzioni di fondo da cui Locke si lascia guidare, si possono ricavare se non ragioni cogenti almeno buoni motivi per ritenere che le idee siano oggetti nella mente e non le cose stesse, sia pure colte solo nella misura in cui ci sono note. Tra questi motivi alcuni possono essere rammentati.
Potremmo in primo luogo osservare che non vi sono buone ragioni per credere che le cose siano così come ci appaiono: per un filosofo come Locke, cresciuto nell'età della nuova scienza, l'idea che il mondo sensibile sia eguale al mondo reale appare fin da principio screditata. Le cose ci appaiono colorate, ma i colori non sono una proprietà reale degli oggetti, poiché dipendono dal modo in cui la nostra sensibilità reagisce alle cose stesse: i colori non sono nelle cose, ma nella soggettività che le percepisce. Ora, ciò che è vero per il colore è ragionevole attenderselo per ogni altra qualità sensibile, indipendentemente dal fatto che sia o meno un'immagine fedele delle cose stesse: la natura meramente soggettiva delle qualità secondarie - un tema questo su cui dovremo in seguito ritornare - deve valere così come un invito a considerare ogni esperienza come un evento di natura soggettiva, come qualcosa che si dà nella mente del soggetto.
Un secondo argomento che non poteva non spingere Locke verso un'interpretazione mentalistica delle idee ci riconduce alla possibilità dell'illusione percettiva. In alcuni casi (in tutti, se facciamo valere le considerazioni appena esposte) percepiamo qualcosa le cui proprietà ci appaiono diverse da quelle che in seguito attribuiamo all'oggetto percepito. Il bastone nell'acqua sembra piegato, e invece scopriamo che le cose non stanno così; la torre di lontano sembra tondeggiante, ma avvicinandoci scopriamo che ha forma quadrata; un cibo dolce può sembrare amaro a chi ha la febbre - o almeno così dice Sesto Empirico. Gli esempi potrebbero essere moltiplicati, ma la conclusione sembra chiara: ciò che ci sembra di percepire non è l'oggetto che viene di fatto percepito - non lo è perché è diverso da quello. Ma anche se il bastone è diritto e la torre squadrata noi vediamo egualmente qualcosa: vi è dunque un oggetto del nostro atto percettivo ed è diverso dall'oggetto reale. Possiamo allora ragionevolmente supporre che si tratti di un oggetto mentale.
L'ipotesi del realismo diretto - la tesi secondo la quale percepiremmo direttamente gli oggetti esterni - sembra essere negata anche dalla constatazione dell'intervallo temporale che separa l'istante presente della percezione dal momento cui la percezione si riferisce. Quest'intervallo nella norma è irrilevante: se ascolto un amico e se lo guardo in volto il tempo che la luce e il suono impiegano per coprire la distanza che ci separa è talmente piccolo da non essere mai preso in considerazione. Ma lo spazio è immenso e se guardiamo le stelle nel cielo non possiamo escludere che ciò che ora vediamo là in alto abbia cessato di esistere decine di migliaia di anni fa e che lo spettacolo che osserviamo sia l'ultima eco luminosa di una realtà che non c'è più. E tuttavia anche se l'oggetto cui la percezione è rivolta è ormai scomparso noi ora percepiamo qualcosa: supponiamo allora che l'oggetto ci sia - nella mente.
L'ipotesi che le idee siano eventi mentali si lega bene alla comprensione della percezione come processo reale. Certo, io vedo gli oggetti là lontano da me, ma se li vedo qualcosa deve essermi accaduto: deve in altri termini essersi dato un processo fisico che dalla cosa conduce all'io e che termina in una peculiare acquisizione mentale - nell'idea che fa da eco percettiva della cosa. Ed anche in questo caso l'idea (l'oggetto mentale) deve essere distinta dalla realtà esterna che la produce (dall'oggetto reale) proprio come in generale si deve distinguere l'effetto dalla causa.
Credo che queste o simili argomentazioni stiano sullo sfondo delle riflessioni del Saggio sull'intelletto umano, e tuttavia nelle pagine che stiamo leggendo Locke non sente il bisogno di giustificare più di tanto le sue scelte. In un certo senso, più che di argomentazioni di natura generale, Locke sembra fidarsi della praticabilità di un modello di esperienza che richiami la nostra attenzione sul fatto che le idee della percezione esterna presuppongono un rapporto del nostro corpo con gli oggetti esterni. Questo contatto con gli oggetti avviene grazie agli organi di senso:
our Senses, conversant about particular sensible objects, do convey into the mind several distinct perceptions of things, according to those various ways wherein those objects do affect them. And thus we come by those ideas we have of yellow, white, heat, cold, soft, hard, bitter, sweet, and all those which we call sensible qualities (ivi, II, i, 3).
A questa constatazione così piana Locke fa seguire una breve precisazione che deve essere letta con un poco più di attenzione poiché ci invita a tracciare una distinzione più sottile di quanto a prima vista non appaia. Locke osserva infatti che la sensazione di per sé non si pone ancora sul piano dei contenuti dell'esperienza, poiché di idee si può parlare solo quando ci si dispone sul terreno della coscienza. Ne segue che quando Locke afferma che i sensi portano alla mente le idee delle qualità sensibili si deve intendere che essi
from external objects convey into the mind what produces there those perceptions. This great source of most of the ideas we have, depending wholly upon our senses, and derived by them to the understanding, I call sensation (ivi).
I sensi ci appaiono qui come canali che trasportano le sollecitazioni degli oggetti esterni sino alla mente che, come avevamo dianzi osservato, è il luogo in cui gli stimoli fisici assumono risonanza psichica. Ne segue che, in linea di principio, il termine "sensazione" allude in Locke al processo fisiologico che determina le idee nell'intelletto: la sensazione non è ciò che di fatto esperiamo, ma è la fonte da cui deriviamo le idee, le quali a loro volta si danno come tali soltanto nella mente.
Locke, per il vero, è più preciso ed osserva che le sensazioni sono sì un evento fisiologico, ma possono chiamarsi tali solo in relazione al loro essere quell'evento corporeo che conduce al prodursi di un'idea nella mente: la sensazione, scrive Locke,
is such an impression or motion made in some part of the body, as produces some perception in the understanding (ivi, II, i, 23).
Si tratta certo di un modo di esprimersi particolare e se sfogliamo le pagine del Saggio - un'opera che, in generale, è caratterizzata da una scarsa precisione terminologica - ci accorgiamo che Locke non è disposto a dar troppo seguito a questo tentativo di definizione, e non è difficile trovare passi in cui le sensazioni altro non sono che le idee che ci derivano dalle varie forme della sensibilità. E tuttavia, a dispetto della sua sostanziale ininfluenza rispetto al corso delle considerazioni del Saggio, questa piccola pignoleria ha qualcosa da insegnarci: in questo particolare modo di esprimersi, si manifesta infatti la consapevolezza che tutto ciò che propriamente ci è dato sono le idee e che anche quando ci allontaniamo da esse per muovere verso la loro causa prossima - l'eccitazione quasi motoria delle vie sensoriali - lo facciamo senza per questo abbandonare la dimensione della coscienza. In altri termini: ciò che c'è dato è il giallo che vedo, ed è questa mia esperienza ciò che mi permette di dare un nome ad un processo che mi è relativamente ignoto, poiché non è affatto chiara quale sia la relazione tra la mia esperienza e le sue cause fisiologiche. Parlare del giallo come di una sensazione vorrà dire allora muovere dalla mia esperienza, per fare poi di questo mio vissuto il nome della sua causa prossima che tuttavia mi è ignota, poiché ignoto è il nesso che lega determinati eventi al mio percepire così.
Avremo modo di immergerci nuovamente in questo ordine di problemi. Un fatto tuttavia è ben chiaro. Locke ci invita a considerare la percezione come il risultato di un processo fisico e fisiologico ma poi, come di consueto, ci invita a rammentare che ciò che propriamente ci è dato è solo l'orizzonte circoscritto delle nostre idee. Di queste idee è ragionevole pensare che abbiano una causa, ma quest'ipotesi - per quanto plausibile e fondata - non deve sovrapporsi al dato descrittivo: al mio avere coscienza di qualcosa che si impone alla mente, destandola e costringendola alla percezione. Vi è un dato ed un'ipotesi che cresce sul dato, e il compito del Saggio consiste nel mostrare come l'una sorga dall'altro, cercando di non dimenticare l'ordine di priorità che li contraddistingue.
Che così stiano le cose si mostra con relativa chiarezza nel modo in cui Locke traccia la distinzione, così ricca di conseguenze, tra idee semplici e idee complesse - una distinzione, sulla cui legittimità Locke ci convince proponendoci un intreccio di considerazioni descrittive e causalistiche, che va dipanato e compreso.
A favore di questa distinzione sembrano schierarsi innanzitutto ragioni di carattere descrittivo: Locke ci invita infatti a distinguere le idee semplici dalle idee complesse, e ad intendere per idee complesse il prodotto di una qualche relazione tra idee semplici - sia essa posta dalla soggettività o dettata dalla dimensione obiettiva dell'esperienza. Così, chiameremo complesse le idee che esprimono i rapporti di parentela perché una sola parola (padre, per esempio) esprime le idee di almeno due persone colte secondo una relazione peculiare; ma chiameremo complessa anche l'idea che ci facciamo di una materia come il legno, che è appunto qualcosa di cui conosciamo il colore, la consistenza, il peso, la resistenza, l'odore che emana quando brucia, e così via. Ora, nel primo caso avremo un'idea complessa che ha origine dalle consuetudini umane e quindi dalla soggettività, mentre nel secondo avremo a che fare con un'idea che ci è imposta dalle cose stesse; ma a questa differenza specifica fa eco una somiglianza di fondo: in entrambi i casi le idee complesse debbono ricondurci ad una somma di idee semplici, che si pongono così come i materiali effettivi della nostra vita di coscienza. E ciò è quanto dire che anche le cose che diciamo di percepire debbono infine svelarsi per quello che sono: per una silloge di idee semplici, strette nell'unità di un'idea complessa che da esse deriva.
È forse opportuno rammentare che non si tratta di una mossa ovvia. Alle spalle di Locke vi è una lunga tradizione teorica che ci invita a pensare agli oggetti secondo il modello della sostanza e degli accidenti, - un modello ci invita a considerare come necessaria e, in ultima analisi, indiscutibile la priorità della sostanza sulle sue singole proprietà. Se ci poniamo in questa prospettiva dobbiamo riconoscere che innanzitutto vi sono le cose nella loro singolarità e nella loro autonoma sussistenza, e solo poi vi sono gli accidenti che da un lato presuppongono la presenza dei sostrati cui si riferiscono, dall'altro ci permettono di meglio comprenderli e di definirli più esattamente nelle loro molteplici caratteristiche. Che non sia questa la prospettiva lockeana è del tutto evidente. Per quanti problemi possa suscitare in noi la lettura delle pagine che nel Saggio egli dedica al concetto di sostanza, un fatto è chiaro: il cammino che Locke qui ci invita a compiere non muove dal riconoscimento della priorità della cosa, di cui si deve anzi sottolineare fin da principio la complessità che vale evidentemente come un indice della sua dipendenza dalla posizione di ciò che è semplice. Innanzitutto vi sono le proprietà che si annunciano nelle idee semplici e solo poi vi è l'idea complessa della sostanza che dobbiamo pensare proprio così - come il risultato della somma di idee semplici cui si aggiunga l'idea di una ragione che giustifichi la loro effettiva coesistenza.
All'origine di questo diverso modo di impostare le cose vi è ancora una volta una preoccupazione di carattere descrittivo e quindi un atteggiamento teorico che, di conseguenza, tende a privilegiare la prospettiva gnoseologica su quella ontologica. Locke ci invita innanzitutto a riflettere che ciò che noi sappiamo delle cose che ci circondano è ciò che esperiamo: parlare di cose vorrà dire allora parlare di idee. Le idee, a loro volta, derivano dalla riflessione o dalla sensazione, e se ci dimentichiamo per un attimo di questa interna fonte di idee siamo evidentemente ricondotti al fatto che le cose si scandiscono per noi in immagini che appartengono al medium che è tipico della forma sensibile da cui derivano: vediamo colori, ascoltiamo suoni, sentiamo la levigatezza o la ruvidità di una superficie o il calore che da essa emana. Di qui l'impossibilità, per Locke, di pensare alla priorità della cosa rispetto alle sue determinazioni: se l'esperienza consta di idee e se le idee derivano dalla sensazione, allora la nostra possibilità di parlare di cose dipende dalla sintesi quasi predicativa delle idee semplici in un'idea complessa. Per l'esperienza che ne abbiamo, la mela che stringiamo tra le mani è soltanto un colore, un sapore, un profumo, un peso, e se ci ostiniamo a parlarne come di una cosa è solo perché non possiamo sottrarci all'idea che queste molte idee si accompagnino necessariamente le une alle altre e che vi sia qualcosa che determina il loro essere insieme.
Per l'esperienza che ne abbiamo - su questo punto è necessario insistere. Ogni nostra esperienza muove di fatto da qui: da un insieme circoscritto di idee semplici, come il colore, la forma, la consistenza, la solidità, e così via. Queste idee sono tutto ciò che ci è dato e si pongono come le componenti immaginative semplici di cui consta ogni nostra idea complessa: far luce sulla loro natura vorrà dire allora avere circoscritto i termini semplici la cui sintassi permette ogni più complesso discorso mentale. Quest'immagine va presa alla lettera: Locke ci invita infatti a pensare alla nostra esperienza nella forma di un linguaggio in cui le singole parole - le idee semplici - si connettono per dar vita a proposizioni mentali, che a loro volta si riferiscono - secondo un nesso su cui dovremo in seguito far luce - alle cose e agli stati di cose del mondo. Ma ciò è quanto dire che le cose di cui normalmente diciamo di avere esperienza debbono apparirci come il risultato di una sintesi quasi predicativa, in cui entità complesse sorgono dalla connessione sintattica di unità più semplici, in un processo che deve infine condurci ad oggetti non ulteriormente analizzabili che fungono da condizione di possibilità della sensatezza di ogni proposizione mentale. Ora, quali siano queste entità semplici che ci permettono di formare sintatticamente gli oggetti del nostro esperire è, per Locke, un fatto descrittivamente evidente: la mela del nostro esempio c'è perché la percepiamo, ma quando la percepiamo il dato descrittivo della sua presenza si scandisce in un colore, in un sapore, in un profumo, in un gusto - in datità sensibili che possono essere sintatticamente connesse, ma che non possono essere ulteriormente analizzate poiché sono il contenuto di una sensazione. Il requisito logico della riconducibilità delle idee complesse ad idee semplici idee si lega così al presupposto descrittivo della non analizzabilità delle sensazioni: il qui ed ora di ogni singola sensazione diviene così il paradigma della semplicità.
È tuttavia sufficiente leggere con attenzione le parole di Locke per rendersi conto che il problema è più complesso e che la tesi della priorità della prospettiva gnoseologica si lega al riconoscimento che ciò che è vero sul terreno dell'esperienza dipende innanzitutto dalle modalità proprie dell'esperire. Così, della tesi secondo la quale innanzitutto vi sono le proprietà che si annunciano nelle idee semplici e solo poi vi è l'idea complessa della sostanza non si deve semplicemente prendere atto sul terreno descrittivo, ma si deve anche rendere conto sul terreno delle ipotesi concernenti la natura reale dei processi che sono alla base di ogni nostro esperire. È in questa luce che diviene importante osservare come, per Locke, la natura composita della nostra esperienza di oggetti possa essere imputata almeno in parte (se non forse nella sua totalità) alla differenziazione dei canali sensibili attraverso i quali un'identica realtà si annuncia alla coscienza e alla sua specifica modalità di tradurre gli stimoli fisici in idee. Scrive Locke:
The better to understand the nature, manner, and extent of our knowledge, one thing is carefully to be observed concerning the ideas we have; and that is, that some of them are simple and some complex. Though the qualities that affect our senses are, in the things themselves, so united and blended, that there is no separation, no distance between them; yet it is plain, the ideas they produce in the mind enter by the senses simple and unmixed (ivi, II, ii, 1).
Abbiamo tra le mani un pezzo di cera e questo materiale mutevole, che Cartesio ci invita a manipolare perché ci si mostri nell'evidenza di un esempio il farsi res extensa di una realtà determinata, deve ora guidarci verso una differente riflessione. Al lume naturale cartesiano che supera i limiti sensibili dell'esempio e ci permette di cogliere la natura delle sostanza nel progressivo dissolversi della determinatezza sensibile, si deve sostituire ora la consapevolezza che la dimensione intuitiva non può essere abbandonata e che non è quindi possibile prendere commiato dalla molteplicità di idee sensibili che la percezione scorge in quell'identica cera. Poiché proprio questo è il punto: se l'unicità della sostanza si scandisce in una molteplicità di idee, ciò accade a causa della forma stessa del percepire, del suo scandire l'oggetto in una molteplicità di idee che traggono la loro origine dal modo in cui le diverse forme del nostro sentire reagiscono ad una stessa configurazione obiettiva. Nella cera che abbiamo tra le mani il colore, la morbidezza e il profumo potrebbero tutti ricondurci ad una sola realtà; per noi, tuttavia, questa eventuale unicità è comunque inattingibile, poiché la percezione è il risultato di una molteplicità di dispositivi sensoriali che reagiscono, secondo la legge che è loro propria, agli stimoli che derivano dal mondo esterno. E ciò che è vero quando le fonti sensibili delle idee sono diverse vale anche nel caso in cui uno stesso canale sensibile ci porga più idee; anche qui il nostro sistema percettivo agisce rendendo discrete le informazioni che trae dal continuum ipotetico dell'oggetto:
For, though the sight and touch often take in from the same object, at the same time, different ideas;- as a man sees at once motion and colour; the hand feels softness and warmth in the same piece of wax: yet the simple ideas thus united in the same subject, are as perfectly distinct as those that come in by different senses. The coldness and hardness which a man feels in a piece of ice being as distinct ideas in the mind as the smell and whiteness of a lily; or as the taste of sugar, and smell of a rose. And there is nothing can be plainer to a man than the clear and distinct perception he has of those simple ideas; which, being each in itself uncompounded, contains in it nothing but one uniform appearance, or conception in the mind, and is not distinguishable into different ideas (ivi).
La frantumazione dell'oggetto nelle sue proprietà ed il rifiuto della priorità del concetto di sostanza divengono così l'indice della natura della nostra esperienza, del suo dipendere nella sua forma e nel suo contenuto dal modo in cui il percepire necessariamente si attua.
Di qui la peculiarità della posizione lockeana: da un lato Locke ci invita a disporci in una prospettiva descrittiva, dall'altro vincola questa stessa descrizione ad una tesi di carattere generale - alla tesi secondo la quale la percezione altro non è se non il modo in cui il nostro corpo risponde agli stimoli esterni, traducendoli nell'idioma cosciente delle idee. Ma ciò è quanto dire che la riflessione sulle idee sensibili deve essere fin da subito consapevole che l'esperienza è in generale determinata nella sua forma e nel suo contenuto da una molteplicità di regole di traduzione il cui meccanismo ci è ignoto - le regole che determinano la nostra reazione cosciente alle cose che ci circondano. Queste regole sono in qualche misura ineludibili poiché non possiamo immaginare che cosa sarebbe la nostra esperienza se avessimo una diversa sensibilità. E tuttavia la nostra incapacità soggettiva di immaginare le idee che potrebbero derivare da una sensibilità diversa dalla nostra non è affatto un argomento sufficiente per negare la possibilità di una diversa natura sensibile. Gli animali potrebbero sentire (e di fatto sentono) diversamente da noi e l'ipotesi che il mondo sensibile si dispieghi in forme diverse a diverse specie è tutt'altro che negata dal fatto che ci sia impossibile immaginare anche soltanto un nuovo colore. Scrive Locke:
Only the qualities that affect the senses are imaginable. This is the reason why - though we cannot believe it impossible to God to make a creature with other organs, and more ways to convey into the understanding the notice of corporeal things than those five, as they are usually counted, which he has given to man - yet I think it is not possible for any man to imagine any other qualities in bodies, howsoever constituted, whereby they can be taken notice of, besides sounds, tastes, smells, visible and tangible qualities. And had mankind been made but with four senses, the qualities then which are the objects of the fifth sense had been as far from our notice, imagination, and conception, as now any belonging to a sixth, seventh, or eighth sense can possibly be; - which, whether yet some other creatures, in some other parts of this vast and stupendous universe, may not have, will be a great presumption to deny. He that will not set himself proudly at the top of all things, but will consider the immensity of this fabric, and the great variety that is to be found in this little and inconsiderable part of it which he has to do with, may be apt to think that, in other mansions of it, there may be other and different intelligent beings, of whose faculties he has as little knowledge or apprehension as a worm shut up in one drawer of a cabinet hath of the senses or understanding of a man; such variety and excellency being suitable to the wisdom and power of the Maker. I have here followed the common opinion of man's having but five senses; though, perhaps, there may be justly counted more;- but either supposition serves equally to my present purpose (ivi, II, ii, 2).
Il nostro mondo sensibile potrebbe essere diverso, ed in questo rimando alla possibilità di altri mondi sensibili si mostra, per Locke, la relatività di ciò che altrimenti ci appare universalmente stabile. Questo mondo che vedo non è che la forma sensibile che si disegna nella mia mente a causa del suo peculiare modo di reagire agli stimoli esterni. Il mondo che percepisco deve così svestirsi della pretesa di unicità e di realtà che normalmente gli attribuisco per porsi non come un mondo ma come un effetto dell'interazione del mondo con una sua parte. Di qui la piega etica che attraversa queste considerazioni del Saggio. Proprio come Democrito sosteneva che i mondi sono infiniti innanzitutto per dimostrare con le ragioni della fisica quanto fosse detestabile e ridicola la pretesa di chi immagina che l'universo abbia come proprio centro l'uomo, alla stessa stregua Locke ci costringe a pensare che il nostro modo di cogliere il mondo potrebbe essere tanto cieco rispetto alla sua ricchezza di senso quanto misero ci appare in confronto al nostro l'universo sensibile di un verme, imprigionato per giunta nel buio di un cassetto.
Democrito ride del mondo
(particolare da Bramante, Democrito ed Eraclito)
2. La conclusione cui siamo appena giunti ci permette di comprendere più da vicino le ragioni di un titolo: Locke non scrive un trattato sulla conoscenza o sulla verità ma un saggio che ha per oggetto l'intelletto umano e se in questo tono dimesso parlano ancora le scelte stilistiche su cui ci siamo già soffermati, nella decisione di porre fin nel titolo il rimando alla nostra natura parla invece un'esigenza che è diretta espressione delle considerazioni che abbiamo appena proposto e su cui è forse opportuno soffermarsi ancora un poco.
In primo luogo, sottolineare che la nostra esperienza dipende nella sua determinatezza qualitativa dalla natura dei nostri organi di senso vuol dire appunto sottolineare che le riflessioni che Locke intende proporci si inseriscono a pieno titolo nell'ambito di una riflessione sulla natura umana: il nostro mondo percettivo potrebbe essere diverso da quello che è proprio come diverso è l'universo cui possono di fatto accedere anche gli altri animali, anche se - in modo apparentemente paradossale - questa constatazione di natura relativistica si lega all'assolutezza dell'orizzonte cosciente delle nostre percezioni.
Su questo punto si deve insistere. Le uniche percezioni cui ciascuno di noi ha libero accesso sono le sue private percezioni: gettare uno sguardo sulle percezioni degli altri è infatti senz'altro impossibile. Certo, se osserviamo tutti uno stesso oggetto, possiamo dire di vedere tutti lo stesso colore e la stessa forma; ciò tuttavia non significa ancora che vi sia davvero la possibilità di mettere le une accanto alle altre le sensazioni che proviamo per confrontarle: un simile confronto è semplicemente impossibile e presuppone che sia lecita una mossa che è invece evidentemente insensata - presuppone che abbia un senso sostenere che io possa appropriarmi del tuo punto di vista senza per questo farlo mio. Ora, che non possa sentire il tuo mal di denti è un fatto che nella norma non crea particolari problemi, anche perché di fatto la possibilità dell'accordo linguistico e la facilità con cui ci intendiamo quando descriviamo nelle forme più diverse i nostri vissuti sembra valere come un indizio del fatto che le nostre percezioni hanno una comune determinatezza qualitativa. Anche se non posso vedere con i tuoi occhi la scena che dici di percepire, posso comunque ascoltare come tu ne parli e posso misurare ciò che vedi soppesando le parole che mi dici. Così, anche se non posso vedere ciò che tu vedi, posso comunque capire ciò che hai visto e posso quindi cogliere nella concordanza linguistica l'eco della congruenza materiale delle nostre esperienze.
Non credo sia difficile convenire che le cose stanno nella norma così. E tuttavia anche se si riconosce che non vi è un libero accesso all'esperienza dell'altro, la tesi della relatività dell'esperire sembra essere difficilmente sostenibile. Certo, nulla ci permette di asserire che ciò che vivo quando osservo questo oggetto di colore rosso sia proprio eguale a ciò che gli altri esperiscono osservandolo: l'assolutezza del mio campo d'esperienza mi impedisce di attuare il confronto che mi si chiede. Ma ciò che vale come impedimento per affermare l'unicità dell'esperire deve valere anche come ostacolo nel caso della tesi della sua mera relatività. Cogliere una relatività significa sempre istituire un confronto, ed è proprio questa possibilità che sembra essere in linea di principio esclusa: finché ci muoviamo sul piano descrittivo, la relatività specifica dell'esperire non può essere di fatto positivamente affermata.
Diversamente stanno le cose se rammentiamo il nesso che lega ogni nostra esperienza alla natura dei nostri organi di senso. Se ciò che percepiamo dipende dal modo in cui siamo fatti, come negare che percepiremmo un altro mondo se avessimo altri organi di senso? Perché questo è ben chiaro: non posso vedere come vede una mosca o come vede un pesce, ma posso egualmente vedere come sono fatti i loro occhi e come sono disposti gli uni rispetto agli altri e quali siano i meccanismi complessi che sono all'origine della decodificazioni delle informazioni racchiuse a livello retinico. Così, anche se non posso vedere come vede un pesce, posso egualmente sapere come è fatto il suo universo percettivo: so, per esempio, che il suo campo visivo è molto più ampio del nostro (un pesce può vedersi la coda, noi non potremmo vedercela nemmeno se l'avessimo), ma so anche che la sua percezione della profondità e della distanza non può fare affidamento sull'elaborazione dello scarto di parallasse, poiché in un pesce gli occhi non sono siti in posizione frontale. E ciò che comprendo sulla natura dell'universo percettivo può spiegarmi molte cose del suo comportamento che, a sua volta, vale come una nuova chiave di accesso nel mondo così come si dispiega ai suoi organi di senso. In altri termini: non possiamo avere le esperienze di un pesce (perché ciò accada ci vorrebbe il Mago Merlino e le magie che sono raccontate in un vecchio cartone animato intitolato La spada nella roccia) ma questo non significa che sia davvero necessario nutrire dubbi su ciò che un pesce può vedere. Anche in questo campo possiamo scoprire molte cose, e sarebbe davvero curioso sostenere che non è possibile per noi uomini cogliere quanto diversa dalla nostra sia l'esperienza di un pesce. I pesci hanno una sensibilità tattile, ma per questi animali il tatto è un organo prevalentemente passivo e non attivo: come è ovvio, un pesce non può manipolare gli oggetti. Ma può invece fare affidamento sul fatto che l'acqua è un fluido relativamente consistente che trasmette bene le spinte dinamiche, e questo fa sì che il tatto nei pesci possa trasformarsi in un senso a distanza: se si osserva con un po' di attenzione un pesce si scorge che sulla sua pelle, libera dalle scaglie, vi è la linea lateralis - una serie di piccoli punti allineati che consentono una percezione della pressione e che raccolgono quindi informazioni su ciò che, muovendosi, a sua volta muove la massa acquorea
Tutto questo, appunto, lo possiamo scorgere, ma Locke - piuttosto che soffermarsi su questo possibile cammino - ci invita a ricordare che qualcosa irrimediabilmente ci sfugge. Possiamo capire che aspetto debba avere il mondo di chi ha una sensibilità diversa dalla nostra, ma non possiamo ciò nonostante impossessarci anche di una sola idea che non giunga dai nostri sensi. Non possiamo immaginare ciò che non esperiamo, proprio come un cieco - osserva più volte Locke - non può davvero afferrare l'idea del rosso.
Su questi tema vorrei soffermarmi un poco, suggerendovi la lettura di un breve saggio di Thomas Nagel (What is it like to be a bat? In Mortal questions) pubblicato nel 1979. In queste pagine Nagel ci invita ad un compito che supera senz'altro le nostre capacità di immedesimazione: in What is it like to be a bat? ci si domanda infatti quale sia la natura dell'universo percettivo di un pipistrello.
Di fronte ad una simile domanda forse ci si può sentire lievemente imbarazzati, anche perché non è forse il nostro più vivo desiderio quello di metterci nei panni di una microchiroptera - di questo mammifero notturno dall'aspetto poco elegante che si ciba solo di insetti. Ma una ragione c'è. I pipistrelli hanno un senso che non abbiamo: vedono poco e male, ma hanno un sonar che permette loro di localizzare gli oggetti con estrema precisione. Volando, i pipistrelli emettono dei rapidi gridi che noi non percepiamo: si tratta di ultrasuoni che mappano lo spazio circostante, poiché gli oggetti che lo occupano costituiscono un fronte che riflette le onde sonore restituendole alla fonte che le ha emesse.
Così, se ci convinciamo dell'opportunità di questa curiosa indagine e se abbiamo osservato con un po' di attenzione il volo notturno di questi animaletti forse potremmo farci un'idea del loro universo percettivo. Il sonar è un senso che ricorda la vista: offre evidentemente un'immagine tridimensionale dello spazio e permette un'acquisizione percettiva a distanza. Questo lo vediamo: il pipistrello percepisce gli ostacoli perché li evita. E lo capiamo: un sonar è uno strumento che "legge" l'immagine acustica che gli oggetti restituiscono quando sono colpiti da determinate onde sonore - e le onde sonore, proprio come le onde elettromagnetiche, si propagano nello spazio, consentendo una percezione a distanza. Una differenza per il vero c'è: le onde sonore hanno un'ampiezza d'onda molto maggiore della luce e sono quindi meno adatte per misurare le distanze e lo sono tanto meno quanto più abbandoniamo la regione dei suoni acuti per spingerci verso quella dei suoni gravi. Il pipistrello usa gli ultrasuoni proprio per ovviare a questo inconveniente che, comunque, in qualche misura permane. Ma vi sono naturalmente altre differenze rispetto al vedere: il mondo avvertito da un sonar è inguaribilmente privo di colori e forse è già sufficiente alludere ad un universo di cose di cui non si può dir nemmeno che siano grigie a rendere immaginativamente sfuggente l'universo percettivo di un pipistrello. Non solo. Per vedere basta aprire gli occhi e le esplorazioni percettive si muovono comunque su uno sfondo visibilmente presente. Per il pipistrello le cose non stanno probabilmente così: il sonar coglie gli oggetti ma non li situa altrettanto bene in uno sfondo e chiede quindi una continua esplorazione percettiva. Lo spazio di un pipistrello si costituisce come un mosaico di cui è presente di volta in volta solo qualche tessera - ed in questo caso è l'analogia con il tatto a farsi avanti. Per noi uomini che siamo animali essenzialmente visivi anche questo compito immaginativo è forse troppo arduo: capiamo, ma non sappiamo dare ai nostri pensieri una veste intuitiva.
Potremmo naturalmente continuare a lungo su questa strada. Ma, lo abbiamo già detto, non è questo ciò che Locke e, in fondo, anche Nagel ci chiedono. Il loro obiettivo è un altro: vogliono convincerci che in generale non possiamo assumere un punto di vista soggettivo su un'esperienza diversa dalla nostra. Ciò su cui Nagel e Locke vogliono attirare la nostra attenzione è che non ci è possibile immaginare come un pipistrello percepisca il mondo, anche se possiamo far luce sulla natura dei suoi organi di senso e - aggiungiamo noi - non ci sono affatto oscure molte delle proprietà che evidentemente caratterizzano l'universo percettivo dei pipistrelli.
Ora, forse voi vi chiederete perché sia opportuno perdere una parte del vostro tempo ad immaginare che cosa capiti ai pipistrelli quando di notte emettono grida che non percepiamo per disegnare una mappa dello spazio per noi illeggibile. Ma a questo dubbio credo si possa rispondere perché queste strane argomentazioni ci invitano a riflettere su due importanti caratteristiche del concetto di idea, su due aspetti che definiscono in profondità la filosofia che sorregge questa nozione così importante nella filosofia empiristica della percezione.
La prima caratteristica è emersa implicitamente in questo nostro girovagare tra sonar e linee laterali, tra microchiroptere e pesci: ciò che da queste nostre considerazioni credo sia già emerso è che, per Locke, vi è una dimensione della nostra esperienza che non può essere messa da parte, ed è appunto la sua immediata datità soggettiva. Su questo punto Locke è chiaro: le nostre idee dipendono dalla natura degli organi di senso e si legano ad una qualche modificazione corporea, ma ciò non toglie che le une non siano riducibili alle altre. Le idee appartengono ad un punto di vista soggettivo sul mondo e non sono riducibili a nessun evento obiettivo. Certo, una parte dei nostri sforzi mirava di fatto a mostrare come fosse possibile dire qualcosa anche su contenuti d'esperienza che ci sono preclusi, e tuttavia il tentativo di venire a capo di un universo percettivo diverso dal nostro additando la dimensione obiettiva del comportamento o dei nessi causali che sono all'origine della percezione dimentica l'aspetto primo del percepire - la sua immediatezza sensibile e intuitiva. La filosofia della mente, per Locke, inizia proprio da qui: dal gesto in cui la mente prende atto di uno stimolo fisico e fisiologico, traducendolo in immagini. Una teoria della mente che trascuri quest'aspetto è, per Locke, semplicemente falsa. Potremmo intendere questo riconoscimento innanzitutto come una constatazione di natura empirica: a dispetto di ciò che Cartesio riteneva vero per gli animali e che alcune contemporanee teorie della mente sostengono per ogni essere percipiente, Locke è certo che vi sia qualcosa come una vita d'esperienza e che il gioco delle azioni e delle reazioni che sorregge la nostra prassi ambientale è comunque mediata da un'istanza cosciente - dal farsi avanti delle idee. Ma nella posizione del Saggio vi è di più: per Locke ad esserci dato è propriamente solo il punto di vista soggettivo ed ogni nostra ulteriore acquisizione conoscitiva poggia in maniera diretta o indiretta su quei contenuti intuitivi che la coscienza ci porge. Come vedremo meglio in seguito, possiamo parlare di una realtà obiettiva, ma possiamo parlarne soltanto a partire dalle nostre idee, da ciò che ci è dato e che costituisce l'orizzonte entro cui si muove ogni nostro discorso mentale.
La seconda caratteristica su cui le nostre considerazioni ci invitano a riflettere è che, per Locke, l'esperienza non è riducibile alla sua dimensione puramente cognitiva poiché nella natura delle idee è racchiusa una dimensione ineludibilmente non concettuale. Che cosa sia il rosso non posso spiegarlo a parole: debbo necessariamente mostrarlo. C'è qui qualcosa che non posso capire, ma che debbo vedere, e la mia possibilità di comprendere che cosa significhi la parola "rosso" è vincolata al fatto che la radice sensibile di quel significato sia di fatto accessibile per me.
Ora, come sappiamo, per Locke non vi è un discrimine netto tra le idee della percezione e le idee del pensiero e questo ci spinge verso una generalizzazione ulteriore: le idee, tutte le nostre idee, affondano le loro radici nel terreno sensibile e ciò è quanto dire che non vi è idea che non sia vincolata nel suo senso al suo aspetto intuitivo. Il mondo così come ci appare è davvero l'orizzonte di ogni nostra coscienza possibile, e ciò rende ulteriormente vincolante il rimando alla nostra natura umana. Di questo nostro esser fatti così ogni nostro pensiero reca una sua ineludibile traccia, ed è per questo che nelle pagine di Locke e di tanta filosofia settecentesca ci si imbatte con tanta frequenza in riflessioni che hanno per oggetto la cecità. Chi è nato cieco non può avere le idee che noi abbiamo, e questo per Locke significa che il dizionario elementare con cui si costruisce ogni ragionamento è nel caso di chi non vede profondamente diverso dal nostro. Così, non è un caso che il discorso sulla cecità diventi una sorta di terreno di prova su cui vagliare la dipendenza dei nostri pensieri dalla datità di certi contenuti. Nel Settecento due nomi raccolgono intorno a sé un dibattito ricco di problemi e di stimoli intellettuali: da una parte vi è uno studioso di ottica di nome Molyneux che ci invita ad immaginare che cosa saprebbe distinguere a prima vista un cieco cui fosse stata restituita la vista, dall'altra vi è un matematico cieco - Saunderson - che dimostra che la scienza delle spazio può essere insegnata e compresa anche da chi non può sollevare lo sguardo sulla esemplarità della figura.
In questi strani problemi dovremo addentrarci, senza tuttavia perdere la presa sulla domanda che ci muove e che concerne la grammatica del concetto lockeano di idea.
1. Le considerazioni che abbiamo proposto nella lezione precedente avevano un duplice obiettivo: volevano mostrare da un lato come la nostra esperienza filtrasse la natura obiettiva degli oggetti subordinandola ad una regola di traduzione peculiare per sottolineare poi, dall'altro, come questa stessa regola dipendesse dalla specificità dei nostri sistemi percettivi e potesse quindi variare di specie in specie.
Muovendo da queste premesse ci eravamo tuttavia imbattuti in un problema nuovo: ci eravamo chiesti se era possibile immaginare come apparisse il mondo ad un pipistrello o, per dirla con Locke, ad una creatura angelica.
A questa domanda si deve dare una risposta negativa, e la ragione è a portata di mano: per Locke non è possibile immaginare anche solo una proprietà sensibile che non sia stata direttamente percepita e che non sia quindi riconducibile all'idioma che caratterizza ogni nostra percezione e che determina l'ambito circoscritto di ciò che può essere oggetto della nostra mente. Le idee che abbiamo sono tutte necessariamente codificate nel linguaggio dei nostri sistemi percettivi che fissano così il punto di rotazione e l'ampiezza del compasso che circoscrive ogni nostra possibile esperienza. Al di là delle idee che abbiamo e che riceviamo dai sensi in conformità con la loro stessa natura non vi è spazio per altri pensieri semplici; proprio come l'uomo non può creare nulla di nuovo anche se può fare infinite cose con ciò che nel mondo trova, così anche la mente è vincolata nei suoi pensieri alle idee del senso interno ed esterno - a queste originarie percezioni che, determinando gli elementi semplici della coscienza, circoscrivono insieme l'ambito delle possibili sintassi mentali e quindi anche lo spazio della concepibilità:
These simple ideas, the materials of all our knowledge, are suggested and furnished to the mind only by those two ways above mentioned, viz. sensation and reflection. When the understanding is once stored with these simple ideas, it has the power to repeat, compare, and unite them, even to an almost infinite variety, and so can make at pleasure new complex ideas. But it is not in the power of the most exalted wit, or enlarged understanding, by any quickness or variety of thought, to invent or frame one new simple idea in the mind, not taken in by the ways before mentioned: nor can any force of the understanding destroy those that are there. The dominion of man, in this little world of his own understanding being much what the same as it is in the great world of visible things; wherein his power, however managed by art and skill, reaches no farther than to compound and divide the materials that are made to his hand; but can do nothing towards the making the least particle of new matter, or destroying one atom of what is already in being. The same inability will every one find in himself, who shall go about to fashion in his understanding one simple idea, not received in by his senses from external objects, or by reflection from the operations of his own mind about them. I would have any one try to fancy any taste which had never affected his palate; or frame the idea of a scent he had never smelt: and when he can do this, I will also conclude that a blind man hath ideas of colours, and a deaf man true distinct notions of sounds (ivi, II, ii, 2).
But beyond these ideas, as received from their proper sources, our faculties will not reach. If we would inquire further into their nature, causes, and manner, we perceive not the nature of extension clearer than we do of thinking. If we would explain them any further, one is as easy as the other; and there is no more difficulty to conceive how a substance we know not should, by thought, set body into motion, than how a substance we know not should, by impulse, set body into motion. So that we are no more able to discover wherein the ideas belonging to body consist, than those belonging to spirit. From whence it seems probable to me, that the simple ideas we receive from sensation and reflection are the boundaries of our thoughts; beyond which the mind, whatever efforts it would make, is not able to advance one jot; nor can it make any discoveries, when it would pry into the nature and hidden causes of those ideas (ivi, II, xxiii, 29).
Un'infinita varietà di idee trae la sua origine da un insieme finito di percezioni semplici, secondo un modello che allude in modo anche troppo scoperto al linguaggio e alla sua struttura sintattica. E proprio come nel caso del linguaggio la libertà della sintassi si ancora al vincolo del dizionario così, anche nel caso della vita di coscienza, la possibilità di foggiare nuove idee complesse muove dal riconoscimento che le idee semplici hanno un'unica fonte: l'esperienza. In questo non siamo liberi di creare: le idee semplici non sorgono da un fare creativo della soggettività, ma le sono date sensibilmente ed è per questo che la specificità dei nostri sensi è insieme la regola che circoscrive l'orizzonte di ogni nostra esperienza possibile. Le nostre idee sono quelle che sono e sono fatte così perché questi sono i nostri organi di senso: altre possibili idee che derivino da una diversa conformazione sensibile avrebbero potuto animare una diversa vita d'esperienza, ma sono per noi semplicemente inaccessibili e non hanno quindi diritto di cittadinanza in un'indagine che ha per oggetto l'intelletto umano.
Queste considerazioni si erano poi legate ad una riflessione più analitica, volta a far luce sulla natura delle idee. Ed in particolar modo, avevamo attirato la nostra attenzione su un fatto importante: le idee semplici sembrano essere, per Locke, contenuti intuitivi di cui non è possibile un'esauriente caratterizzazione concettuale. In che modo percepisca un soggetto diverso da noi è un mistero su cui non è dato indagare, poiché nessuno può di fatto comprendere che cosa esperisca un'intelligenza angelica se di fatto ci è negata la possibilità di gettare uno sguardo nella sua mente, per scorgere ciò che in quel palcoscenico si recita e si inscena per lui. Così, anche se - come ci assicura Dante - gli angeli non hanno bisogno delle nostre parole per comprenderci, dovremmo poi a nostra volta rinunciare a comprendere ciò che gli angeli ci rispondono, poiché non è per noi possibile comprendere le loro parole senza avere accesso allo scrigno dei significati elementari di quel linguaggio - senza poter in altri termini accedere alla sfera di quelle idee semplici che sono date ad intelligenze diverse dalla nostra. Possiamo definire a parole le idee complesse, ma le idee semplici debbono essere necessariamente mostrate: che cosa siano il rosso, l'aroma del caffè o la configurazione spaziale di un triangolo scaleno è qualcosa che possiamo comprendere se e solo se abbiamo diretta esperienza del rosso, dell'aroma del caffè e di quella peculiare forma geometrica cui diamo quel nome. Se l'esperienza non si dà, anche la nostra possibilità di intendere il termine che la denota viene meno, - un fatto questo che è interamente racchiuso nella tesi secondo la quale il significato di un termine è il contenuto intuitivo di un'idea.
Di qui la frequenza con cui Locke ci invita a riflettere sull'universo mentale di chi dalla nascita è cieco o sordo. A chi non ha mai potuto vedere il mondo non si può spiegare che cosa sia il rosso, proprio come non si può spiegare a chi non può sentire che cosa sia un suono acuto e che cosa lo differenzi da uno grave. Il significato di queste parole non è accessibile per chi non veda o non senta, e ciò è quanto dire che al di là della nostra esperienza nelle sue diverse forme non vi è un'altra via che ci consenta di impadronirci del dizionario dei nostri concetti. Se non lo abbiamo effettivamente provato, nessuno potrà spiegarci qual è l'aroma del caffè, ed uno stesso ordine di considerazioni vale per i suoni o per i colori. Qui abbiamo bisogno di esempi che possano fungere come un metro che guidi i nostri giochi linguistici: dobbiamo in altri termini avvalerci di un rimando ostensivo e dobbiamo invitare chi ci ascolta a guardare bene e a fare di ciò che ha sotto gli occhi il campione cui ancorare il proprio uso linguistico.
Non vi è dubbio che una simile affermazione possa sembrarci di primo acchito ovvia. Un cieco non può imparare che cosa sia il rosso - questo è chiaro, proprio come non sembra essere in alcun modo legittimo dubitare del fatto che non vi sia una via diversa per apprendere che cosa sia il suono di un violino se non quello di ascoltarlo. Per comprendere davvero il significato di una parola è necessario poterla ancorare ad un'idea definita, e non vi è dubbio che questo bisogno di ancorare i concetti all'evidenza di una loro esibizione concreta sia una delle più convincenti ragioni che spingono Locke nella sua nota polemica contro l'innatismo. Un'idea che non possa tradursi in una presentazione effettiva e che sia prima del suo stesso manifestarsi non soltanto non è dato trovarla, ma non avrebbe nemmeno buon gioco per proporsi come regola d'uso di un determinato concetto.
Su questo tema avremo in seguito l'opportunità di riflettere; ora dobbiamo invece soffermarci sul modo particolare in cui quest'ordine di considerazioni viene dipanandosi in Locke, poiché se si leggono con attenzione queste pagine del Saggio sull'intelletto umano ci si avvede che nel modo di porre il problema che è loro proprio è implicita una prospettiva teorica tutt'altro che scontata: Locke è convinto che il significato delle parole del nostro linguaggio - della parola "rosso", per esempio - non soltanto rimandi all'esibizione di un contesto intuitivo, ma coincida con un vissuto peculiare (l'esperienza vissuta del rosso) e ritiene quindi del tutto ovvio che non si possa sensatamente parlare di un qualsiasi oggetto se non se ne possiede l'idea che sola può fungere da metro e insieme da referente mentale di quel termine.
Certo, questa tesi sembra godere di un'effettiva plausibilità se accettiamo gli esempi di Locke e ci interroghiamo sui colori, sui suoni, sui sapori: qui abbiamo a che fare con determinazioni che non possono essere colte se non da un'unica fonte sensibile e ciò sembra rendere legittimo il dire che non possiamo comprendere di che cosa una determinata esperienza sia esperienza se non possediamo un'idea di un certo determinato tipo. Si tratta tuttavia di una tesi che appare già meno ovvia se chiamiamo in causa altre esperienze: un cieco non può possedere alcuna effettiva esperienza visiva, ma può comunque comprendere che cosa voglia dire vedere gli oggetti che lo circondano e sa che cos'è la superficie che io vedo perché può toccarla. Nella Diottrica di Cartesio, vi è un vecchio disegno che ci invita a riflettere su come avvenga la percezione visiva: i raggi luminosi che dall'oggetto giungono alla retina incrociandosi nella pupilla sono come i bastoni che un cieco tiene tra le mani e che gli consentono di saggiare a distanza la presenza degli oggetti, valutandone la forma e la disposizione
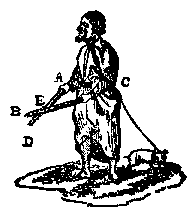
Di questo antico disegno, che paradossalmente intende spiegarci i meccanismi della visione invitandoci a vestire i panni di chi non vede, possiamo avvalerci, credo, per dire quale idea possa farsi un cieco del nostro vedere: il vedere rammenta il toccare gli oggetti - ma è un toccarli a distanza, e che così stiano le cose è un fatto che gli si manifesta nella sicurezza con cui chi vede può guidarlo verso una meta o può indirizzare la sua mano verso un oggetto. Del nostro vedere il cieco ha questa esperienza, e ciò è quanto dire che può forse chiedersi come faccia chi vede a fare ciò che fa (a scansare con sicurezza gli ostacoli, a prendere senza incertezze gli oggetti disposti su un tavolo, ecc.), ma che non avrebbe ragioni altrettanto valide per sentirsi costretto a domandarsi che cosa faccia chi vede. A questa domanda una risposta può darla, anche se vaga e parziale.
E ciò che è vero per l'esperienza della percezione visiva, vale anche altrove. La forma è qualcosa che vedo ma è anche qualcosa che tocco, e la differenza tra le sensazioni che avverto non cancella il fatto che ciò che si manifesta nella mia esperienza visiva sia proprio la stessa realtà che faticosamente si manifesta nella mia esperienza tattile. Ciò che vedo è proprio ciò che tocco, anche se da una parte ho luci e colori, dall'altra una successione più o meno ordinata di punti ruvidi o lisci, sporgenti o rientranti. Abbiamo esperienze diverse, ma in queste diverse forme dell'esperire si manifesta con maggiore o minore nitidezza uno stesso oggetto - una forma determinata. Del resto, anche se nel gioco tra la vista e il tatto si manifesta innanzitutto una forma che si arricchisce della trama molteplice delle qualità sensibili, non vi è dubbio che proprio a partire di qui potremmo muovere per additare un diverso livello di obiettivazione - un livello che è caratterizzato dal fatto che la forma degli oggetti è colta in quanto non è determinata né da proprietà tattili, né da proprietà visive. Posso imparare che cosa sia una retta guardando una linea bianca tracciata dal gesso sulla lavagna o seguendo per un poco con la punta delle dita la costa di un righello, e i nostri ricordi delle prime lezioni di geometria sono carichi di esempi del genere. E tuttavia, se davvero abbiamo imparato che cosa la retta sia non potremo sensatamente chiedere quale sia il suo colore o quale la sua levigatezza. Una linea retta non ha né proprietà tattili né proprietà visive, anche se impariamo ad impiegare correttamente quel concetto operando con le forme dell'intuizione sensibile. La nostra esperienza della retta - perché di un'esperienza, sia pure particolare, ancora si tratta - ci ha permesso di cogliere nella manifestazione paradigmatica di alcuni esempi il manifestarsi di qualcosa di nuovo, di una forma che si è liberata dalle forme della sua manifestazione sensibile. E se le cose stanno così, se la comprensione geometrica muove dall'esempio ma non è poi vincolata alla specificità intuitiva di una idea visiva o tattile, ciò significa che le idee semplici non sono soltanto un contenuto intuitivo intraducibile, ma hanno una loro determinatezza concettuale.
Ma forse del rimando alla geometria non vi è bisogno. Si potrebbe infatti sostenere che un cieco non ignora interamente che cosa significhi vedere un colore: significa appunto saper discernere gli oggetti in base ad una qualche proprietà che appartiene alla loro superficie. Del colore può apprendere allora innanzitutto la forma che lo caratterizza: il suo porsi sensibilmente come una determinazione della cosa che ci riconduce a ciò che innanzitutto la cosa è - una corporeità estesa. Ma del colore chi non vede può comprendere anche che è una proprietà che può variare secondo un insieme di dimensioni che possiamo indicare astrattamente. I colori possono essere ordinati secondo un modello geometrico che è insieme espressione della molteplicità logica del sistema che essi caratterizzano - un sistema che potremmo raffigurare così:
|
|
Si tratta appunto di una rappresentazione geometrica dei colori, e ciò significa che vi è nei colori qualcosa che può essere indicato al di là della specificità sensibile delle qualità cromatiche. I colori hanno appunto questa forma, ed è una forma che può essere colta anche da chi i colori non li vede. Certo, indicare la forma grammaticale che sorregge la regola d'uso dei nomi di colore non significa affatto restituire a chi non vede un'esperienza che resta comunque negata. Il blu e il giallo non sono parole e non possiamo capirli: dobbiamo anche vederli. E tuttavia che cosa il blu e il giallo siano per noi si manifesta proprio nella percorribilità di un insieme di regole grammaticali che, per esempio, ci vietano di dire che vi è un blu che tende all'arancione o un giallo che tende al viola, ma che ci consentono invece di parlare di un rosso giallastro o di un blu violaceo. E proprio come il filosofo settecentesco avvertiva il bisogno di commentare le gesta del matematico Saunderson che, a dispetto della sua cecità, comprendeva quale fosse la natura di una sfera e che cosa fossero le sue proiezioni, anche noi avvertiamo qui il bisogno di additare in linea di principio che anche di fronte al colore è possibile comprendere e non solo vedere.
Del resto, per giungere a questa meta potremmo forse avvalerci di un esempio che lo stesso Locke ci propone. Se interrogassimo un cieco sulla natura del colore potrebbe risponderci con un'immagine, ed è così che di fatto risponde il cieco di cui Locke narra: alla domanda su quale sia l'aspetto del rosso scarlatto egli risponde che potrebbe trattarsi di qualcosa simile al suono di una tromba. Come reagire di fronte a questa strana immagine? Forse riconoscendo che qui vi è soltanto una vaga analogia, su cui non vale la pena di insistere più di tanto: le sinestesie sono il dominio della soggettività e della vaghezza, ed è facile su questo terreno essere tanto vaghi quanto vacui. Ma forse ciò che è vago può assumere contorni più definiti e forse Locke ci offre involontariamente un tema di riflessione più significativo: in questo additare un suono per un colore potrebbe infatti esprimersi la comprensione indiretta di una omologia strutturale tra quel suono ben noto e la regola d'uso di quel nome di colore.
Di qui la conseguenza che ci sembra di poter trarre. Riconoscere che i nostri giochi linguistici poggiano sull'esibizione di esempi non significa ancora sostenere che il loro significato sia un'idea racchiusa nella soggettività, e ciò è quanto dire che il significato della parola "rosso" - per tornare all'esempio da cui abbiamo preso le mosse - non riposa necessariamente sulla nostra idea del rosso: potrebbe essere vero invece che la mia capacità di percepire i colori altro non sia che la condizione cui è vincolata la mia possibilità di giocare al gioco linguistico chiamato in causa da quel termine. Così, posso aver capito che cosa significa misurare, ma se non mi fosse possibile avere tra le mani un metro la misurazione sarebbe egualmente per me una prassi negata. Vi proporrei, in altri termini, di distinguere il significato di un gioco linguistico dai prerequisiti della sua effettiva praticabilità, e cercherei di convincervi dell'opportunità di questa mossa osservando come dalla constatazione secondo la quale la grammatica filosofica di un termine come "rosso" è resa concretamente percorribile dalla natura dei colori non segua ancora che l'assenza della percezione del colore sia causa dell'impossibilità di il senso delle parole che di quella grammatica si avvalgono. Una grammatica è fatta di regole, e le regole sono suscettibili di una formulazione astratta - quella formulazione cui attinge chi, pur non avendo alcuna esperienza di quegli oggetti misteriosi che chiamiamo colori, comprende che sono cose che occupano una superficie e che possono variare in vario modo, divenendo ora più chiari ora più scuri, ora più puri ora più sporchi, in un senso abbastanza simile a quello di cui ci si avvale quando si osserva che un suono può farsi più acuto o grave più limpido o materico.
Avremo modo di ritornare su questo tema. Un punto è tuttavia sin qui chiaro: all'origine di queste obiezioni al discorso lockeano vi è la convinzione che i significati delle nostre parole non siano le idee e che in generale non sia vero che il significato di un termine possa essere ricondotto al possesso di un dato intuitivo, di un contenuto che può essere soltanto vissuto. Per Locke, invece, la comprensione implica un possesso: possiamo capire la parola "rosso" solo perché possiamo vivere l'esperienza del rosso, solo perché nella mente si conserva questa radice non concettuale di ogni nostro pensiero.
Ora, vi è un senso in cui la filosofia di Locke si orienta esplicitamente in questa direzione, ed io credo che se ci fermassimo alle linee essenziali delle sue argomentazioni dovremo semplicemente sostenere che ogni idea è, per Locke, un contenuto presentativo atomico, un dato che non può essere descritto a parole poiché coincide con la scena intuitiva che in esso si dipinge. E tuttavia questa posizione radicale deve essere indebolita, e di questa necessità ci si avvede non appena richiamiamo l'attenzione sul fatto che, per Locke, vi sono idee cui perveniamo attraverso diverse fonti sensibili. Tra queste, l'idea di spazio gioca un ruolo centrale: parliamo di forme visive ma anche di forme tattili e lo stesso vale per la distanza o per le superfici. Ma ciò è quanto dire che, in questo caso, al variare della forma intuitiva delle idee non corrisponde una differenza incolmabile. Qualcosa permane quando vedo la forma che ho appena toccato - ma che cosa?
Per rispondere a questa domanda Locke ci invita ancora una volta a vestire i panni del cieco e a chiederci che cosa sapremmo se distinguere se ci fosse data la vista per vedere ciò che da sempre abbiamo tattilmente esperito.
2. Anche su questo punto è necessario procedere con cautela per cercare di comprendere davvero come stiano le cose, almeno per Locke. Ciò che abbiamo sono le idee, e le idee sono caratterizzate dal loro essere contenuti sensibili che si danno immediatamente alla soggettività e il cui esserci si risolve nella modalità sensibile di questo darsi. Le idee sono appunto questo: un contenuto intuitivo, una certa qualità che viviamo e che è tutta racchiusa nell'evento sensibile che ce la porge. E se manca il canale sensibile che fa da filtro all'insorgere in noi di una famiglia di idee, mancherà anche una molteplicità di oggetti della nostra mente.
È in questa prospettiva che assume una sua ovvia rilevanza la discussione che del quesito di Molyneux Locke ci propone.
La storia di questo quesito, su cui ci siamo brevemente soffermati nella scorsa lezione, ha origine pochi anni prima della pubblicazione del Saggio: il 7 luglio del 1688 Molyneux scriveva una lettera a Locke, proponendogli un problema di filosofia della percezione. Nel 1688 era uscita una breve anticipazione in lingua francese del Saggio di Locke, e Molyneux - che stava lavorando da anni ad un trattato di ottica (Dioptrica nova, 1690) - si convince di aver trovato una guida filosofica sicura e fondata. Di qui la decisione di scrivere al nuovo maestro proponendogli una questione intricata, ma ricca di possibili sviluppi teorici.
Ecco il testo della lettera:
A Man, being born blind, and having a Globe and a Cube, nigh of the same bigness, committed into his Hands, and being taught or told, which is called the Globe and which the Cube, so as easily to distringuish them by his touch ior feeling, then both being taken from him and laid on a Table, let us suppose his Sight restored to Him; Whether he could, by his Sight, and before he touche them, know which is the Globe and which the Cube? Or wehether he could know by his Sight, before he stretched out his Hand, whether he could not reach themm, tho they were removed 20 or 1000 feet from him
In questa lettera sono proposti in realtà due quesiti diversi. Gettiamo innanzitutto lo sguardo sul secondo che concerne il problema della percezione della distanza. Si tratta di un problema cui Molyneux è convinto di poter rispondere facilmente, perché di fatto la sua Dioptrica nova si apre con una tesi che doveva avere un'eco molto significativa nelle pagine del Saggio per una nuova teoria della visione di Berkeley. Molyneux scrive:
For Distance of it self, is not to be perceived; for 'tis a line (or a lenght) preented to our eye with its end toward us, which must therefore be only a point, and that is invisible (p. 113).
È forse opportuno sottolineare fin da principio che non si tratta di una tesi nuova. La si ritrova in tutti i trattati di prospettiva, che ci invitano a prendere atto che vi è un punto in cui la profondità si fa invisibile - il punto dell'occhio. Significato di un termine.
È una tesi vecchia, che assume tuttavia nelle pagine di Molyneux un significato nuovo: non vale più come una constatazione figurativa, ma come un problema percettivo. Il punto dell'occhio non è più il luogo del quadro che fissa il punto di vista e che insieme affida ad un unico minuscolo segno il compito di rendere presente sulla tela ogni punto di quella semiretta che dall'occhio conduce all'infinito; l'enigma che quel segno racchiude è di natura percettiva: se la distanza è un segmento perpendicolare che si chiude nell'occhio e se la proiezione prospettica di un segmento perpendicolare allo sguardo è un punto come posso vedere lo spazio profondo?
Rispondere a questa domanda significa, per Molyneux, rammentarsi dell'esperienza come trama aperta di possibili apprendimenti: solo il gioco della ripetizione può permetterci di cogliere in ciò che vediamo i segni della profondità spaziale. E se le cose stanno così, il cieco della nostra finzione non potrà che tacere quando alzerà per la prima volta gli occhi sulla scena che di fronte a lui si dipana. Per sapere dire quanto distanti siano il cubo e la sfera che vede dovrà lasciare che l'esperienza e il tempo gli insegnino molte cose che ancora non sa.
Una risposta ovvia - ed è forse per questo che quando Molyneux ripropone a Locke il suo quesito lascia cadere il problema della distanza: una risposta per questo problema vi è già e non sembra necessario cercarla nella mente di un filosofo molto ammirato, ma evidentemente meno attento alla corrispondenza di quanto non sarebbe stato opportuno: la lettera di Molyneux resta infatti nel cassetto e Locke vi rivolge lo sguardo solo quando qualche anno dopo Molyneux prende nuovamente carta e penna per scrivergli. Solo allora Molyneux diviene il dotto di cui ci si può vantare di essere amici, ed è così che nella seconda edizione del Saggio Locke trova un posto per pubblicare e discutere la seconda lettera che lo scienziato irlandese gli aveva inviato. Così si legge infatti nel ix capitolo del Saggio:
I shall here insert a problem of that very ingenious and studious promoter of real knowledge, the learned and worthy Mr. Molyneux, which he was pleased to send me in a letter some months since; and it is this:- "Suppose a man born blind, and now adult, and taught by his touch to distinguish between a cube and a sphere of the same metal, and nighly of the same bigness, so as to tell, when he felt one and the other, which is the cube, which the sphere. Suppose then the cube and sphere placed on a table, and the blind man be made to see: quaere, whether by his sight, before he touched them, he could now distinguish and tell which is the globe, which the cube?" To which the acute and judicious proposer answers, "Not. For, though he has obtained the experience of how a globe, how a cube affects his touch, yet he has not yet obtained the experience, that what affects his touch so or so, must affect his sight so or so; or that a protuberant angle in the cube, that pressed his hand unequally, shall appear to his eye as it does in the cube". I agree with this thinking gentleman, whom I am proud to call my friend, in his answer to this problem; and am of opinion that the blind man, at first sight, would not be able with certainty to say which was the globe, which the cube, whilst he only saw them; though he could unerringly name them by his touch, and certainly distinguish them by the difference of their figures felt. This I have set down, and leave with my reader, as an occasion for him to consider how much he may be beholden to experience, improvement, and acquired notions, where he thinks he had not the least use of, or help from them. And the rather, because this observing gentleman further adds, that "having, upon the occasion of my book, proposed this to divers very ingenious men, he hardly ever met with one that at first gave the answer to it which he thinks true, till by hearing his reasons they were convinced" (ivi, II, ix, 8).
Alla domanda ora segue una risposta negativa che Locke ci dice di condividere insieme alle ragioni che lo stesso Molyneux adduce. Così nel Saggio leggiamo con approvazione quel che Molyneux aveva scritto: anche Locke sostiene che il cieco risanato non può ancora sapere come appaia alla vista ciò che il tatto coglie come una sporgenza, né può indovinare quale sia la forma visiva di quegli angoli che ha già tante volte sfiorato con la punta delle dita.
Nella risposta di Molyneux non è tuttavia ancora racchiuso tutto ciò che Locke ritiene di dover dire su questo tema. Così, per addentrarci in ciò che Locke pensa su questo tema dobbiamo innanzitutto riflettere un poco sul luogo del Saggio in cui egli ritiene opportuno rendere pubblico il quesito che gli era stato sottoposto. Non si tratta di una scelta casuale: Locke discute la domanda di Molyneux in un paragrafo che ha per tema il peso delle abitudini sulla percezione, e questo fatto si comprende non appena si riflette su quale sia la premessa che fa da sfondo a queste considerazioni: la domanda sulla capacità di riconoscere gli oggetti delle proprie esperienze tattili viene introdotta nel Saggio dalla constatazione secondo la quale una percezione visiva della profondità non c'è. Noi vediamo propriamente soltanto superficie variamente colorate, non spazi tridimensionalmente organizzati. Per comprendere che cosa davvero vediamo vale ancora una volta il richiamo (così tipicamente venato di considerazioni fisiologiche) alle immagini pittoriche. Sulla tela nulla va al di là della superficie: il pittore non fa altro che disporre sul piano i pigmenti della sua tavolozza, ritagliando ad arte macchie di colori diversi. Quelle macchie tuttavia sanno riproporre lo stesso messaggio che la vista ci offre e che il tatto ci ha insegnato ad interpretare tridimensionalmente: lo spazio bidimensionale della percezione visiva si traduce così in uno spazio tridimensionale ed è tanta l'abitudine che ci guida in questa prassi interpretativa che ciò che propriamente è percepito sfugge dalla mente, proprio come sfuggono dalla mente i caratteri tipografici che, leggendo, si perdono nella meta cui conducono - la comprensione del significato.
Credo che questa premessa sia importante per capire la posizione di Locke. Locke in effetti non ha dubbi: il cieco risanato non saprà riconoscere "a prima vista" la sfera e il cubo che aveva tattilmente imparato a distinguere e a cui sapeva dare il giusto nome, poiché non può ancora "leggere" tridimensionalmente ciò che i suoi occhi gli porgono. Ma questa constatazione ovvia si lega ad una nuova domanda cui non è facile rispondere e nemmeno dire quale sia la risposta che Locke ha in mente. Il problema almeno è chiaro: Locke si chiede come si debba pensare la relazione tra la vista e il tatto.
Questa relazione si fa percepibile con l'esperienza: il cieco non riconosce "a prima vista", il cubo e la sfera ma ha appunto bisogno di tempo. E il tempo è necessario perché è necessario un apprendimento: la vista deve essere educata dal tatto. E tuttavia questo non dice ancora quale via Locke intenda seguire. Credo che quattro siano in astratto le possibilità che Locke ha aperte di fronte a sé:
Tatto e vista potrebbero essere diversi per ciò che concerne il medium rappresentativo, ma potrebbero essere egualmente modi di manifestazione di una stessa realtà obiettiva. Il cieco risanato non saprebbe al primo sguardo cogliere ciò che gli si mostra, ma poi imparerebbe a legare la vista al tatto e a cogliere nell'uno e nell'altra le manifestazioni di uno stesso oggetto. Ciò che vede è appunto un oggetto che si manifesta nella forma che è caratteristica di ciò che è visibile: il cieco vedrà innanzitutto un insieme di colori, disposti in vario modo. Ma ciò che il cieco vede non si esaurisce in quei colori, e lascia per essenza aperta la possibilità di una diversa manifestazione: ciò che si manifesta alla vista nella varietà dei colori si manifesta al tatto come resistenza e come forma. Si tratta certo di un'ipotesi plausibile, ma lontana dalla prospettiva di Locke. E le ragioni ci sono note. Per Locke, le idee non sono manifestazioni di qualcosa che vada al delle datità fenomeniche, anche se naturalmente possono essere segno di una stessa realtà trascendente. Così, se ci poniamo nella prospettiva del Saggio sull'intelletto umano, non possiamo intendere il rapporto che lega la percezione tattile alla percezione visiva alla luce dell'identità dell'oggetto esperito. Due idee non possono parlarci dello stesso oggetto poiché di fatto sono due oggetti dell'intelletto: ne segue che se una relazione deve esserci, essa può concernere sia l'oggetto trascendente e non percepibile di cui le idee sono segni, sia la loro natura contenutistica, ma non l'oggetto reale così come è tattilmente e visivamente esperito. Ed è chiaro che la possibilità di sostenere che idee differenti sono segno di un'identica realtà non percepibile è un'ipotesi che può sostenersi solo se qualcosa sul terreno di ciò che è dato la giustifica: l'ipotesi dell'identità del referente non esperibile ci riconduca così come al suo fondamento all'analisi delle relazioni interne tra le idee tattili e visive.
La seconda ipotesi che vogliamo vagliare ci invita a prendere in considerazione la tesi della somiglianza tra le idee. Locke dice che abbiamo un'idea di spazio che ci deriva dal tatto e dalla vista, e ciò potrebbe significare che vi è un contenuto qualitativamente simile che si ripete nell'immagine tattile e nell'immagine visiva di una sfera. Vi sarebbe cioè un nucleo comune che resta non appena spogliamo la sfera tattile e la sfera visiva dalle loro proprietà idiosincratiche: dal colore e dalla luce da un lato, dalla ruvidità e dalla resistenza dall'altro. E tuttavia non è affatto facile comprendere che cosa possa rimanere di comune una volta che si spogli un'idea visiva da ciò che è eminentemente visivo e un'idea tattile da ciò che eminentemente tattile - non lo si comprende se ci si muove all'interno dell'ipotesi che abbiamo formulato e che ci invita a cercare un elemento comune di natura qualitativa. Del resto, le considerazioni sulla natura bidimensionale della percezione visiva della spazialità rendono ulteriormente problematica la via che abbiamo indicato: tra l'immagine visiva e l'immagine tattile una somiglianza effettiva non c'è, poiché se anche fosse possibile liberare una forma dal modo in cui ci appare visivamente o tattilmente non è affatto chiaro in che modo potremmo poi far combaciare uno spazio tridimensionale scandito per vuoti e per pieni con una superficie piana su cui si alternano macchie di colore.
Di qui la possibilità di una terza ipotesi di natura più apertamente negativa, - di un'ipotesi che potrebbe spingerci a considerare l'esperienza tattile e l'esperienza visiva non soltanto diverse, ma prive di qualsiasi correlazione che non sia quella fondata dall'abitudine. Le idee tattili e le idee visive potrebbero divenire l'una segno dell'altra, ma senza che ciò comporti una qualsiasi deroga alla tesi dell'eterogeneità. Una parola può essere segno di una cosa senza che per questo vi sia una relazione di somiglianza tra l'una e l'altra: la parola "sfera" non assomiglia a una sfera e per questo è necessario del tempo perché chi non sa l'italiano impari a usarla correttamente. Si tratta anche in questo caso di un'ipotesi percorribile, ed è di fatti questa la tesi che Berkeley fa sua nelle pagine della sua Teoria della visione. Ma ancora una volta non è questa la via che Locke sembra intraprendere. Il tatto e la vista sono eterogenei, ma tuttavia ciò che Locke si sente di negare è solo che il cieco possa riconoscere "con certezza" la sfera e il cubo, e di questa espressione che Locke aggiunge esplicitamente nel suo commento a Molyneux si deve rendere conto. E ciò significa: la risposta al quesito di Molyneux deve essere tale da permetterci di comprendere sia perché il cieco non può dire con certezza "questa è la sfera", sia perché possa comunque essere pensabile che il cieco abbia una qualche inclinazione a imboccare una strada piuttosto che l'altra. Di qui la quarta ipotesi
Locke non nega l'eterogeneità dell'immagine tattile della sfera rispetto all sua immagine visiva ma ritiene che la differenza qualitativa non sia tale da negare radicalmente l'ipotesi di una correlazione analogica. Pensiamo alla relazione che lega il solco di un disco alla musica che il giradischi vi legge: si tratta certo di due realtà qualitativamente diverse, poiché un suono non assomiglia ad un solco, anche se la puntina sa leggere quello in questo. Non vi assomiglia, ma una relazione c'è: il solco sale e scende proprio come possono fare le note di una melodia e può variare con un diverso passo, alternando rapidi cambiamenti a lenti movimenti - proprio come fanno i nostri brani musicali. Possiamo allora esprimerci così: il solco e la musica stanno in una relazione analogica secondo una regola di proiezione che è data dal funzionamento del giradischi. Certo, anche in questo caso chi osservasse per la prima volta il solco di un disco non potrebbe dire con certezza qual è la musica che gli corrisponde, poiché non è affatto detto quale sia la regola di proiezione che trasforma i movimenti della puntina nel solco nella melodia che ascoltiamo. Per comprendere la regola che deve guidarci abbiamo bisogno dell'esperienza, che sola può mostrare che tra le scene tattili e le scene visive è possibile cogliere qualcosa come una analogia strutturale.
Credo che Locke segua quest'ultima via. Per Locke la vista e il tatto ci danno idee differenti. Ma queste idee si raccordano le une alle altre secondo una regola di proiezione che ci consente di legarle insieme e di considerarle segni di un'identica realtà - una realtà che, ancora una volta, non appare nell'esperienza se non come ciò di cui sono segno i segni. E tuttavia, nello scegliere questa via per venire a capo della questione di Molyneux si comprende anche in quale senso sia necessario, per Locke, disporre il contenuto delle idee in una dimensione nuova e più complessa, che renda sensato l'ipotesi di un loro confronto interno. Le idee sono atomi psichici e si danno ciascuna per sé come un contenuto che può essere appreso soltanto vivendolo, e tuttavia almeno in alcuni casi, le idee rivelano un'identica forma che ci permette di cogliere nell'una la rappresentazione strutturale dell'altra. Come ciò accada e se ciò sia davvero coerente con la grammatica filosofica su cui Locke sembra invitarci a concordare è una domanda cui dovremo cercare in seguito di dare una risposta.

Livio Mehus
Allegoria del tatto
(e paragone tra le arti)
1. Le riflessioni che abbiamo proposto nelle precedenti lezioni ci hanno lentamente condotto verso una posizione complessiva che potremmo formulare così: ogni nostra esperienza, per quanto complessa sia, ci riconduce infine alle idee semplici, che di fatto si pongono come i segni di un linguaggio mentale, di un idioma che nella mente opera con oggetti suoi propri, per costruire le proposizioni che ci permettano di rappresentare la realtà e di operare su di essa. Tutte le annotazioni che abbiamo passo dopo passo messo in luce nel nostro tentativo di analizzare le pagine lockeane convergono infine verso questa tesi.
Verso questa meta si dirigono innanzitutto le riflessioni volte a far luce sul carattere necessariamente cosciente delle idee. Sulla natura di questa relazione ci siamo a suo tempo soffermati ed avevamo osservato come di qui Locke muovesse per dedurre il carattere di evento di ogni nostra percezione. Ma in quella tesi vi è di più, e per rendersene conto è sufficiente dare la giusta attenzione a quei passi in cui Locke stringe la consapevolezza delle idee al loro carattere puramente mentale. Se percepire significa essere cosciente, allora le idee debbono essere racchiuse nello spazio della consapevolezza - nella mente; conosciamo il mondo esterno solo perché siamo consapevoli del linguaggio mentale in cui quel mondo coscientemente si reduplica:
It is evident the mind knows not things immediately, but only by the intervention of the ideas it has of them (ivi, IV, iv, 3) For, since the things the mind contemplates are none of them, besides itself, present to the understanding, it is necessary that something else, as a sign or representation of the thing it considers, should be present to it: and these are ideas (ivi, IV, xxi, 3).
Ma non è solo il tema della consapevolezza che ci riconduce verso una concezione mentalistica dell'esperienza percettiva: verso quest'ordine di considerazioni siamo sospinti anche dalla constatazione della dipendenza delle idee dalla configurazione complessiva dei nostri organi di senso, così come dalle riflessioni sulla necessaria separatezza delle idee semplici - di questi atomi psichici di cui non ha senso predicare l'identità, poiché ogni idea si dispiega per quello che è alla coscienza che la intende. Su questo punto le argomentazioni raccolte intorno alla questione di Molyneux assolvono una funzione centrale, e non è un caso se la metafora del cieco risanato come mezzo per indagare la struttura della nostra esperienza percettiva diviene in Berkeley il cavallo di battaglia per elaborare una filosofia della visione di stampo radicalmente fenomenistico: nella risposta radicalmente negativa che egli dà al quesito di Molyneux vi è tutto ciò che è necessario per negare che la percezione sia innanzitutto rivolta agli oggetti esterni e che siano proprio questi oggetti a manifestarsi nelle idee che ce ne facciamo.
Da tutti questi molteplici indizi possiamo trarre così una conclusione sullo statuto ontologico delle idee che abbiamo già ampiamente anticipato: per Locke, le idee sono eventi mentali, che hanno una causa negli oggetti esterni e che si differenziano da altri molteplici eventi solo per il fatto che accadono nel luogo rischiarato dalla nostra consapevolezza.
Ora, riconoscere che le idee sono eventi tra gli altri sembra porre le analisi lockeane di fronte ad un dissidio teorico difficilmente sanabile. Locke parla delle idee come termini di un linguaggio mentale, ed un linguaggio per essere tale deve poterci parlare di qualcosa: i suoi segni debbono avere una funzione denotativa. Ma le idee sono appunto eventi, ed un evento è un fatto come gli altri ed è in linea di principio privo di un rimando intenzionale. Di qui il dissidio cui alludevamo: se le idee altro non sono che il modo in cui una cosa - la nostra mente - reagisce ad una momentanea alterazione dell'apparato sensoriale cui è connessa, allora non si comprende che cosa ci permetta di parlare di un linguaggio mentale di cui le idee sarebbero i segni e non invece di un linguaggio delle reazioni chimiche o degli eventi fisici. Per dirla in un modo (apparentemente) paradossale: se possiamo dire che la percezione del bianco è un evento che significa una qualità della neve, perché non affermare allora che il suo sciogliersi significa un aumento della temperatura? Il fatto che le idee siano eventi che accadono in un luogo che ci è caro - la nostra testa - non è una buona ragione per considerarli eventi peculiari.
Si tratta indubbiamente di un problema complesso e non credo che la risposta che Locke nel Saggio sull'intelletto umano ci propone sia soddisfacente. E tuttavia in quelle pagine una risposta prende corpo, ed è un fatto che Locke non cerca di sfuggire al problema o di renderlo meno avvertibile pagando il prezzo dell'incoerenza. Tutt'altro: Locke ci invita apertamente a rifiutare il linguaggio dell'intenzionalità della vita di esperienza e a cercare il fondamento della funzione denotativa del linguaggio mentale nella sua stessa natura di evento.
Affrontiamo innanzitutto il primo momento e chiediamoci che cosa voglia dire affermare che le idee non hanno una intrinseca funzione rappresentativa. Una prima possibile argomentazione per rifiutare alle idee il carattere di rappresentazioni sembrerebbe ricondurci sul terreno delle argomentazioni scettiche: il filosofo seicentesco sa (o crede di sapere) che non vi è una garanzia immanente della conoscenza ed è quindi consapevole che non vi è nessuna ragione cogente per dimostrare al di là di ogni possibile dubbio che le idee sono simili alle cose e che possono quindi denotarle. Negare alle idee una funzione denotativa vorrebbe dire allora argomentare scetticamente sull'effettiva percorribilità del nesso che dalle idee pretende di condurci alle cose.
Ora, non è difficile rendersi conto che non è questa la prospettiva di Locke e che la stessa possibilità dell'istanza scettica presuppone quel nesso figurativo sulla cui effettiva bontà ci chiede poi di dubitare. Lo scettico non nega che le idee abbiano una loro intrinseca funzione denotativa; tutt'altro: di questa necessaria premessa lo scetticismo si avvale per sostenere che le nostre idee sono sì raffigurazioni delle cose, ma raffigurazioni infedeli. La posizione di Locke è più radicale: la sua tesi è che le idee di per se stesse non raffigurino nulla e siano semplicemente gli oggetti del nostro intelletto. Ciò che si raffigura sullo specchio della coscienza non è per sua natura un riflesso di una realtà che stia di là da esso: in se stesse le idee semplicemente sono, e non rimandano affatto ad altro.
Da questo punto di vista assume un senso peculiare la discussione che apre il capitolo ottavo e che ha per oggetto quelle idee che non rimandano ad un'entità positiva che funga da loro causa, ma che ci riconducono invece a privazioni, a mancanze. Gli esempi sono a portata di mano: così come vi è un'idea del bianco vi è anche un'idea del nero, anche se l'oscurità altro non è se non mancanza di luce, ed un analogo discorso potrebbe essere fatto anche per il silenzio o per il freddo che altro non sono che mancanze di suono e di calore. Rispetto a queste idee Cartesio reagiva così:
E per ciò che riguarda le idee delle cose corporee [...] scopro che non vi si trovano che pochissime cose che io concepisca chiaramente e distintamente: e cioè la grandezza [...], la figura [...], la situazione [...], ed il movimento il cambiamento di questa situazione; alle quali si possono aggiungere la sostanza, la durata e il numero. Quanto alle altre cose, come la luce i colori, i suoni, gli odori, i sapori, il calore, il freddo e le altre qualità che cadono sotto il tatto, esse si trovano nel mio pensiero con tanta oscurità e confusione, che ignoro persino se siano vere o false e solo apparenti, cioè se le idee che io concepisco di queste qualità siano in effetti le idee di cose reali, oppure se non mi rappresentino che esseri chimerici, i quali non possono esistere. Perché, sebbene abbia notato che solo nei giudizi si può trovare la vera e formale falsità, si può tuttavia trovare nelle idee una certa falsità materiale, quando esse rappresentano ciò che non è nulla come se fosse qualche cosa. Per esempioo le idee che ho del freddo e del caldo sono così pocio chiare e così poco distinte che, per loro mezzo, non posso discernere se il freddo è solo una privazione del caldo, o il caldo una privazione del freddo, oppure se l'uno e l'altro sono qualità reali, o se non lo sono; e poiché essendo le idee come le immagini, non può essercene nessuna che non ci sembri rappresentare qualchecosa, se è vero il dire che il freddo non è altro che la privazione del caldo, l'idea che me lo rappresenta come qualcosa di reale e e positivo non sarà male a proposito chiamata falsa, e così delle altre simili idee (Meditazioni filosofiche, a cura di E. Garin, Laterza, Bari 1975, pp. 95-96 (libro III, § 9)).
All'origine di questa tesi cartesiana, che di fatto ci invita a riconoscere che le idee sono in se stesse potenzialmente vere o false e che sono potenzialmente vere se può esistere l'oggetto che presentano e che sono potenzialmente false se tale oggetto non può esistere, vi è una convinzione ben precisa: anche se le idee hanno una causa ed anche se non è affatto detto che la causa assomigli all'effetto, ciononostante le idee si pongono innanzitutto come rappresentazioni delle cose - ed una rappresentazione di qualcosa che non c'è non è soltanto inadeguata ma senz'altro falsa, almeno dal punto di vista conoscitivo.
Così appunto Cartesio; ma per Locke come stanno le cose? Nel Saggio vi è un passo in cui almeno il titolo sembra dare ragione a Cartesio: il capitolo XXXII si intitola infatti Of True and False Ideas, e ciò sembra legittimare la tesi che anche le idee siano innanzitutto rappresentazioni di qualcosa e siano quindi in se stesse potenzialmente vere o false. Basta leggerlo, tuttavia, per rendersi conto che la prospettiva è mutata: l'obiettivo di queste ultime pagine del secondo libro del Saggio consiste infatti nel cercare di rendere conto di espressioni come quelle che fanno da titolo al passo che abbiamo citato senza per questo attribuire alle idee un'intrinseca funzione rappresentativa. Come questo obiettivo possa essere raggiunto è presto detto: è sufficiente sostenere che di idee false si parla solo perché tacitamente si proietta sulle idee il valore di verità di una proposizione esistenziale che verte sull'oggetto di cui sono segni. Scrive Locke:
Truth and falsehood properly belong to propositions, not to ideas. Though truth and falsehood belong, in propriety of speech, only to propositions: yet ideas are oftentimes termed true or false (as what words are there that are not used with great latitude, and with some deviation from their strict and proper significations?) Though I think that when ideas themselves are termed true or false, there is still some secret or tacit proposition, which is the foundation of that denomination: as we shall see, if we examine the particular occasions wherein they come to be called true or false. In all which we shall find some kind of affirmation or negation, which is the reason of that denomination. For our ideas, being nothing but bare appearances, or perceptions in our minds, cannot properly and simply in themselves be said to be true or false, no more than a single name of anything can be said to be true or false. Ideas and words may be said to be true, inasmuch as they really are ideas and words. Indeed both ideas and words may be said to be true, in a metaphysical sense of the word truth; as all other things that any way exist are said to be true, i.e. really to be such as they exist. [...] But it is not in that metaphysical sense of truth which we inquire here, when we examine, whether our ideas are capable of being true or false, but in the more ordinary acceptation of those words: and so I say that the ideas in our minds, being only so many perceptions or appearances there, none of them are false; the idea of a centaur having no more falsehood in it when it appears in our minds, than the name centaur has falsehood in it, when it is pronounced by our mouths, or written on paper. For truth or falsehood lying always in some affirmation or negation, mental or verbal, our ideas are not capable, any of them, of being false, till the mind passes some judgment on them; that is, affirms or denies something of them. Ideas referred to anything extraneous to them may be true or false. Whenever the mind refers any of its ideas to anything extraneous to them, they are then capable to be called true or false. Because the mind, in such a reference, makes a tacit supposition of their conformity to that thing; which supposition, as it happens to be true or false, so the ideas themselves come to be denominated (Saggio sull'intelletto umano, II, xxxii, 1- 4)
Anche in questo caso, dobbiamo stare attenti a non considerare ovvio ciò che in realtà racchiude una scelta filosofica impegnativa. Certo, di un nome non si può dire che sia vero o falso: vera o falsa è soltanto la proposizione che lo racchiude. Ma qui Locke ci invita a stringere a questa affermazione così difficilmente discutibile una tesi assai più problematica: affermare che le idee sono nomi e quindi non sono né veri né falsi significa a suo avviso sostenere che le idee di per se stesse non denotano nulla perché sono immagini che non sono animate da una istanza intenzionale. Per Locke, le idee non sono quadri che raffigurino il mondo esterno e nemmeno un'eco più o meno vivida della realtà, ma si pongono come reazioni soggettive ad uno stimolo, come forme di un campionario di oggetti di psichici i cui termini sorgono dalla traduzione degli stimoli nervosi in eventi di natura mentale. Scrive Locke:
Concerning the simple ideas of Sensation, it is to be considered, - that whatsoever is so constituted in nature as to be able, by affecting our senses, to cause any perception in the mind, doth thereby produce in the understanding a simple idea; which, whatever be the external cause of it, when it comes to be taken notice of by our discerning faculty, it is by the mind looked on and considered there to be a real positive idea in the understanding, as much as any other whatsoever; though, perhaps, the cause of it be but a privation of the subject. [...]. Thus the ideas of heat and cold, light and darkness, white and black, motion and rest, are equally clear and positive ideas in the mind; though, perhaps, some of the causes which produce them are barely privations, in those subjects from whence our senses derive those ideas. These the understanding, in its view of them, considers all as distinct positive ideas, without taking notice of the causes that produce them: which is an inquiry not belonging to the idea, as it is in the understanding, but to the nature of the things existing without us. These are two very different things, and carefully to be distinguished; it being one thing to perceive and know the idea of white or black, and quite another to examine what kind of particles they must be, and how ranged in the superficies, to make any object appear white or black. [...]. Why a privative cause in nature may occasion a positive idea. If it were the design of my present undertaking to inquire into the natural causes and manner of perception, I should offer this as a reason why a privative cause might, in some cases at least, produce a positive idea; viz. that all sensation being produced in us only by different degrees and modes of motion in our animal spirits, variously agitated by external objects, the abatement of any former motion must as necessarily produce a new sensation as the variation or increase of it; and so introduce a new idea, which depends only on a different motion of the animal spirits in that organ (ivi, II, viii, 1, 2, 4).
Di qui, da queste considerazioni sulla possibilità che una mera privazione come la mancanza di calore o l'assenza di luce possa tradursi in un'esperienza effettiva, è possibile muovere per sottolineare uno dei tratti caratteristici della posizione del Saggio: per Locke, vi è una piena autonomia della sfera dell'esperienza, la cui determinatezza non dipende da altro che dalle sue stesse regole. Sostenere che il nero sia mera assenza di luce è del tutto legittimo, così come legittima è la convinzione che il freddo sia solo un nome cui, sul piano reale, non corrisponde nulla se non una diminuzione del calore; di qui, tuttavia, non segue affatto che il nero e il freddo non siano due idee del tutto paragonabili al bianco e al caldo: se ci si dispone sul terreno descrittivo una distinzione tra le idee che hanno una causa positiva e le idee che hanno una causa privativa è del tutto infondata. Scrive Locke:
We may have the ideas when we are ignorant of their physical causes. A painter or dyer who never inquired into their causes hath the ideas of white and black, and other colours, as clearly, perfectly, and distinctly in his understanding, and perhaps more distinctly, than the philosopher who hath busied himself in considering their natures, and thinks he knows how far either of them is, in its cause, positive or privative; and the idea of black is no less positive in his mind than that of white, however the cause of that colour in the external object may be only a privation (ivi, II, viii, 3).
Proprio come il pittore considera il nero un pigmento come gli altri, così chi descrive la propria esperienza non può fare a meno di riconoscere che il nero e il freddo sono esperienze in senso proprio. Per ciò che concerne la sua dimensione propriamente contenutistica, l'esperienza è autonoma e deve la sua configurazione complessiva al modo peculiare in cui ogni canale sensibile convoglia alla nostra mente l'informazione che deriva dal mondo esterno. Se le onde elettromagnetiche della luce, la riflettanza e la struttura molecolare della materia ci appaiono nel gioco variopinto dei colori, se questo è ciò che esperiamo, ciò dipende in primo luogo dal fatto che i nostri recettori visivi traducono proprio così quegli stimoli - in immagini cromatiche. Ma appunto: ciò che innanzitutto ci è dato sono propriamente solo questi vissuti che in sé non implicano il rimando ad una realtà rappresentata.
Si potrebbe tuttavia spingersi un passo in avanti ed osservare che, in secondo luogo, lo stesso carattere delle idee - il loro proporsi come immagini mentali - ci riconduce ancora una volta alla natura umana e più propriamente alla natura della mente. Anche su questo punto è necessario procedere con cautela, e questo perché parlare delle idee come di immagini mentali sembra necessariamente richiamare alla mente l'idea di un nesso rappresentativo. Sin dalle grotte di Lascaux le immagini hanno proprio questa funzione: rendere presente qualcosa che non c'è - che non è ora visibile o che non lo è più. La preistoria dell'immagine è legata al culto dei morti ed in essa si manifesta in una forma particolarmente evidente come la funzione del raffigurare un tempo esprimesse innanzitutto il bisogno di dare una stabilità a ciò è dolorosamente instabile: la presenza visibile degli uomini, l'arco temporale finirto che racchiude il loro esserci e il loro imporsi al nostro sguardo. Ora, da questo breve excursus nella storia della pragmatica delle immagine si può trarre una conclusione ovvia: il parlare delle idee come immagini sembra essere giustificato dal fatto che le idee ci parlano del mondo, anche se talvolta ci mentono.
Si tratta, tuttavia, di una conclusione che non è opportuno trarre perché, come sappiamo, in Locke le idee non sono di per se stesse raffigurazioni. Se dunque ne parliamo egualmente come di immagini è per una ragione diversa che ci riconduce ancora una volta alla natura della mente e al suo necessario configurarsi come il luogo in cui gli stimoli di natura motoria assumono una dimensione intuitiva. Ancora una volta a guidarci è l'immagine dello specchio: sulla sua superficie un evento fisico - la trasmissione della luce secondo le leggi dell'ottica geometrica - si fa immagine e assume un contenuto cognitivo immediatamente evidente. Lo stesso accade nella mente: qui la sensazione si fa idea e diviene un contenuto che è caratterizzato dalla sua immediata intuitività e consapevolezza.
Ma di qui anche le ragioni che ci invitano a prendere commiato da quest'immagine. Le idee non sono riflessi sulla superficie di uno specchio perché restano idee anche se non assomigliano affatto alle cose da cui traggono origine:
To discover the nature of our ideas the better, and to discourse of them intelligibly, it will be convenient to distinguish them as they are ideas or perceptions in our minds; and as they are modifications of matter in the bodies that cause such perceptions in us: that so we may not think (as perhaps usually is done) that they are exactly the images and resemblances of something inherent in the subject; most of those of sensation being in the mind no more the likeness of something existing without us, than the names that stand for them are the likeness of our ideas, which yet upon hearing they are apt to excite in us (ivi, II, viii, 7).
Ora, in questa negazione di un intrinseco carattere di raffiguratività delle idee traspare una conseguenza che è implicita nella tesi dell'autonomia dell'esperienza - Locke ci invita infatti a prendere atto dell'arbitrarietà del nesso che lega l'aspetto intuitivo delle immagini psichiche al contenuto dell'oggetto reale cui esse infine rimandano. Che determinate onde elettromagnetiche ci appaiano come colori e che si veda rosso là dove vi è una lunghezza d'onda pari a 400 nanometri è un fatto che avrebbe potuto essere diverso in un mondo in cui gli uomini avessero avuto un differente corredo di organi di senso; ne segue che il rosso non è un'immagine necessaria della realtà che lo sottende, ma è un segno che avrebbe potuto essere diversamente configurato e che è dunque, in questo senso, arbitrario. Ora, la constatazione che vi è un elemento di arbitrarietà nel nesso che lega le idee agli oggetti da cui causalmente derivano spinge Locke in una direzione prevedibile: per intendere il nesso tra idee e realtà il Saggio sull'intelletto umano ci invita a prendere come modello il rapporto di designazione linguistica. Le idee non raffigurano la realtà esterna nel modo in cui un ritratto rende visibile un volto; alla metafora della pittura Locke ci invita a sostituire quella della scrittura: le idee non sono una galleria di quadri che si sforza di riprodurre nella soggettività il mondo esterno, ma sono piuttosto parole tracciate sulla pagina bianca. Le idee divengono così un segno della realtà esterna, e come per ogni segno anche in questo caso è importante rammentarsi dell'inerenza ad un peculiare orizzonte linguistico: le idee sono segni che appartengono al linguaggio della mente e che si adattano quindi all'alfabeto delle differenti forme sensibili e alla forma di scrittura della consapevolezza.
Per giungere a questa conclusione è tuttavia opportuno riflettere sulle ragioni che spingono Locke a rifiutare la tesi della raffiguratività intrinseca delle idee a favore di una teoria di stampo causalistico del nesso percettivo. Di qui la necessità di soffermarsi un poco sulla distinzione tra raffigurazioni e segni naturali così come Locke la intende. E ciò significa di fatto riflettere sulla diversità che sussiste tra la relazione di somiglianza da un lato e il nesso causale dall'altro.
2. Ritorniamo dunque sui nostri passi ed in modo particolare rivolgiamo nuovamente lo sguardo alle riflessioni volte a negare alle idee una natura essenzialmente raffigurativa. Le idee non sono raffigurazioni, e non lo sono perché sono prive di due caratteristiche che ineriscono essenzialmente al raffigurare: l'essere parte di una prassi che istituisce una funzione di supplenza del raffigurante nei confronti del raffigurato e il porsi di una relazione di somiglianza che sorregga il nesso raffigurativo e che ci permetta di ripetere nell'immagine l'oggetto che si intende rappresentare.
Affrontiamo innanzitutto il primo punto. Un disegno di un bambino può essere, talvolta, incomprensibile per un adulto, e tuttavia se abbiamo la pazienza di guardare e insieme di ascoltare ciò che il bambino ci dice quello strano intrico di segni che la matita ha lasciato sul foglio si anima di un senso e noi finalmente riconosciamo una storia che vediamo raffigurata di fronte a noi. Ora ascoltiamo e comprendiamo come quel disegno debba essere usato: chi lo guarda deve cercare di scorgervi una grotta, un drago e una lingua di fuoco che sta per colpirci. Quei tratti di matita dobbiamo usarli così, ed è così che li usa un bambino se con quel disegno ci minaccia e ci insegue.
E tuttavia, perché quel disegno possa raffigurare qualcosa non basta ascoltare ciò che ci si dice: dobbiamo anche riuscire a scorgere ciò che ci si invita a vedere. Il nesso di raffigurazione è dunque subordinato ad una condizione necessaria, anche se non sufficiente: tra l'oggetto raffigurato e la raffigurazione deve sussistere una relazione di somiglianza. Ma la somiglianza è una relazione peculiare: può sussistere soltanto tra oggetti che ci siano noti e che quindi appartengano al nostro orizzonte cognitivo. Nella grammatica del concetto di somiglianza vi è una regola che ci impedisce di dire sensatamente che una persona assomiglia come una goccia d'acqua ad un'altra che tuttavia non conosciamo. Di qui la conclusione che dobbiamo trarre. Il nesso di raffigurazione è una relazione evidente che può sussistere solo tra oggetti che cadono nell'orizzonte cognitivo della soggettività: proprio perché poggia sulla somiglianza, non è possibile una raffigurazione di una realtà ignota. Possiamo immaginare un ritratto di una persona che non conosciamo e Antonello da Messina ha dipinto un bellissimo quadro che si intitola proprio così - ritratto di ignoto. Ma se qualcuno facesse con il pennello un punto sulla tela e poi ci dicesse compiaciuto che ciò che ha dipinto è identico ad una realtà che gli è ignota noi penseremmo di avere a che fare con un matto. Ora, ciò che nel vivere ha i tratti della follia, sembra guadagnare invece una sua legittimità sul terreno filosofico: parlare delle idee come di raffigurazioni della realtà significa infatti sostenere che è lecito porre un nesso di raffigurazione tra una realtà nota ed una realtà ignota, tra ciò che è dato alla coscienza e ciò che invece la trascende. Si tratta, tuttavia, di una legittimità apparente e Locke non ci invita affatto a percorrere questo cammino. Tutt'altro: se le idee sono l'unico possibile oggetto della nostra mente e se non si vuole per questo rinunciare all'istanza realistica secondo la quale il mondo è qualcosa di più di ciò che è dato nell'immanenza, allora si deve negare da un canto che vi sia un nesso raffigurativo tra l'esperienza e il mondo per sostenere dall'altro che la relazione che lega le idee alle cose deve essere tale da poter sussistere anche al di là dell'orizzonte degli oggetti propriamente esperiti.
Di qui la via che Locke ci invita a seguire. Se le idee debbono parlarci di una realtà che è comunque sita al di là di ogni nostra possibile esperienza è necessario indicare una relazione che dalle idee ci conduca alle cose senza per questo presupporre l'appartenenza di queste ultime al nostro orizzonte cognitivo. Ora, sostenere che una data immagine è copia di qualcosa di ignoto significa evidentemente asserire un'assurdità: non si può raffigurare qualcosa se non se ne conosce in qualche modo l'aspetto. Diversa è la prospettiva se la relazione di cui si discorre è di natura causale: in questo caso, parlare di un evento e sostenere che deve esserci qualcosa che determina il suo esser così, anche se ignoriamo totalmente quale sia la natura non significa necessariamente sostenere un'assurdità. La causalità è una relazione reale: può sussistere tra due eventi anche se non sappiamo nulla sulla natura di uno di essi. Per Locke proprio così stanno le cose nel caso dell'esperienza sensibile: in quale modo gli oggetti esterni possano determinare gli eventi mentali e quale sia la natura della causa remota dei nostri vissuti non possiamo dirlo con sicurezza - possiamo al massimo avanzare ipotesi più o meno ragionevoli. Ciò non toglie tuttavia che per Locke sia comunque lecito interrogarsi sulla causa reale delle nostre esperienze, e questo proprio perché l'esperienza stessa si dà nel Saggio come un evento che deve il proprio esserci ad una qualche significativa alterazione degli interni equilibri del nostro corpo.
Su questo originario porsi dell'esperienza come un evento di cui rendere conto, Locke attira la nostra attenzione sin dalle primissime battute del suo libro: il percepire - si legge - non è una proprietà inalienabile della sostanza pensante, ma è la risposta cosciente all'agire non cosciente delle cose sulla soggettività. E come spesso accade in filosofia, questa prima mossa che il Saggio ci invita disinvoltamente a compiere per allontanarci dalle secche di una concezione innatistica ("it is past doubt that men have in their minds several ideas,- such as are those expressed by the words whiteness, hardness, sweetness, thinking, motion, man, elephant, army, drunkenness, and others: it is in the first place then to be inquired, How he comes by them?" (ivi, II, i, 1)) si rivela poi molto più impegnativa di quanto non saremmo disposti di primo acchito a credere, poiché nel porsi dell'indagine dell'esperienza sotto l'egida del concetto di origine, Locke scorge il cammino che deve essere battuto per attribuire alle nostre idee un rimando a ciò che sta di là da esse.
Locke ragiona così: le idee sono oggetti della mente; la mente, tuttavia, non è res cogitans, poiché in lei il percepire è una prassi che deve essere innescata. Di qui il porsi delle idee come effetti: le idee hanno un'origine che rimanda ad altro. Questo rimando, tuttavia, non è una caratteristica interna al contenuto delle idee che di per sé non ci conduce di là da esso: è piuttosto una relazione che si dà insieme al rapporto che lega le idee alla mente che le percepisce e che le coglie come accadimenti che necessitano di una causa. La funzione segnica delle idee non deriva dunque dalla forma in cui ci presentano i loro contenuti, ma dal modo in cui esse si danno alla coscienza: se le idee significano qualcosa è perché il loro darsi come effetti ci permette di considerarle come segni naturali delle loro cause obiettive. Così, anche se le idee non raffigurano le cose e sono prive di una loro interna intenzionalità, possiamo tuttavia considerarle come segni: il nesso causale diviene il fondamento di una possibile relazione di denotazione, scritta nelle cose stesse - nel legame causalistico che stringe gli oggetti mentali agli oggetti da cui derivano. Proprio in virtù della sua natura di evento, l'esperienza può così assumere la forma di un linguaggio naturale in cui le idee divengono segni delle cose.
Un esempio può forse aiutarci a comprendere meglio le cose. Vi è una legge fisica che pone una relazione precisa tra il volume, la pressione e la temperatura, ed è su questa legge che si fonda la possibilità di impiegare una colonnina di mercurio disposta su un'asta graduata come uno strumento capace di misurare la temperatura. Ora, nel suo salire e scendere, la colonnina di mercurio obbedisce ad una legge fisica, proprio come accade ad un corpo che cade o alla neve che si scioglie al calore del sole, e tuttavia così facendo il termometro ci dice qualcosa: il termometro parla della temperatura e ci dice quanti gradi ci sono nella stanza. Ora, non vi è dubbio che spesso ci esprimiamo proprio così: diciamo che il termometro segna la temperatura, che la bilancia indica il peso, che il metro ci dice quanto è lunga una stanza. E tuttavia è difficile liberarsi dall'impressione che tutte queste siano soltanto metafore. Il termometro semplicemente si comporta così, e così comportandosi misura la temperatura delle cose. Non vi è dubbio che qualcosa di analogo capiti anche nel caso della percezione: anche in questo caso, infatti, abbiamo a che fare con insieme di nessi causali che attribuiscono ai nostri vissuti la capacità di misurare il mondo e quindi, metaforicamente, di parlarcene.
Di parlarcene nelle forme di un linguaggio naturale: il nesso tra le idee e le loro cause trascendenti è arbitrario per ciò che concerne la relazione tra la forma del segno e la natura del designato, ma è invece naturale per ciò che concerne il porsi della relazione stessa che non deve essere quindi ricondotta ad un fare della soggettività cui non si chiede altro se non di riconoscerla come un'ipotesi la cui plausibilità è certo accresciuta dal nostro averla sposata sin dalla nascita. Di qui la peculiarità della posizione lockeana. Locke non ritiene che l'esperienza debba essere compresa alla luce del concetto di intenzionalità - non ci invita in altri termini a pensare che la coscienza sia innanzitutto coscienza di qualcosa e che si rivolga al proprio oggetto sia pure attraverso la mediazione fenomenica dei propri vissuti; ma non ci chiede nemmeno di pensare all'esperienza come ad una galleria di ritratti, di fronte ai quali l'io si sforzi di riconoscere l'eco del mondo reale, proiettando così i contenuti immanenti della coscienza sul terreno dell'essere. La prospettiva che il Saggio sull'intelletto umano ci invita a condividere è diversa: Locke ci chiede di riflettere sul fatto che ogni nostra esperienza sensibile deve avere una causa e che queste molteplici relazioni causali ci consentono di porre ipoteticamente una funzione che associ le idee a ciò da cui hanno origine, trasformandole così in nomi di un linguaggio naturale che ci parla del mondo in virtù di una teoria del riferimento che è dettata dalle regole stesse del mondo.
Ora, che il nesso di designazione dei nomi del linguaggio mentale riposi sul principio di causalità significa necessariamente riconoscere che tra l'esperienza e il suo oggetto trascendente vi è una relazione esterna e non necessaria: l'oggetto non si manifesta nelle scene percettive che viviamo più di quanto il fuoco non si mostri nella cenere e nel fumo che da esso traggono origine. Ma ciò è quanto dire che il nesso che attribuisce alle idee un significato è di natura empirica e che è in linea di principio possibile che le nostre idee restino le stesse e che il mondo muti: le leggi di natura potrebbero non essere ferree e possiamo immaginare un mondo diverso dal nostro che ci costringesse tuttavia ad una vita d'esperienza eguale a quella che oggi nel nostro mondo viviamo, - e ciò è quanto dire che lo scettico non può essere confutato, anche se le sue tesi appaiono a Locke del tutto futili. La questione scettica è, per Locke, una questione empirica che ha una risposta empirica: è sommamente improbabile che le nostre idee semplici non derivino secondo una regola determinata dagli oggetti che le originano, ed è quindi del tutto ragionevole considerare affidabile la relazione di rimando che dalle idee ci risospinge verso le cose.
Vi è tuttavia una seconda conseguenza implicita nella tesi secondo la quale le idee sono i nomi di un linguaggio naturale che ci parla a suo modo del modo esterno. Il linguaggio verbale è un linguaggio in cui i segni non stringono una relazione reale con gli oggetti significati, ma li denotano in virtù di un nesso ideale. Così, se i pochi suoni che compongono la parola "mano" ci permettono di designare questa parte del nostro corpo, ciò accade esclusivamente perché vi è una regola d'uso che vincola il nostro comune desiderio di parlare delle mani all'impiego di quei suoni. Una regola, tuttavia, implica una norma che proprio perché sgancia il nostro comportamento linguistico dalla fattualità dell'accadere crea insieme la possibilità dell'infrazione. Nel linguaggio posso mentire, e posso farlo perché non vi è nessuna necessità naturale che vincoli il gesto con cui mi esprimo a ciò che intendo esprimere. In un linguaggio naturale, invece, questa possibilità non sussiste: il fumo non può fingere la presenza del fuoco, e non può farlo perché non dice nulla sul fuoco ma c'è a causa del fuoco.
Di qui, da queste considerazioni volte a far luce sulla differenza tra segni verbali e segni naturali, si deve muovere per comprendere la ragione che spinge Locke a dare così poco credito ad uno degli argomenti che solitamente si legano ad una concezione mentalistica dell'esperienza percettiva: l'argomento che fa leva sulla possibilità di un dubbio radicale che abbia per tema il significato oggettivo della nostra esperienza. Quest'argomento appare con estrema chiarezza nelle pagine cartesiane: nelle sue Meditazioni Cartesio ci invita infatti a dubitare di tutto ciò che l'esperienza ci offre, e può farlo solo perché le idee sono a suo avviso raffigurazioni delle cose e possono quindi mentirci sull'aspetto del mondo esterno - un diavoletto maligno potrebbe aver fatto sì che ogni nostra idea ci illudesse sull'aspetto reale del mondo e perfino sul suo stesso esserci, proprio come un dipinto potrebbe ingannarci sull'esserci e sull'esser così del paesaggio che sembrerebbe raffigurare. Ma in Locke la prospettiva è mutata; nel Saggio il linguaggio delle idee non deriva la sua capacità denotativa da una relazione ideale, ma dalla realtà del nesso causale. La connessione tra le idee e il mondo non si fonda su una conformità che possa essere contraffatta, poiché di una conformità non è comunque lecito parlare: le idee non ci parlano del mondo ma sono segni della sua presenza. La possibilità dell'inganno con la sua tacita premessa di senso - l'ipotesi che il contenuto della nostra esperienza non sia conforme alla realtà che dovrebbe dischiuderci - deve apparire a Locke come una preoccupazione inutile che esaspera scetticamente un'ovvietà conclamata: non vi è nessun bisogno di temere le astuzie ingannatrici di un diavoletto che trami per aprire un varco tra le idee e le cose, ma questo non perché sia possibile fare affidamento su una qualche garanzia metafisica che ci rassicuri del fatto che la nostra natura umana è stata creata anche per conoscere, ma perché in generale si può senz'altro riconoscere che le idee non sono conformi alle cose, senza per questo dover rinunciare a considerarle segni naturali delle loro cause sensibili. Non sappiamo come le cose giungano a farsi idee e non possiamo quindi pretendere di scorgere nel contenuto intuitivo delle idee il contenuto reale di ciò che esperiamo: ma possiamo egualmente, almeno per Locke, tacitare il filosofo scettico e chiederci quale sia l'origine delle nostre idee, per risalire così lungo le catene dei nessi causali dai segni che possediamo agli oggetti da cui derivano e cui, proprio in virtù di questo nesso, alludono.
E tuttavia, proprio queste considerazioni che allontanano il dubbio scettico riconoscendo come ovvia una delle sue istanze ci costringe a porci una domanda nuova: dobbiamo chiederci infatti in che misura gli oggetti esterni possano farsi avanti nei segni naturali che la nostra mente possiede. E ciò è quanto dire che dobbiamo chiederci in che misura il nesso di causalità può permetterci di dire qualcosa sulle cause a partire dalla conoscenza degli effetti.
1. Nella lezione precedente ci eravamo soffermati su un tema importante: avevamo osservato infatti come, in Locke, la tesi del carattere mentalistico delle idee potesse legarsi alla convinzione secondo la quale l'esperienza ci parla infine degli oggetti del mondo esterno, e ce ne parla in virtù di quel varco che nella dimensione immanente si apre non appena ci costringiamo a pensare alle idee come effetti che presuppongono una causa, come segni naturali che ci riconducono alla loro origine sensibile - a ciò che determina il processo percettivo da cui hanno origine.
E tuttavia, proprio queste considerazioni e il loro rapporto con il dubbio scettico ci avevano spinto a formulare una domanda che Locke non formula esplicitamente, ma che determina in profondità la struttura teorica del Saggio sull'intelletto umano: dobbiamo chiederci infatti in che misura gli oggetti esterni possano farsi avanti nei segni naturali che la nostra mente possiede, una volta che si sia appurato che ciò che fa delle idee segni della realtà è la relazione causale da cui derivano. Perché questo balza agli occhi: se le idee sensibili fossero raffigurazioni degli oggetti esterni potremmo dire, contemplandole, molte più cose sulla loro natura di quello che può asserire chi, come Locke, sostiene che l'esperienza ci offre soltanto una sequenza di segni, privi di qualsiasi necessario valore iconico.
Locke risponde alla domanda che abbiamo appena formulato introducendo una nozione particolare - la nozione di "power" - cui spetta il compito di circoscrivere i limiti entro cui è lecito parlare degli oggetti esterni. Locke si esprime così:
Whatsoever the mind perceives in itself, or is the immediate object of perception, thought, or understanding, that I call idea; and the power to produce any idea in our mind, I call quality of the subject wherein that power is. Thus a snowball having the power to produce in us the ideas of white, cold, and round,- the power to produce those ideas in us, as they are in the snowball, I call qualities; and as they are sensations or perceptions in our understandings, I call them ideas; which ideas, if I speak of sometimes as in the things themselves, I would be understood to mean those qualities in the objects which produce them in us (ivi, II, viii, 8).
Di fronte ad una simile affermazione si può forse rimanere perplessi, perché non può non destare qualche stupore il gesto di chi in poche righe richiama la nostra attenzione su tre differenti modi di intendere che cosa sia l'oggetto della nostra esperienza, per poi avvisarci che a queste sottili distinzioni concettuali si atterrà ben poco e che parlerà liberamente di idee anche là dove sarebbe meglio non farlo. E lo stupore può facilmente tradursi nella convinzione che una simile distinzione non sia poi tanto importante quando ci si accorge che sono già sufficienti due righe perché Locke non si preoccupi più di essere coerente con le scelte terminologiche che quella distinzione impone e si esprime come più gli piace, disponendosi preferibilmente sul terreno del linguaggio psicologico delle idee.
Non penso che questa convinzione sia davvero fondata e credo che l'apparente disinteresse lockeano per le scelte terminologiche che le sue stesse distinzioni concettuali impongono abbia una ragione su cui è necessario riflettere e che si dispiega non appena facciamo effettivamente luce sul significato della distinzione che Locke ci propone - una distinzione meno facile da comprendere di quello che ad un primo sguardo potrebbe sembrare.
In questa definizione vi è innanzitutto un primo punto fermo: Locke ci invita a sostenere che vi è un oggetto immediato della percezione, e che questo oggetto sono le idee. Ora, sostenere che le idee sono l'oggetto immediato dell'intelletto non significa null'altro se non questo: l'unica cosa di cui siamo consapevoli sono le idee ed è per questo che possiamo parlarne come degli oggetti con cui propriamente ha a che fare la nostra vita di coscienza. Su questo punto ci siamo già soffermati, e del resto le pagine del Saggio non lasciano spazio ad equivoci: le idee non sono di per sé caratterizzate dal rimando intenzionale ad una realtà che le superi, e chi volesse cercare in questo rimando all'immediatezza delle idee una testimonianza della presenza di un oggetto fenomenologicamente mediato - di un oggetto che si dia attraverso la sintesi di molteplici manifestazioni fenomeniche - fraintenderebbe di fatto il senso delle indagini lockeane che ci invitano a considerare le idee come l'unico oggetto di cui abbiamo esperienza.
Ma se di un oggetto fenomenologicamente mediato non è lecito parlare, ciò non toglie tuttavia che dall'immediatezza delle idee si possa muovere per porre in modo indiretto e relazionale l'esistenza di oggetti che fungano da causa dei nostri vissuti. E ciò che legittima questa mossa ci è ormai ben noto: di per sé le idee non hanno una funzione denotativa, ma ciò non toglie che l'esperienza si ponga nel suo senso descrittivo come un effetto che ci invita a cercare una causa trascendente - almeno questo è ciò che Locke sostiene. Così, anche se non vi è una relazione interna tra le idee e le cose, le une possono stare per le altre in virtù di una relazione esterna, di un nesso causale che è dato nel carattere involontario e passivo di ogni nostro percepire.
Di qui la chiave che ci permette di addentrarci nel significato delle distinzioni che Locke ci propone. Locke lega tra loro tre differenti concetti: ci parla di idee, di qualità e di poteri e li pone, come abbiamo visto in questa relazione:
the power to produce any idea in our mind, I call quality of the subject wherein that power is (ivi, II, iii, 8).
Innanzitutto vi sono le nostre idee che sono poi ciò che percepiamo e di cui siamo coscienti. Ciò che percepiamo - la palla di neve rotonda, bianca e fredda dell'esempio - si scandisce innanzitutto in una serie di termini del nostro linguaggio mentale (le idee del bianco, del freddo, della rotondità, ecc.), ma ci dice anche, in secondo luogo, qualcosa dell'oggetto che causa in noi quelle sensazioni: ci dice appunto che esso è tale da determinare in noi proprio quelle sensazioni che proviamo. Ora, questa descrizione è certamente di natura relazionale: descriviamo l'oggetto non in se stesso, ma a partire dalla relazione che stringe con l'io. Dire che la neve è tale da sembrarci bianca non significa proporre una proprietà assoluta della neve, ma una proprietà relazionale, proprio come accade quando ci riferiamo ad una persona indicandola attraverso la relazione di parentela che la stringe a noi. Così quando diciamo che la palla di neve è bianca diciamo, secondo Locke, qualcosa di simile a ciò che asseriamo quando di una persona determinata diciamo che è nostro fratello: in entrambi i casi qualcosa è denotato attraverso una proprietà che implica il rapporto che stringo con essa.
E tuttavia nel caso della situazione percettiva su cui Locke ci invita a riflettere vi è di più. Quando diciamo che la palla di neve è fredda non diciamo soltanto che è tale per me, ma asseriamo qualcosa di simile ad un periodo ipotetico che potremmo formulare così: in circostanze normali, se tocco la palla di neve (ed ogni volta che la tocco) avverto una sensazione di freddo. E ciò è quanto dire che la neve ha la capacità - il potere, appunto - di destare in una normale soggettività percipiente la sensazione del freddo. Possiamo allora trarre una prima conclusione: nella soggettività vi sono soltanto le idee, ma ciononostante degli oggetti sensibili qualcosa sappiamo - conosciamo una loro capacità, quella capacità che si dispiega interamente nel saper ridestare in un soggetto percipiente normale ed in circostanze normali un'idea determinata.
Ora, questa capacità è colta a partire dalla mia reazione soggettiva: dal mio percepire così. Sarebbe tuttavia un errore credere che ciò cui propriamente si allude sia in questo caso qualcosa di soggettivo. Tutt'altro: il potere di apparirmi così è, per Locke, una proprietà obiettiva, poiché in questo caso la soggettività è chiamata in causa esclusivamente come un reagente ad uno stato di cose obiettivo. Dire che la neve ha la capacità di apparirmi bianca non vuol dire altro se non che è tale da suscitare in un soggetto fatto come me una determinata reazione psicologica che in questo caso non vale esclusivamente per il suo contenuto epistemico ma anche come un evento che, in virtù di una determinata relazione causale, attesta l'esser così dello stato di cose agente. Ancora una volta l'esempio del termometro ci può essere utile poiché il mio percepire il bianco quando osservo la neve non è diverso dall'espandersi del mercurio nella colonnina: entrambi sono eventi che ci parlano di una proprietà delle cose - quella che altera il loro stato.
Di qui la conclusione cui Locke intende giungere: a partire da ciò di cui sono consapevole, e quindi a partire dal terreno meramente soggettivo del cogito, è possibile muovere per indicare una determinazione obiettiva di ciò che percepiamo - il suo essere tale da apparire così alla soggettività. Guardo la neve e la vedo bianca, ma questa idea che avverto nella coscienza è anche un segno del fatto che la neve ha la qualità di apparirmi così: i vissuti della coscienza diventano così le lancette di uno strumento di rilevazione che ha rispetto agli altri strumenti una sola peculiarità - è uno strumento che sa leggersi da solo. Si tratta di una caratteristica importante e Locke non sarebbe disposto a seguire le tesi di chi ritiene possibile mettere da parte il concetto di consapevolezza per ricondurre la dimensione dell'esperienza ad un meccanismo che faccia seguire determinati comportamenti alle alterazioni dell'ambiente esterno. E tuttavia è comunque opportuno osservare che la dimensione del cogito assume in Locke una forma particolare: la dimensione intenzionale concerne esclusivamente il legame della coscienza con le idee che vi accadono, non il nesso tra le idee e le cose che queste denotano. Ciò che propriamente esperiamo - i colori, i suoni, il freddo, il caldo, ecc. - non mostrano come il mondo è, ma sono soltanto le diverse posizioni dell'indicatore di quel peculiare strumento di rilevazione degli oggetti esterni che è la nostra coscienza.
Dovremo in seguito soffermarci su alcune importanti considerazioni del Saggio, in cui Locke cerca di circoscrivere la portata di queste conclusioni. E tuttavia, piuttosto che anticipare ora ciò che Locke ha da dirci a proposito della distinzione tra qualità primarie e qualità secondarie, è forse opportuno osservare quanto lontana dalle tesi implicite nella grammatica del linguaggio ordinario sia la posizione cui la filosofia della percezione del Saggio sull'intelletto umano infine approda. Noi normalmente parliamo del nostro vedere le cose che ci circondano e non avremmo dubbi nel dire che sono gli oggetti che si manifestano sensibilmente secondo aspetti di volta in volta differenti. Ora abbasso lo sguardo e vedo il dorso delle mie mani sulla tastiera, ora piego la testa e le vedo diversamente, perché mi mostrano un diverso profilo: al mutare del punto di vista mutano gli aspetti che la cosa ci mostra e mutano insieme anche i modi della sua manifestazione - vedo un'identica cosa ma imparo da ogni fase percettiva qualcosa di più sul suo aspetto complessivo. E ciò che è vero nel caso di una percezione concordante vale anche quando l'esperienza ci costringe a correggere la nostra prima impressione, e ci mostra che ciò che credevamo una persona nella nebbia è in realtà un arbusto: anche qui le scene percettive ci mostrano qualcosa, che si definisce per quello che è solo nel senso complessivo che il decorso percettivo assume per noi.
Potremmo naturalmente dire molte altre cose su questo tema, ma ciò che ora ci interessa è soltanto osservare come per tutto questo complesso sistema di distinzioni concettuali nelle pagine del Saggio non vi sia posto: nelle scene percettive gli oggetti non si manifestano, ed in generale non ha senso per Locke parlare dell'esperienza come del luogo in cui le cose si mostrano alla soggettività, poiché in senso proprio un mostrare non ha affatto luogo. Percepire qualcosa non significa cogliere l'oggetto così come si manifesta, ma solo divenire consapevoli di una molteplicità di eventi mentali che ci riconducono di là da essi in virtù di una relazione causale che trasforma gli effetti in segni e le cause prime in designati.
2. Le considerazioni che abbiamo appena proposto ci hanno mostrato come le idee sensibili possano diventare segni delle cose da cui traggono origine, rinunciando così ad attribuire una funzione rappresentativa a ciò che in esse si presenta. Ma ciò è quanto dire che nel Saggio sull'intelletto umano le idee hanno una duplice valenza: da un lato le idee sono vissuti che si dispiegano nella loro dimensione intuitiva nella coscienza, dall'altro sono segni che rimandano oscuramente ad una causa. Venire a capo della duplice valenza delle idee vorrà dire allora comprenderle sia nella loro natura presentativa, sia nella loro funzione di segni.
Un esempio può forse aiutarci a comprendere meglio le cose: per Locke, chi dice che la neve è bianca propone un'asserzione che è del tutto simile a quella racchiusa in una proposizione come "l'arsenico è velenoso", poiché "bianco" proprio come "velenoso" sono termini che denotano la proprietà di un oggetto attraverso il modo in cui si dispiega per la soggettività. Possiamo ignorare quale sia la natura dell'arsenico o della bianchezza, ma almeno questo lo sappiamo: siamo certi che l'uno abbia la capacità di avvelenare chi ne assume anche una piccola quantità, mentre l'altra sia tale da destare in noi proprio la sensazione del bianco. E ciò che vale in questo caso, è vero anche per ogni altro termine che alluda ad una capacità e che quindi celi nel suo senso il rimando ad una trama di condizionali che ci permette di cogliere la cosa nella misura in cui si manifesta in un determinato comportamento.
Su questo punto è necessario soffermarsi un poco. Dire di un cibo che è velenoso significa indicarne una proprietà potenziale: di un fungo diciamo che è velenoso perché può farci star male in circostanze in cui altri cibi non ci creerebbero un analogo fastidio. La peculiarità dell'essere velenosi è tutta qui: ad essere velenoso è il fungo (e cioè qualcosa che c'è e che ha certe caratteristiche indipendentemente dalle svariate occasioni in cui entra in contatto con noi), e tuttavia la tossicità è una sua caratteristica che si dimostra soltanto in circostanze determinate - quelle circostanze sfortunate in cui ci si rivela che la composizione chimica di un certo fungo ci impedisce di assimilarlo senza problemi. Una amanita falloide è fatta in un certo modo, ma che sia velenosa lo impariamo sempre a nostre spese, quando per sbaglio la mangiamo. E non a caso: termini come "velenoso" o "fragile" ci parlano comunque di una relazione, anche se di fatto ce ne avvaliamo anche per indicare una proprietà delle cose, sia pure conosciuta solo obliquamente. Così dire di qualcosa che è velenosa significa sempre asserire due cose in una: da un lato indichiamo qualcosa che appartiene alla natura dell'oggetto, dall'altro la cogliamo solo attraverso un determinato nesso relazionale e potenziale. Il risultato è inscritto nel senso d'uso di questo termine: un fungo velenoso è velenoso anche quando se ne sta beato nel bosco, anche se qualcosa è un veleno soltanto in certe circostanze e soltanto per chi è sensibile alle sue tossine.
Ora, lo stesso ordine di considerazioni vale quando ci poniamo sul terreno di quei condizionali che sono chiamati in causa dalla percezione sensibile. Anche in questo caso asserire che la neve è bianca significa in primo luogo dire che ha il potere di apparirci così (o se si vuole: di suscitare in noi proprio questa idea); ma il potere che così si manifesta è interamente ed esclusivamente determinato dalla relazione in cui si esplica. Così, proprio come la fragilità è una determinazione di cui ha senso chiedere il fondamento ma che è, in quanto disposizione, interamente data nel nesso che la lega condizionalmente a determinate circostanze e a determinati eventi, allo stesso modo i poteri di cui Locke ci parla sono sì nelle cose, ma si danno esclusivamente nel nesso che li lega al sorgere di determinate sensazioni nella soggettività percipiente.
Possiamo trarre una prima, impegnativa conclusione: l'esperienza ci dice qualcosa dell'oggetto, ma solo in quanto è oggetto per noi.
Di fronte ad un'affermazione così filosofica è forse opportuno tornare ai nostri funghi. Una cosa è velenosa perché contiene certe sostanze che impediscono certe funzioni vitali; dire che è tossica, tuttavia, non significa ancora dire come sia fatta, ma soltanto indicare un suo comportamento che è insieme indice di una proprietà di cui soltanto questo sappiamo - che è causa del comportarsi così di molte cose come i funghi o le domande agli esami. La tesi di Locke è che ciò valga anche per le nostre percezioni: dire della neve che è bianca non significa ancora dire come sia fatta, ma soltanto indicare che deve essere fatta in un modo che a noi si manifesta soltanto nel suo essere causa in circostanze normali di una determinata reazione percettiva.
Ora, abbiamo più volte osservato che la sfera della nostra esperienza coincide con le idee che abbiamo: in senso proprio abbiamo esperienza soltanto delle nostre idee. Ma ciò è quanto dire che l'apparire bianco della neve non è una delle caratterizzazioni, tra le altre possibili, di quel qualcosa che ha il potere di apparirmi così, ma è l'unica possibile descrizione che di quel momento oggettivo possiamo effettivamente dare sulla base della nostra esperienza. Per definire il potere della neve di apparire bianca in condizioni normali ad un normale soggetto senziente non vi è altro possibile modo se non quello di indicare l'idea che avvertiamo, il cui nome diviene così il mezzo che ci permette di denotare, insieme al calco, la forma che vi si è impressa.
Sin qui ci siamo soffermati sulla distinzione tra le idee che sono nella mente e i poteri che sono nelle cose stesse, ma le considerazioni che abbiamo proposto ci hanno mostrato come sia necessario articolare ulteriormente questa distinzione, proprio come Locke ci propone di fare quando alle idee e ai poteri affianca le qualità sensibili, in una proposizione che vale la pena di rileggere perché è tanto oscura da spingerci a dubitare persino della sua struttura grammaticale.
Leggiamola:
Thus a snowball having the power to produce in us the ideas of white, cold, and round,- the power to produce those ideas in us, as they are in the snowball, I call qualities (ivi).
Qui vorremmo correggere qualcosa: ci attenderemmo infatti che la clausola finale si chiudesse con il singolare proprio come con il singolare si apre: se così fosse sarebbe ben chiaro che cosa Locke ci propone di chiamare qualità. E invece il singolare non c'è (Locke scrive "as they are in the snowball"), e questo ci costringe a riflettere un poco. Un punto è chiaro: le qualità sensibili appartengono all'oggetto e debbono quindi ricondurci sul terreno dei poteri della cosa e non sul piano meramente soggettivo delle idee. Chiamiamo dunque qualità (P) di un oggetto sensibile (T) il potere che è in (T) di suscitare in circostanze normali in un soggetto senziente (S) un'idea (p). E tuttavia Locke non si ferma qui e non ci propone semplicemente di identificare qualità sensibili e potere, e questo perché quando parliamo di una qualità di un oggetto non ci limitiamo ad indicare una sua proprietà disposizionale: dire di (T) che è (P) non significa soltanto asserire che (T) determina in (S) l'idea (p), ma vuol dire appunto sostenere che è tale da avere, tra l'altro, il potere di suscitare in (S) quell'idea. Dal potere come capacità di suscitare nel soggetto percipiente una determinata sensazione si deve allora distinguere la qualità sensibile come fondamento su cui poggia quel potere. Lo abbiamo già detto: dire, per esempio, che il vetro è fragile significa in primo luogo asserire che si romperà se si daranno le condizioni c1...cn. Della fragilità, tuttavia, si può in linea di principio rendere conto: si può in altri termini dire che un calice di cristallo è fragile perché è fatto così e così. Ora, il fondamento di una determinata proprietà disposizionale può essere noto: possiamo dire che un calice di cristallo è molto sottile e che il vetro è un materiale le cui parti sono tenute insieme da un certo tipo di legami, per concludere poi che questa è la ragione per cui tra le altre cose un calice è fragile. Ma potremmo trovarci anche in una situazione del tutto diversa: potremmo ignorare quali siano le ragioni per cui il condizionale della fragilità si realizza costantemente ed in questo caso la parola "fragilità" sarebbe l'unico nome che avremmo a disposizione per indicare la causa occulta che spiega il comportamento dei calici di cristallo.
Credo che proprio questa sia la situazione in cui, per Locke, ci troviamo quando abbiamo a che fare con l'esperienza percettiva. Percepire significa avere determinate idee; le idee parlano in nome di un potere insito nelle cose: il potere di farci percepire così in circostanze determinate. Ma dietro ogni potere deve esserci una qualità, un esser così dell'oggetto che determini il suo comportarsi in un certo modo: se la neve ci appare fredda è perché è tale da apparirci fredda. Vale anche qui una regola di carattere generale: se un oggetto sa esercitare una determinata azione in circostanze date - se in altri termini ha un qualche potere - allora vi è, in linea di principio, una qualità che spetta alla cosa e che è all'origine del modo in cui concretamente agisce. Ancora una volta: se la neve ci appare fredda è perché ha il potere di suscitare in noi l'idea del freddo, ma se ha un simile potere è perché la sua natura è tale da giustificare il suo agire così sui nostri organi di senso. Dietro ad ogni proprietà relativo-condizionale Locke tende così a porre una proprietà assoluta, radicata nella natura stessa delle cose.
E tuttavia quale sia questa natura e quali siano le qualità sensibili che giustificano e fondano il nesso condizionale che lega l'oggetto al suo apparirci così non ci è dato saperlo e ciò significa che le qualità dell'oggetto e la sua interna natura si pongono come una forma vuota cui la nostra esperienza necessariamente allude, come il referente ultimo della nostra esperienza, di cui tuttavia possiamo parlare soltanto attraverso il linguaggio mentale delle idee. E ciò è quanto dire che la prospettiva causalistica dell'esperienza così come Locke la formula ci consente da un lato di riconoscere che le idee indicano un universo di cose che stanno di là da esse, ma ci vieta dall'altro di parlarne se non disponendosi in un linguaggio insuperabilmente mentalistico.
Di qui l'equivocità della nozione di qualità sensibile che nelle pagine del Saggio oscilla tra tre differenti significati che rimandano a tre differenti modi in cui la parola "sensibile" può legarsi alla parola "qualità". Quali siano queste tre diverse modalità è presto detto. Un aggettivo ha normalmente una funzione determinante: il mare può essere calmo o burrascoso, e "il mare è calmo" o "il mare è burrascoso" sono espressioni che ci dicono qualcosa del mare - ci dicono quale sia lo stato attuale del suo moto ondoso. Ma le cose non stanno sempre così: un aggettivo può avere anche una funzione limitante. Se dico che il mare burrascoso è pericoloso non asserisco qualcosa del mare ma dico quale tra i mari possibili è pericoloso. Ma vi è una terza possibilità: se dico di qualcuno che è un falso magro, non dico affatto che è una persona magra che, tra le altre sue qualità, è anche falsa. Ciò che dico è che quella persona non è affatto magra, a dispetto delle apparenze: l'aggettivo, in questo caso, non determina né limita, ma modifica il significato del nome cui si applica. Anche la parola "sensibile" gioca su questi tre significati: dire di una qualità che è una qualità sensibile può significare per Locke sia che è una proprietà obiettiva che, tra le altre cose, può essere di fatto percepita, sia che essa è una certa proprietà che è colta soltanto in quanto è percepita da noi, sia infine che essa si dispiega soltanto nell'universo psicologico e soggettivo della mente. Le qualità sensibili sono allora nell'ordine le proprietà assolute degli oggetti, le proprietà degli oggetti in quanto sono da noi percepiti e infine anche gli oggetti mentali - le idee.
Ora, di questa equivocità Locke è consapevole, ma ritiene che sia comunque necessario avvalersene, poiché l'unico modo per parlare delle qualità degli oggetti passa attraverso l'indicazione di un qualche vissuto soggettivo. Su questo punto ci siamo già soffermati: l'importanza che il Saggio attribuisce alla nozione di "power" si muove appunto in questa direzione. E tuttavia le qualità non sono poteri e non possono essere semplicemente intese alludendo ad una qualche relazione con la soggettività. Poco fa avevamo osservato che vi è un senso in cui, per Locke, la parola "bianco" è analoga alla parola "velenoso": il nome di quell'idea di colore sembra infatti ricondurci ad un potere insito nella cosa, ad una sua capacità di modificarci in un senso determinato. Si tratta di una tesi sensata, ma sicuramente molto lontana dal linguaggio quotidiano poiché quando dico che la neve è fredda non voglio soltanto asserire che mi apparirebbe così in circostanze normali, ma intendo affermare che la neve in se stessa ha proprio questa caratteristica: di essere fredda. Ora, Locke non è disposto a dare pienamente ascolto alla grammatica del linguaggio: la neve non è fredda o bianca in se stessa, ma lo è solo per chi reagisce sensibilmente così alla natura reale di quella sostanza. E tuttavia in quell'uso linguistico qualcosa di legittimo vi è, ed è il soggetto della predicazione e il referente ultimo della proprietà predicata. Quando diciamo che la neve è fredda pronunciamo un giudizio che dipende nella sua forma dalla nostra natura, ma ciò che intendiamo affermare - sia pure con mezzi inadeguati - è qualcosa che concerne esclusivamente la neve. Di qui la mossa che Locke ci invita a compiere: la limitatezza del nostro orizzonte cognitivo, il suo essere rinchiuso al di qua delle cose che sono ci costringe a percorrere consapevolmente l'ambiguità insita nel concetto di qualità sensibile e a fare dei nomi che stanno per le idee il mezzo per denotare le qualità delle cose. Il sensibile immanente diviene nome del sensibile trascendente.
Ne segue che se talvolta Locke ci parla delle idee come se fossero nelle cose non è soltanto per sciatteria o per comodità di linguaggio, ma per una ragione più profonda: è perché di fatto quando parliamo di una qualità delle cose non possiamo che intenderla alla luce della sua eco soggettiva, e ciò è quanto dire che la pienezza intuitiva che si lega alle qualità sensibili (nel senso modificante del termine) è la forma soggettiva attraverso la quale diviene possibile denotare le qualità sensibili (nell'accezione determinante del termine).
Su questo tema dovremo in seguito ritornare, quando finalmente avvieremo le nostre considerazioni di natura critica. E tuttavia è forse opportuno fin d'ora richiamare l'attenzione su di un aspetto del problema che è tutt'altro che pacifico e ovvio: Locke ci invita a considerare che i nomi delle idee abbiano come loro ultimo referente gli oggetti che delle idee sono causa. Questa tesi sembra trovare la sua prima giustificazione proprio sul piano descrittivo, e le riflessioni che abbiamo dedicato alle ragioni che ci guidano quando asseriamo che la neve è fredda lo mostrano con sufficiente chiarezza. Ma le cose sono più complesse. Si può davvero dire che il rosso è un'ampiezza d'onda di circa 400 nanometri? La parola "rosso" denota davvero questo?
1. Le riflessioni che abbiamo appena proposto ci hanno permesso di far luce sul modo in cui, per Locke, si pone la relazione tra le nostre idee sensibili e gli oggetti esterni. Questa relazione si fonda su un nesso di natura causale e giustifica il rimando dalle idee alle qualità degli oggetti, anche se di fatto il modo in cui questo nesso si pone ci permette di affermare soltanto questo: che le nostre idee denotano qualcosa e che parlando di esse intendiamo parlare delle qualità degli oggetti esterni che sono quindi esperiti, sia pure soltanto come ciò che è all'origine del nostro percepire così.
Che di fatto per Locke le cose stiano in questo modo lo si può desumere richiamando vari passi del Saggio che ci invitano a riflettere ora sulla natura del linguaggio, ora sulla forma della conoscenza. Per ciò che concerne il linguaggio, la prospettiva lockeana ci costringe ancora una volta a legare in unico nodo la dimensione delle idee e la dimensione delle cose, poiché ogni nome contiene un duplice rimando denotativo: da un lato è il nome di un'idea che abbiamo, dall'altro sta per l'oggetto che deve averla causata. Anzi, nel caso del linguaggio il quadro è ancora più ambiguo, poiché dobbiamo rammentare che le parole stanno per le idee di chi parla, anche se si deve supporre che possano essere segni anche di ciò che passa nella mente di chi ascolta: se ciò non accadesse il linguaggio avrebbe una funzione denotativa, ma sarebbe privo di una funzione pragmatica. Le parole del linguaggio si rivelano così nel loro triplice modo di essere segni:
though words, as they are used by men, can properly and immediately signify nothing but the ideas that are in the mind of the speaker; yet they in their thoughts give them a secret reference to two other things. First, They suppose their words to be marks of the ideas in the minds also of other men, with whom they communicate: for else they should talk in vain, and could not be understood, if the sounds they applied to one idea were such as by the hearer were applied to another, which is to speak two languages. But in this men stand not usually to examine, whether the idea they, and those they discourse with have in their minds be the same: but think it enough that they use the word, as they imagine, in the common acceptation of that language; in which they suppose that the idea they make it a sign of is precisely the same to which the understanding men of that country apply that name. Secondly, Because men would not be thought to talk barely of their own imagination, but of things as really they are; therefore they often suppose the words to stand also for the reality of things (ivi, III, ii, 4-5).
Le parole sono innanzitutto segni delle (nostre) idee, ma dobbiamo egualmente pensare che si riferiscano agli oggetti esterni. Questa richiesta fa tutt'uno con la logica del comunicare: nessuna intende alludere alle proprie reazioni sensibili quando parla degli oggetti che lo attorniano ed intorno a cui ruota l'esistenza sua e degli altri.
E ciò che vale sul piano linguistico si ripresenta anche sul terreno della conoscenza che, per Locke, è concordanza tra idee e si muove quindi all'interno della prospettiva mentalistica. Il conoscere si muove sul terreno dell'evidenza: la prassi conoscitiva deve quindi poter fare affidamento sulla dimensione intuitiva e presentativa delle singole idee. Ciò non toglie tuttavia che il conoscere debba potersi distinguere dalla mera fantasticheria: la conoscenza deve essere conoscenza obiettiva e deve fondarsi sulla percezione delle cose che ci circondano. Di qui la specificità della posizione di Locke che pone sì la conoscenza nell'ambito delle relazioni tra idee, ma si sforza poi di porre sotto questo stesso titolo anche quel peculiare nesso che lega le idee della percezione all'esistenza reale e che ci permette quindi di sostenere che i nostri atti percettivi non sono momenti di un sogno coerente, ma ci parlano invece delle cose del mondo. Lo spazio della sensatezza circoscritto dal nostro intelletto - lo spazio presentativo delle idee nella loro determinatezza qualitativa - si riferisce quindi a qualcosa che c'è, ma di cui non possiamo dire nulla senza con questo abbandonare il terreno della conoscenza certa ed avventurarci sul piano delle ipotesi.
Non vi è dubbio che in questa distinzione, così come Locke la propone, sia possibile scorgere un aspetto che appartiene davvero alla logica del conoscere: una (ragionevole) analisi del processo conoscitivo deve infatti presupporre che vi sia una differenza tra ciò che sappiamo della cosa e la cosa che intendiamo conoscere, poiché è su questo scarto che poggia la possibilità di un approfondimento conoscitivo. Dall'oggetto percepito in quanto tale - dall'oggetto così come si dà nell'idea che ne abbiamo - si deve distinguere dunque l'oggetto in sé, il referente ultimo delle nostre idee. Il conoscere presuppone questa distinzione, proprio per la sua interna processualità; e tuttavia non è difficile scorgere come in Locke distinguere tra l'idea che si dà all'intelletto e l'oggetto in sé voglia dire alludere ad una frattura ontologica e gnoseologica, poiché se ci si dispone nella prospettiva del Saggio si deve riconoscere che vi è una soluzione di continuità tra ciò che è manifesto nella coscienza e ciò cui le idee si riferiscono, proprio come non vi è un percorso possibile tra la natura presentativa delle idee e il rimando cieco che dall'idea come effetto ci spinge verso un oggetto non ulteriormente noto che funge da causa.
Dovremo in seguito ritornare su quest'ordine di problemi, per mostrare la complessità e, credo, la contraddittorietà implicita nella prospettiva che abbiamo dianzi delineato. Ora, vorremmo invece osservare come, a partire di qui, si possa tentare di delineare uno schema astratto di quel complesso di argomentazioni che nel Saggio cerca di rendere conto dei molteplici significati in cui si può parlare di oggetto della nostra esperienza.
Il punto di partenza ci è noto. Il nesso di causalità attribuisce alle idee, che di per sé sono prive di una valenza raffigurativa, una funzione denotativa che permette loro di guadagnare un referente obiettivo: le idee stanno per le cose del mondo.
Questo nesso, tuttavia, ci è noto soltanto nel suo esserci e non nel come del suo realizzarsi: non sappiamo quale sia la regola che traduce il movimento reale (la causa obiettiva) nell'evento mentale che lo rende leggibile per la coscienza e questa lacuna conoscitiva non può essere colmata, poiché non vi è - per Locke - una transizione possibile dalla concatenazione fisica dei processi alla loro manifestazione cosciente. Così l'unica cosa che sappiamo del nesso causale che è all'origine della nostra esperienza è il suo esserci, e ciò è quanto dire che il rimando causalistico guadagna una relazione tra idee e cose, ma non ci consente in alcun modo di determinare queste a partire da quelle. Lo abbiamo già detto: le idee non sono raffigurazioni ma segni delle cose, e ciò significa che per ogni idea è possibile proiettare sul terreno dell'essere un punto origine, di cui non è possibile dare una descrizione ulteriore.
Così:
Idea
→
Punto obiettivo
Certo, sostenere che ogni sensazione ha una causa significa di fatto garantire la funzione denotativa delle idee; tuttavia se non si vuole ridurre la sfera obiettiva ad una serie di incognite su cui nulla si può dire se non che sono l'origine presunta di certe sensazioni, è necessario credere che i segni dell'esperienza siano in grado se non di raffigurare le cose esterne, almeno di tracciarne una rappresentazione formale.
Ne segue che se l'esperienza deve poter assumere la forma di un linguaggio che ci parla della realtà non basta la relazione che lega i nostri stati sensibili alla loro causa: è anche necessario che le percezioni, nella loro infinita varietà, si raccordino secondo certe regole, e che queste regole a loro volta possano essere intese come se ci parlassero delle leggi che connettono tra loro i punti obiettivi nella loro trascendenza. In altri termini: perché la denotazione possa assumere una direzione determinata, il segno sensibile deve entrare a far parte di una relazione sintattica, cui si chiede di instaurare quella dimensione rappresentativa che le percezioni di per se stesse non possono avere. Una percezione non deve necessariamente essere simile a una cosa e non è in senso proprio un'immagine di una realtà che la trascenda. Ma se la determinatezza qualitativa del sensibile nella sua specificità nega alle percezioni una funzione figurativa nei confronti del reale, la regola che ci permette di comprendere il loro occorrere e il loro ordinato susseguirsi può, nel suo essere libera da ogni determinazione qualitativa, rappresentare una legge che abbia valore oggettivo e che ci parli quindi di un mondo extra-sensibile. Locke sembra, in altri termini, ragionare così: proprio come i segni sul pentagramma non hanno una qualche comunanza qualitativa con il brano musicale che in essi si trascrive ma possono egualmente rappresentarlo perché l'accadere dei segni sul foglio avviene secondo una disposizione strutturalmente analoga alla disposizione dei suoni in un brano, così l'accadere delle idee nella coscienza non può permetterci di sostenere che il mondo sia ricco di colori e di suoni, ma ci fa egualmente conoscere qualcosa - quella disposizione dei punti obiettivi del mondo che è causa della configurazione delle nostre idee coscienti. Il fondamento obiettivo della nostra esperienza si fonda così sul porsi della coscienza come un pentagramma in cui le configurazioni di idee ci parlano di una impercettibile armonia mundi. Allo schema che lega un punto sensibile ad un punto obiettivo dobbiamo affiancare ora uno schema più complesso che faccia corrispondere l'una all'altra la sintassi dei vissuti alla sintassi degli enti:
Certo, l'analogia con il pentagramma non può essere presa alla lettera e non è difficile cogliere dove il paragone zoppica. Guardo le note sul pentagramma e seguo sullo spartito un determinato movimento musicale, e il mio poter leggere questo in quelle riposa sulla possibilità di mostrare segni e suoni nella loro relazione reciproca. Il maestro di musica può costringerci ad imparare dei nomi (do, re, mi fa, ecc.), e può invitarci a ripetere più volte la cantilena del loro succedersi, ma questo addestramento mnemonico deve infine legarsi ad un qualche esercizio al pianoforte: la tiritera delle note deve diventare melodia o canto e il loro ordinato succedersi deve assumere la forma percettiva della scala, poiché solo così diviene possibile imparare la regola proiettiva che ci permette di leggere nei segni sul pentagramma la musica che ascoltiamo.
È appena il caso di osservare che nel caso della coscienza percettiva le cose stanno diversamente: se posso ascoltare le note e seguirle visivamente sul pentagramma, non mi è possibile invece "ascoltare" la mia vita di coscienza sullo sfondo dell'accadere degli eventi reali del mondo, e questo semplicemente perché degli eventi non ho altra traccia se non quella che si disegna nelle idee della mia coscienza. Tutto questo ci è ben noto, e tuttavia è opportuno richiamarlo alla mente perché ci costringe a riflettere su un fatto importante. Quando un bambino impara a leggere il pentagramma ha certo bisogno di ripetere molte volte la successione delle note e deve accompagnare i suoi sforzi suonando e risuonando la scala: la ripetizione è una condizione essenziale dell'apprendimento della regola. Ciò non toglie tuttavia che ciò che la ripetizione infine sancisce sia una relazione interna: i segni sul pentagramma debbono essere compresi a partire dal gioco linguistico che con essi si gioca e che si manifesta in modo esemplare nel leggere cantando le note. Di qui la possibilità di cogliere tra segno e disegnato un'identità: l'identità della forma logica che si esibisce nella sintassi dei segni e dei suoni.
Diversamente stanno le cose quando ci disponiamo sul terreno delle idee. Qui il rimando da ciò che è dato alla coscienza all'oggetto che di quel vissuto è causa non può andare al di là di una mera proiezione causale: vi è un accadimento cui si suppone corrisponda una causa. Di questo sostrato reale che sostiene il nesso di denotazione vi è un'eco ben precisa non appena ci disponiamo sul piano della sintassi. Qui l'essere insieme delle idee non è una ragione sufficiente per proiettare la sintassi della coscienza sulla sintassi del reale, poiché se il rapporto di denotazione è una relazione reale anche l'essere insieme deve potersi porre come realmente fondato. Di qui il diverso significato che la ripetizione assume quando ci si dispone sul terreno delle idee. Qui la necessità del ripetersi non ci riconduce al fondamento della regola, ma assume piuttosto il senso di una verifica sperimentale. Perché si possa attribuire all'essere insieme delle idee un significato effettivo è necessario che il ritrovarsi insieme di quelle idee sia un fatto costante; la costanza, tuttavia, non è la forma in cui si attesta una regola, ma verifica l'esistenza di un nesso reale e si pone quindi come un indice della sua probabilità. Se le idee sono segni di un linguaggio naturale, allora è il caso di osservare che in senso proprio un linguaggio naturale non c'è, poiché il nesso di significazione non è riducibile ad un nesso causale.
Vi è tuttavia una seconda ragione che ci costringe ad indebolire l'immagine del pentagramma - ed è anche questa una ragione su cui occorre riflettere. Le note sul pentagramma possono dirci qual è la musica che si deve eseguire solo perché, se trascuriamo alcune possibili complicazioni, tra i singoli suoni e i segni sulla carta sussiste una corrispondenza biunivoca: per ogni nota segnata sul rigo corrisponde una ed una sola nota eseguita dal musicista. Ma se abbandoniamo la notazione musicale per tornare al tema di cui discorriamo ci accorgiamo subito che la questione è più complessa poiché in questo caso non abbiamo alcuna garanzia della natura biunivoca del nesso che lega gli eventi nella coscienza ai punti obiettivi siti sul piano della realtà. Tutt'altro: Locke è convinto che la nostra esperienza separi ciò che nelle cose è unito, e lo separi proprio perché il percepire è vincolato alla molteplicità dei canali sensibili e quindi alla varietà delle regole di traduzione che determinano l'acquisizione soggettiva della realtà obiettiva. Tra idee e punti obiettivi potrebbe non esserci una corrispondenza biunivoca e ciò sarebbe quanto sostenere che più segni del pentagramma potrebbero tradursi in un'unica nota.
Di questo problema si deve prendere atto, e tuttavia se cerchiamo davvero di comprendere il nesso di pensieri che sorregge le analisi lockeane ci accorgiamo che qualcosa ci risospinge verso la via che avevamo precedentemente indicato. In particolar modo verso quella via ci risospinge la constatazione che le idee sono segni che stanno per la loro causa, ma che la denotano solo in quanto è causa della nostra reazione sensibile. Un raggio di sole è colto sensibilmente come luce dagli occhi e come tepore dal corpo, ma il fatto che i miei "strumenti" di rilevazione sensibile reagiscano in modo così diverso alla causa che li mette in movimento non è ancora una buona ragione per pensare che effetti diversi, in circostanze diverse, non derivino da una stessa realtà. Non lo significa se non ci disponiamo su un terreno nuovo e se non ci abituiamo a porre sul terreno obiettivo solo ciò che ci permette di parlarne come un potere nel senso che abbiamo dianzi delineato. Ma se ci si pone in questa prospettiva, se ciò di cui abbiamo esperienza è coloto solo in quanto ha il potere di apparirci così, allora si può davvero dire che ogni punto idea nella coscienza sta per un momento obiettivo, anche se poi è possibile che questi momenti siano soltanto differenti aspetti di un'identica realtà. Così, anche se possiamo ritenere che la complessità delle idee abbia talvolta la propria giustificazione non nella molteplicità della causa ma nella varietà dei punti di rilevazione, ciò non toglie che ogni singola idea denota della realtà soltanto ciò che la rende capace di suscitare proprio quell'idea, ed è proprio questa delimitazione dell'oggetto a partire da ciò che suscita nel soggetto a rendere percorribile l'immagine del pentagramma e, insieme ad essa, la tesi della proiettabilità che abbiamo sin qui sostenuto.
2. Delle considerazioni che abbiamo sin qui proposto ci si può avvalere, io credo, per cercare di venire a capo di uno dei passi più complessi e discussi del Saggio: il capitolo dedicato al concetto di sostanza.
Quale sia il problema che si cela dietro questa nozione così cara alla riflessione filosofica non è difficile scorgerlo. Il concetto di sostanza ci invita a riflettere su molte e diverse cose che appartengono di diritto all'ambito della metafisica, e tuttavia sul terreno percettivo il concetto di sostanza è innanzitutto un richiamo alla necessità di rendere conto della multiforme unità delle cose, del loro scandirsi in molteplici proprietà. Ora, può darsi che questo sia soltanto un fatto, ma è comunque un fatto importante che non è possibile trascurare: il nostro mondo della vita non è fatto di punti obiettivi, di oggetti incolori del tutto semplici che possono assumere un senso solo perché è lecito connetterli sintatticamente. Il mondo intuitivo non è fatto di punti ma di cose, e le cose hanno proprietà che non sono semplicemente l'una accanto all'altra nella forma dell'essere insieme, ma appartengono all'unità della cosa secondo nessi molteplici e distinguibili descrittivamente. Almeno sin quando ci si muove sul terreno dell'esperienza percettiva, il bisogno del concetto di sostanza è quindi un bisogno che ha radici evidenti: in questo foglio di carta che vedo vi è un nesso inscindibile tra l'aspetto visivo della superficie e la grana tattile della carta, tra la sua estensione e il suo colore, e non sarebbe affatto una buona descrizione delle nostre esperienze fornire un elenco di qualità per spiegare a chi non lo sappia che cos'è un foglio di carta. La paroletta "e" non basta e non è sufficiente nemmeno darle l'accento e trasformarla nella "è" della copula. Il problema dell'unità intuitiva della cosa è appunto un problema complesso, poiché le proprietà non stanno nella cosa come i nomi in un elenco.
Ora, quale forma assume in Locke questo bisogno di cui abbiamo cercato di mostrare le radici descrittive? Sappiamo già che nel Saggio la nozione di sostanza non sembra godere di buona stampa e basta gettare uno sguardo alla composizione di questo libro per rendersi conto che il cammino che Locke ci invita a compiere è dettato dalla massima secondo la quale ciò che è semplice viene prima, in linea di principio, di ciò che è complesso e che non vi è quindi ragione per attribuire all'oggetto quella priorità gnoseologica che spetta invece alle sue qualità. Locke sembra in altri termini attenersi ad una massima che potremmo formulare così: poiché la sensatezza di ogni idea fa tutt'uno con il suo essere completamente analizzabile e quindi riconducibile ad una qualche datità intuitiva elementare, debbono esistere idee semplici, cui spetta un evidente primato gnoseologico.
Di qui la struttura del secondo libro del Saggio, il suo muovere dalle idee semplici per giungere solo in seguito all'idea complessa della sostanza che dobbiamo pensare proprio così - come il risultato della somma di vissuti semplici cui si aggiunga l'idea vaga di una ragione che giustifichi la loro effettiva coesistenza. Così, se ci poniamo nella prospettiva di Locke, la mela che stringiamo tra le mani è innanzitutto un colore, un sapore, un profumo, un peso, e se ci ostiniamo a parlarne come di una cosa è solo perché non sappiamo sottrarci all'idea che queste molte idee si accompagnino necessariamente le une alle altre e che vi sia qualcosa che determina il loro essere insieme. L'idea di sostanza ci appare così come un'abitudine che ci domina, come una rivincita del senso comune la cui chiarezza tuttavia non va al di là delle idee vaghe che animano i ragionamenti infantili:
if any one will examine himself concerning his notion of pure substance in general, he will find he has no other idea of it at all, but only a supposition of he knows not what support of such qualities which are capable of producing simple ideas in us; which qualities are commonly called accidents. If any one should be asked, what is the subject wherein colour or weight inheres, he would have nothing to say, but the solid extended parts; and if he were demanded, what is it that solidity and extension adhere in, he would not be in a much better case than the Indian before mentioned who, saying that the world was supported by a great elephant, was asked what the elephant rested on; to which his answer was - a great tortoise: but being again pressed to know what gave support to the broad-backed tortoise, replied - something, he knew not what. And thus here, as in all other cases where we use words without having clear and distinct ideas, we talk like children: who, being questioned what such a thing is, which they know not, readily give this satisfactory answer, that it is something: which in truth signifies no more, when so used, either by children or men, but that they know not what; and that the thing they pretend to know, and talk of, is what they have no distinct idea of at all, and so are perfectly ignorant of it, and in the dark (ivi, xxiii, 2).
Così, della pretesa conoscenza della realtà intrinseca dei corpi, della convinzione che un'indagine razionale possa far luce sulla natura ultima del reale e sulla ragione profonda che rende conto dell'unità dell'oggetto al di là del suo scandirsi in qualità molteplici, Locke non intende parlarci se non nella forma ironica di chi vuole esplicitamente prendere le distanze da uno stile filosofico che non si può più condividere.
Del resto alle ironie del filosofo empirista che si addentra nei santuari della metafisica si affiancano le cautele che derivano dall'analisi del linguaggio, che ci invita a riconoscere che la necessità di un nome che stia per le cose - e non semplicemente per le idee delle proprietà che loro competono - nasce innanzitutto da un'istanza pragmatica:
The mind being, as I have declared, furnished with a great number of the simple ideas, conveyed in by the senses as they are found in exterior things, or by reflection on its own operations, takes notice also that a certain number of these simple ideas go constantly together; which being presumed to belong to one thing, and words being suited to common apprehensions, and made use of for quick dispatch, are called, so united in one subject, by one name; which, by inadvertency, we are apt afterward to talk of and consider as one simple idea, which indeed is a complication of many ideas together: because, as I have said, not imagining how these simple ideas can subsist by themselves, we accustom ourselves to suppose some substratum wherein they do subsist, and from which they do result, which therefore we call substance (ivi, II, xxiii, 1).
Le cose stanno appunto così: vi sono nomi che stanno per un insieme di idee, ed in questo artificio di natura comunicativa è sita una delle ragioni che rendono apparentemente necessario il concetto di sostanza. Diciamo la parola "neve" e con questo solo nome ci costringiamo a pensare a molti diversi vissuti di natura sensibile: l'idea del bianco, del freddo, di una certa consistenza, e così via.
Ma accanto a questa ragione di natura soltanto pragmatica Locke ne pone una seconda che dapprima richiama la nostra attenzione sul fatto che molte idee si danno costantemente insieme e che poi di qui muove per avanzare una supposizione che si fonda direttamente sulla tesi della proiettabilità delle relazioni sintattiche tra idee sul terreno obiettivo. Che il mondo sia proprio come i sensi ce lo dipingono non vi è ragione per crederlo: le idee, nella loro dimensione contenutistica, sono il frutto della nostra natura sensibile e non possiamo quindi addurre l'esser così delle nostre idee per sostenere che debbano di conseguenza esservi colori e suoni. Ma se la dimensione contenutistica delle idee dipende nella sua specificità dalla nostra natura umana, l'accadere delle sensazioni e le sintassi di quell'accadere non dipendono dalla nostra complessione sensibile, ma da una causa esterna o da una molteplicità connessa di cause: le forme della sintassi degli eventi sensibili possono parlarci allora dell'unità reale che lega ciò che ogni singola idea denota - il fondamento obiettivo che determina la capacità del reale di suscitare in noi quell'idea.
E se ora pensiamo che alla sintassi contingente dei vissuti corrisponda sul terreno dell'essere un legame tanto reale quanto sconosciuto abbiamo la nozione di sostanza che Locke ci invita a formulare:
we come to have the ideas of particular sorts of substances, by collecting such combinations of simple ideas as are, by experience and observation of men's senses, taken notice of to exist together; and are therefore supposed to flow from the particular internal constitution, or unknown essence of that substance. Thus we come to have the ideas of a man, horse, gold, water, &c.; of which substances, whether any one has any other clear idea, further than of certain simple ideas coexistent together, I appeal to every one's own experience. It is the ordinary qualities observable in iron, or a diamond, put together, that make the true complex idea of those substances, which a smith or a jeweller commonly knows better than a philosopher; who, whatever substantial forms he may talk of, has no other idea of those substances, than what is framed by a collection of those simple ideas which are to be found in them: only we must take notice, that our complex ideas of substances, besides all those simple ideas they are made up of, have always the confused idea of something to which they belong, and in which they subsist: and therefore when we speak of any sort of substance, we say it is a thing having such or such qualities; as body is a thing that is extended, figured, and capable of motion; spirit, a thing capable of thinking; and so hardness, friability, and power to draw iron, we say, are qualities to be found in a loadstone. These, and the like fashions of speaking, intimate that the substance is supposed always something besides the extension, figure, solidity, motion, thinking, or other observable ideas, though we know not what it is (ivi, II, xxiii, 3).
In questa definizione così vaga del concetto di sostanza ci colpiscono innanzitutto alcune cose su cui siamo costretti a riflettere. In primo luogo Locke ci invita a rammentarci del fatto che le idee circoscrivono il come di ogni nostro conoscere e quindi sostiene in un passo famoso che l'essenza dell'oro la conosce meglio l'orafo dello scienziato, e ciò naturalmente significa che dell'oro possiamo conoscere soltanto ciò che l'esperienza ci mostra. Dell'oro abbiamo questa esperienza sensibile, e di questo siamo certi - che è giallo, duttile, malleabile, pesante: quali siano però le caratteristiche reali che determinano il suo apparirci così possiamo soltanto ipotizzarlo, ma non ci è dato saperlo.
Vi è tuttavia un secondo punto su cui dobbiamo riflettere. Per Locke, quando parliamo dell'oro non parliamo di una mera connessione tra idee, ma di una sostanza che ha il potere di apparirci così. I termini che stanno per le idee divengono così nomi di poteri obiettivi: "giallo", "duttile" o "malleabile" valgono anche come parole che denotano la proprietà dell'oro di apparirci giallo, duttile e malleabile. E ciò che è vero per i nomi di poteri vale anche per il nome della sostanza: la parola "oro" non significa solo una consuetudine percettiva - l'abitudine a pensare insieme certe idee - ma esprime anche la nostra convinzione che vi sia una sostanza reale dell'oro e che sia questa la causa delle nostre abitudini percettive. Così, anche se le idee si danno nella forma logica del nome e pongono il loro contenuto come un oggetto ci riconducono infine a poteri che sembrano connettersi gli uni agli altri nell'unità di una sostanza. La forma logica della connessione di idee si apre sul terreno ontologico ad una situazione meno definita e che sembra comunque ricondurci verso la consueta architettonica dell'essere: il suo scandirsi in sostanze e attributi.
È su questa base che Locke ci invita a tracciare una netta distinzione tra ciò che egli chiama le essenze nominali e le essenze reali. Che cosa sia l'essenza nominale è presto detto: si tratta del nostro raccogliere sotto un nome le idee che ci sembrano accompagnarsi le une con le altre e che quindi sembrano offrirci un insieme di caratteristiche sufficientemente definito per cogliere che cosa sia l'oggetto di cui discorriamo. L'essenza nominale coincide dunque con il contenuto semantico di un concetto astratto, e non è altro che la congiunzione di un insieme (eventualmente aperto) di idee. Queste idee, tuttavia, ci parlano dell'essenza reale della cosa e ciò di quella complessa strutturazione dell'oggetto che è all'origine del nostro esperirlo così. L'immagine che Locke ci propone è indicativa: ci invita a pensare ad un grande orologio - l'orologio di Strasburgo - e a guardarlo con gli occhi di uno spettatore ingenuo che non sappia quali complessi ingranaggi si muovano dietro alle lancette e al gioco degli automi che a mezzogiorno si animano per dar vita alla loro breve rappresentazione. L'essenza nominale è ciò che leggiamo sul quadrante: ci è utile per leggere l'ora, ma non ci dice nulla su ciò che l'orologio davvero è - sulla sua essenza reale.
Si tratta, io credo, di un'immagine bella e molto chiara ma falsante, almeno su un punto. Quando guardiamo le lancette dell'orologio vogliamo soltanto leggere l'ora, e del nesso che lega il quadrante agli ingranaggi che garantiscono il funzionamento dell'orologio ci disinteressiamo, e ciò è quanto dire che un nesso causale non deve necessariamente tradursi in una relazione denotativa. Ne segue che chi guarda le lancette non guarda in nessun senso ragionevole del termine al meccanismo che le muove: la loro posizione dipende da quella degli ingranaggi ma non ne è il segno. Le cose stanno diversamente quando dall'esempio torniamo a ciò che dovrebbe rendere intuitivo. Una mela, scrive Locke, ha un'essenza nominale ben precisa che consta di un sapore, un profumo, un colore, una certa consistenza, un peso, e così via. Dietro a queste idee vi è l'ingranaggio che le produce: vi è cioè un'essenza reale della mela che ci è ignota, proprio come ignoti sono i movimenti del meccanismo di un orologio. Ma la differenza salta agli occhi: quando parliamo della mela e ne elenchiamo le proprietà ci riferiamo insieme alla sua essenza reale, poiché ogni idea rimanda ad un potere insito nella cosa ed ogni potere implica che vi sia una determinazione reale dell'oggetto che stia a fondamento di quel potere. Ma ciò è quanto dire che l'essenza nominale si riferisce comunque all'essenza reale dell'oggetto, e che questa si pone come un vincolo realistico che ci impedisce di sostenere una piena identità tra l'oggetto mentale (e la sua parte controparte obiettiva: l'oggetto in quanto è conosciuto) e l'oggetto in sé.
Un vincolo realistico: ammettere che l'oggetto così come noi lo conosciamo non si esaurisce in ciò che ne conosciamo vuol dire anche porre con estrema chiarezza un limite ad ogni tentativo di racchiudere l'esse nel percipi. Ciò che sappiamo della realtà non esaurisce ciò che la realtà è, e questo fatto è in qualche misura inscritto nella logica stessa del conoscere, nel suo necessario riferirsi a ciò che dell'oggetto non è noto. La possibilità del conoscere poggia evidentemente sullo iato che comunque sussiste tra l'oggetto così come noi lo conosciamo e l'oggetto così come in se stesso è - un fatto questo che ci invita ancora una volta a riflettere sul fatto che i nostri nomi non denotano soltanto la cosa così come ci è data, ma l'oggetto come polo identico di un processo conoscitivo aperto.
E tuttavia questo vincolo assume in Locke una piega peculiare: Locke ci invita infatti a porre una netta cesura tra l'oggetto conosciuto e l'oggetto in se stesso. L'essenza nominale sta per l'essenza reale, ma non la manifesta e non vi è un progresso possibile da questa a quella: distinguere tra l'oggetto conosciuto e le idee non vuol dire alludere alla possibilità di un percorso che è dato insieme all'apertura del processo conoscitivo, ma significa invece sostenere che ciò che propriamente possiamo acquisire è solo una conoscenza sempre più approfondita dei segni che stanno per le cose, non delle cose stesse.
Certo, sulla natura degli oggetti possiamo avanzare ragionevoli ipotesi e la scienza fisica nel suo complesso è una dimostrazione evidente di come sia possibile elaborare ipotesi sensate sulla natura delle cose e di come si possa poi controllare metodicamente la plausibilità di quelle ipotesi. Ma di ipotesi appunto si tratta, ed il filosofo è costretto - per Locke - a ribadire che il conoscere ha sì una meta trascendente, ma non può fare altro che alludervi muovendosi all'interno di una sfera immanente. Il linguaggio delle idee diviene così il mezzo per far tacere quella realtà di cui pure si vorrebbe parlare e che può essere invece soltanto indicata.
1. Nella lezione precedente abbiamo gettato un rapido sguardo sul concetto di sostanza così come si configura nelle pagine del Saggio. Si tratta indubbiamente di una questione complessa su cui si dovrebbe discutere più a lungo; noi ci accontenteremo invece di queste poche osservazioni, per gettare un ultimo sguardo su un problema particolare: vogliamo infatti chiederci se davvero si può parlare con Locke di un'idea di sostanza, se - in altri termini - sia possibile sostenere con Locke che vi è un'idea vaga e misteriosa che esprime l'inerenza delle proprietà ad un sostrato che le sostiene.
Che questa sia la tesi del Saggio non vi è dubbio, e basta leggere le prime pagine del capitolo xxiii per convincersene:
if any one will examine himself concerning his notion of pure substance in general, he will find he has no other idea of it at all, but only a supposition of he knows not what support of such qualities which are capable of producing simple ideas in us (ivi, II, xxiii, 3).
L'idea di sostanza è dunque un'idea oscura, e abbiamo già osservato come parte del significato di queste pagine sia nell'ironia con cui Locke tratteggia l'immagine della sostanza propria della metafisica di derivazione aristotelica. Ma non è tanto l'oscurità di quest'idea su cui dobbiamo ora riflettere, quanto il suo porsi come un concetto che implica una relazione. Il concetto di sostanza è un relativo (ivi), un termine questo che Locke spiega così:
When the mind so considers one thing, that it does as it were bring it to, and set it by another, and carries its view from one to the other- this is, as the words import, relation and respect; and the denominations given to positive things, intimating that respect, and serving as marks to lead the thoughts beyond the subject itself denominated to something distinct from it, are what we call relatives (ivi, II, xxv, 1).
Di qui la ragione per cui Locke ci invita a considerare il concetto di sostanza assimilabile sotto questo rispetto ad altri termini relativi. Anche nel caso del concetto di sostanza si allude infatti ad una relazione: quando parliamo di sostanza parliamo infatti di ciò che sul terreno obiettivo lega le proprietà di un oggetto se la nostra esperienza ci mostra il costante ripetersi di determinate sintassi percettive. L'idea di sostanza è dunque l'idea del presunto legame che sul lato obiettivo deve sussistere tra i poteri che sono all'origine di quelle idee che costantemente si accompagnano nella nostra vita percettiva. Di qui appunto la tesi seconda la quale l'idea di sostanza poggia implicitamente su una relazione: l'esserci di un fondamento obiettivo delle qualità sensibili è la conclusione cui perveniamo muovendo dal costante ripetersi di una serie di idee. La sintassi sensibile diviene allora il nome relativo della connessione reale, proprio come i nomi delle idee divengono usualmente i nomi relativi dei poteri obiettivi da cui causalmente derivano.
Per cogliere la specificità della nozione di sostanza non basta tuttavia sottolineare che si tratta di un'idea relativa: è necessario anche osservare che si tratta di una nozione di secondo livello, poiché l'idea di sostanza è un modo in cui ci rappresentiamo l'unità di determinate idee e quindi anche dei poteri obiettivi da cui derivano. Per dirla in breve: la sostanza è il correlato obiettivo di una rappresentazione di rappresentazioni. Sul primo livello abbiamo dunque il nostro pentagramma che rimanda direttamente ai poteri insiti nelle cose e mediatamente alle qualità sensibili che li fondano, mentre sul secondo livello abbiamo per così dire le legature che ci dicono quali idee si presentano insieme alludendo così ad un loro fondamento ontologico. E proprio come la legatura come norma di esecuzione si traduce in una peculiare figurazione nell'ascolto, così la legatura sintattica delle idee nelle coscienza deve parlarci di un nodo sito sul terreno stesso dell'essere.
Il nostro esempio può così ulteriormente definirsi. Le idee sono punti sul pentagramma e stanno per i poteri che a loro volta si fondano secondo una relazione suriettiva, ma non necessariamente iniettiva, nelle proprietà dell'oggetto; le legature tra i punti sul pentagramma sono invece espressione di una loro ripetuta sintassi che parla in nome della connessione delle proprietà in un identico sostrato.
Ciò che ci colpisce in queste considerazioni è, io credo, la possibilità di sviluppare un'immagine anche al di là delle forme che ci avevano permesso di introdurla. E tuttavia, anche in questo caso non bisogna lasciarsi legare le mani dal potere di un'immagine. Così, rammentarsi dell'immagine del pentagramma, delle note e delle legature può essere utile per far luce sulla struttura di fondo delle argomentazioni lockeane concernenti il rapporto tra le idee della coscienza e le cose del mondo, ma può divenire poi un ostacolo se non si presta la dovuta attenzione ad una distinzione di fondo: quando ascoltiamo una melodia sentiamo le legature che sono quindi direttamente percepibili, mentre Locke non ci dice affatto che sul terreno della coscienza avvertiamo un'effettiva connessione tra le idee che appartengono ad un identico oggetto.
Su questo punto le pagine del Saggio sono reticenti se non esplicitamente negative. Certo, per spiegarci che cosa sia la sostanza Locke ci invita a seguire un possibile percorso fenomenologico, ma solo per mostrare la sua insufficienza:
if any one will examine himself concerning his notion of pure substance in general, he will find he has no other idea of it at all, but only a supposition of he knows not what support of such qualities which are capable of producing simple ideas in us; which qualities are commonly called accidents. If any one should be asked, what is the subject wherein colour or weight inheres, he would have nothing to say, but the solid extended parts; and if he were demanded, what is it that solidity and extension adhere in, he would not be in a much better case than the Indian before mentioned who, saying that the world was supported by a great elephant, was asked what the elephant rested on; to which his answer was- a great tortoise: but being again pressed to know what gave support to the broad-backed tortoise, replied - something, he knew not what (ivi, II, xxiii, 2).
Il senso di queste considerazioni è abbastanza chiaro. Apparentemente Locke ci invita a riflettere sulla relazione che lega il colore alla superficie e il peso alla materia che la occupa, ma poi abbandona senz'altro questo cammino scandito dal rimando ad esemplificazioni di natura descrittiva ed osserva che non sappiamo dire che cosa stringa in unità le singole idee. Quell'unità c'è, ma non si manifesta e noi ne sappiamo tanto poco quanto l'indiano sa dell'oscuro fondamento su cui la Terra e i suoi animati sostegni poggiano.
Ora, se un fondamento intuitivo del vincolo sostanziale non c'è, l'unica ragione che può spingerci ad affermare che più idee si legano insieme sino a divenire l'indice di un unità trascendente è il loro costante ripetersi. Il continuo riproporsi delle stesse serie sensibili diviene così da un lato la conferma sperimentale dell'ipotesi che attribuisce alla sintassi delle idee una funzione indicante, dall'altro il fondamento di un'abitudine percettiva che finisce col chiuderci gli occhi sul carattere ipotetico di quel nesso. Così, se diciamo che c'è una mela quando sentiamo un certo profumo, vediamo una certa forma e un certo colore, sentiamo un certo sapore ed avvertiamo un peso ed una consistenza determinati ciò accade perché un'abitudine sinora mai contraddetta ci ha mostrato che tutte le volte che sentiamo quel sapore e quel profumo avvertiamo poi una certa sensazione sulla punta delle dita e vediamo disegnarsi davanti ai nostri occhi quella forma e quel colore. Sostanza e causalità si comportano sotto questo riguardo esattamente allo stesso modo - una certa successione di idee diviene segno di una relazione obiettiva in virtù dell'abitudine che, per così dire, mette a tacere il dubbio che il susseguirsi delle nostre sensazioni sia il frutto del caso e non sia indice di una relazione obiettiva:
Thus, finding that in that substance which we call wax, fluidity, which is a simple idea that was not in it before, is constantly produced by the application of a certain degree of heat we call the simple idea of heat, in relation to fluidity in wax, the cause of it, and fluidity the effect. So also, finding that the substance, wood, which is a certain collection of simple ideas so called, by the application of fire, is turned into another substance, called ashes; i.e., another complex idea, consisting of a collection of simple ideas, quite different from that complex idea which we call wood; we consider fire, in relation to ashes, as cause, and the ashes, as effect. So that whatever is considered by us to conduce or operate to the producing any particular simple idea, or collection of simple ideas, whether substance or mode, which did not before exist, hath thereby in our minds the relation of a cause, and so is denominated by us (ivi, II, xxvi, 2).
Di qui la posizione lockeana. Le serie sensibili non sono connesse intrinsecamente: la loro unità dipende esclusivamente da un nesso esteriore - dal loro costante ripetersi. Ma ciò è quanto dire che non vi è una manifestazione sensibile dell'unità sostanziale, ma solo il costituirsi di una sintassi fattuale come segno di una sintassi necessaria.
È una tesi ben nota: il nucleo centrale delle argomentazioni che abbiamo sin qui proposto poggia infatti sulla convinzione che in Locke il nesso tra idee e cose non è un nesso intenzionale e che il rimando dalle une alle altre poggia esclusivamente su di una relazione causale che fa dell'effetto un segno e della causa un designato. Questa stessa tesi deve manifestarsi anche qui, e ciò significa che non dobbiamo attenderci che l'unità delle proprietà sensibili nella sostanza si manifesti nella forma di unificazione che lega le idee nella loro fattuale sintassi. Anche in questo caso all'esperienza non si chiede di mostrarci come stanno le cose, ma solo di esserne segno: nella sintassi delle idee non si manifesta l'unità della cosa, poiché in generale ciò che è dato alla coscienza è soltanto un indizio della realtà trascendente.
Si tratta appunto di cose su cui ci siamo già soffermati, e tuttavia proprio a partire di qui ci si mostra un fatto nuovo su cui è opportuno soffermarsi. Le idee non manifestano l'oggetto, ma ne sono segno: questa è la tesi di Locke. E tuttavia le idee hanno un contenuto intuitivo: l'agire delle cose sulla soggettività determina la sua risposta sensibile che si dà appunto nella dimensione intuitiva delle idee. Nel caso dell'idea di sostanza, tuttavia questa dimensione intuitiva finisce con l'essere esplicitamente negata: l'unità delle proprietà reali nella cosa non ha un riscontro sensibile, ma è solo l'eco di una proprietà sintattica dei vissuti di coscienza. Ne segue che, a dispetto di ciò che lo stesso Locke ci propone, la sostanza non è un'idea in senso lockeano, ma è parte dell'ipotesi di raccordo tra il piano ideale e il piano reale. Dire che vi sono sostanze significa solo lavorare all'interno dell'ipotesi che lega i vissuti alla loro causa trascendente e che ritiene per questo plausibile proiettare sul piano obiettivo non già le determinazioni contenutistiche delle idee, ma la struttura formale del loro accadere. Più che un vissuto che si lasci in qualche modo descrivere, l'idea di sostanza è una supposizione ragionevole in cui si esprime con grande chiarezza il carattere non intenzionale del rapporto tra l'esperienza e il suo oggetto - se di un oggetto dell'esperienza è in generale lecito parlare anche là dove ad una relazione interna si è sostituito un nesso esterno ed in ultima analisi accidentale.
2. Il quadro che abbiamo tracciato relativamente al concetto di sostanza ci invita ad avanzare ora qualche considerazione critica. Come abbiamo osservato, Locke ritiene che il concetto di sostanza poggi infine sul costante ripetersi di alcune serie di vissuti ed uno stesso ordine di considerazioni viene fatto valere anche per il nesso causale.
Si tratta di una spiegazione coerente con l'impostazione del Saggio, e tuttavia è forse opportuno chiedersi se le argomentazioni che Locke ci propone sono sufficienti per impostare correttamente i problemi che sono stati sollevati. Ora, se ci si pone questa domanda, molti sono i dubbi che diviene difficile tacitare.
In primo luogo: Locke dice che un insieme (S) di percezioni (a, b, c, d) che si ripetano costantemente in circostanze date è indice del vincolo sostanziale (S) che lega determinate qualità (a, b, g, d). Ma afferma poi che così stanno le cose anche a proposito del concetto di causalità: una relazione causale poggia sul costante ripetersi di una successione di idee, ed il rimando vago alla nozione di produzione non sembra suggerire nulla di più che un possibile vincolo temporale. Nel caso della relazione causale il presentarsi insieme di determinate sensazioni deve assumere un ordinamento: la causa è appunto prima dell'effetto. Ma ora ci chiediamo: è davvero sufficiente questa precisazione per distinguere, per esempio, una serie causale da un insieme sostanziale? A mio parere il dubbio è legittimo. Mi avvicino alla neve e dapprima vedo il bianco, poi provo la sensazione del freddo (che può essere avvertita ancor prima che le mie mani sfiorino la coltre nevosa), e poi ancora una certa sensazione di consistenza ed un gusto particolare, che naturalmente avverto solo se porto la neve alla bocca. Qui l'essere insieme delle percezioni ha assunto una piega temporale, scandita dalla prassi della nostra esplorazione percettiva. Dubbi tuttavia non ne abbiamo: il bianco, il freddo, la consistenza e il sapore non sono connessi da una relazione causale, ma parlano delle proprietà della neve e indicano un'identica sostanza. Qui l'ordinamento temporale non parla di una relazione causale che è invece percepita se modifico appena un poco l'esempio: la mano affonda nella neve e alla sensazione di freddo si affianca la sensazione di una resistenza crescente, e io colgo la neve che si fa compatta sotto il mio peso. Ma allora, se le cose stanno così, che cosa distingue un nesso causale e un vincolo sostanziale?
Per rispondere a questa domanda dovremmo, credo, abbandonare la prospettiva lockeana e prendere in esame non soltanto l'esserci di una sintassi tra i vissuti di coscienza, ma il come di questa sintassi, il senso interno che in essa si dipana. Vedere una dopo l'altra le proprietà di una cosa è interamente diverso dal cogliere un nesso causale, ed entrambe queste relazioni si differenziano descrittivamente dal prodursi di una serie accidentale. Talvolta abbiamo l'impressione che tutte le volte che ci sediamo al tavolo per lavorare squilli il telefono, ma nessuno di noi seriamente sospetta che tra questi due eventi vi sia un qualche legame causale. E questo naturalmente non ha nulla a che fare con la nostra mente razionale rischiarata dalla conoscenza delle leggi naturali: qui non vi è bisogno di saper nulla e tutto è già dato insieme alla forma dei decorsi fenomenici. Il bambino vede che è il colpo che assesta al coperchio la causa di tanto rumore, anche se naturalmente non sa nulla sulle ragioni che determinano l'insorgere di quel frastuono. E inversamente: lo stregone che colpisce in effigie il nemico sa bene che vi è bisogno di qualcosa d'altro per realizzare i propri desideri e sa che il suo gesto non è causa possibile ma celebrazione augurale dell'evento sperato - e proprio perché lo sa al di là di ogni possibile concomitanza arroga a sé, allo stregone, il compito di agire magicamente lasciando ad altri il compito accessibile a tutti della mediazione causale.
Un discorso del tutto analogo vale naturalmente anche nel caso della sostanza. Tutte le volte che rivedo una certa collina sul mare sento una pace profonda che si dà insieme ai colori e alle forme che vedo, ma la pace profonda non appartiene a quel colle, e non vi apparterrebbe nemmeno se fossi l'unico uomo al mondo e non potessi discernere nel variare delle sensibilità il permanere di un nucleo obiettivo della cosa. Un paesaggio può essere sereno o angosciante, pieno di pace o di squallore, ma non può racchiudere in sé ciò che io provo: il riproporsi sempre daccapo delle stesse idee in una loro ripetuta coesistenza non è ancora un criterio sufficiente per tracciare il cerchio intorno ad esse e per sancire così la loro appartenenza ad un'unica cosa.
Non è questa la prospettiva di analisi da cui Locke ritiene opportuno lasciarsi guidare. Locke non si interessa ai nessi contenutistici che sussistono sul piano delle relazioni interne all'esperienza, poiché l'esperienza sotto questo riguardo non è interessante per ciò che concerne la sua interna dimensione presentativa, ma solo per la sua effettiva presenza. L'esperienza è un evento tra gli altri, e come ogni altro evento può divenire segno di qualcosa solo quando sappiamo mostrare che vi è una legge naturale che lo lega a qualcosa d'altro la cui presenza può proprio per questo essere ragionevolmente inferita: se l'esperienza denota qualcosa ciò accade non per il suo contenuto fenomenologico ma perché la ripetizione sancisce la regola empirica che lega gli accadimenti, in cui l'esperire si scandisce, ai punti obiettivi del mondo e alle loro effettive relazioni. Per dirla in breve: un nesso tra idee è un indizio che acquista un significato obiettivo solo se si ripete costantemente, perché solo questo ripetersi può porsi come garanzia empirica del sussistere di un legame reale che altrimenti non è dato scorgere nel contenuto fenomenologico della nostra esperienza.
Queste considerazioni ci sono ben note e ci riconducono al cuore della riflessione lockeana, alla sua dimensione più decisamente realistica. Nella coscienza vi sono idee, certo; ma queste idee ci interessano sono solo in quanto sono eventi che accadono e che debbono quindi avere una causa che in esse si misura e si attesta. Ma se le nostre idee altro non sono che posizioni sull'asta graduata di uno strumento, allora si deve senz'altro riconoscere che il valore conoscitivo dell'esperienza è qualcosa che le si aggiunge dall'esterno: il rosso che vedo ogni volta che lo sguardo cade sulla parete della mia casa diviene così l'indizio che mi invita a sospettare che il muro sia fatto in modo tale da apparirmi così.
Di fronte a questo modo di impostare le cose le perplessità che abbiamo fatto dianzi valere non possono che acquistare un nuovo vigore. Quanto più ci immergiamo nel discorso lockeano tanto più povera sembra essere la nozione di esperienza con la quale siamo chiamati a confrontarci. Sino al punto in cui la contraddizione sembra inevitabile: diciamo che le nostre idee si pongono come effetti, ma che cosa giustifica quest'asserzione? Perché mai dovremmo in questo caso credere al contenuto descrittivo della nostra esperienza e dar peso alla dimensione di passività che la caratterizza e che ci invita a considerarla come un effetto? E ancora: se le idee sono soltanto eventi e non valgono per il loro contenuto di senso ma solo per il loro accadere che cosa giustifica il nostro discorrere egualmente di cause e di effetti? Di queste nozioni sappiamo solo perché ne abbiamo un'idea; le idee tuttavia sono soltanto eventi di per sé privi di un valore conoscitivo: ne segue che non vi è ragione per pensare che il mondo obbedisca alle nostre idee e sia quindi retto causalisticamente. La difficoltà è qui: il Saggio ci invita a formulare nel linguaggio mentale delle idee la condizione extra-mentale da cui dipende la loro funzione semantica e questo sembra costringerci a credere che le nostre idee siano di per se stesse in grado di condurci alla trama di quei nessi causali da cui viene poi fatta dipendere la possibilità delle nostre esperienze di condurci di là da esse. Proprio come il barone di Munchausen, anche le nostre idee sembrano così capaci di sollevarsi sul piano della dimensione semantica tirandosi semplicemente per il codino.
È difficile dire se Locke nel Saggio si macchia davvero di questa contraddizione. Un fatto tuttavia è chiaro: comunque stiano le cose, Locke sente il bisogno di affiancare alla teoria della percezione sin qui esposta un'ipotesi nuova che è in sé legittima. Le idee sono eventi che ci parlano delle cose solo in virtù dei nessi causali e ciò è quanto dire che non sarebbe lecito pretendere che il loro contenuto raffiguri gli oggetti denotati; ciò non toglie tuttavia che le idee possano almeno in parte dischiudere un'immagine persuasiva del mondo. Di qui la conclusione che Locke ci invita a trarre: anche se non abbiamo ragioni per credere che gli oggetti siano proprio come ce li rappresentiamo, ciò non toglie tuttavia che sia possibile che qualcosa nel contenuto descrittivo delle nostre idee suggerisca una forma di raffigurazione plausibile del mondo e ci consenta di avanzare un'ipotesi su come esso davvero è.
Così, anche se non possiamo sostenere che le nostre idee siano davvero qualcosa di più che semplici eventi ed anche se non abbiamo ragioni cogenti che ci permettano di sostenere che le cose sono così come ce le rappresentiamo, pure possiamo chiederci se nel mondo come la sensazione lo dipinge non vi siano dei tratti che debbono (o meglio: che è presumibile che debbano) far parte anche della realtà intesa. Di qui la via che Locke ci invita a percorrere: vi è in ciò che percepiamo qualcosa che suggerisce una ragionevole ipotesi sulla natura delle cose e che ci permette di restituire alle idee una funzione raffigurativa, sia pure ipotetica.
È in questa luce che debbono essere analizzate le riflessioni lockeane sulla distinzione tra qualità primarie e secondarie.
1. Le idee sono il prodotto soggettivo di una causa trascendente e quindi nulla rende necessaria l'ipotesi secondo la quale ciò che ci raffiguriamo sensibilmente è di fatto una raffigurazione sufficientemente precisa della realtà in se stessa.
Su questo punto ci siamo più volte soffermati, e tuttavia nella precedente lezione abbiamo attirato l'attenzione su una necessaria distinzione: avevamo osservato infatti che le cause non debbono essere simili agli effetti, ma tuttavia possono esserlo. Nulla vieta infatti che le immagini che si disegnano nella nostra mente possano restituirci i contorni obiettivi della causa da cui derivano, e questo anche se non abbiamo alcuna fondata ragione per considerare le une immagini delle altre. Lo abbiamo già osservato: ogni raffigurazione implica un nesso di somiglianza, ma la somiglianza di per sé non è ancora un motivo per dire che una cosa ne raffigura un'altra: due gocce d'acqua possono essere eguali proprio come recita un ben noto luogo comune, ma non siamo autorizzati per questo a sostenere che l'una raffiguri l'altra - le gocce d'acqua non stanno l'una per l'altra. Che le cose stiano così è difficile negarlo, e tuttavia non troveremmo nulla da ridire se qualcuno tentasse di spiegarci come era la forma della goccia di pioggia che è appena caduta sul vetro invitandoci a guardare quella che ora lo solca. La somiglianza potrebbe giustificare una simile prassi, che in sé non ci costringe ancora a considerare quelle due gocce come se fossero strette da un rapporto di raffigurazione che preesiste al nostro utilizzo e che determina il loro essere fatte così.
Nel caso delle idee e del rapporto che esse stringono con le cose la situazione è tuttavia ancor più sfuggente. Questo rapporto è, come sappiamo, di natura causale, e le cause non debbono essere simili agli effetti. Ma potrebbero esserlo: quando camminiamo nel fango lasciamo ben chiare le impronte delle nostre scarpe sul terreno, ma le orme - che pure ci consentono di cogliere quale sia la natura dell'oggetto che le ha impresse e quale la sua esatta configurazione - non sono evidentemente animate da una qualche istanza intenzionale o figurativa. L'orma non è in sé una raffigurazione dell'oggetto, ma potremmo usarla così: osserviamo ciò che nel fango ha assunto una forma e osserviamo la suola della scarpa e vedendo l'una nell'altra cogliamo l'una come raffigurazione dell'altra. Ma come sappiamo il contesto teorico di Locke non ci consente un simile raffronto: tutto ciò che abbiamo sono le idee, e non possiamo quindi scoprire la loro somiglianza con qualcosa che vada di là da esse. Ma forse qualcosa di più sappiamo: per Locke le idee sono tracce lasciate dagli oggetti nella nostra mente, e ciò è quanto dire che è forse lecito interrogarsi sulla forma del sigillo chiedendosi che cosa possa aver mai prodotto un simile segno nella ceralacca. In fondo, dall'impronta potremmo risalire argomentativamente alla forma del sigillo, e potremmo farlo perchè sappiamo molte cose: sappiamo che due corpi non possono occupare lo stesso luogo, che le sostanze solide non mutano facilmente la propria forma come invece accade ai liquidi, e sappiamo anche il fango o la cera sono sostanze che si comportano ora come un liquido, ora come un solido, a seconda del loro essere più o meno calde o più o meno umide. Tutto questo sapere ci permetterebbe di dire qualcosa sulla natura di ciò che ha impresso quell'orma, e di fatto le orme sono indizi su cui costruire ipotesi ragionevoli. Ma per ipotesi ragionevoli nel caso di una raffigurazione effettiva non vi è spazio, e ciò è quanto dire l'impronta non raffigura il sigillo, ma ne è un segno e una traccia, o e la differenza è tutta insita nel fatto che l'esser traccia di una traccia non poggia su una relazione interna ma su di un nesso causale, su di una relazione che presuppone il sistema concordante delle cause nel mondo.
Di qui le ragioni del nostro discorrere di cera e fango: le idee potrebbero essere il calco e l'oggetto il sigillo che vi si imprime. Così, il loro esser traccia del reale potrebbe ricondurci se non all'immagine cartesiana dell'esperienza come una galleria di quadri - i quadri intendono raffigurare qualcosa - almeno alle tante varianti del racconto del mandylion - di quel velo che sarebbe diventato modello per le icone poiché su di esso si sarebbe impresso il volto di Gesù.
Non vi è dubbio che se ci si pone in questa prospettiva una parte della peculiarità della posizione lockeana sembra venir meno. In fondo, anche Cartesio aveva riconosciuto il carattere illusorio di molte percezioni e aveva esplicitamente sostenuto che la percezione sensibile poteva attingere ad una funzione cognitiva solo nel caso delle qualità primarie: ascoltare i nostri sensi anche là dove ci parlano il linguaggio dei colori o dei sapori significava infatti, per Cartesio, confondere la dimensione cognitiva dell'esperienza con la sua funzione pragmatica, con il suo essere utile alla conservazione della vita. E tuttavia la differenza c'è, e la si può cogliere proprio cercando di comprendere in che modo si articoli la strategia argomentativa lockeana di fronte ad un problema che il Saggio condivide con le Meditazioni metafisiche cartesiane: alludo ancora una volta alla distinzione tra le qualità primarie e le qualità secondarie.
Quale sia la via che le Meditazioni metafisiche ci invitano a seguire per rispondere a questa domanda ed alle istanze scettiche cui si lega è presto detto: Cartesio ritiene che si debba ancorare la veridicità delle nostre esperienze chiare e distinte alla constatazione secondo la quale vi è un dio che ci ha creati e che non può avere voluto che ci ingannassimo anche quando l'errore sembra essere per noi escluso. Così, quando Cartesio ci invita a ragionare su ciò che davvero è un pezzo di cera, ritiene di poter dimostrare che ciò che della cera permane, al di là delle molte modificazioni che possiamo arrecarle, è il suo essere res extensa. Le qualità primarie si liberano dalle qualità secondarie non appena la percezione sensibile assume la forma di un'osservazione attenta, in cui l'immediatezza del sentire cede il passo ad una prassi intellettuale che si gioca sul piano intuitivo, sollecitandolo nella direzione delle sue possibili mutazioni, per mostrare così i primi passi sensibili di un cammino che è in realtà volto a sceverare ciò che è capriccio dei sensi da ciò che invece è forma necessaria dell'essere. Se con la cera giochiamo è solo per scorgere le regole del gioco - queste regole di natura intellettuale che hanno tuttavia una qualche eco intuitiva.
Nelle pagine del Saggio sull'intelletto umano una presa di posizione così decisa non vi è. Locke non ha certo dubbi su quali siano le proprietà intrinseche degli oggetti che si rispecchiano nella nostra esperienza: sono le proprietà che avvertiamo nelle idee semplici della solidità, dell'estensione, del movimento o della quiete, della figura e del numero. Ed è altrettanto certo sulla natura delle qualità secondarie: colori, suoni, sapori e odori appartengono senza dubbio alla sfera di quelle idee che ci dicono solo che l'oggetto ha il potere di apparirci così, ma non ci informano affatto sulla natura del fondamento obiettivo di quel potere. E tuttavia, per quanto scarsa sia la sua propensione alle domande radicali (e radicalmente insincere) dello scettico, resta vero - per Locke - che una risposta dogmatica non si può dare e che non si può fare altro che mantenere sul terreno delle ipotesi la presa dell'esperienza sulla realtà trascendente.
Questa ipotesi vogliamo formularla così: le qualità primarie sono proprietà intrinseche degli oggetti su cui possiamo asserire qualcosa poiché le idee delle qualità primarie sono simili per contenuto a ciò che sta a fondamento dei poteri che in circostanze normali producono in noi quelle stesse idee. Per dirla con un esempio: questo foglio ha il potere di suscitare in me la percezione della sua forma; la forma percepita tuttavia è simile a ciò che nella cosa determina il suo potere di suscitare in me quell'esperienza - è simile alla forma che caratterizza l'oggetto in se stesso. Di qui la possibilità di un uso trascendente dei significati immanenti: assumere l'ipotesi delle qualità primarie significa dunque sostenere, almeno ipoteticamente, che è legittimo impiegare il linguaggio mentalistico delle idee per descrivere in senso proprio e non equivoco le proprietà assolute degli oggetti reali. Dire che vi sono qualità primarie significa dunque riconoscere che talvolta il nesso equivoco che lega i nomi delle idee alle determinazioni reali che stanno a fondamento del potere di suscitare in noi determinati vissuti è reso legittimo dalla forza della somiglianza che lega l'effetto psichico alla sua causa trascendente
A favore di quest'ipotesi militano per Locke alcuni argomenti su cui è opportuno richiamare brevemente la nostra attenzione e che hanno tutti una struttura analoga: Locke ci invita a riflettere su alcune asimmetrie che, a suo dire, distinguono le idee delle qualità secondarie dalle idee delle qualità primarie. Ed è da queste asimmetrie che si deve muovere per argomentare ipoteticamente il porsi di alcune delle nostre idee come un'affidabile eco della configurazione di ciò che è reale.
Ora, su queste asimmetrie Locke si sofferma nel capitolo ottavo, seguendo una forma espositiva apparentemente chiara: si propongono alcune tesi di carattere generale a cui si fanno seguire poi alcuni esempi. Su questi esempi dobbiamo riflettere, perché è soprattutto nelle esemplificazioni che è possibile cogliere quelle asimmetrie su cui Locke ci invita a riflettere e cui vorremmo qui dare una forma più chiara:
1. Le idee delle qualità primarie ci pongono di fronte a proprietà che sembrano permanere al di là delle possibili modificazioni che possiamo imprimere all'oggetto, laddove le qualità secondarie sembrano venir meno non appena abbandoniamo lo spazio antropologicamente determinato della nostra esperienza. Posso, per esempio, suddividere quanto voglio un oggetto, ma non posso per questo pensare di giungere ad un quid che sia privo di forma, di estensione o di solidità. Ora, secondo uno stile argomentativo in cui non è difficile scorgere una qualche affinità con la metodica cartesiana, Locke ci invita a seguire un cammino i cui primi passi si muovono sul terreno intuitivo delle operazioni reali, per poi addentrarsi nelle pieghe di un esperimento mentale. Così, il processo di frantumazione della cosa in parti si traduce dapprima in una prassi reale che sembra autorizzarci a pensare che ogni ulteriore frammentazione condurrà ancora alle stesse qualità primarie che sembrano porsi così come proprietà che non possono essere tolte dagli oggetti, poiché appartengono alla loro stessa natura:
Qualities thus considered in bodies are, First, such as are utterly inseparable from the body, in what state soever it be; and such as in all the alterations and changes it suffers, all the force can be used upon it, it constantly keeps; and such as sense constantly finds in every particle of matter which has bulk enough to be perceived; and the mind finds inseparable from every particle of matter, though less than to make itself singly be perceived by our senses: v.g. Take a grain of wheat, divide it into two parts; each part has still solidity, extension, figure, and mobility: divide it again, and it retains still the same qualities; and so divide it on, till the parts become insensible; they must retain still each of them all those qualities. For division (which is all that a mill, or pestle, or any other body, does upon another, in reducing it to insensible parts) can never take away either solidity, extension, figure, or mobility from any body, but only makes two or more distinct separate masses of matter, of that which was but one before; all which distinct masses, reckoned as so many distinct bodies, after division, make a certain number. These I call original or primary qualities of body, which I think we may observe to produce simple ideas in us, viz. solidity, extension, figure, motion or rest, and number (ivi, II, viii, 9).
Diversamente stanno le cose nel caso delle qualità secondarie. Se frantumo un oggetto concreto avrò ancora oggetti estesi e solidi, dotati di una figura e di un numero; se invece rivolgo lo sguardo al suo colore questa permanenza non sembra essere altrettanto necessaria. Potrebbe, in altri termini, risultare che il colore è una proprietà macroscopica delle cose; uno sguardo che sapesse scorgere i costituenti ultimi della realtà non dovrebbe necessariamente scoprirli colorati e potrebbe costringerci a prendere atto di un mondo senza colori. Del resto, i microscopi sembrano costringerci a revocare in dubbio le nostre certezze sulla natura cromatica delle cose:
The now secondary qualities of bodies would disappear, if we could discover the primary ones of their minute parts. Had we senses acute enough to discern the minute particles of bodies, and the real constitution on which their sensible qualities depend, I doubt not but they would produce quite different ideas in us: and that which is now the yellow colour of gold, would then disappear, and instead of it we should see an admirable texture of parts, of a certain size and figure. This microscopes plainly discover to us; for what to our naked eyes produces a certain colour, is, by thus augmenting the acuteness of our senses, discovered to be quite a different thing; and the thus altering, as it were, the proportion of the bulk of the minute parts of a coloured object to our usual sight, produces different ideas from what it did before. Thus, sand or pounded glass, which is opaque, and white to the naked eye, is pellucid in a microscope; and a hair seen in this way, loses its former colour, and is, in a great measure, pellucid, with a mixture of some bright sparkling colours, such as appear from the refraction of diamonds, and other pellucid bodies. Blood, to the naked eye, appears all red; but by a good microscope, wherein its lesser parts appear, shows only some few globules of red, swimming in a pellucid liquor, and how these red globules would appear, if glasses could be found that could yet magnify them a thousand or ten thousand times more, is uncertain (ivi, II, xxiii, 11).
Ora, se solo ciò che è macroscopico e non ciò che è minuscolo ci appare colorato, ciò è un segno della natura eminentemente soggettiva del colore e delle altre qualità secondarie: macroscopico e microscopico sono termini che assumono un senso solo in relazione alla soggettività. L'ancoraggio del colore alla dimensione in cui si gioca la nostra esistenza sembra porsi così come un riprova del carattere antropologicamente determinato della percezione cromatica.
2. Le qualità primarie sembrano proprietà degli oggetti anche perché nulla sembra connetterle necessariamente alla peculiarità del soggetto esperiente. Due oggetti sono due da vicino e da lontano, e lo stesso dicasi per la loro forma o per la loro solidità. Le qualità primarie sono appunto qualità degli oggetti, e non ci dicono nulla sulla natura del soggetto che le esperisce. Diversamente stanno le cose quando ci disponiamo sul terreno delle qualità secondarie: qui la dipendenza delle qualità dal soggetto esperiente si fa manifesta, anche se di primo acchito siamo egualmente inclini a credere che le cose siano proprio come le esperiamo. Eppure basta poco per accorgersi - sostiene Locke - che il caldo non è nel fuoco più di quanto non lo sia il dolore che avvertiamo quando facciamo ancora un passo verso di esso:
Flame is denominated hot and light; snow, white and cold; and manna, white and sweet, from the ideas they produce in us. Which qualities are commonly thought to be the same in those bodies that those ideas are in us, the one the perfect resemblance of the other, as they are in a mirror, and it would by most men be judged very extravagant if one should say otherwise. And yet he that will consider that the same fire that, at one distance produces in us the sensation of warmth, does, at a nearer approach, produce in us the far different sensation of pain, ought to bethink himself what reason he has to say - that this idea of warmth, which was produced in him by the fire, is actually in the fire; and his idea of pain, which the same fire produced in him the same way, is not in the fire. Why are whiteness and coldness in snow, and pain not, when it produces the one and the other idea in us; and can do neither, but by the bulk, figure, number, and motion of its solid parts? (ivi, II, viii, 16).
Le qualità secondarie sono dunque centrate nell'io e dipendenti dall'io che le esperisce. Ora, ciò significa in primo luogo richiamare l'attenzione sul fatto che molte proprietà secondarie hanno carattere oppositivo: caldo e freddo, dolce e amaro e in fondo anche liscio e ruvido sono termini che - come gradevole o sgradevole - contengono un necessario riferimento a chi le percepisce, che si pone come il punto fermo rispetto al quale quelle grandezze si fanno misurabili. Ma vuol dire anche, in secondo luogo, osservare la loro dipendenza dal modo in cui esse stesse si manifestano. Se improvvisamente, per una misteriosa ragione, le cose rosse apparissero a tutti gialle, ciò che è rosso diverrebbe per ciò stesso giallo: la dipendenza delle qualità secondarie dall'io si manifesta così nella relatività del loro essere che è tale solo rispetto ad una cerchia di soggetti percipienti. Essere dolce o amaro, giallo o rosso, caldo o freddo è come essere nutriente o velenoso: è qualcosa che si può dire di qualcosa d'altro solo se si definisce quali siano i soggetti esperienti. Nel caso delle qualità secondarie si può dunque sostenere che l'essere equivale all'apparire e che non è possibile distinguere tra manifestazioni apparenti e reali di una determinata proprietà. Se una cosa sembra rossa di fatto è anche rossa perché nel caso delle qualità secondarie l'essere fa tutt'uno con l'apparire e non può quindi darsi il caso che qualcosa appaia ma non sia così come appare. La asimmetria rispetto alle qualità primarie non potrebbe essere più evidente: una forma può apparirci in una falsa luce e non vi è ragione di credere che la percezione non possa costringerci a correggere l'immagine dell'oggetto per ciò che concerne una qualunque delle sue proprietà primarie.
Del resto questa differente posizione rispetto all'essere e all'apparire deve a sua volta essere ulteriormente ribadita, e nel Saggio si sostiene esplicitamente che le idee delle qualità secondarie esistono solo in quanto idee e non sono pensabili se non in relazione con un percipi. Ora, questa tesi è in un certo senso ovvia: le idee - tutte le idee - esistono solo in quanto sono percepite. Ma nel caso delle idee delle qualità secondarie l'affermazione assume un senso particolare: Locke intende infatti sostenere che per il loro stesso contenuto le idee delle qualità secondarie si qualificano in quanto idee, e cioè in quanto oggetti che esistono solo per l'intelletto che li coglie. Nella loro stessa natura contenutistica, colori, suoni e sapori si pongono come idee dell'intelletto poiché non possiamo pensarli se non come modi in cui si realizza il nostro contatto esperienziale con le cose, laddove le qualità primarie sono proprietà degli oggetti che debbono essere pensate anche al di là del nostro esperirli:
The particular bulk, number, figure, and motion of the parts of fire or snow are really in them,- whether any one's senses perceive them or no: and therefore they may be called real qualities, because they really exist in those bodies. But light, heat, whiteness, or coldness, are no more really in them than sickness or pain is in manna. Take away the sensation of them; let not the eyes see light or colours, nor the ears hear sounds; let the palate not taste, nor the nose smell, and all colours, tastes, odours, and sounds, as they are such particular ideas, vanish and cease, and are reduced to their causes, i.e. bulk, figure, and motion of parts (ivi, II, viii, 17).
Di qui l'analogia tra qualità secondarie e dolori - una analogia che non è certo evidente da un punto di vista fenomenologico, ma che trae le sue ragion d'essere dalla tesi della mera soggettività delle qualità secondarie. Colori e sapori altro non sono che un modo di reagire a qualcosa che è dato, proprio come il dolore è il nostro modo di reagire a qualcosa che modifichi violentemente il nostro stato corporeo.
3. Le qualità secondarie non sono separabili dalle circostanze da cui dipende la percezione delle idee corrispondenti. Per scegliere una stoffa la guardiamo alla luce del sole, perché l'illuminazione artificiale falsa il colore delle cose; proprio questa prassi, tuttavia, ci invita a riflettere sulla relatività delle qualità secondarie: ciò che al chiuso sembra di un colore, ne mostra un altro all'aperto e lo spettacolo muta ancora con il passare del tempo. Vale qui la legge dell'impressionismo che Monet ha voluto affidare alle sue cattedrali: un colore degli oggetti non vi è, poiché il colore è solo il prodotto instabile di un gioco percettivo e non una proprietà delle cose - una verità che, per Locke, fa tutt'uno con la constatazione che è sufficiente spegnere la luce perché il colore scompaia. Non così naturalmente la forma degli oggetti che non dipende dalla luce o dall'oscurità e che dobbiamo pensare nell'oggetto come una sua determinazione stabile:
Let us consider the red and white colours in porphyry. Hinder light from striking on it, and its colours vanish; it no longer produces any such ideas in us: upon the return of light it produces these appearances on us again. Can any one think any real alterations are made in the porphyry by the presence or absence of light; and that those ideas of whiteness and redness are really in porphyry in the light, when it is plain it has no colour in the dark? It has, indeed, such a configuration of particles, both night and day, as are apt, by the rays of light rebounding from some parts of that hard stone, to produce in us the idea of redness, and from others the idea of whiteness; but whiteness or redness are not in it at any time, but such a texture that hath the power to produce such a sensation in us (ivi, II, viii, 19).
Forse su questa osservazione è necessario soffermarsi un poco perché, anche se vorrei rimandare ancora un poco le considerazioni di natura critica, non sembra affatto privo di senso sostenere che l'erba è verde anche quando il buio non ci permette di vederla. A questa obiezione, tuttavia, Locke ritiene di poter rispondere: se siamo inclini ad attribuire un colore alle cose anche nella più oscura delle notti, ciò accade perché i nomi dei colori non sono soltanto segni delle idee ma, come sappiamo, valgono anche come designazioni equivoche di una disposizione obiettiva delle cose - la loro capacità di ridestare in circostanze determinate in un soggetto normale un'idea di quel tipo. Dire che l'erba è verde di notte significa allora soltanto sostenere questo: che anche di notte non perde la capacità di apparire verde alla luce del sole. Questa capacità, tuttavia, non ha come suo fondamento una qualità secondaria, ma una qualità primaria: se le cose ci appaiono così è perché la loro struttura atomica è tale da determinare in noi proprio quella reazione soggettiva che designiamo con quella parola. Se dunque il nostro linguaggio quotidiano ci invita a dire che le cose hanno un colore indipendentemente dalle circostanze, ciò accade solo a causa dell'equivocità del linguaggio, del suo impiegare lo stesso nome per indicare l'idea e il potere obiettivo da cui dipende.
4. Vi è infine un'ulteriore ragione che, per Locke, ci spinge a sostenere che le qualità secondarie hanno un'esistenza confinata allo spazio della soggettività, ed è l'argomento delle illusioni percettive. Locke ritiene che la riflessione sul carattere relazionale delle qualità secondarie ci permetta di spiegare
how water felt as cold by one hand may be warm to the other. Ideas being thus distinguished and understood, we may be able to give an account how the same water, at the same time, may produce the idea of cold by one hand and of heat by the other: whereas it is impossible that the same water, if those ideas were really in it, should at the same time be both hot and cold. For, if we imagine warmth, as it is in our hands, to be nothing but a certain sort and degree of motion in the minute particles of our nerves or animal spirits, we may understand how it is possible that the same water may, at the same time, produce the sensations of heat in one hand and cold in the other; which yet figure never does, that never producing- the idea of a square by one hand which has produced the idea of a globe by another. But if the sensation of heat and cold be nothing but the increase or diminution of the motion of the minute parts of our bodies, caused by the corpuscles of any other body, it is easy to be understood, that if that motion be greater in one hand than in the other; if a body be applied to the two hands, which has in its minute particles a greater motion than in those of one of the hands, and a less than in those of the other, it will increase the motion of the one hand and lessen it in the other; and so cause the different sensations of heat and cold that depend thereon (ivi, II, viii, 21).
Non è difficile ritrovare qui il filo di un'argomentazione che ci è ben nota. L'acqua in sé non può essere calda e fredda in un medesimo istante - o più propriamente: una certa quantità d'acqua non può racchiudere in sé i poteri di suscitare in un soggetto normale in circostanze normali sensazioni differenti. Ma ciò è quanto dire che la possibilità di parlare sensatamente di un'illusione (e cioè di una percezione che ci inganna sulla natura delle cose) è, nel caso delle qualità secondarie, almeno in parte fuori luogo, poiché di fatto ogni attribuzione di un potere rimanda comunque ad un nesso relazionale. E proprio come uno stesso cibo può essere nutriente per una specie e dannoso per un'altra, così la stessa acqua può essere calda per una mano e fredda per l'altra. Certo, di qui non si può muovere per attribuire all'acqua del secchio poteri contrastanti ed è comunque lecito dire che vi è qualcosa come un'illusione percettiva: anche per le qualità secondarie vi è dunque la possibilità della smentita. Di qui tuttavia non si può trarre alcuna conseguenza impegnativa, poiché in realtà se di un contrasto ha senso parlare non è in seno all'oggetto, ma solo tra la reazione individuale e la reazione normale rispetto ad esso. Così, se dell'acqua del secchio non si può dire che è calda e fredda allo stesso tempo è solo perché si presuppone che "caldo" e "freddo" siano i nomi che diamo all'acqua per indicare le reazioni che in circostanze normali e in soggetti normali quell'acqua suscita. La contraddizione che i sensi ravvisano si rivela così una contraddizione soltanto apparente.
2. Le riflessioni che abbiamo appena discusso ci hanno mostrato quali siano le ragioni che spingono Locke a riproporre la classica distinzione tra le qualità primarie e le qualità secondarie.
Sulla bontà di questi argomenti è forse opportuno rimandare un poco la discussione, anche se è difficile non scorgere come talvolta Locke dia per scontato ciò che di fatto si deve dimostrare. E tuttavia, al di là dei dubbi che può talvolta suscitare nel lettore una prassi argomentativa non troppo attenta ai presupposti implicitamente assunti, resta vero che un tratto accomuna tutte queste dimostrazioni che Locke ci propone: il variare delle prove addita infatti un identico punto comune - la convinzione che le qualità secondarie siano proprietà essenzialmente relative che possono essere poste solo in relazione alla soggettività che le esperisce. L'asimmetria con le qualità primarie è tutta qui: forma, estensione, solidità, numero e movimento sono proprietà che possiamo pensare nelle cose anche senza riferirle ad un soggetto percipiente, laddove il caldo e il freddo, l'amaro e il dolce, i colori, gli odori e i suoni debbono essere pensati, per Locke, come modi in cui la soggettività reagisce alla realtà delle cose. Al mondo obiettivo delle qualità primarie fa così eco il mondo per la soggettività delle qualità secondarie, il mondo pensato nella sua relazione ad una soggettività umana colta nella sua generale normalità percettiva.
Verso questa meta ci conducono tutte le argomentazioni che abbiamo analizzato, ed è un fatto che Locke ci invita a trarre questa conclusione proponendoci di compiere una mossa di cui non è di primo acchito facile comprendere la necessità: Locke ci invita infatti ad affiancare alle qualità primarie e secondarie quelle qualità che Locke chiama terziarie e che ci riconducono al modo in cui determinate sostanze reagiscono quando sono messe in una relazione causale con altre sostanze. Così, per esempio, diremo che lo zucchero è solubile in acqua o che la cera è sensibile al calore, suggerendo così una proprietà che spetta allo zucchero o alla cera solo in quanto è in una relazione causale con l'acqua e il fuoco. Per dirla con Locke:
The ideas that make our complex ones of corporeal substances, are of these three sorts. First, the ideas of the primary qualities of things, which are discovered by our senses, and are in them even when we perceive them not; such are the bulk, figure, number, situation, and motion of the parts of bodies; which are really in them, whether we take notice of them or not. Secondly, the sensible secondary qualities, which, depending on these, are nothing but the powers those substances have to produce several ideas in us by our senses; which ideas are not in the things themselves, otherwise than as anything is in its cause. Thirdly, the aptness we consider in any substance, to give or receive such alterations of primary qualities, as that the substance so altered should produce in us different ideas from what it did before; these are called active and passive powers: all which powers, as far as we have any notice or notion of them, terminate only in sensible simple ideas. For whatever alteration a loadstone has the power to make in the minute particles of iron, we should have no notion of any power it had at all to operate on iron, did not its sensible motion discover it: and I doubt not, but there are a thousand changes, that bodies we daily handle have a power to use in one another, which we never suspect, because they never appear in sensible effects (ivi, II, viii, 23).
Si tratta di una tripartizione abbastanza chiara, e tuttavia - come abbiamo appena osservato - non è facile capire perché si debba parlare qui anche delle qualità terziarie. Da questo stupore, tuttavia, è opportuno liberarsi, poiché Locke intende invitarci ancora una volta a riflettere sul fatto che la relazione percettiva è comunque una relazione reale e deve essere intesa non soltanto alla luce del suo correlato cosciente (l'idea), ma come sviluppo di un processo causale di modificazione. E se ci si pone in questa luce la cera che si scioglie per il calore del sole si comporta in modo assai simile all'io che diviene cosciente del rosso a causa dell'oggetto percepito.
Anche queste considerazioni dovrebbero esserci ormai note: in esse traspare infatti ancora una volta la tesi di fondo della filosofia di Locke: il suo porre la percezione come una relazione reale che lega i nostri vissuti alle cose che li causano.
E tuttavia proprio dalla lettura di queste pagine l'assolutezza di questa posizione sembrerebbe uscire ridimensionata. Certo, le qualità secondarie sono essenzialmente relative, ma non ogni idea è idea di una qualità secondaria, e di fatto tutto lo sforzo di queste pagine consiste nel metterci di fronte ad una asimmetria che deve essere di fatto accettata: alle qualità che consistono unicamente nel loro apparirci così debbono affiancarsi anche le qualità primarie che si manifestano al soggetto ma che non si esauriscono in questo manifestarsi e che non sono soltanto determinate dal loro essere tali da apparirci in un certo modo, ma anche dal loro essere il fondamento di quel potere obiettivo. Sembrerebbe dunque legittimo sostenere che vi è una differenza sostanziale tra le percezioni: da un canto vi sono le idee delle qualità secondarie che sono meri segni che derivano la loro funzione dall'esserci di un nesso causale, dall'altro vi sono le idee delle qualità primarie che, per la loro stessa natura, sembrerebbero potersi porre come raffigurazioni di una realtà trascendente. L'asimmetria tra le idee su cui abbiamo attirato l'attenzione si porrebbe così come un segno di una differenza radicata nel carattere stesso delle idee, nella loro natura epistemica.
Non credo che questa conclusione debba essere tratta. E per due ragioni diverse strettamente legate l'una all'altra.
La prima ragione che vorrei addurre ci riconduce alla natura stessa delle argomentazioni che Locke ci propone. Se le rileggiamo con attenzione ci accorgiamo infatti che non si fa mai appello ad un qualche carattere interno alle idee. Locke non ci dice che le idee di estensione o di numero siano più chiare e distinte delle idee di colore o di suono, e non ci invita a sostenere che le prime abbiano in se stesse qualcosa che spinge la soggettività a prestare loro ascolto. Se le idee delle qualità primarie possono dirsi raffigurazioni non è per una loro interna qualità, ma solo per una proprietà che concerne la natura dei contenuti che in esse si esibiscono. Non è il modo in cui si dà l'idea di spazio o di numero a spingerci verso la tesi secondo la quale spazio e numero esistono realmente; se così crediamo non è perché la nostra esperienza dello spazio e del numero sia particolarmente chiara e convincente, ma perché spazio e numero hanno, per così dire, le carte in regola per esistere. Tutti gli argomenti che Locke ci suggerisce si orientano di fatto in questa direzione: Locke vuole mostrarci come le qualità primarie facciano necessariamente parte dell'arredo originario del mondo e come sia in ultima analisi impensabile un mondo che non sia fatto proprio come dio lo ha pensato - Deus fecit omnia in numero, pondere ac mensura. Ma ciò è quanto dire che se vi è una scelta a favore delle qualità primarie questa non dipende dalla natura delle idee che ce le presentano, ma da ciò che in esse si presenta. Che le qualità primarie abbiano un posto nel mondo è un'ipotesi ragionevole cui dobbiamo giungere riflettendo su ciò che le qualità primarie sono, non sul modo in cui si presentano.
Di qui si può muovere verso la seconda ragione cui alludevamo. Nel capitolo ottavo Locke parla di qualità primarie e secondarie, ed osserva che se delle prime ha senso affermare che sono proprietà assolute degli oggetti, nel caso delle seconde sottolinea invece con estrema nettezza che si tratta di mere determinazioni relazionali. Quando diciamo che una cosa è rossa non facciamo altro che sostenere che si tratta di una cosa che di norma sa suscitare in chi la percepisce una sensazione determinata. Se invece diciamo di quello stesso oggetto che è uno, non diciamo semplicemente che è tale da apparire così ad una soggettività determinata: diciamo invece che se un oggetto ha il potere di apparirci così, ciò accade proprio perché è fatto così. Da un lato abbiamo dunque una determinazione relativa che è colta solo a partire dal nesso causale che la cosa stringe con la soggettività, dall'altra una determinazione assoluta che può essere sensatamente posta come fondamento del potere che la cosa ha di apparirci come ci appare. Ma appunto: questa differenza che qui Locke ci invita a tracciare non riguarda affatto le idee in quanto tali, ma la possibilità di muovere per ipotesi da ciò che nel Saggio si ritiene di poter affermare positivamente (dalle idee e dal loro rimandare ad un potere obiettivo che le determina nella soggettività) al fondamento stesso di questo potere - a ciò che propriamente esiste sul terreno delle cose. Questo passo è appunto di natura ipotetica: ciò che propriamente esperiamo sono le idee che, nel loro porsi come effetti, si danno come un oggetto immediato che tuttavia ci conduce mediatamente sul terreno obiettivo, colto tuttavia solo nel suo essere tale da modificare così e così la nostra soggettività. Al di là di questo, nulla è propriamente dato, né direttamente, né indirettamente. Se dunque al di là del dato ci si spinge è solo in virtù di un'ipotesi sulla cui ragionevolezza Locke non nutre dubbi, anche se non per questo dimentica la peculiarità del suo statuto logico: anche se nulla nella nostra esperienza può dirci come stiano davvero le cose, è ragionevole pensare che se le cose ci appaiono di norma così come ci appaiono è perché vi è qualcosa a fondamento della loro capacità di apparirci così, ed è altrettanto ragionevole attendersi che questo qualcosa sia per la sua stessa natura indipendente dalle variazioni concernenti il terreno delle manifestazioni fenomeniche. Di qui la via che Locke ci propone di seguire nelle sue argomentazioni: se vogliamo risalire dal potere delle cose di manifestarsi così a ciò che determina un simile potere (se, in altri termini, vogliamo distinguere le qualità secondarie dalle qualità primarie) dobbiamo cercare nell'unica messe di dati che è a nostra disposizione - nel materiale sensibile delle idee - ciò che sembra in linea di principio indipendente dalle peculiarità della situazione percettiva ed avanzare di qui un'ipotesi che non conosce una verificazione effettiva - l'ipotesi secondo la quale forma, numero, disposizione, movimento sono le caratteristiche effettive che determinano la capacità delle cose di apparirci come ci appaiono. Vale dunque il seguente schema:
Datità di esperienza Entità inferite ipoteticamente Immediate Mediate Ipotetiche Idee o Correlati psichici Poteri (o qualità secondarie) o correlati obiettivi Qualità primarie o fondamento obiettivo Assolute Relative Assolute Soggettive Para-oggettive oggettive Dimensione psichica Dimensione obiettiva In questo schema almeno una voce deve essere commentata, ed è l'equiparazione tra poteri e qualità secondarie. Nelle pagine del Saggio si cercherebbe invano una simile affermazione e forse a ragione: Locke intende distinguere proprietà come il colore e il sapore dalle determinazione obiettive della figura e del numero, non tracciare una linea di demarcazione che separi ciò che è ipoteticamente posto come proprietà assoluta della cosa e ciò che è dato come sua determinazione relativa e quindi come sua capacità di suscitare in noi esperienze determinate. Questa distinzione sembra del resto costringerci a sposare una tesi in sé fastidiosa: dovremmo infatti accettare che per ogni qualità primaria si possa parlare non soltanto dell'idea che le corrisponde ma anche di un potere che è ciò che nella cosa corrisponde alla capacità di destare in un soggetto umano la sensazione in questione - e di parlarne come di una qualità secondaria! Si tratta, certo, di una complicazione che per molte ragioni è meglio evitare. E tuttavia, da un punto di vista teorico, le cose mi sembra stiano proprio così, almeno in Locke. Del resto, tenere sotto gli occhi lo schema proposto è importante se non si vuole correre il rischio di cadere in un fraintendimento verso cui la terminologia di Locke, nella sua apparente semplicità, ci conduce - la tesi secondo la quale le qualità primarie e le qualità secondarie apparterrebbero ad uno stesso livello teorico. Ma le cose naturalmente non stanno così, poiché le qualità primarie sono proprietà assolute degli oggetti e sono poste ipoteticamente, laddove le qualità secondarie sono determinazioni meramente relative che hanno come loro obiettivo fondamento null'altro se non qualità primarie ipoteticamente inferite. Così parlare di qualità secondarie non significa soltanto parlare di idee ma di una disposizione di natura obiettiva, laddove parlare di qualità primarie non significa alludere ad un potere nelle cose, ma a quelle determinazioni assolute che dobbiamo porre sul terreno oggettivo e che possiamo pensare solo se estendiamo ipoteticamente il nostro idioma mentale, proiettando le determinazioni sensibili di alcune idee sulla realtà obiettiva delle cose: Secondary qualities of bodies. Secondly, such qualities which in truth are nothing in the objects themselves but power to produce various sensations in us by their primary qualities, i.e. by the bulk, figure, texture, and motion of their insensible parts, as colours, sounds, tastes, &c. These I call secondary qualities (ivi, II, viii, 10). The ideas of the primary alone really exist. The particular bulk, number, figure, and motion of the parts of fire or snow are really in them,- whether any one's senses perceive them or no: and therefore they may be called real qualities, because they really exist in those bodies. But light, heat, whiteness, or coldness, are no more really in them than sickness or pain is in manna. Take away the sensation of them; let not the eyes see light or colours, nor the ears hear sounds; let the palate not taste, nor the nose smell, and all colours, tastes, odours, and sounds, as they are such particular ideas, vanish and cease, and are reduced to their causes, i.e. bulk, figure, and motion of parts (ivi, II, viii, 17). E ciò è quanto dire che l'assunzione ipotetica delle qualità primarie altro non è se non un'ipotesi sulla legittimità dell'estensione del campo semantico delle idee dalla sfera di ciò che è meramente mentale all'ambito della realtà obiettiva.