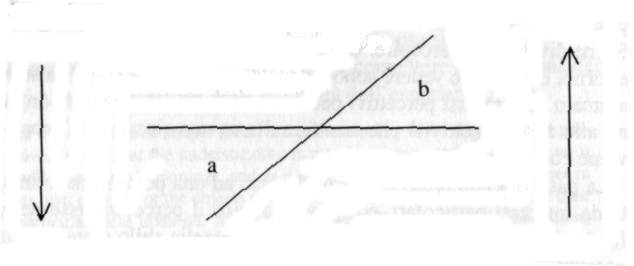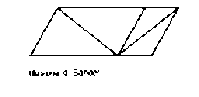|
|
|
Quest’ordine di considerazioni si può già in qualche misura scorgere nelle pagine di Estetica dello spazio e le illusioni ottico-geometriche (Voss, Hamburg 1894) — un saggio di Theodor Lipps dedicato a far luce sulla natura delle illusioni ottiche. Certo, per Lipps l’origine di queste illusioni non riposa sulla percezione, ma sul sovrapporsi ad essa di processi rappresentativi che hanno la loro origine nell’io: Lipps non è, in altri termini, disposto a negare la dipendenza univoca della percezione dalle condizioni dello stimolo e ritiene quindi necessario far dipendere dalla soggettività l’inganno di cui essa stessa è vittima (ivi, 63-9). Basta tuttavia leggere con attenzione queste pagine per rendersi conto che in antiche fogge si fa avanti un contenuto nuovo. Se infatti alla percezione nella sua obiettiva esattezza può sovrapporsi e sostituirsi una rappresentazione erronea, ciò accade perché la forma, nella sua determinatezza fenomenica, "costringe" chi la osserva a coglierla come se fosse il frutto di un agire, come se in essa l’io potesse riconoscere quelle tendenze e quei dinamismi che caratterizzano la vita. Sotto lo sguardo della soggettività le forme spaziali si animano, poiché alla percezione nella sua obiettività vengono sostituendosi le rappresentazioni dell’oggetto che hanno la loro origine nell’atteggiamento proiettivo dell’io: all’esserci della forma subentra così il suo vivere, il suo animarsi di una molteplicità di dinamismi che tendono a liberarla dalla fissità del dato. E tuttavia se le rappresentazioni proiettive possono sorgere e tacitare l’obiettività del dato ciò accade soltanto perché nella forma percettiva dell’oggetto vi sono le "ragioni" che ci spingono a viverla secondo un’angolatura determinata. Un rapporto per certi versi analogo tra dimensione soggettiva del percepire e natura non sensoriale delle illusioni ottico-geometriche traspare anche nelle analisi di Benussi. Anche per Benussi infatti le illusioni ottiche rimandano ad un intervento della soggettività che dai dati elementari di senso è invitata ad una apprensione formale che risulta essere inadeguata rispetto alla costituzione obiettiva del dato. Come abbiamo dianzi osservato, l’interesse di Benussi doveva tuttavia soffermarsi soprattutto su quella forma di illusioni dei sensi che sono riconducibili sotto il titolo dell’ambiguità: qui la possibilità di variare l’assetto percettivo dell’immagine giocando sugli orientamenti dell’attenzione doveva mostrare in vitro la presenza della soggettività nella strutturazione asensoriale dell’immagine.
Il tentativo di ricondurre le illusioni ottiche alla dinamica delle proiezioni soggettive doveva presto lasciare il campo ad altre soluzioni; diverso doveva essere invece il destino della convinzione, che pure anima le pagine di Lipps e di Benussi, secondo la quale la scena percettiva è percorsa da una molteplicità di tendenze che determinano il senso di ciò che esperiamo. Di questa tesi la psicologia della forma doveva fare la sua bandiera, ed in questa luce le illusioni ottiche dovevano necessariamente apparire come una dimostrazione del fatto che la percezione è determinata da un insieme di regole che le permettono di andare al di là dell’informazione contenuta nello stimolo ma che, proprio per questo, possono talvolta indurci in errore. Il capitolo degli inganni percettivi doveva così offrire una ricca messe di materiale per mostrare da un lato l’insostenibilità della tesi secondo la quale la dimensione sensibile della percezione dipende esclusivamente dallo stimolo e per ribadire dall’altro che nella percezione sono all’opera regole di formazione e di unificazione.
Come reagire di fronte a tanto sapere speso su questo tema così capace di catturare la nostra curiosità? Credo si debba reagire così, proponendo innanz itutto una prima riflessione. Parliamo di illusioni e di inganni percettivi, ma non saremmo disposti a mettere sotto questo titolo ogni percezione ingannevole ma, per così dire, solo quelle che resistono alla nostra capacità di correggerle.
Che cosa intendo dire è presto detto: vi sono casi in cui la nostra percezione è, per così dire, messa in scacco, e questo perché ci pone di fronte a situazioni percettive che possono essere sanate nell’unità del loro riferimento oggettuale solo prescindendo da una qualche peculiarità della scena percettiva. Non è così che stanno le cose nel caso dei molti errori percettivi nei quali normalmente ci imbattiamo. Si narra che Zeusi avesse dipinto un grappolo d’uva tanto vero a vedersi da ingannare gli uccelli accorsi a beccarlo, ma che avesse dovuto poi cadere nell’inganno sottile di Parrasio che dipinge sulla tela un panno che invano Zeusi cerca di sollevare. Così sapevano un tempo ingannare e ingannarsi i pittori, e tuttavia se di questo vecchio aneddoto è opportuno qui ricordarsi è perché in questo caso lo sguardo che scopre l’inganno è insieme latore di una nuova decisione percettiva che illumina ciò che percettivamente si dà di una nuova istanza interpretativa. Lo sguardo che cede all’immagine e al gioco del trompe l’œil cerca di cogliere nell’immagine tutto ciò che la anima di una tridimensionalità che non le appartiene, ma non appena la mano svela l’inganno anche lo sguardo corre a cercare ciò che può redimerlo dall’errore: ora, riguardando quel disegno, lo sguardo cade su tutti i particolari che assecondano ciò che il tatto ci ha rivelato e di fatto l’inganno si dissipa e la vista nuovamente vede proprio ciò che la mano tocca.
Ma non sempre le cose stanno così; nel caso dell’esempio del bastone spezzato, non posso vedere diritto il bastone — non posso nemmeno dopo che l’ho toccato e che mi sono accertato del fatto che non vi è alcuna rottura. Meglio di così il remo non posso vederlo, anche se so che lo vedo male e che non è affatto vero che sia spezzato. Qualcosa di simile accade anche nel caso di molte illusioni ottiche. Posso sapere che le sbarrette della Müller-Lyer sono eguali e posso accertarmene in vario modo, ma non posso fare a meno di vedere l’una più lunga dell’altra. Le cose stanno così e non c’è null’altro da fare che accettare di credere che le cose siano diverse da come le vediamo. Di qui una constatazione che è necessario fare: la persistenza dell’illusione e insieme lo stupore che ci pervade di fronte alle illusioni e agli inganni insanabili della percezione ci costringono a riflettere sul fatto che una prospettiva meramente descrittiva è in ultima istanza insufficiente per venire a capo della percezione nel suo complesso.
Qui la nostra percezione del mondo mostra dall’interno i suoi limiti, additando il punto in cui il suo "sapere" non basta più. Vi è un punto in cui l’immagine percettiva del mondo si fa incoerente, ed è in questo punto che dobbiamo armarci di pazienza e comprendere che vi è una diversa nozione di percezione che fa tutt’uno con il sistema delle cause e che ci costringe a prendere atto che questo mondo è solo nostro. Il bastone resta inspiegabilmente piegato, e questa parola — inspiegabilmente — allude già al passo che abbiamo compiuto o che siamo invitati a compiere: ciò che non si può comprendere sul piano fenomenologico si pone come indice della dimensione fisica e psicologica della percezione e ci chiede di abbandonare il terreno della descrizione per riconoscere le ragioni della spiegazione.
Nelle nostre considerazioni sul pensiero di Locke avevamo avvertito il bisogno di sottolineare come la scoperta della dipendenza del nostro esperire dalla natura dei nostri organi di senso si legasse ad una divagazione di natura etica: nella constatazione della dipendenza dell’universo sensibile dalla natura dei nostri sensi risuona ancora percepibile l’eco della scoperta che questo non è il mondo, ma solo il nostro mondo, che così ci appare solo perché di fatto questa è la nostra contingente natura. Nell’affascinato stupore che destano in tutti noi i giochi illusionistici della percezione vorrei dunque invitarvi a scorgere una goccia di metafisica.

Il gambo del fiore immerso nell'acqua appare spezzato in questo quadro di Hannah Höch
Lezione quattordicesima
1. Prima di poter trarre le conseguenze delle nostre considerazioni dobbiamo cercare di dare una risposta all’ultima delle tesi che stanno sullo sfondo del rappresentazionalismo in Locke: la distinzione tra qualità primarie e secondarie. Richiamiamo brevemente il senso delle considerazioni di Locke: per un filosofo cresciuto nell’età della nuova scienza, colori, suoni e sapori non sono proprietà reali degli oggetti, ma dipendono dal modo in cui la nostra sensibilità reagisce alle cose stesse. I colori (i suoni, i sapori, ecc.) non sono nelle cose, ma nella soggettività che le percepisce: è dunque legittimo supporre che ciò che vale per alcune valga anche per tutte le nostre percezioni. Ora, ciò che è vero per il colore è ragionevole attenderselo per ogni altra qualità sensibile, indipendentemente dal fatto che sia o meno un’immagine fedele delle cose stesse: la natura meramente soggettiva delle qualità secondarie vale così come un invito a considerare ogni esperienza come un evento di natura soggettiva, come qualcosa che si dà nella mente del soggetto.
Ho già detto che, in generale, una simile conclusione non mi sembra plausibile: non mi sembra, in altri termini, legittimo sostenere che se una percezione si rivela illusoria, allora deve esistere qualcosa di diverso — un oggetto mentale — dentro di me. E ciò che vale sul terreno delle illusioni, dovrebbe evidentemente valere anche nel caso delle qualità secondarie che non possono quindi arrogarsi il diritto di costringerci a vestire di mentale ciò che percepiamo come obiettivamente presente.
Eppure, anche in questo caso è opportuna qualche cautela, perché non vorrei affatto sostenere che qualità secondarie ed illusioni percettive meritino davvero di essere poste su uno stesso piano. Così vorrei proporvi di riprendere le argomentazioni di Locke (o almeno: alcune delle argomentazioni di Locke) per cercare di vedere verso quale meta esse propriamente ci conducano.
Tra i suoi argomenti, Locke ci invitava a riflettere sulla natura soggettiva delle qualità secondarie proponendoci un esempio divenuto famoso:
Flame is denominated hot and light; snow, white and cold; and manna, white and sweet, from the ideas they produce in us. Which qualities are commonly thought to be the same in those bodies that those ideas are in us, the one the perfect resemblance of the other, as they are in a mirror, and it would by most men be judged very extravagant if one should say otherwise. And yet he that will consider that the same fire that, at one distance produces in us the sensation of warmth, does, at a nearer approach, produce in us the far different sensation of pain, ought to bethink himself what reason he has to say — that this idea of warmth, which was produced in him by the fire, is actually in the fire; and his idea of pain, which the same fire produced in him the same way, is not in the fire. Why are whiteness and coldness in snow, and pain not, when it produces the one and the other idea in us; and can do neither, but by the bulk, figure, number, and motion of its solid parts? (ivi, II, viii, 16).
Il senso di questo argomento è ben chiaro: se la percezione del calore del fuoco trapassa nella sensazione di dolore che avvertiamo solo perché ci facciamo più vicini alla fiamma è perché il calore e il dolore si assomigliano in questo — sono entrambe sensazioni soggettive che non ci parlano della natura dell’oggetto, ma della reazione del soggetto ad una certa datità obiettiva. E proprio come nessuno ritiene che il dolore ci parli della punta del coltello con cui ci siamo tagliati, così sarebbe opportuno non dire che il fuoco è caldo.
Come reagire a questo argomento? Osservando, io credo, che non è affatto vero che il calore del fuoco e la sensazione di dolore stiano in una relazione di continuità, anche se è banalmente vero che al crescere dell’uno possa insorgere l’altra e possa crescere sino a cancellare la mia capacità di rivolgermi ad altro che non sia il mio corpo. Ma le cose normalmente non stanno così: di solito avverto il calore del fuoco e il piacere che me ne deriva, e se mi dispongo alla giusta distanza dalla fiamma non è perché avverta dolore ma perché ho un’esperienza adeguata di quanto il fuoco in se stesso sia caldo. Non è in altri termini vero che normalmente io confonda la sensazione dolorosa della scottatura con la percezione del calore bruciante del fuoco, e prova ne è il fatto che io avverto che il fuoco brucia ed è caldissimo anche se, di norma, non mi scotto affatto. Del resto, lo stesso argomento potrebbe essere ritorto anche contro le proprietà primarie: avverto quanto asia acuminata la punta di un coltello soloi fino a quando la sensazione tattile della forma non viene tacitata dall'avvertimento dolore che la lama provoc in me: il dolore nasconde la sensazione della forma, ma questo naturalmente non vuol dire che una esperienza trapassi nell'altra.
Si potrebbe tuttavia osservare che l’argomento di Locke, al di là della sua forma, allude a un problema effettivo. Le qualità secondarie, si dice, sono paragonabili alle sensazioni di dolore e lo sono proprio perché leggono la natura degli oggetti da cui derivano alla luce della prospettiva della soggettività che le percepisce. E se formuliamo così il nostro problema, abbandonando la determinatezza dell’esempio per tradurlo in una forma più astratta, potremmo dire che tutte le qualità secondarie sono accomunate da un rimando alla soggettività esperiente. Questo rimando può avere forme diverse e diversi gradi: ciò che tuttavia Locke ritiene possibile cogliervi è un segno descrittivo della dipendenza delle qualità secondarie dall’esserci del soggetto percipiente e dal suo essere fatto così. Del resto, verso questa conclusione siamo spinti per Locke anche da un’analogia che rammenta quella dianzi proposta e che ci invita a considerare qualità come il dolce o l’amaro, il giallo o il rosso, il caldo o il freddo come se fossero riconducibili a proprietà come l’essere nutriente o l’essere velenoso — a proprietà che possono essere predicate solo se si definisce quali siano i soggetti esperienti che sono chiamati in causa e rispetto ai quali soltanto quella proprietà può dirsi esistente. Il rosso lo vediamo noi uomini ma non lo vedono i topi, proprio come determinati cibi che per noi sarebbero letali sono invece un accettabile nutrimento per un ratto: ciò che è velenoso è velenoso per noi e non lo è in se stesso, proprio come ciò che è rosso è rosso solo per chi lo percepisce così, poiché i colori non sono una determinazione assoluta delle cose ma il modo in cui a queste reagisce una determinata soggettività percipiente. E ciò è quanto dire che le proprietà secondarie sono qualità che esistono solo in relazione ad un io che le percepisce.
Ora, di fronte a queste considerazioni credo si debbano avanzare alcune perplessità che sorgono innanzitutto dalle frequenti oscillazioni che sono implicite nell’argomentare lockeano. Torniamo al dato su cui siamo invitati a riflettere: non tutti gli animali percepiscono i colori, che sono dunque un possibile segno per caratterizzare il nostro universo visivo. Di qui, tuttavia, non mi sembra lecito muovere a nessuna delle conseguenze che Locke intende trarne. Il fatto che gli uomini, ma non i topi, vedano il rosso non significa necessariamente che i colori siano il modo in cui gli uomini reagiscono psichicamente ad una qualche realtà: potrebbe semplicemente voler dire che vi sono proprietà obiettive che gli uomini, ma non i topi, colgono. Abbiamo già osservato che è questa la via che ci sembra giusto seguire. Quando parliamo del rosso o di qualsiasi altro colore non intendiamo parlare delle nostre sensazioni e non cerchiamo nemmeno di ancorare il significato delle nostre parole alle sensazioni che eventualmente si danno sul terreno della soggettività; il senso della nostra prassi è un altro: ci riferiamo senz’altro a proprietà che attribuiamo agli oggetti e lo facciamo avvalendoci di termini che traggono il loro significato dal rimando ad un insieme di esempi cui spetta una funzione paradigmatica. Il significato è la regola d’uso di un termine, e la regola d’uso ci riconduce ad un certo modo di usare un esemplificazione concreta, non ad una qualche sensazione privata. Di qui la conclusione che intendiamo trarre: per poter usare correttamente la parola "rosso" dobbiamo necessariamente saper distinguere il rosso dagli altri colori e questo naturalmente circoscrive lo spazio di chi può sensatamente avvalersi di quel termine. E tuttavia alludere all’insieme dei prerequisiti che sono chiamati in causa dalla grammatica dei nomi di colore non vuole affatto dire che nel significato dei nomi di colore sia implicito un riferimento a chi questi prerequisiti possiede. Non potremmo parlare del rosso se non fossimo capaci di distinguere questo colore dagli altri, ma il fatto che abbiamo un sistema percettivo che soddisfa questo prerequisito della grammatica dei colori non vuol dire che nel significato della parola vi sia un qualunque riferimento al nostro sistema percettivo. "Rosso" non significa "rosso per me", e nemmeno "rosso per noi", anche se l’utilizzo sensato di quel termine postula la mia e nostra capacità di discernere ciò che è rosso da ciò che non lo è. Ma se le cose stanno così, il rimando analogico a predicati come "velenoso" o a sensazioni come il dolore non può che risultare del tutto improprio. Dire di una cosa che è velenosa significa effettivamente descrivere solo il modo in cui reagiamo ad essa e lo stesso facciamo quando diciamo che il fuoco scotta: in tutti questi casi ci limitiamo ad asserire che, in virtù di una qualche sua proprietà che tuttavia non descriviamo, l’oggetto genera in noi una reazione peculiare — ed è solo quest’ultima che viene indicata. Così se qualcuno ci chiedesse che cosa significa dire che il fuoco scotta, potremmo indicare come si comporta chi ha messo una mano sul fuoco: insegnare a qualcuno ad usare quel termine vuol dire dunque muovere dall’oggetto verso il soggetto che lo esperisce. Diversamente stanno le cose quando a dover costituire materia d’apprendimento è la parola "rosso": in questo caso non vi è davvero bisogno di indicare il comportamento percettivo di nessuno, poiché basta additare un campione di quel colore, facendo affidamento sul fatto che chi l’osserva possa avvalersene secondo la regola d’uso che ci è nota.
Credo che queste considerazioni (che potete almeno in parte leggere in un bel libro di Hacker, intitolato Appearance and Reality) siano sufficienti a chiarire in che senso non ritengo valide le argomentazioni lockeane. E tuttavia prendere commiato da quelle posizioni teoriche vuol dire anche, io credo, mostrare in che senso non sia vero un corollario che può essere dedotto dalle tesi dianzi esposte: la tesi secondo la quale la natura delle qualità secondarie è tale da ricondurre interamente l’essere all’apparire, di modo che non è possibile distinguere tra manifestazioni apparenti e reali di una determinata proprietà. Se una cosa sembra rossa di fatto è anche rossa perché — così si argomenta — nel caso delle qualità secondarie l’essere fa tutt’uno con l’apparire e non può quindi darsi il caso che qualcosa appaia ma non sia così come appare. Certo, talvolta possiamo correggerci in una attribuzione cromatica, ma questo accade — si potrebbe argomentare — solo perché non ci troviamo d’accordo con il giudizio della maggioranza e quindi non perché l’esperienza ci costringa a revocare in dubbio la nostra percezione, ma perché non ci accordiamo sul nome che dobbiamo attribuirle. Per il primo uomo un’esperienza del colore che sia di fatto esposta alla dialettica dell’essere e dell’apparire non può esservi — almeno così deve ragionare chi ritiene che le qualità secondarie siano datità meramente soggettive.
Ma appunto: le cose stanno davvero così? Credo si debba dare una risposta negativa, e per due ragioni strettamente connesse.
In primo luogo non mi sembra vero che non abbia senso pensare ad un’esperienza che ci costringe a rivedere i nostri giudizi sul colore di ciò che ci sta di fronte. Posso ricredermi sul colore di una stoffa o di una parete, e posso essere invitato a farlo: ad una persona che creda di vedere rosso ciò che in realtà non lo è posso dire di guardare meglio e questo consiglio ha un senso proprio perché il colore non è una sensazione privata ma una proprietà obiettiva.
In secondo luogo, poi, riconoscere che possiamo non trovarci d’accordo con altri nell’attribuire ad un oggetto proprio questo colore non significa solamente sostenere che non abbiamo lo stesso standard di riferimento, ed una riprova ne è il fatto che quando ci accorgiamo che un nostro giudizio non collima con quello degli altri non per questo ci interroghiamo fin da principio sullo standard d’uso della parola, ma guardiamo meglio ciò che abbiamo di fronte a noi per vedere se non ci siamo sbagliati. Anche in questo caso, dunque, la percezione cerca sul suo terreno di sanare il dissidio che da essa stessa è sorto, e ciò è quanto dire che nel senso dei processi percettivi che hanno per loro oggetto il colore vi è sufficiente spazio per tracciare il discrimine che separa l’una dall’altra apparenza e realtà.
Le considerazioni che abbiamo sin qui proposto indicano con sufficiente chiarezza quale via dovremmo seguire per rispondere alla strana convinzione di Locke secondo la quale sarebbe legittimo sostenere che un fiore al buio non ha un colore, ma solo la possibilità di suscitarlo in un soggetto percipiente normale quando si diano migliori condizioni di illuminazione.
Ora, non vi è dubbio che quest’affermazione si fondi ancora una volta sulla convinzione che vi sia un’effettiva identità tra colore e sensazione cromatica ed è per questo che potremmo semplicemente liberarcene sottolineando ancora una volta che i nomi di colori non stanno per sensazioni e che una simile ipotesi si scontra da un lato con il senso che attribuiamo al nostro discorrere di oggetti della percezione, dall’altro con la stessa dinamica dell’apprendimento di termini come "rosso", "caldo", "pesante", e così di seguito.
Ora, questo argomento così lontano dal senso comune ci invita ad una riflessione ulteriore che ci porta al cuore della asimmetria che per Locke caratterizza le qualità secondarie. Lo avevamo osservato: per Locke le qualità secondarie sono innanzitutto poteri; ne segue che affermare di una cosa che è rossa significa soltanto asserire che è tale da sembrare rossa a qualcuno che le guardi in circostanze normali. Di qui un’ulteriore conclusione che Locke ci invita a trarre con estrema chiarezza: quando parliamo del potere, insito in una cosa, di apparire così a chi la guardi, dobbiamo riconoscere che ne parliamo sul fondamento di ciò che percettivamente ci appare, poiché solo dall’effetto possiamo in questo caso cogliere quale sia la natura della causa. E tuttavia, anche se dipende nella sua intelligibilità dalla sensazione che suscita in noi, ogni potere ha come suo fondamento una determinazione assoluta, ed il cuore dell’argomentazione lockeana sulle qualità primarie e secondarie consiste propriamente nel sostenere che vi sono idee il cui contenuto sembra legittimare la proiezione dall’apparire all’essere, altre invece — ed è il caso delle idee delle qualità secondarie — in cui un simile nesso non è legittimo. Ma appunto, se la proiezione che ci spinge a sostenere di un determinato oggetto che è rosso è erronea ciò accade perché essa poggia su un unico criterio: diciamo di questo frutto che è rosso solo perché ci sembra rosso, e il suo sembrarci così è l’unica ragione che possiamo addurre per dire che quel frutto è appunto di quel colore. Nel caso delle qualità primarie le cose stanno diversamente: se traccio due segmenti su un foglio e dico che l’uno è più grande dell’altro non dico qualcosa che abbia come suo unico criterio fondante il fatto che così percettivamente ci sembra, poiché è in linea di principio possibile prendere un segmento e riportarlo sull’altro, misurandoli. Per dirla con un altro esempio: per decidere se una ruota è rotonda posso farla rotolare su un piano e stare attento ad eventuali sobbalzi, ma se debbo decidere se è blu non posso fare altro che aprire gli occhi e guardare.
Credo che anche in questo caso considerazioni vere e false si stringano in unico nodo. Ma le considerazioni false decidono la sostanza del problema, e concernono la legittimità della tesi secondo la quale le nostre esperienze percettive sarebbero di fatto il criterio sul cui fondamento sosteniamo che qualcosa è, per esempio, rosso. Non credo che questa sia una descrizione accettabile, e non lo credo perché parlare di un criterio è legittimo solo se ha senso parlare di un’inferenza più o meno fondata, e non mi sembra che possa essere questo il caso del nostro percepire qualcosa di rosso. Un’inferenza implica un terreno di certezze: posso inferire dal fumo che vi è del fuoco, ma appunto del fumo debbo essere immediatamente certo senza doverlo a sua volta inferire. Da qualche parte si deve pur cominciare, ed il carattere della nostra esperienza percettiva è di norma coerente con l’esigenza di costituire un terreno che consenta di sostenere, là ove è necessaria, la prassi delle inferenze. E tuttavia questa prassi non può essere generalizzata e non è difficile scorgere che vi è una differenza descrittiva tra i casi in cui applichiamo un criterio che ci consente di muovere dal nostro percepire un certo insieme di caratteristiche sensibili a qualcosa di diverso da esse e il caso in cui riteniamo di poter muovere dall’apparire così all’essere così. Guardando una persona posso dire che sembra stanca ed in questo caso inferisco la sua stanchezza da molti e diversi tratti del suo viso e del suo comportamento, e per ciascuno di essi avrebbe senso parlarne come di un criterio della stanchezza, poiché di fatto avremmo a che fare con un insieme di caratteristiche percepibili (e percepite) che tuttavia non coincidono con la stanchezza e che sono date senza che si avverta il bisogno di fare affidamento su un criterio qualsiasi. Ma questa situazione descrittiva è di fatto interamente diversa da quella che abbiamo indicato — qui ci si chiede infatti di sostenere che l’apparirmi rosso di qualcosa non sia il criterio per inferire qualcosa di diverso dal colore, ma sia il fondamento su cui far poggiare il mio giudizio che quella cosa è di quel colore. Di qui la conclusione che ci sembra opportuno trarre: l'apparirmi rosso di un cesto di fragole non è una ragione per sostenere che le fragole siano rosse e non ha quindi senso cercare di indebolirla sostenendo che si tratta di un criterio che poggia interamente sulla determinatezza fattuale del nostro sentire. Se vedo rosse le fragole non ho né una buona né una cattiva ragione per inferire che le fragole siano di quel colore: ciò che percettivamente si mostra non è un criterio che mi permetta di giudicare, ma è la forma sensibile entro la quale soltanto si costituisce il riferimento su cui verte ogni mio successivo domandare se le fragole, e cioè questo frutto rosso e profumato, sono davvero rosse e profumate. Prima di potersi porre come un (debole) criterio per affermare l'esser così di qualcosa, la percezione è il luogo in cui quel qualcosa si definisce come un riconoscibile oggetto.
2. Sulle ragioni che ci spingono a non considerare vincolanti gli argomenti che Locke ci propone per difendere la sua dottrina delle qualità secondarie sarebbe forse opportuno soffermarsi ancora a lungo — ma non ne abbiamo il tempo, e dobbiamo dunque accontentarci delle poche cose che abbiamo detto. E tuttavia vi è almeno un punto su cui dobbiamo ancora riflettere e che forse è all’origine di molte delle perplessità che sorgono non appena cerchiamo di lasciare da parte questa vecchia distinzione metafisica: non vi è dubbio infatti che una simile distinzione sia stata tracciata in seno alla scienza e che di questa frattura tra qualità obiettive e soggettive la riflessione scientifica abbia offerto più di una conferma. Si possono avanzare molti dubbi sulla distinzione galileiana tra qualità primarie e secondarie, ma un fatto è relativamente certo: che le scienze hanno cancellato suoni, odori e colori dall’universo fisico e reale e si sono sforzate di parlare esclusivamente il linguaggio delle qualità primarie. I colori non vi sono: vi sono invece onde elettromagnetiche che hanno una determinata frequenza; il caldo e il freddo non ci sono: vi è invece il movimento delle particelle della materia; i sapori non vi sono: vi sono invece determinate proprietà chimiche che agiscono sui nostri organi del gusto, e così di seguito. Perché non rassegnarsi allora al progresso scientifico e perché non riconoscere a quella distinzione una sua legittimità?
Di fronte ad un simile modo di argomentare si potrebbe forse osservare che qualcosa nella descrizione che abbiamo appena proposto è meno nitido di quanto non sembri. In primo luogo dobbiamo avanzare un’obiezione di principio. Quando parliamo di colori e di suoni e quando diciamo della neve che è fredda è soffice ci muoviamo sul terreno della nostra esperienza percettiva e così facendo non intendiamo affatto prendere una qualsiasi posizione sul terreno della fisica. Dire che le fragole sono rosse e la neve è bianca non significa asserire nulla sulla realtà che la fisica vuole indagare, proprio come non vuol dire essere fautori di una teoria geocentrica sostenere che il Sole sorge e tramonta. Anzi, per essere almeno un poco più precisi, del Sole con la lettera maiuscola — della stella intorno a cui ruotano i nostri nove pianeti — non è affatto lecito parlare, almeno sino a quando ci si muove sul terreno del mondo della vita: su questo piano non si parla ancora dei corpi dell’astronomia, e questo semplicemente perché su questo piano non vi è ancora la Terra, ma solo il terreno su cui poggiamo i piedi. Alla stessa stregua, quando diciamo che la neve è fredda e bianca non intendiamo affatto dire qualcosa che vada contro la termodinamica o che neghi la teoria fisica dei colori: vogliamo soltanto dire che così è fatta la neve, e cioè questa cosa che vedo e tocco. Certo, le scienze ci mostreranno che le cose non stanno così, ma come ho provato a sostenere questo non è un buon argomento per dire che sia illegittimo parlare di questo nostro mondo di qualità secondarie, né tanto meno per ricondurre gli oggetti delle nostre esperienze percettive nell’universo chiuso della nostra mente.
Ma vi è anche una seconda considerazione che è forse opportuno proporre. Le scienze matematiche hanno abbandonato le qualità secondarie, ma questo non significa ancora che abbiano davvero sposato le qualità primarie, perché è davvero molto dubbio che lo spazio e i corpi di cui ci parla la fisica possano essere semplicemente ricondotti ai concetti di spazio, di tempo e di materia che la percezione sensibile ci porge. Si potrebbe forse dire di più e osservare che le cosiddette qualità primarie circoscrivono un’idea di corpo che non è poi così priva di contorni antropocentrici, e vi è chi ha osservato che la cosa costruita sulle qualità primarie più che un’entità astrattamente conoscibile è un corpo concretamente manipolabile, quasi che l’idea di spiegazione scientifica che la sorregge sia stata ritagliata sulla base di un modello che l’uomo facilmente comprende, poiché l’agire causale viene ricondotto alla dinamica concreta di un meccanismo, in cui le parti si correlano le une alle altre proprio come le nostre membra fanno forza sugli oggetti su cui esercitiamo la nostra prassi. Lungi dall’essere un’immagine priva di riferimenti al nostro apparato percipiente, l’immagine della cosa disegnata sulla falsariga delle qualità primarie è il soggetto ideale di una spiegazione che non vuole allontanarsi da modelli fortemente intuitivi.
Credo che in queste considerazioni vi sia qualcosa di vero, e tuttavia sarebbe un errore ritenere che di questa distinzione non si debba in alcun modo tenere conto o che essa sia priva di un qualche legame con la dimensione propriamente percettiva. Non vi è dubbio che quando la fisica seicentesca ha sentito il bisogno di distinguere le qualità primarie dalle qualità secondarie si è innanzitutto lasciata guidare da una constatazione importante: lo spazio, il tempo e il movimento possono essere descritti matematicamente ed è in questo caso possibile una matematizzazione diretta di queste grandezze.
Potremmo forse esprimerci così: le qualità primarie sono predestinate al numero. E tuttavia, questa vocazione matematica delle qualità primarie non ci riconduce soltanto ad un fatto che diviene possibile sul terreno della prassi scientifica, ma allude anche ad una dimensione che si manifesta sul terreno dell’esperienza. In questo fatto ci siamo già imbattuti: il colore è oggetto soltanto della vista, mentre posso vedere, toccare e forse anche udire la spazialità — su questo ci siamo a lungo soffermati. Ma sottolineare la molteplice accessibilità dello spazio vuol dire anche sottolineare che già sul terreno dell’esperienza esso si pone come una proprietà che di per sé tende a farsi astratta e a liberarsi dal come della sua manifestazione sensibile determinata. Lo spazio colorato, ombreggiato e prospettico della visione "rinuncia" a queste sue forme intuitive quando la mano sfiora i contorni delle cose e ritrova lo stesso spazio che lo sguardo aveva percorso — lo ritrova, a patto di scindere la dimensione meramente tattile di ciò che gli si mostra dalla sua ossatura formale. Lo spazio può essere colto da più fonti sensibili solo perché nella percezione della res extensa vi è qualcosa che accomuna tatto e vista e che permane come identico polo del riferimento percettivo nel progressivo venir meno delle componenti idosincratiche della percezione. Qui le osservazioni di Locke ci costringono a riflettere su un problema autentico: quando Locke osserva che un cieco non può imparare ad usare la parola "rosso" mette l’indice sulla natura concreta del colore, sul suo essere di fatto inseparabile dal come della sua manifestazione visiva. Ma se un cieco non può imparare ad usare correttamente i nomi dei colori, può invece usare senza errori tutto il vocabolario dello spazio percepito: può parlare di grandezze e di distanze, di alto e di basso, e può distinguere i luoghi grazie alla logica dei deittici. Può naturalmente imparare anche la grammatica del prospettivismo, ma deve in questo caso disporsi sul terreno di considerazioni geometriche relativamente complesse — quelle considerazioni che ci mostrano la dimensione obiettiva che sorregge l’eco soggettiva della dinamica dei punti di vista.
Sullo sfondo di queste considerazioni si pone un problema cui abbiamo più volte alluso — il problema della geometria. La geometria nasce quando la forma intuitiva cede il terreno alla descrizione logica della forma: se Euclide è davvero il padre della geometria non lo è in virtù dei teoremi che portano il suo nome, ma perché per primo ha sentito il bisogno di dire che cos’è una retta e che cos’è un angolo — di dire una volta per tutte che cosa sono queste cose che sembrano così chiare perché in qualche misura le vediamo. E tuttavia anche se la geometria nasce quando la forma si dispiega in una qualche definizione, ciò non significa che non abbia un senso ricordarsi del fatto che la retta di parole che Euclide ci porge ha prima di sé un cammino che si snoda sul terreno dell’esperienza percettiva. Verso quella meta si indirizza già l’esperienza dello spazio che è, proprio come diceva Platone, un concetto bastardo, in cui la percezione si tende verso la dimensione concettuale.
Nel suo porsi come l’identico che permane al di là delle molteplici forme del suo manifestarsi lo spazio guadagna una sua più valida aspirazione all’obiettività, ed in questo caso le considerazioni lockeane sulla dimensione antropologica delle qualità secondarie possono essere recuperate. Le forme spaziali si mostrano come un identico che permane al di là dell'unicità della fonte sensibile che le rende accessibili, ed è in generale vero che dello spazio possiamo parlare "dimenticandoci" del nostro umano sentire così. Non così per i colori: qui vi è davvero qualcosa che li ancora alla nostra esperienza: è dal punto prospettico che ci è stato assegnato che il mondo ci appare nella varietà dei suoi colori.
Del resto, nelle nostre considerazioni sulle argomentazioni lockeane abbiamo spesso avvertito il bisogno di riconoscere che una conclusione che ci era parsa illegittima si legava ad osservazioni su cui vale davvero al pena di soffermarsi. In particolar modo, discorrendo delle qualità secondarie ci eravamo imbattuti in una considerazione interessante: avevamo osservato come non vi fosse altro criterio per decidere se un oggetto ha davvero il colore che ha se non quello di guardarlo, laddove della rotondità di una ruota ci si può convincere anche lasciandola rotolare ed osservando come si comporta. Sulle conclusioni che di qui si volevano trarre avevamo avanzato alcune obiezioni, ma il fatto evidentemente resta: le qualità secondarie non sono causalmente efficienti, laddove le qualità primarie partecipano evidentemente ad una molteplicità di nessi causali. La ruota procede regolarmente perché la sua forma è quella di una circonferenza più o meno esatta, e noi compendiamo con chiarezza la ragione di questo nesso. Non vi è invece alcuna traiettoria che possa dipendere dal colore della ruota che, se non è quello del materiale di cui è fatta, è stato sxcelto per ragioni puramente estetiche.
Certo, è stato osservato che un oggetto nero si scalda al sole e che le pareti bianche tengono fresche le nostre case, ma anche se questo è vero non vi è dubbio che la ragione del nesso ci sfugge e che di un nesso causale non è in questo caso lecito parlare né sul terreno dell'esperienza percettiva, né sul terreno del sapere scientifico. Sul terreno percettivo vi è soltanto una concomitanza che non si dispiega in un nesso evidente, e sul terreno scientifico il colore scompare per far posto a considerazioni che concernono esclusivamente l'assorbimento dei raggi luminosi. E ciò è forse sufficiente per cogliere un margine di verità nella tesi secondo la quale i colori e le altre qualità secondarie non hanno un posto nel sistema delle interazioni causali del mondo — un fatto questo che sembra in effetti testimoniare a favore della loro natura soggettiva.
Così, di fronte a tutte queste considerazioni, è forse opportuno porsi una nuova domanda: vorrei, in altri termini, domandarmi se tra queste qualità non vi sia, già sul terreno fenomenologico, una qualche differenza che renda conto del loro diverso destino. È per questo motivo che alle considerazioni critiche sulla teoria lockeana della percezione vorrei far seguire una rapida discussione delle pagine che Husserl dedica alla costituzione della cosa materiale e quindi anche alla distinzione tra qualità primarie e secondarie.
Si tratta di una discussione complessa che si situa all'interno di un progetto filosofico molto ricco ed impegnativo: Husserl affronta il problema della genesi del concetto di cosa materiale nel (progettato, ma mai definitivamente concluso) secondo volume delle Idee per una fenomenologia pura ed una filosofia fenomenologica, — in un testo, quindi, in cui le preoccupazioni analitiche e descrittive sui stringono già con i progetti filosoficamente pèiùambiziosi della fenomenologia. Ora, di questi progetti che confluiscono nel disegno di una critica fenomenologica della ragione così come del significato complessivo che il metodo fenomenologico proprio in quegli anni assume per il suo fondatore non avremo in queste lezioni l'opportunità di parlare. E non a caso: anche se è necessario essere consapevoli che la fenomenologia per Husserl era questione ben più impegnativa, vorrei avvalermi del metodo fenomenologico come di un metodo degli esempi che ci aiuti a chiarire che cosa propriamente intendiamo quando parliamo degli oggetti della nostra esperienza. Così, addenrtrarci nelle pagine husserliane non vorrà dire ora far luce sul significato complessivo della sua fenomenologia, ma solo riproporre un insieme dui analisi che ci consenta dio dare una formulazione nuova ai problemi che abbiamo sin qui discusso.
Lezione quindicesima
1. Come abbiamo osservato nella lezione precedente, queste ultime lezioni avranno per tema le pagine in cui Husserl si sofferma sulla distinzione tra qualità primarie e secondarie, all'interno di una discussione più ampia sul concetto di cosa materiale.
Ora, parlare di costituzione della cosa materiale vuol dire innanzitutto sottolineare il carattere genetico delle analisi che si intendono proporre. Il progetto husserliano è, sotto questo riguardo, chiaro: parliamo, per esempio, di costituzione della cosa materiale per sottolineare che il nostro percepire un oggetto materiale in quanto tale rimanda ad un processo relativamente complesso, che può essere analizzato e scandito evidenziando una serie di differenti livelli di senso. Certo, parlare di costituzione significa parlare di genesi, e tuttavia ciò non significa affatto che le analisi fenomenologiche possano dirci come di fatto si siano formate nella nostra mente le attese percettive che ci guidano per esempio nella percezione di un sasso, determinando implicitamente il posto che esso occupa all’interno di una più generale ontologia dei fenomeni. La costituzione fenomenologica non è un capitolo di una nuova psicologia filosofica che possa parlarci del come della nostra esperienza senza per questo assumersi l’onere dell’indagine sperimentale; l’obiettivo delle indagini fenomenologiche è un altro: le analisi costitutive debbono assumere la forma di una genesi solo per mostrare quali siano le stratificazioni di senso che sono implicite negli oggetti di cui ci parla. Potremmo forse esprimerci così: noi parliamo di cose materiali, ma l’applicabilità di questo concetto rimanda ad un intreccio di esperienze che aggiungono senso a senso, secondo una regola di composizione che potremmo scorgere se, procedendo a ritroso, impoverissimo l’esperienza che abbiamo delle cose sino al punto di renderle non più adatte a fungere da modello di una cosa materiale. Questo stesso cammino si può tuttavia percorrerlo procedendo nella direzione opposta, seguendo la via di una genesi immaginaria, in cui le esperienze più semplici precedono quelle più complesse, secondo una regola che è dettata solo dallo spessore dell’oggetto di cui si deve rendere conto. Ma ciò è quanto dire che la genesi che Husserl ci propone è una genesi ideale, non una genesi reale: essa concerne il senso dell’oggetto costituito, colto nello spessore delle sue stratificazioni di senso, non la storia reale del suo effettivo porsi come un prodotto della soggettività psicologica.
Credo che queste considerazioni possano aiutarci a non cadere in un equivoco che deve essere sin da principio messo da parte: Husserl parla di costituzione fenomenologica e ci invita insieme a condividere una prospettiva trascendentale, e per quanti significati possano annidarsi nello spessore storico di questo termine una conclusione è comunque legittima: una prospettiva filosofica può dirsi trascendentale se riconduce l’essere all’esperienza che ne abbiamo, qualunque significato poi si attribuisca al come di questa riconduzione. Parlandoci della nostra esperienza delle cose materiale Husserl intende dunque tracciare anche un capitolo di ontologia: l’esperienza della cosa materiale ci mostra quale sia la natura di quella peculiare regione ontologica cui ci riferiamo quando parliamo di oggetti inanimati. E tuttavia accettare la risonanza ontologica e trascendentale del discorso di Husserl non significa ancora assumere una prospettiva propriamente idealistica: anche se Husserl parla di costituzione della natura materiale e ci invita per questo a disporci sul terreno dell’analisi e della descrizione della nostra esperienza percettiva, non intende per questo sostenere che la natura e, in generale, i differenti oggetti della nostra esperienza siano il frutto di una creazione soggettiva, di un fare dell’io che crea i propri oggetti a partire da ciò che si dà sul terreno della coscienza. La prospettiva husserliana è diversa: Husserl ritiene che l’indagine costitutiva abbia una funzione metodica e che sia innanzitutto finalizzata a svelare quale sia il significato che assumono per noi gli oggetti esperiti. Tracciare la genesi fenomenologica della regione "natura" non significa allora indicare quale sia il processo reale da cui la natura sorge: vuol dire invece descrivere la genesi ideale del significato che nella nostra esperienza la natura come regno delle mere entità materiali assume.
Queste premesse sono necessarie, io credo, per addentrarsi nelle prime (ed oscure) pagine del secondo volume di Idee che Husserl scrive nel 1912, pensando di pubblicarlo poco dopo ma che, come tante altre opere fenomenologiche, diverrà tema di continue revisioni, che occuperanno prima Husserl, ma poi anche Edith Stein e Landgrebe, cui in tempi diversi sarà affidato il compito di una pubblicazione che tuttavia non avverrà se non dopo la morte di Husserl.
L’incipit di queste pagine tradisce bene quale sia l’obiettivo che le anima: se la fenomenologia vuole davvero essere una critica della ragione e della conoscenza, deve cercare di rendere conto della struttura e dell’articolazione del sapere scientifico, e nei primi decenni del secolo scorso ciò significa innanzitutto interrogarsi sulle ragioni che rendono conto della distinzione tra le scienze della natura e le scienze dello spirito. Ora questa distinzione deve essere giustificata, e tuttavia ciò che caratterizza l’approccio husserliano al problema consiste nella convinzione secondo la quale alla distinzione metodologica tra scienze della natura e scienze dello spirito deve essere anteposta una differenziazione che concerna la natura degli oggetti così come sono da noi esperiti. In altri termini: la riflessione metodologica deve essere innanzitutto ancorata ad un’indagine ontologica, e questo termine così carico di risonanze filosofiche deve essere inteso in un’accezione di senso peculiare, poiché quando Husserl ci parla di ontologia e di ontologie regionali intende soltanto mettere in luce quali siano le caratteristiche invarianti che appartengono alle diverse tipologie di oggetti di cui abbiamo esperienza. L’ontologia fenomenologica è, in altri termini, il risultato di un’analisi descrittiva, volta a mettere in luce la grammatica dei concetti di cosa materiale, di corpo proprio, di persona. E per intendere la grammatica di questi concetti altra via non vi è, per Husserl, che immergersi nel terreno delle indagini costitutive: il compito della chiarificazione concettuale deve prendere le forme di un’indagine volta a mostrare l’intreccio delle esperienze attraverso le quali sorgono per noi le diverse regioni (la regione materiale, animale, spirituale) in cui si articola l’ontologia fenomenologica — l’ontologia delle cose così come si manifestano nella nostra esperienza.
Come abbiamo più volte osservato, il nostro compito consiste nel cercare di rendere conto della grammatica del concetto di cosa materiale ed il primo passo in questa direzione che Husserl ci invita a compiere consiste nel prendere le mosse dal concetto che raccoglie sotto un unico denominatore le scienze chimiche e fisiche: il concetto di natura. Ora, cercare di precisare l’area semantica di questo concetto significa innanzitutto osservare che la natura in quanto tale è, come dice Husserl, l’universo spazio temporale che, come tale, abbraccia la totalità delle realtà trascendenti. Tutte le cose sono appunto cose nella natura, e ad essa appartengono in virtù della loro determinatezza spaziale e temporale: se la natura ha una sua unità essa deve dunque dipendere innanzitutto da questa duplice caratteristica dei suoi oggetti.
La natura è l’universo di tutto ciò che è spaziale e temporale — questa è la prima definizione che ci viene proposta, ma piuttosto che cercare di fissarne con esattezza il significato vorrei cercare di sottolineare qual è la prima conclusione che di qui possiamo trarre. Del resto, il senso di una definizione si comprende quando diviene chiara quale sia la linea di confine che essa ci aiuta a tracciare, ed è evidente che il rimando alla determinatezza spaziale e temporale esclude alcuni oggetti dall’ambito di ciò che appartiene alla natura: i numeri, per esempio, sono in un qualche senso del termine oggetti ma non sono nello spazio e nel tempo, e lo stesso dicasi per i teoremi geometrici ed in generali per quegli "oggetti" che hanno natura ideale. Per questi oggetti dire "dove" e "quando" significa dire cose insensate: "7+5" no è eguale a 12 qui ed ora, ma in qualsiasi luogo. O più propriamente: il senso di quest'operazione non è ulteriormente determinabile sul terreno dei predicati spaziali e temporali.
E tuttavia questa prima delimitazione del terreno non basta, e Husserl ci invita a segnare un ulteriore confine: per delimitare l’area semantica del concetto di natura
il concetto di oggettività spazio temporale non basta […]. Anzi risulterà anche che non tutti i predicati che in verità vanno attribuiti alle realtà spazio temporali, e che noi infatti attribuiamo loro, ineriscono all’essenza di quell’oggetto naturale che è il correlato dell’idea della scienza naturale (Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, a cura di E. Filippini, Einaudi Torino 1974, vol. II, p. 401 (eventuali cambiamenti nella traduzione non verranno in seguito segnalati)).
L’oggetto delle scienze naturali è una realtà spazio temporale, ma non tutto ciò che siamo soliti attribuire alle realtà spazio-temporali può davvero essere messo nel computo delle cose della natura: vi sono, in altri termini, predicati che attribuiamo alle cose che sono nel tempo, ma che non appartengono per ciò stesso alla natura. Gli esempi sono a portata di mano:
sotto questo profilo è fin da principio evidente che tutti i predicati che noi attribuiamo alle cose sotto il titolo di accettabilità, bellezza, utilità, adeguatezza pratica, perfezione rimangono del tutto fuori considerazione (valori, beni, oggetti diretti a un fine, utensili, buono per qualcosa, ecc.). Questi predicati non riguardano lo studioso della natura, non fanno parte della natura nel senso che il naturalista le attribuisce (ivi, p. 402).
Che le cose stiano così è relativamente ovvio: il fisico può indagare la traiettoria di un corpo lanciato in aria, ma la indaga disinteressandosi della funzione che a quel corpo spetta — che si tratti di un satellite, di un obice o di un pallone da calcio nulla cambia da un punto di vista strettamente naturalistico. Ma appunto: qual è il fondamento di questa astrazione metodica? E più propriamente: nel tracciare questo discrimine lo scienziato si lascia guidare una decisione arbitraria che è esclusivamente fondata nei suoi interessi metodici o segue una regola necessaria che ripete sul terreno teoretico ciò che comunque si manifesta anche sul piano dell’esperienza? Anche su questo punto Husserl non intende abbandonare il dettato dell’obiettivismo fenomenologico:
Ora, questa scienza [la scienza naturale] non è affatto propensa a limitarsi arbitrariamente nella scelta dei suoi oggetti oppure dei predicati che si riferiscono ai suoi oggetti. Piuttosto alla base di essa sta, anche se indefinita, un’idea essenziale della natura. Correlativamente: la coscienza che funge come esperienza scientifico naturale, e quindi anche come pensiero interno all’esperienza scientifico naturale, ha una sua essenziale unità fenomenologica, ed è proprio questa coscienza che ha come suo correlato essenziale la natura; una "appercezione" dominante determina dunque preliminarmente che cos’è oggetto delle scienze naturali e che cosa non lo è (ivi, p. 401).
Di qui il problema che Husserl ci invita a porci: se l’idea di natura è un’idea tutt’altro che arbitraria e se da un lato implica una procedura astrattiva e, dall’altro, non può essere delimitata semplicemente indicando quali oggetti le appartengano e quali no, allora si deve far luce sull’impostazione fenomenologica che sorregge quell’atteggiamento intenzionale che negli oggetti spazio-temporali coglie soltanto ciò che è natura, tralasciando i predicati valutativi, emotivi e pratici. Delineare l’idea di natura vorrà dire allora chiedersi che cosa dia una sua interna unità a quella forma dell’esperire che ci rende sordi a tutti i predicati obiettivi che trascendano la sfera della mera natura.
Rispondere a questa domanda significa rivolgere l’attenzione ad un particolare atteggiamento fenomenologico che Husserl propone di chiamare atteggiamento teoretico. Che cosa Husserl intenda è presto detto: parliamo di atti teoretici in senso stretto per indicare quegli atti in cui non soltanto si avverte ma si constata la presenza di un certo oggetto. Ora, constatare è qualcosa di più che percepire, poiché implica il farsi avanti di un interesse effettivo per l’oggetto esperito. Se entro in un’aula vuota vedo molte cose, ma non è affatto detto che constati qualcosa: lo sguardo può correre sui tavoli e sulle sedie, sulle pareti e sulle finestre senza per questo renderli tema di un’osservazione particolare. Ma perché si dia lo spazio per una constatazione basta poco: ora rientro nell’aula per vedere se è qui che ho dimenticato l’ombrello e di fatto lo vedo appoggiato alla sedia. In questo caso il vedere è mutato di segno, anche se questo naturalmente non significa che ora percepisca un’immagine più nitida o che avverta chissà quale vissuto peculiare: ciò che è mutato non è la qualità sensibile dell’atto, ma nemmeno il suo accompagnarsi ad una qualche altra sensazione che potrebbe comunque aver luogo — per esempio: vedo l’ombrello e mi sento "sollevato" per non averlo di nuovo smarrito. Ciò che di significativo muta non riguarda la dimensione introspettiva del vissuto, ma solo il posto che esso occupa nel contesto della mia esperienza: non appena lo sguardo si fa espressione di un interesse percettivo che lo guida esplicitamente verso una meta, l’esperienza perde il suo carattere di sfondo e guadagna un esplicito riferimento oggettuale. Solo allora ha luogo un constatare: solo quando qualcosa diviene tema di un interesse percettivo che ad esso si rivolge, rendendolo a pieno titolo oggetto della mia esperienza. Ecco, ora apro la borsa e constato che non mi sono dimenticato di quel foglio importante, e se posso esprimermi così non è perché abbia fatto qualcosa di più che vedere se nella borsa il foglio effettivamente vi era, ma solo perché lo sguardo era in questo caso animato da un interesse effettivo e rispondeva ad una domanda particolare che poteva trovare solo nella percezione di quel foglio una risposta.
È per fissare questa differenza che Husserl ci propone di parlare di atti di natura teoretica, osservando come tali atti siano le forme intenzionali in cui effettivamente il soggetto afferra e coglie un oggetto:
In questi atti non soltanto vi è in generale un oggetto per l’io, ma l’io in quanto tale vi si dirige nella forma della constatazione (del pensare, del porre attivamente) e quindi anche dell’apprensione; in quanto "teoretico" l’io è dunque obiettivante in senso attuale (ivi, 403).
Non vi è dubbio che proprio questa sia la caratteristica degli atti teoretici che attira l’attenzione di Husserl: negli atti teoretici l’oggetto è propriamente posto dall’io che lo coglie nella sua datità come tema del proprio interesse, — di un interesse che è intento a cogliere le caratteristiche obiettive della realtà che si vuole conoscere. Se dunque la natura consta di oggetti, gli atti teoretici dovranno insegnarci qualcosa intorno ad essa.
Ora, tracciare una simile distinzione in seno agli atteggiamenti intenzionali non è ancora sufficiente per venire a capo del problema che ci sta a cuore. E la ragione ci è ormai nota: parlare di oggetti, sia pure spazio temporali, non significa ancora disporsi nell’orizzonte della natura poiché — come abbiamo già osservato — vi sono oggetti che da un lato hanno predicati che non appartengono alla dimensione che siamo soliti definire naturalistica ma che, dall’altro, possono egualmente divenire tema di un interesse teoretico. Su questo punto Husserl ci invita ad assumere una posizione molto netta che è fortemente coerente con l’obiettivismo fenomenologico che gli è proprio: quando troviamo bello un libro e buona un’azione non proiettiamo sugli oggetti alcuni predicati relazionali che in realtà descrivono l’eco soggettiva che la percezione delle cose ridesta in noi, ma ci disponiamo propriamente sul terreno obiettivo e costituiamo una oggettività nuova che può essere colta in un atto teoretico ad essa rivolto. Trovare bello un libro non significa dire che vi è un testo che suscita in chi lo legge un certo piacere: significa invece, per Husserl, che nel piacere si avverte una proprietà del libro che può divenire poi tema di un atto ad essa diretto — l’atto che si orienta verso l’essere bello di quel libro. Husserl si esprime così:
la bellezza la colgo intuitivamente nell’oggetto, anche se ciò non accade certo in una percezione sensibile semplice come nel caso del colore o della forma; e tuttavia, la bellezza la trovo proprio nell’oggetto. Il bello non è affatto un predicato di relazione, come accade invece quando di un oggetto dico che mi piace. Il "piacevole", il "lieto", il "triste" e tutti gli altri predicati dell’oggetto di eguale livello nel loro senso obiettivo non sono predicati di relazione che si riferiscano agli atti. […]. Io provo ancora piacere, sento ancora gioia o tristezza ecc., ma invece di essere semplicemente allegro o triste, invece di compiere questi atti emotivi, li traduco, in virtù di una modificazione dell’atteggiamento, in un diverso modo intenzionale: sono ancora vissuti, ma non vivo più propriamente in essi. Io rivolgo lo sguardo verso l’oggetto e — disposto nel mio atteggiamento modificato che si è fatto teoretico — trovo nell’oggetto stesso il correlato di quell’atto emotivo, trovo uno strato obiettivo, sovrapposto allo strato dei predicati sensibili: lo strato del "lieto", dell’oggettivo e obiettivamente "triste", del "bello" e del "brutto", ecc. (ivi, 413-414).
Il senso di queste considerazioni è chiaro: Husserl ci invita a sostenere che è possibile un rivolgimento dell’interesse tale da consentirci di avere esperienza non soltanto di un oggetto che ci piace ma anche della bellezza di quell’oggetto, non soltanto di una situazione che ci addolora, ma della tristezza che le è propria. In altri termini: Husserl sostiene che negli atti emotivi, valutativi e pratici si manifestano alcune caratteristiche obiettive (in una casa il suo essere accogliente, in un tavolo il suo offrirci un piano d’appoggio, in una sera d’estate la serenità, ecc.) che tuttavia possiamo cogliere come un nuovo strato obiettivo in seno alle cose che le fondano soltanto in virtù di uno sguardo nuovo, di un nuovo atto teoretico che invece di vivere nella tonalità emotiva o nell’inclinazione pratica che la situazione o le cose ci suggeriscono si rivolge ad esse, per cogliere nella presenza di quella tonalità o di quell'inclinazione ciò che chiamiamo lieto o triste, utile o inutile.
Ora, parlare di un mutamento dell’atteggiamento intenzionale significa di fatto sottolineare che gli atti teoretici che ci permettono di cogliere come predicati obiettivi il bello e il buono sono atti essenzialmente mediati, poiché presuppongono gli atti pratici ed emotivi da cui traggono origine. Posso cogliere il bello come un predicato obiettivo che appartiene al quadro, ma posso farlo solo perché prima di rivolgermi teoreticamente ad esso ho vissuto la percezione di quel dipinto nella coscienza della soddisfazione estetica. Ha così luogo una modificazione dell’atteggiamento intenzionale: la coscienza non si orienta più verso il godimento dell’oggetto, ma cerca nell’oggetto di cogliere la presenza obiettiva di un valore. Scrive Husserl:
Noi possiamo osservare un quadro "godendolo". In questo caso viviamo nello svolgersi del piacere estetico, di un atteggiamento di apprezzamento che è anche un godere. Ma possiamo anche giudicare "bello" il quadro con gli occhi dello storico o del critico d’arte. Allora viviamo in un atteggiamento teoretico, nell’atteggiamento del giudizio e non più nell’atteggiamento valutativo del piacere (ivi, p. 408).
In questo rimando al costituirsi dei predicati assiologici e pratici negli atti corrispondenti e nel loro essere presupposti dagli atti teoretici che danno statuto obiettivo a ciò che in quelli prende preliminarmente forma, sembra manifestarsi un nuovo punto di contatto con gli atti teoretici che sono coinvolti dall’idea di natura. Non vi è dubbio, infatti, che anche quando rivolgiamo il nostro sguardo per constatare e prendere atto dell’esser così di qualcosa presupponiamo egualmente un terreno di predatità: perché il mio interesse percettivo possa rivolgersi verso una meta determinata è necessario che il terminus ad quem di quel tendere sia già stato predelineato sul terreno percettivo. Per dirla in breve: posso rivolgermi verso un oggetto e renderlo tema del mio interesse solo se quell’oggetto si è già fatto strada nella mia coscienza come una cosa di un certo tipo e ha ridestato la mia attenzione. Per aver voglia di osservare bene qualcosa bisogna averla già vista. Ma appunto: ciò è quanto dire che gli atti teoretici presuppongono gli oggetti cui si riferiscono, anche se non è coinvolto alcun atto pratico o valutativo, — anche se l’oggetto non chiede di essere colto come qualcosa che reca in sé un valore. Scrive Husserl:
bisogna tenere ben presente che inerisce alla peculiarità dell’atteggiamento teoretico e degli atti teoretici […] il fatto che in essi sono come già racchiusi quegli oggetti, che solo in seguito diventeranno propriamente teoretici. Vi sono dunque oggetti costituti anche sul terreno preteoretico, anche se si tratta di oggetti di cui non ci si appropria teoreticamente e che quindi non sono oggetti intesi in senso proprio, né tanto meno sono oggetti di atti teoretici che li determinino (ivi, p. 405).
Basta tuttavia leggere con attenzione le considerazioni che Husserl ci propone per rendersi conto che l’apparente simmetria nella quale ci siamo imbattuti nasconde una differenza significativa che ci riconduce ad una dualità insita nella nozione di obiettivazione e che si manifesta nel diverso rapporto che gli atti teoretici stringono con le predatità da cui sorgono.
Affrontiamo innanzitutto il primo punto e riflettiamo su quale sia il significato che attribuiamo alla tesi secondo la quale una cosa si fa propriamente oggetto per me quando il mio sguardo si dirige verso di essa, rendendola tema di un interesse percettivo. E per farlo muoviamo innanzitutto da un esempio. C’è un sasso che vedo, insieme agli altri ciottoli sul greto del fiume, ma non lo osservo affatto e ciò fa sì che esso non occupi in senso proprio la mia soggettività che non è ad esso rivolta: ma ciò che ora non osservo può ridestare in seguito il mio interesse, e se ciò accade dirò che quel sasso è divenuto oggetto della mia attenzione. Ora, parlare degli atti teoretici e dire che hanno una funzione propriamente obiettivante può significare proprio questo: sottolineare il fatto che alla percezione di sfondo che non si rivolge esplicitamente ad un tema può sostituirsi una prassi attiva ed esplicitamente tematica, e che solo in questo secondo caso la cosa che ci sta di fronte può assumere il senso di un oggetto cui siamo intenzionalmente rivolti. E se le cose stanno così, dire che ciò che osserviamo e constatiamo diviene oggetto in senso proprio non significa null’altro se non questo: che vi è qualcosa — un sasso, una penna, un quadro — cui siamo intenzionalmente rivolti e che, proprio per questo, ci si dà nella forma logica dell’essere un soggetto di possibili predicazioni. Sottolineare la funzione obiettivante degli atti teoretici vorrà dire allora, in questo caso, sottolineare il nuovo posto e la nuova forma che spetta a qualcosa in quanto è posto come un oggetto per la soggettività. Il divenire oggetto è in questo caso una determinazione sintattica: ci dice qual è il posto che qualcosa occupa nella struttura articolata dell'esperienza percettiva.
E tuttavia parlare di obiettività non significa soltanto questo; l’atteggiamento teoretico può assumere una funzione obiettivante in un senso interamente diverso del termine, e per rendersene conto è sufficiente rivolgere lo sguardo a quegli atti teoretici che hanno come loro presupposto atti pratico-valutativi: in questo caso parliamo di obiettivazione per alludere a quel rivolgimento dell’orientamento intenzionale che ci spinge a indirizzare lo sguardo dal modo in cui emotivamente o praticamente l’oggetto si manifesta al che cosa di quel manifestarsi. Ma ciò è quanto dire che l’atto teoretico in questo caso non si limita a rendere tema ciò che comunque era già presente sullo sfondo dell’esperienza, ma si rivolge alla nostra esperienza nel suo complesso per cogliere l’eco obiettiva della nostra partecipazione alla realtà percepita. In altri termini: perché si possa parlare di un oggetto che ha predicati valutativi di vario genere vi è bisogno di una forma di obiettivazione nuova, che dia forma obiettiva a ciò che si manifesta nelle diverse forme del nostro aver cura delle cose. Ed in questo caso, il divenir oggetto non significa acquisire una mera proprietà sintattica: nel nuovo rivolgimento dell'interesse soggettivo ciò che era soltanto un modo di rapportarsi alla cose viene colto come una sua proprietà di secondo lvello, come una sua determinazione assiologica.
Di qui la conclusione che vogliamo trarre: il nesso che lega gli atti teoretici alle datità che sono da essi presupposte conosce due diverse forme, poiché in un caso abbiamo uno stesso oggetto che si manifesta in una forma impropria ed extra tematica e in una propria e tematica, nell’altro due oggetti parzialmente diversi — l’uno è una cosa che è vissuta secondo una determinata coscienza emotiva, l’altro è un oggetto teoretico che ha un predicato assiologico. Ma ciò è quanto dire che in questo duplice significato del concetto di obiettivazione vi è lo spazio per tracciare una distinzione tra quegli oggetti che possono essere resi tali semplicemente sollevandoli dallo sfondo in cui erano posti — gli oggetti della natura, privi di predicati assiologici — e le entità che chiedono un rivolgimento teoretico che sorga dagli atti partico-valutativi, per scorgere il nuovo strato di senso che in essi implicitamente si manifesta — gli oggetti assiologicamente e praticamente determinati.
Di qui, da questa differenziazione tra le forme di presupposizione degli atti teoretici, comincia a farsi strada una prima delineazione della legittimità dell’idea di natura. Gli atti teoretici sono atti in cui qualcosa diviene propriamente oggetto per noi, ma questo processo di obiettivazione può assumere la forma di una mera esplicitazione e tematizzazione di ciò che è dato: gli stessi momenti della cosa che la rendevano meramente presente per noi sono ora oggetto di una osservazione esplicita, volta a scorgere che cosa propriamente li caratterizza. Ma è possibile un diverso scenario: possiamo orientare diversamente il nostro interesse teorico e, senza perdere la presa sugli aspetti che lo contraddistinguono, possiamo rivolgere lo sguardo anche a ciò che in esso traspare in virtù degli atti valutativi e pratici: l’oggetto può apparirci allora come bello, lieto, utile, e così di seguito. Ma questo rivolgimento porta con sé una nuova nozione di obiettività: nel suo aprirsi alla specificità di senso che si manifesta negli atti valutativi, l’oggetto abbandona la dimensione puramente naturale.
Del resto, questo stesso ordine di considerazioni si ripropone anche se indichiamo un cammino lievemente differente. Avevamo osservato che gli atti teoretici presuppongono gli oggetti cui di fatto si riferiscono ed avevamo utilizzato per alludere all’ambito dei presupposti la nozione di predatità. Ora, non vi è dubbio che la catena delle presupposizioni può contenere più anelli: posso rallegrarmi del fatto che tu trovi bella la dimostrazione del teorema di Pitagora, — basta formiulare una proposizione perché il gioco delle concatenazioni si mostri nell'aperta iterabilità dei suoi nessi. Ma per quanto sia lunga la catena, dobbiamo infine poter giungere ad oggettualità che non implichino prima di sé altri oggetti. Ora, l’atto teoretico che ha per oggetto l’essere bello di questo marmo implica necessariamente un atto valutativo che colga in questo marmo il fondamento di un determinato godimento estetico in cui si manifesta implicitamente un nuovo strato di senso dell’oggetto; ma appunto: l’atto valutativo del godimento estetico implica a sua volta, e necessariamente, la presenza percettiva dell’oggetto di cui gode e ciò è quanto dire che gli atti valutativi e pratici sono essenzialmente fondati e che rimandano necessariamente ad atti che si limitano a porre l’oggetto nella sua obiettiva presenza — a porlo, dunque, come qualcosa che sussiste di per se stesso e che non ha bisogno di fondarsi su altre oggettività. Di anello in anello siamo così ricondotti ad oggetti che stanno di per se stessi e che non implicano nel loro senso il rimando ad alcuna precedente esperienza. Ora questi oggetti sono caratterizzati innanzitutto da questo: non hanno alcun predicato di natura assiologica e pratica, e non implicano alcuna costruzione logico-ideale, come accade invece quando abbiamo a che fare con "oggetti" peculiari come i numeri o gli stati di cose. Questi oggetti che non hanno natura ideale e che sono del tutto privi di predicati non reali sono gli oggetti dei sensi — quegli oggetti, il cui essere si scandisce interamente in proprietà sensibili come la forma, il colore, la temperatura, il peso, e così di seguito. Il nesso delle fondazioni ci riconduce così come alla sua base ultimamente fondante alla percezione sensibile:
se noi risaliamo lungo la struttura intenzionale di una qualsiasi oggettività data […], perveniamo […] a oggettività fondanti, a noemata che non contengono più nessun retro—riferimento, giungiamo ad oggetti che sono o possono essere afferrati in tesi semplici e che non rimandano più a tesi, implicite e da riattivare, che contribuiscano alla compagine costitutiva dell’oggetto. Gli oggetti così caratterizzati fenomenologicamente — e quindi gli oggetti originari cui per la loro costituzione rimandano tutti gli oggetti possibili — sono gli oggetti dei sensi (ivi, p. 416).
Possiamo ora circoscrivere meglio che cosa intende dire Husserl quando parla della regione "natura": per Husserl, la sfera della natura abbraccia l’esplicitazione teoretica di quegli oggetti — gli oggetti sensibili — che non hanno bisogno di fondarsi in altre obiettività. Ed il senso di questa definizione non è poi così difficile da cogliere: Husserl ci invita a distinguere sul terreno dell’obiettività l’ambito delle cose reali — la sfera di quegli oggetti che non hanno bisogno di altro per potersi dare e che non esibiscono alcun nesso di fondazione — dall’ambito delle oggettualità pratiche, valutative e categoriali — dall’ambito di quelle oggettualità che non sono immediatamente date e che nel loro stesso senso implicano il rimando ad una prassi soggettiva di esplicitazione. Circoscrivere l’idea di natura vuol dire allora indicare un’unità fenomenologica essenziale: le appartengono infatti gli oggetti che nel loro senso non rimandano al come del loro essere esperiti da una soggettività.
Di qui possiamo muovere per trarre due ulteriori conclusioni. La prima risulta con immediatezza da ciò che abbiamo appena detto: se gli oggetti reali della natura appartengono all’ambito di ciò che non implica nel suo darsi alcun rapporto di fondazione, allora si può sostenere che l’ontologia regionale della cosa materiale occupa necessariamente il primo posto nel campo delle considerazioni ontologiche. Ma vi è anche una seconda conclusione di carattere più ampiamente metodologico che di qui può essere tratta: per venire a capo dell’idea di natura, Husserl ci invita a tornare sul terreno dell’esperienza percettiva, poiché è qui che abbiamo imparato a compitare la grammatica filosofica del concetto di cosa materiale.
2. Il risultato cui siamo sin qui giunti non è soltanto interessante perché ci permette di dare un significato più preciso a ciò che Husserl intende quando parla dell’idea di natura e quando osserva che essa possiede una sua essenziale unità fenomenologica, ma anche perché addita il camino che le nostre analisi dovranno seguire: la comprensione del concetto di natura ci ha infatti sospinti verso il terreno della percezione sensibile nella sua immediatezza — verso la percezione di oggetti che hanno soltanto le caratteristiche che si annunciano in una percezione sensibile semplice che non si fonda su altre percezioni, orientandone diversamente il significato.
Su questo tema dovremo tra breve tornare. Ora tuttavia dobbiamo affrontare una possibile obiezione che forse si sarà già fatta sentire. Husserl ci invita a prendere le mosse dagli oggetti meramente sensibili, ma non è difficile rendersi conto del fatto che le nostre percezioni non sono mai del tutto prive di una qualche eco pratica o emotiva. Se entro nella mia stanza e guardo ciò che la occupa vedo libri, sedie, tavoli e un computer e ciascuno di questi oggetti è innanzitutto caratterizzato da un significato d’uso che gli spetta necessariamente, proprio come gli spetta una certa coloritura affettiva: quei libri sono i miei libri, ed anche quando non mi dicono nulla, il loro "non dirmi nulla" è una peculiare connotazione affettiva. Anche l’indifferenza è un predicato valutativo ed allude quindi ad un orizzonte grammaticale che in linea di principio dovrebbe essere assente dalle cose della natura, così come Husserl la delimita. Ma se le cose stanno così, non dovremmo semplicemente dire che una mera natura semplicemente non c’è e che l’essere non è mai nella forma della mera presenza?
La risposta è semplice: non dovremmo affatto, e non perché sia possibile che davvero vi sia una soggettività capace di dimenticarsi ogni atteggiamento valutativo per avere di fronte a sé il mondo delle mere cose. Ancora una volta non è una questione empirica quella che ci interessa, ma una possibilità grammaticale, e questa possibilità non può essere messa da parte semplicemente additando la difficoltà di dare ad essa una veste reale. Una circonferenza è una linea chiusa i cui punti sono equidistanti da un punto. Bene, ora lo sai, ma questo non significa che tu sia per questo in grado di disegnarla, nemmeno con il compasso. Ma sarebbe ridicolo a partire di qui sostenere che di circonferenze non si deve parlare.
Forse una simile argomentazione può convincerci, anche se sembra suggerirci una conclusione in tono minore: forse si può parlare di mere cose, ma non si può per questo dimenticare che si tratta di astrazioni, con cui raramente abbiamo a che fare. Nulla ci impedisce di parlare di un’idea di natura, ma il luogo di questo discorso è il cielo lontano delle astrazioni. Un discorso plausibile ma falso, poiché dimentica il fatto che il senso implicito in molte delle nostre azioni ritaglia un significato meramente cosale negli oggetti. Il vento sposta i fogli sul tavolo, ed io li fermo con un libro — ma anche se si trattasse della Critica della ragion pura nel senso di quella prassi non vi sarebbe nulla di più che il peso che la caratterizza. E ancora: un bambino può essere molto orgoglioso nel misurare la sua altezza perché di lì si comprende quanto sia cresciuto; l’orgoglio del diventar grandi si avvale tuttavia di un metro che mostra in generale soltanto questo — che è possibile far combaciare in due punti distinti gli estremi di due corpi. E ciò è quanto dire: il fatto che le mere cose appartengano ad una dimensione astrattiva non le rende per questo meno presenti nella vita quotidiana.
Credo che il senso di queste considerazioni possa essere facilmente compreso, e tuttavia è forse opportuno osservare che è proprio qui la ragione per cui Husserl parla di atteggiamento teoretico e non soltanto di atti teoretici. Quando siamo nell’atteggiamento teoretico siamo prevalentemente rivolti verso le cose, ma questo non significa che tutti gli atti valutativi siano messi da parte o che non vi siano istanze pratiche: vuol dire solo che non sono esse a tracciare il canovaccio che ci guida.
Così scrive Husserl: nelle ricerche di ordine teoretico
noi siamo atteggiati teoreticamente, anche se nello stesso tempo possiamo realizzare intenzioni spontanee e vivissime di piacere; per esempio durante ricerche ottico-fisiche possiamo provare un intenso sentimento di piacere per la bellezza dei fenomeni che si vanno manifestando. Inoltre sullo sfondo si possono prendere anche decisioni, per esempio la decisione di mostrare ad un amico la bellezza di quei fenomeni, anche se noi non siamo ancora nell’atteggiamento pratico e continuiamo a mantenere e a perseguire il "tema" dell’atteggiamento teoretico (ivi, p. 412).
Il disporsi in un atteggiamento piuttosto che in un altro non vuol dire allora fingere di tacitare ogni diverso interesse: vuol dire soltanto dare un peso maggiore alle voci dell’esperienza che sono con esso coerenti.
Lezione sedicesima
1. Possiamo ora rivolgere la nostra attenzione alla nostra esperienza percettiva delle cose materiali, per indicare passo dopo passo quali siano i livelli costitutivi che le sono propri.
A dire il vero Husserl ci invita ad una distinzione preventiva di cui dobbiamo rendere conto. Il primo passo consiste nell’osservare che ciò che chiamiamo "natura" va al di là della sfera delle mere cose: la natura abbraccia infatti sia le cose materiali, sia gli esseri viventi cui pure spetta il titolo di entità reali, di enti che appartengono al nostro mondo.
Ora, che questo modo di intendere l’universo delle cose naturali non sia arbitrario lo si ricava innanzitutto da una considerazione di carattere generale: le cose materiali e gli esseri animali appartengono comunque all’ordine del tempo ed occupano nel suo unitario ordinamento un posto definito, che non spetta invece agli oggetti ideali. Le cose reali della natura hanno dunque un posto nel tempo:
qualsiasi essere del tipo "cosa" ha un’estensione temporale; ha una propria durata, e si articola saldamente, insieme con la propria durata, nel tempo obiettivo. Quindi, insieme con la sua durata, ha un posto ben stabile nel tempo unico del mondo che è una forma generale di esistenza di qualsiasi cosalità. Tutto ciò che la cosa altrimenti "è", tutto ciò che le spetta in base alle altre determinazioni essenziali, è nella sua durata, è con la precisa determinazione di un quando. È giusto quindi distinguere tra la determinazione temporale (tra la durata della cosa) e la caratteristica reale, che come tale riempie la durata e si estende attraverso di essa (ivi, p. 426).
Da queste considerazioni si possono dedurre molte cose, ed in modo particolare si può dedurre che è nella natura delle cose la possibilità del cambiamento. Ma la conclusione che deve essere tratta è un’altra: Husserl vuole infatti mostrarci che tutte le cose sono reali perché hanno un posto nell’unico tempo nel mondo che ci appare così come la forma che è presupposta da ogni cosa o da ogni evento, indipendentemente dal suo appartenere alla natura materiale o animale.
Accanto al tempo vi è poi lo spazio, ed anche in questo caso si deve rammentare che
qualsiasi essere del tipo "cosa" ha nello spazio del mondo una sua posizione che è relativa a quella di tutte le altre cose e che è in linea di principio modificabile (ivi, p. 427).
Al momento dell’eguaglianza si deve tuttavia affiancare la constatazione della differenza, e Husserl ci invita a constatare che un essere animato è sì nello spazio, ma solo perché ha un corpo: il mio essere un individuo è un fatto che è sì localizzato e ancorato ad un luogo, ma che non si distende nello spazio come accade invece al colore o al peso di un oggetto qualsiasi. Quando pronuncio la parola "io" alludo a qualcosa che è sì localizzata nello spazio e che è proprio là dove è il mio corpo, ma questo non significa che il mio essere un io sia una proprietà che riempia lo spazio come un colore "riempie" la superficie degli oggetti. Scrive Husserl:
riguardo all’estensione corporea occorre distinguere tra la cosalità materiale e la cosalità della natura animale. Non senza ragione Cartesio definisce l’extensio un attributo essenziale della cosa materiale che, proprio per questo, si dice anche semplicemente corporea rispetto all’essere psichico o spirituale, il quale nella sua spiritualità, non ha un’extensio e anzi la esclude per essenza (ivi, p. 427).
Di qui dovremmo muovere, secondo Husserl, per tracciare con maggiore chiarezza la distinzione tra realtà materiali e natura animale.
Non è tuttavia questa la meta che ci proponiamo, e del resto lo stesso Husserl ritiene che di questo breve accenno alla definizione cartesiana della sostanza attraverso il predicato dell’estensione ci si debba avvalere non tanto per tracciare un discrimine tra gli ambiti della natura cui abbiamo alluso, quanto per cogliere una caratteristica fenomenologica essenziale delle cose materiali. Dobbiamo, in altri termini, interrogarci sulla dimensione fenomenologica che spetta alla tesi cartesiana della res extensa.
Affrontare una simile tesi significa chiedersi quale sia la natura della relazione che stringe tutto ciò che chiamiamo "cosa", e che le appartiene, all’estensione che necessariamente le spetta. Ora, il primo passo in questa direzione consiste, per Husserl, nel dire che cosa dobbiamo intendere quando parliamo dell’estensione di una cosa. Una prima ipotesi deve essere fin da principio messa da parte: quando parliamo di estensione in relazione ai corpi non intendiamo, per Husserl, alludere semplicemente ad una parte dello spazio in cui casualmente vi sia qualcosa. L’estensione di un corpo non è una superficie o un volume, non è in altri termini una parte dello spazio, ma è una parte della cosa, un suo (necessario) attributo. L’estensione è, per essenza, spazio riempito, ed è per questo che Husserl ci invita a parlarne come di una Raumkörperlichkeit, di una corporeità spaziale o, se si vuole, di una spazialità che si è fatta corpo.
Le ragioni di questa prima mossa sono evidenti - se ci si dispone sul terreno fenomenologico. Dal punto di vista percettivo la partizione dello spazio è innanzitutto dettata dalla presenza dei corpi: perché si possa parlare di estensione sul terreno percettivo debbo poter vedere o toccare un corpo che occupi lo spazio, circoscrivendo così un luogo che si contrappone al vuoto che lo circonda. Ma se l’estensione è lo spazio di un luogo, un luogo vi è solo là dove vi è anche un corpo: la nozione di estensione ci invita dunque a riflettere su quella corporeità spaziale di cui Husserl così insistentemente ci parla.
Non vi è dubbio che in questa prima caratterizzazione del concetto di Raumkörperlichkeit sia innanzitutto all’opera l’esigenza teorica di non disgiungere l’estensione dalla cosa, e tuttavia proprio l’evidenza di questo intento teorico non deve spingerci verso un possibile fraintendimento su cui è forse opportuno indugiare un attimo. Le cose che vediamo hanno una loro estensione: occupano appunto un certo spazio che ha una sua determinata ampiezza e che è fissato dai confini ultimi del corpo cui appartiene. Ora se immaginiamo di accrescere o di diminuire la mole dell’oggetto muterà anche la sua estensione: lo spazio occupato varia evidentemente con la grandezza dell’oggetto. Ma che dire se decidiamo di muovere l’oggetto e se mutiamo quindi il luogo che lo ospita? Una prima risposta potrebbe suonare così: quando un corpo si muove non muta la propria estensione che, per così dire, è così strettamente legata alla materia da poterla seguire nei suoi spostamenti. Basta tuttavia riflettere un poco per rendersi conto che un simile considerazione presuppone una considerazione astratta dell'estensione che viene ridotta alla sua componente meramente relazionale: l’estensione è solo quell’identico rapporto tra i limiti che circoscrivono il corpo, al di là della variazione del luogo che essi delimitano. Perché questo è chiaro: quando un corpo si muove non può portare con sé lo spazio su cui si estende, e ciò è quanto dire che ogni spostamento di un corpo implica una modificazione dell’estensione. Muovendosi, la cosa muta la propria estensione proprio perché muta il proprio luogo, che non può seguirla poiché in generale nessuna parte dello spazio può muoversi:
per essenza, né lo spazio stesso, né un pezzo dello spazio può muoversi; lo spazio stesso non può mai presentare una lacuna, cioè un punto vuoto di spazialità, un punto che possa riempirsi soltanto quando vi si introduca qualche cosa. Lo spazio è assolutamente "rigido", le sue parti non sono "estensioni" nel senso che abbiamo definito, non sono "corpi" per esempio corpi rigidi nel senso della fisica (ivi, p. 428).
Di qui la definizione di estensione che Husserl ci propone - una definizione che, come abbiamo osservato, tende a ricondurre il concetto di Raumkörperlichkeit alla nozione di luogo occupato, di spazio sensibilmente riempito:
per estensione spaziale o meglio corporea di una cosa intendiamo la corporeità spaziale che inerisce alla sua concreta compagine essenziale, esattamente nel modo in cui le inerisce, nella sua piena determinatezza; così, non soltanto qualsiasi cambiamento di grandezza che lasci intatta la forma spaziale comporta una modificazione dell’estensione, e così qualsiasi modificazione della forma che lasci intatta la grandezza, e qualsiasi deformazione, in qualsiasi senso si assuma questo termine: anche ogni mutamento di posizione comporta un mutamento dell’estensione (ivi).
Ora, in questa definizione è implicita una prima determinazione del modo in cui l’estensione si rapporta alla cosa: Husserl ci invita infatti a pensare all’estensione come allo scheletro e all’impalcatura sensibile su cui percettivamente si danno e in cui si fondano le differenti qualità sensibili di cui la cosa consta.
Per trarre questa conclusione Husserl richiama innanzitutto la nostra attenzione sulla possibilità ideale della frammentazione che così evidentemente caratterizza le cose materiali. Questa proprietà è, per Husserl, una proprietà essenziale dell’estensione, e di questo fatto ci accorgiamo se ci rammentiamo del fatto che lo spazio è di per sé divisibile in parti che non smarriscono la loro natura spaziale.
Ma appunto: l’estensione non è una parte di spazio, ma è spazio occupato da un corpo. Ne consegue che la divisibilità dello spazio assume nella Raumkörperlichkeit la forma della frammentazione: proprio perché ogni corpo ha una sua estensione e proprio perché l’estensione si fonda nella divisibilità dello spazio, si può affermare che per ogni cosa materiale è idealmente possibile una frammentazione, e che a sua volta la frammentazione conduce a parti che sono in linea di principio (anche se non necessariamente in linea di fatto) ulteriormente frammentabili. Scrive Husserl:
l’essenza stessa dell’estensione comporta la possibilità ideale della frammentazione. È evidente che qualsiasi frammentazione dell’estensione comporta una frammentazione della cosa stessa, fa sì cioè che la cosa si scomponga in parti, ciascuna delle quali ha a sua volta un carattere pienamente cosale, il carattere della cosalità materiale. Viceversa, qualsiasi suddivisione della cosa in cose, qualsiasi frammentazione della cosa come tale, frammenta anche l’estensione cosale (ivi, p. 428).
Il cammino che abbiamo indicato ci ha permesso di leggere la possibilità della frammentazione della cosa alla luce della divisibilità dello spazio in cui è sita. La divisibilità, tuttavia, non è identica alla frammentazione: lo spazio si può dividere, ma non si può frammentarlo, perché non è una cosa e non può quindi andare in pezzi e disperdersi in una molteplicità di nuove cose. La divisione dello spazio conduce alla definizione di una molteplicità di parti che tuttavia rimangono in seno ad un identico spazio che non viene meno nella prassi della segmentazione: le parti dello spazio sono nello spazio, che non è affatto tolto dalla sua partizione. Nel caso della frammentazione, invece, la cosa viene meno e al suo posto si danno nuove cose - nuove parti reali che valgono ora come nuovi oggetti.
All’origine di questa diversità vi è, naturalmente, ciò che di nuovo è implicato dalla prassi della frammentazione: il suo riferirsi non allo spazio ma alla corporeità estesa, a quello spazio realmente riempito che sta a fondamento del concetto di cosa. Ma ciò è quanto dire che la possibilità della frammentazione è un indice puntato sulla differenza tra spazio e Raumkörperlichkeit: nella frammentazione ci si mostra che cosa lo spazio è diventato quando si è fatto corporeità spaziale. Ma vi è di più: quando qualcosa si rompe e va in pezzi ci si mostra anche che cosa accada alla cosa come insieme di proprietà quando ne modifico una - l’estensione corporea. Il colpo di cesoia che recide il ramo modifica innanzitutto la forma della pianta, ma insieme è il gesto che crea un nuovo oggetto: il ramo che cade.
Di qui si deve muovere per cogliere la particolarità dell’estensione corporea che non è affatto una proprietà tra le altre, proprio perché non si somma a proprietà come il peso o il colore, ma sta prima di esse, poiché si pone come il sostrato su cui esse poggiano. La possibilità della frammentazione mostra proprio questo: che vi è una prassi concreta che, agendo sull’estensione, frantuma la cosa in una molteplicità di cose, laddove non esiste alcuna prassi che possa mettere capo ad un analogo risultato operando sulle altre qualità dell’oggetto. Posso modificare il colore di una cosa senza che questo debba necessariamente alterare la forma o levigatezza che le compete, proprio come posso modificarne la consistenza e il peso senza che sia per questo lecito pensare che debbano necessariamente modificarsi le altre proprietà dell’oggetto, estensione compresa. Ma se un piatto cade e va in frantumi, il frammentarsi dell’estensione porta necessariamente con sé il venir meno dell’unità dell’oggetto e il suo disperdersi in una molteplicità di cose materialmente determinate: in questo caso la prassi che agisce sulla cosa, alterandone l’estensione, porta con sé un mutamento che coinvolge necessariamente tutte le qualità dell’oggetto che vengono ad appartenere a nuove entità materiali.
All’immagine empiristica che vuole ricondurre la cosa percepita ad una mera somma di qualità (di idee nel senso lockeano) si deve così contrapporre la consapevolezza che la funzione e la posizione della corporeità estesa nell’unità della cosa materiale non è affatto paragonabile alla funzione e alla posizione delle altre qualità reali che le si attribuiscono. Ma ciò è quanto dire che l’estensione corporea - la Raumkörperlichkeit - non è affatto una proprietà tra le altre:
In altre parole: la cosa non è un che di esteso soltanto in questo senso, e cioè che tra altre determinazioni possiede anche quella determinazione che chiamiamo estensione corporea; è vero piuttosto che la cosa in tutto e per tutto ciò che contenutisticamente è (in tutto ciò che concerne il suo essere di sostanza che riempie il tempo così come nelle sue caratteristiche) si estende ed è qualcosa che riempie la sua estensione corporea (ivi, p. 428).
Il senso di quest’osservazione è chiaro. Le cose materiali non sono pesanti, colorate ed anche estese, poiché il loro essere colorate e pesanti si dà solo come il modo qualitativamente determinato secondo cui l’estensione si dà. E correlativamente: le cose non sono colorate, pesanti ed estese, poiché coloratezza e pesantezza sono tali solo nel loro estendersi, nel loro disporsi nella forma dell’estensione che non è dunque una proprietà tra le altre ma è la struttura che permette ad ogni determinatezza della cosa di manifestarsi.
Così, a partire dalla prassi della frammentazione, si mostra come vi sia una differenza effettiva tra la determinazioni reali della cosa e quella sua peculiare determinatezza che è l’estensione corporea. Queste proprietà debbono essere chiaramente distinte poiché non stanno sullo stesso piano - le proprietà reali della cosa si danno infatti come riempimenti dell’estensione, come suoi plena sensibili. Da una parte avremo allora le determinazioni estensive della cosa (la grandezza, la forma, la figura e, in generale, tutte le determinazioni concretamente geometriche della Raumkörperlichkeit), dall’altra le qualità reali della cosa stessa che si danno come le forme concretamente sensibili della sua forma corporea.
Ora, in queste considerazioni non è difficile scorgere il terreno per tracciare una distinzione che ci è già nota. Da una parte, infatti, abbiamo la Raumkörperlichkeit che determina la struttura formale della cosa e che ne costituisce l’impalcatura fondamentale, dall’altra vi sono le sue qualità reali che si danno come riempimenti della sua struttura, come sue forme di qualificazione. Da una parte abbiamo dunque le qualità primarie, dall'altra le qualità secondarie:
la cosa non conosce altre determinatezze estensive se non la pura corporeità (qualità primaria) e le qualità sensibili che la modificano, le qualità secondarie "qualificanti" (ivi, p. 429).
Quest’affermazione merita una parola di commento. Husserl parla di qualità primarie e di qualità secondarie, ma è evidente che il riproporsi di questa distinzione in questo contesto non allude più ad una distinzione che corra tra il mentale e il reale, poiché nulla è più lontano dalla prospettiva husserliana della tesi secondo la quale colori e sapori sono determinazioni che si giocano sul terreno della soggettività. Dire che il colore o il peso sono qualità secondarie non significa, per Husserl, sostenere che siano determinazioni mentali; vuol dire invece alludere al diverso ruolo che le determinazioni estensive giocano nel processo di costituzione della cosa - un ruolo che, come abbiamo visto, si manifesta nella possibilità pratica del frazionamento. Se prendo un foglio di carta e lo faccio a pezzi, le proprietà dell’intero si ritroveranno nelle parti, e ciò è quanto dire che vi è un’asimmetria tra l’estensione e le altre proprietà della cosa: in un caso abbiamo proprietà il cui cambiamento non incide sul come dell’estensione, dall’altra una Raumkörperlichkeit la cui variazione si ripercuote sulle proprietà che ospita e che su di essa si estendono. La distinzione tra qualità primarie e qualità secondarie deve essere dunque riformulata in una distinzione concernente le qualità riempienti da un lato e la struttura spaziale che le sorregge dall’altro:
ogni qualità corporea di una cosa "riempie il corpo spaziale", in essa la cosa si espande, ed in ciascuna la cosa stessa riempie la propria corporeità (estensione) che in uno stesso punto del tempo è la stessa per ogni diversa qualità reale. E ciò che vale per l’intero, vale anche per le parti. In modo particolare, qualsiasi cosa è diversa dalle altre, ognuna può avere una sua diversa estensione spaziale, e questa estensione può a sua volta riempirsi qualitativamente in diversi modi; il riempimento dello spazio […] può essere diverso, a seconda della specie delle caratteristiche e a seconda del fatto che siano presi in esame qualità durevoli o meri stati reali […]: ma il tipo generale è sempre e necessariamente lo stesso. Per qualsiasi specie di qualità si deve dire che essa può avere i suoi modi particolari di riempire la corporeità spaziale, di coprirla, di estendersi in essa. Ma qualità riempiente lo è necessariamente. La cosa non conosce altre determinatezze estensive se non la pura corporeità (qualità primaria) e le qualità sensibili che la modificano, le qualità secondarie "qualificanti" (ivi, p. 430).
Ora, non è difficile scorgere in questo rapporto un nesso di dipendenza che lega le determinazioni estensive della cosa alle sue determinazioni qualitative, e tuttavia se riflettiamo su questo nesso sembra possibile trarre una conclusione che tende a riproporre una sostanziale simmetria in seno alle determinazioni che in generale spettano alle cose in quanto tali: proprio come il colore non può esistere senza un’estensione che lo sorregga, l’estensione della cosa non può essere priva di determinazioni riempienti, e non è in generale pensabile se non come una corporeità spaziale determinata. Il nesso di fondazione è un nesso bilaterale e questo sembra convincerci dell’opportunità di lasciare da parte il richiamo a quella distinzione metafisica cui stiamo da tempo dedicando le nostre attenzioni.
Non credo che questa conclusione sia legittima. Certo, un’estensione senza plena non è pensabile, ma questo non significa che vi sia davvero un rapporto di simmetria tra forma estensiva e qualità riempienti. E la ragione ci è nota: ogni forma riempiente rimanda all’estensione che la sorregge e in cui necessariamente ogni proprietà reale della cosa si distende, laddove l’estensione - per poter assumere una sua Raumkörperlichkeit - ha bisogno soltanto di un rimando ad un qualche riempimento. Un’estensione corporea che fosse priva di qualsiasi proprietà sarebbe propriamente un nulla: possiamo parlare di estensione della cosa distinguendola dalla mera datità dello spazio solo perché, in quanto spazio di un corpo, l’estensione è qualitativamente determinata e si pone come un che di reale. Ma se è vero che l’estensione corporea chiede di fungere da sostrato di una qualche determinazione reale, ciò non toglie che essa non rimandi in sé ad una qualche proprietà determinata: un colore deve essere necessariamente esteso, ma un’estensione non deve essere necessariamente colorata, come ci insegna il fatto che possiamo senz’altro esperire tattilmente l’esserci di un corpo esteso. Ancora una volta: la peculiarità delle determinazioni estensive della cosa non è nel loro essere una proprietà reale che stia accanto alle altre e che sia rispetto ad esse privilegiata dalla possibilità di occorrere da sola. La Raumkörperlichkeit non è un primus inter pares: non è la più importante tra le proprietà della cosa. La tesi di Husserl è diversa: la differenza tra qualità primarie e secondarie è tutta sita nel porsi delle determinazioni estensive come fondamento delle proprietà qualitative, come forma che è da esse necessariamente implicata e che fa tutt’uno con l’esserci della cosa e con la sua possibilità di porsi come un sostrato di proprietà. Le determinazioni estensive sono proprietà primarie perché su di esse si fonda la possibilità della cosa di avere una sua determinatezza empiricamente rilevante, e ciò è quanto dire che l’estensione corporea è la condizione essenziale su cui poggia la possibilità della cosa di essere ciò che è - di avere le qualità che ha. Ne segue che la Raumkörperlichkeit non è una proprietà reale, ma è il fondamento reale della determinatezza dell’oggetto, di quel suo essere così che è tale solo in virtù del suo esser una modificazione della forma essenziale dell’oggetto - la sua corporeità estesa. All’estensione corporea come livello zero della determinatezza della cosa si sovrappongono così le qualità di primo livello che di fatto sono modi in cui la corporeità estesa di fatto è: il rosso sarà così l’esser rosso di questa superficie, la pesantezza una determinazione che pervade le parti di un determinato volume, la durezza la resistenza che un corpo oppone alle forze che tendono a modificarne la forma, e così di seguito. Scrive Husserl:
naturalmente l’estensione corporea non può mai stare da sola, la sua particolare posizione non è quella di una qualità reale tra le altre. La cosa è ciò che è nelle sue qualità reali, che prese singolarmente non sono tutte nello stesso senso necessarie; ciascuna di esse è un raggio dell’essere della cosa. Ma l’estensione corporea non è in questo stesso senso un raggio dell’essere reale, non è in eguale modo ("propriamente non è") una qualità reale ma è una forma essenziale di tutte le proprietà reali. Ne segue che un corpo spaziale vuoto realiter è un nulla, e propriamente è soltanto in quanto una cosa con tutte le sue proprietà reali vi si estende. Più propriamente: il corpo è una determinazione reale, ma è determinazione fondamentale solo in quanto è fondamento essenziale e forma di ogni altra determinazione. In questo senso, l’estensione anche se, o meglio: proprio perché è "proprietà reale" in un senso del tutto differente dal consueto, può dirsi la caratteristica essenziale della materialità (ivi, p. 430).
Di qui la legittimità della riconduzione della differenza tra determinazioni estensive e determinazioni "riempienti" alla distinzione classica tra qualità primarie e secondarie può dirsi chiarita nelle sue linee essenziali, anche se - proprio da questo chiarimento - risulta evidente come il suo senso sia propriamente cambiato. Nel distinguere tra qualità primarie e secondarie Husserl sembra avere in mente innanzitutto un problema di ontologia fenomenologica, e non ancora una questione concernente le scienze fisico-naturali. Così, distinguere tra l’estensione e le determinazioni reali e qualitative dell’oggetto significa in primo luogo, per Husserl, invitarci a riflettere sulla natura delle cose materiali, sulla forma che dobbiamo attribuire a questo concetto e sul senso che è racchiuso nella sua grammatica.
Nella sua Critica della ragion pura, introducendo la sua distinzione tra giudizi analitici e sintetici, Kant ci invitava a distinguere tra la proposizione "tutti i corpi sono estesi" cui si deve attribuire valore analitico, e la proposizione "tutti i corpi sono pesanti" la cui natura è sintetica e implica l’operare trascendentale dell’intelletto. Ora, di fronte ad una simile distinzione si possono avanzare molti dubbi che nascono in parte dalla tesi che si possa davvero definire l’analiticità nella forma kantiana - analitico è per Kant quel giudizio in cui il concetto del predicato è racchiuso nel concetto del soggetto - in parte dalle molte oscurità che si addensano intorno alla nozione di una logica trascendentale come ambito teorico del sintetico a priori. E tuttavia proprio quegli esempi, e il modo stesso in cui Kant li introduce, possono apparirci ora in una nuova luce, poiché se ci poniamo nella prospettiva che abbiamo appena delineato deve assumere un senso il sostenere che l’estensione appartiene al concetto di corpo, mentre non vi appartiene invece il concetto di peso, poiché i plena non debbono necessariamente essere, poiché la presenza di ogni singola determinazione reale rimanda non alla forma dell’oggetto, ma alla sua concreta datità fattuale. Così, anche senza bisogno di immergerci nelle considerazioni difficili concernenti il significato dei termini che Kant riteneva di avere una volta per tutte chiarito, possiamo tuttavia dire che le determinazioni estensive, ma non il peso appartengono alla grammatica del concetto di corpo.
2. Le considerazioni che abbiamo dianzi proposto ci hanno mostrato in che senso, per Husserl, sia legittimo parlare delle qualità primarie e secondarie come di caratteristiche che determinano la natura del concetto di cosa materiale, colto nella sua dimensione intuitiva. Ora, nel tentativo di tracciare questa distinzione, Husserl ha attirato la nostra attenzione sulla differenza che sussiste tra l’impalcatura spaziale della cosa e la sua determinatezza qualitativa e quindi riempiente: alla spazialità estesa del corpo si debbono in altri termini affiancare le qualità che nell’estensione stessa si distendono.
Sul senso generale che deve essere attribuito a queste pagine di Husserl (al § 13 del secondo volume di Idee) non credo sia necessario indugiare ancora, e tuttavia è opportuno osservare che non tutte le proprietà che attribuiamo ad un oggetto si estendono nello stesso modo nella sua corporeità: il colore è, per esempio, una proprietà che si dà come modo della superficie della cosa, mentre il peso compenetra percettivamente lo spazio corporeo della cosa. Ancora diversa è la modalità di darsi di un profumo: l’odore di un cibo permea tutte le sue parti, ma si diffonde necessariamente nell’atmosfera e ha nella cosa più il suo centro di irradiamento che la sua completa localizzazione. Uno stesso discorso vale per il calore che si diffonde nello spazio circostante. Diverso è invece il caso del suono: vi sono rumori che pervadono il corpo che li emette, altri che percettivamente hanno soltanto origine da essi. Un suono sordo e grave come quando colpiamo con le nocche un armadio vuoto risuona nello spazio che è racchiuso dalle assi, mentre lo squillo acuto di un fischietto ha un’origine precisa ma non si diffonde nello spazio della cosa da cui ha origine.
Non vi è dubbio che qui vi è spazio per una molteplicità di indagini descrittive. Ma ciò che ora ci interessa sottolineare è che queste diversità, che appartengono evidentemente al tessuto costitutivo della nozione intuitiva di cosa materiale, si riverberano in una sorta di classificazione delle proprietà dell’oggetto, nel loro scandirsi secondo una diversa regola di inerenza e di prossimità rispetto alla cosa. Non tutte le proprietà appartengono alla cosa allo stesso titolo, e questo non accade soltanto perché vi sono proprietà che intuitivamente ci riconducono all’esser così dell’oggetto (la durezza) ed altre che sono invece colte fin sul terreno percettivo come stati relativamente mutevoli della cosa (il suo calore), ma anche perché non tutte le proprietà fanno presa sulla sua corporeità allo stesso modo: il colore appartiene alla cosa più del suo profumo ed entrambi cedono il passo alle determinazioni che ci riconducono nell’alveo della nozione ingenua di massa corporea. Quanto poi al suono che una cosa emette è relativamente evidente che in questo caso il parlare di una proprietà è in qualche misura fuori luogo, anche se vi sono contesti in cui questa differenza si fa più sfumata e l'imbarazzo meno avvertibile. Del resto, tutte le lingue ci mostrano un ordine nella serie degli aggettivi, una sorta di gerarchia implicita in cui è possibile almeno in parte cogliere l’eco linguistica della distinzione percettiva cui abbiamo appena alluso.
Su questo tema non è possibile indugiare più a lungo. E tuttavia, se a partire di qui rivolgiamo nuovamente l’attenzione al nostro problema ci imbattiamo in un ordine di considerazioni su cui è opportuno riflettere. L’abbiamo già osservato: un corpo spaziale vuoto realiter è un nulla, e per essere chiede che vi siano determinazioni reali che lo determinino e che diano al suo porsi come forma e impalcatura della cosa quella pienezza che è implicata dalla nozione stessa di realtà.
Quando ci eravamo imbattuti in questa tesi avevamo innanzitutto sottolineato come di qui si potesse dedurre il carattere della corporeità, il suo porsi come la forma e come il fondamento di ogni altra determinazione. Ora dobbiamo invece lasciarci incuriosire da un termine che Husserl consapevolmente impiega - da quel "realiter" cui affida il compito di introdurre un nuovo problema. La corporeità è spazio occupato, ed il modo in cui lo spazio si riempie passa innanzitutto attraverso la percezione sensibile: traccio un riquadro sul foglio e al suo interno lascio cadere una macchia di inchiostro e lo spazio vuoto che ho incorniciato con quattro tratti di penna ospita ora un oggetto percettivo, che fa tutt’uno con il riempirsi di una certa porzione di spazio. Proprio così:
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Lezione diciassettesima 1. Nella lezione precedente avevamo attirato l’attenzione su un problema importante: avevamo infatti osservato che il nostro discorrere di cose reali (o, come Husserl altrimenti si esprime, di sostanze materiali) allude ad un predicato che si costituisce sul terreno della nostra esperienza percettiva, ma che non può essere ricondotto ad un qualche momento sensibile come accade invece per proprietà come il peso o il colore. Di qui il compito che avevamo indicato: se davvero vogliamo tracciare una genesi del concetto intuitivo di cosa materiale dobbiamo mostrare come sia possibile che i predicati che attribuiscono all’oggetto trascendente della percezione la dimensione della materialità e della sostanzialità sorgano in seno alla nostra esperienza. Il primo passo per raggiungere questo obiettivo consiste nel disporsi sul terreno di una finzione metodica: abbiamo di fronte a noi un oggetto — questa penna, per esempio — e noi vogliamo costringerci a coglierla, dimenticando interamente il contesto obiettivo cui pure appartiene. Ora, il contesto ha una sua ricaduta anche sul modo in cui gli oggetti si manifestano percettivamente: il colore dipende, per esempio, dalla luce che lo illumina e quindi anche dall’ora del giorno, e ciò che vale per i colori vale anche mutatis mutandis per le altre proprietà. Di questo non dubitiamo affatto, e tuttavia di questa trama di dipendenze vogliamo per il momento disinteressarci, e per renderci più facile questo compito vogliamo proporre un’ulteriore semplificazione metodica: anche se sappiamo che le cose materiali possono, per loro natura, mutare di forma, di aspetto e di luogo, ciò nonostante vogliamo limitarci per ora ad una finzione di comodo — vogliamo fingere di avere sott’occhio un oggetto che non muti affatto e che nel suo permanere com’è ci aiuti a dimenticare la sua dipendenza dal come delle circostanze cui appartiene. Ma se appunto rivolgiamo il nostro sguardo ad un oggetto che non muti e che, proprio per questo, ci permetta di dimenticare il contesto cui appartiene ci imbattiamo in una constatazione importante: per Husserl, non abbiamo nulla che ci consenta di dire che ciò che vediamo è, nel suo senso, distinguibile da un mero fantasma. Davanti a noi vi è una penna, e cioè una cosa materiale: su questo non abbiamo dubbi. E tuttavia, se non oltrepassiamo i confini che ci siamo imposti, non abbiamo alcuna ragione per distinguere la penna che vedo da una parvenza, nel senso in cui una parvenza è — per esempio — l’arcobaleno o un’immagine vista in uno stereoscopio. Qualcosa evidentemente c’è anche in questi casi — vedo per esempio l’arcobaleno che è un oggetto che non ha natura immanente, che occupa un certo luogo nello spazio e che è in linea di principio intersoggettivamente accessibile; e tuttavia ciò che c’è non basta perché possa parlare dell’arcobaleno come di una cosa materiale: se ha un suo posto nelle favole e nelle leggende è perché l’arcobaleno è immateriale (anche se solo nella prospettiva dell’esperienza percettiva) e può proprio per questo porsi per l’immaginazione come un ponte tra la gravità della terra e la natura eterea del cielo. Ora, l’arcobaleno ma anche le nuvole o il fumo che si solleva dalla pentola ci appaiono così: come macchie di uno o più colori che occupano una parte circoscritta del cielo o dello spazio vuoto di fronte a noi. Ma — ed è questo il punto su cui Husserl ci invita a riflettere — se guardiamo una penna non vediamo in ultima analisi di più: anche in questo caso, infatti, ciò che sensibilmente si manifesta è una determinata estensione "riempita" (seppure in un modo significativamente diverso da ciò che accade nel caso del fumo o di una nuvola) da un qualche colore. Di qui la conclusione che Husserl ci invita a trarre: un corpo spaziale riempito (un corpo determinato qualitativamente) dal plenum qualitativo che vi si estende non è ancora una cosa, una cosa nel senso consueto di un che di reale e materiale. D’altro canto è chiaro che ogni cosa sensibile nella sua datità presuppone, come elemento fondamentale della sua stessa essenza (e quindi come qualcosa che non può mancare né essere tolto), una simile corporeità estesa qualitativamente riempita. La cosa dunque è sempre data nella forma di un’estensione spaziale riempita, ma è anche sempre data come qualcosa che non si limita a questo. Diciamo allora che all’essenza di una cosa inerisce uno schema sensoriale, e per schema sensoriale intendiamo questa intelaiatura fondamentale, questa forma corporea ("spaziale") insieme al plenum che su di essa si distende. La cosa che si manifesta immobile e qualitativamente immutata non ci "mostra" altro che il suo schema o la sua apparenza, anche se al contempo viene appresa come un che di materiale. Ma sotto questo riguardo essa non ci si "mostra", non si porge propriamente alla vista, non giunge ad una datità originale. In ciò che è "propriamente" dato non muterebbe nulla se l’intero strato della materialità venisse cancellato dall’apprensione. Ciò è di fatto pensabile. Nell’esperienza originale, nella percezione, il "corpo" è qualcosa di impensabile senza una determinatezza sensibile, laddove il fantasma è dato originalmente ed è quindi anche pensabile senza le componenti della materialità, le quali a loro volta sono evidentemente non indipendenti (vi è dunque una scindibilità unilaterale) (ivi, p. 435). In questo passo husserliano molte cose debbono essere sottolineate. In primo luogo Husserl ci invita a far valere un nuovo concetto: le cose, egli osserva, ci si danno innanzitutto come uno schema sensibile, che altro non è se non l’estensione corporea qualitativamente riempita. Così, quando parliamo dello schema sensibile visivo di una cosa intendiamo propriamente quella stessa cosa proprio come è vista da noi: il rimando alla nozione di schema vale allora come un mezzo per circoscrivere ciò che nella percezione di cosa coincide con il suo essere oggetto per la nostra esperienza percettiva. Di qui, in secondo luogo, la conseguenza che Husserl ci invita a trarre. Se la nozione di materialità non rimanda ad un momento presentativo e se, d’altro canto, la cosa che si manifesta non ci "mostra" altro che il suo schema sensibile, anche se viene comunque appresa come un che di materiale, allora ogni percezione di cose materiali può essere intesa come il risultato del fondarsi di un momento nuovo e non direttamente presentativo sullo schema sensibile in virtù del quale qualcosa è oggetto della nostra esperienza. Ma ciò è quanto dire che lo schema sensibile può esservi anche se non è ancora data la cosa; le cose invece presuppongono la datità dello schema — questo è il punto. Ne segue appunto che l’apprensione che determina lo strato della materialità poggia sullo schema sensibile, ma non è ancora data con esso: la cosa materiale è dunque qualcosa di più di un oggetto spaziale determinato. Ora, se l’apprensione della materialità non è ancora data insieme alla percezione di una qualche estensione qualitativamente determinata, dobbiamo evidentemente cercare di arricchire il nostro esempio, per vedere quali siano le esperienze che sono chiamate in causa dal concetto intuitivo di cosa materiale. Il primo passo in questa direzione consiste nel rammentarsi della dimensione tattile: la penna che è di fronte a noi possiamo afferrarla, e ciò fa sì che non vi sia soltanto uno schema visivo, ma anche uno schema tattile della cosa — il suo porsi come un’estensione che ha qualità che si annunciano al tatto, come la morbidezza o il calore. Percepire significa del resto sempre avere esperienze che hanno origine da diversi sistemi sensibili, e questo comporta — per Husserl — che vi siano forme di connessione e di identificazione che ci permettano di mantenere l’identità del riferimento oggettuale e di cogliere nel variare della modalità sensibile della nostra percezione ora l’arricchirsi di nuove proprietà, ora il manifestarsi in forma nuova di determinazioni qualitative che ci erano già note. Una descrizione effettiva di come ciò sia possibile è tutt’altro che semplice, e Husserl in queste pagine si limita ad indicare soltanto alcune linee generali del discorso. In primo luogo Husserl osserva che la percezione implica il costituirsi non di una molteplicità di schemi, ma di uno schema complessivo articolato in diversi strati, ciascuno dei quali rimanda ad una diversa modalità sensibile. Scrive Husserl: Si deve riconoscere che il concetto di schema (fantasma) non è affatto limitato ad una sola sfera sensoriale. Una cosa percepita ha anche uno schema tattile che viene in luce nell’apprensione tattile. Nello schema complessivo vanno dunque distinti in generale tanti strati quanti sono i generi di dati sensoriali che possiamo trovare nel loro distendersi sull’estensione spaziale della cosa — su quell’estensione che ci si dà come identica. Lo schema non si fa dunque plurale a causa della multiformità del riempimento. Le qualità sensibili riempiono la corporeità spaziale, che resta una e assolutamente identica, disponendosi in diversi strati che, in virtù di quest’identità e della loro essenziale inseparabilità dall’estensione, non possono in linea di principio disperdersi in una molteplicità di schemi separati (ivi, 436). Come ciò accada può essere in linea di principio chiarito rammentando innanzitutto il fatto che ogni percezione rimanda ad un orizzonte di percezioni possibili, che sono motivate da ciò che appartiene al presente percettivo o alla struttura di tipicità che caratterizza la percezione di qualcosa. Se, per esempio, osservo questa penna, vedo soltanto uno dei suoi infiniti profili, ma ciò è sufficiente perché il decorso percettivo assuma un suo orientamento definito: ciò che vedo delinea un possibile sviluppo della percezione che di fatto le attribuisce un senso definito, — un fatto questo che si manifesterebbe, per esempio, nello stupore da cui sarei pervaso se il retro della penna fosse concavo invece che convesso e se il colore fosse interamente diverso da quello che la sua parte manifesta esibisce. Ora ciò che percepisco non può essere disgiunto da questo orizzonte di possibili percezioni, che — nel loro essere sintatticamente connesse a ciò che propriamente si mostra — definiscono il senso di ciò che si manifesta: vedo una penna solo perché fa parte del senso percettivo che in ogni singolo istante mi si offre il fatto che ciò che vedo è soltanto un aspetto dell’oggetto, un aspetto che si continua secondo una certa regola negli altri aspetti, che non sono soltanto anticipati nella loro astratta tipicità, ma sono prefigurati secondo la regola di unificazione delle scene percettive che si è finora attestata. E ciò che è vero sul terreno di un unico strato dello schema complessivo della cosa, vale anche quando chiamiamo in causa la molteplice difformità degli strati. Anche in questo caso ogni singola fase del decorso percettivo deve essere intesa come un momento reale il cui senso dipende dal suo connettersi con una molteplicità di percezioni possibili, solo che ora gli orizzonti di senso non rimandano più ad un unico strato dello schema, ma si orientano verso altri strati, anticipando ciò che verrà percepito quando, per esempio, stenderemo la mano per toccare ciò che vediamo. Ma se il senso di ciò che vedo è anche nel suo rimandare a ciò che avvertirei tattilmente se sfiorassi quella superficie di cui vedo la lucentezza, ciò accade soltanto perché la connessione tra percezioni reali e possibili non ha, per Husserl, la forma di una sintassi accidentale di immagini, ciascuna delle quali faccia parte a se stessa, ma è la forma sintetica in cui l’oggetto si manifesta per quello che è. Percepire un corpo significa cogliere un’unità sintetica complessa: il corpo è un’unità dell’esperienza, ed è implicito nel senso di quest’unità il suo essere indice di una molteplicità di possibili esperienze, nelle quali il corpo stesso può giungere a datità in forme sempre nuove (ivi, p. 438). Ma ciò significa che ciò che vedo e sento e tocco manifesta un identico oggetto che si struttura in proprietà diverse che si svelano a sensi diversi. Ma anche in proprietà obiettivamente identiche che si danno diversamente ai nostri sensi. Così, la lucentezza che vedo si lega alla sensazione tattile della levigatezza, ma l’una non è semplicemente accanto all’altra come lo sono invece gli eventi che l’abitudine stringe in un nodo, poiché la levigatezza mostra tattilmente ciò che la lucentezza fa visivamente vedere, e un’esperienza può sfociare e continuare nell’altra perché entrambe mostrano un identico modo di riempire una stessa superficie corporea. Husserl parla a questo proposito più che di un immediato mostrarsi, di un annunciarsi [bekunden] di un’identica proprietà obiettiva in forma sensibili differenti, e ciò che è vero nel caso della levigatezza e della lucidità vale anche nel caso della forma e dell’estensione che si obiettivano al di là della loro datità immediatamente visiva o tattile. Ma anche là dove non avrebbe senso parlare di un’identica proprietà che si manifesta in forme sensibili differenti, non per questo la connessione deve essere ricondotta ad una mera convenzione fondata sull’istituirsi di un’abitudine percettiva. Certo, le abitudini percettive possono giocare un ruolo importante, ed è vero che molti nessi chiedono di essere appresi e implicano nella loro genesi la ripetizione. Ma sarebbe semplicemente privo di senso sostenere che ogni apprendimento è apprendimento di una convenzione e che la ripetizione è necessaria perché ogni nesso si fonda sull’abitudine. Così, se freddo e caldo si associano, in un’esperienza più volte ripetuta, a contrazione ed espansione, ciò non significa che non vi sia altra ragione per legarli reciprocamente che non sia la trama psicologica dell’abitudine: io vedo che vi è un rapporto causale e che, al decrescere e al crescere del calore, l’aria occupa proporzionalmente un minore ed un maggior volume — vedo, in altri termini, una dipendenza, che in altri nessi causali è ancor più manifesta. Su questo tema vi sarebbero ancora molte cose da dire, anche soltanto per chiarire tutto ciò che Husserl ci dice. Ma il punto verso cui tendono queste argomentazioni è un altro: Husserl vuole mostrarci che anche questo ampliamento del terreno esemplificativo non è sufficiente per farci accedere al terreno della materialità. Certo, l’aprirsi della schema alla tattilità dà alla percezione una motivazione in più per credere a ciò che le si mostra: se la mano non riuscisse ad afferrare ciò che vediamo potremmo ragionevolmente sospettare di avere un’allucinazione, e del resto si potrebbe osservare che esempi analoghi a quelli che abbiamo a suo tempo proposto potrebbero trovare nella tattilità il luogo in cui la loro peculiarità si manifesta — in fondo se qualcosa ci induce a negare l’applicabilità del concetto di cosa materiale al vapore che si leva nell’aria ciò accade anche perché il fumo è qualcosa che si vede ma non si può toccare. E tuttavia, anche se il tatto gioca sicuramente un ruolo nella determinazione di ciò che è oggetto per noi (un oggetto intangibile è ancor meno accettabile di un oggetto invisibile) non ci permette ancora — per Husserl — di cogliere ciò che pure appartiene al senso delle cose materiali: il loro porsi da un lato come oggetti reali che non sono determinati soltanto dal loro essere oggetti percettivi e, dall’altro, il loro conseguente porsi come oggetti che non sono riducibili al loro manifestarsi così come di fatto si manifestano alla soggettività che li esperisce. Sul significato di questa duplice tesi è opportuno indugiare un poco. Ciò che Husserl vuole dire è, in primo luogo, che ogni cosa materiale non è soltanto caratterizzata dal suo darsi attraverso una serie di fenomeni, ma anche dal suo porsi come qualcosa che reagisce e interagisce con gli altri oggetti. L’oggetto percettivo è soltanto uno schema sensibile: si dà per quello che è a partire da ciò che di esso intuitivamente si manifesta e ciò è quanto dire che il suo essere si dispiega necessariamente nelle proprietà che l’esperienza sensibile e percettiva vi scorge. Dire che la cosa materiale non si esaurisce nello schema sensibile significa allora sostenere che possiamo parlarne come di un qualcosa il cui senso va al di là del suo essere dato soltanto come oggetto della percezione. Ma vuol dire anche, in secondo luogo, che appartiene all’idea di cosa materiale il suo porsi non soltanto come l’unità sintetica delle manifestazioni sensibili, ma come qualcosa il cui senso non dipende esclusivamente dal come del nostro coglierla sensibilmente e non è interamente dato insieme al fatto che la cosa appare così — con questa forma, con questo colore, con il suo essere calda o fredda, e così via — al soggetto che la percepisce. Ne segue che anche se la cosa materiale si annuncia nei suoi schemi sensibili, non è per questo identica ad essi per ciò che concerne la sua natura. Di qui la conclusione che deve essere tratta e che è implicita negli sviluppi teorici del discorso che Husserl ci propone: se gli oggetti della percezione, che pure possono in generale essere diversi da come di volta in volta li percepiamo, sono necessariamente colti così come si danno in una qualche percezione (in una qualche concretizzazione del loro schema sensibile) e sono quindi in modo altrettanto necessario determinati da predicati di natura sensibile, le cose materiali sono invece in linea di principio determinabili da predicati che si manifestano in fenomeni di natura sensibile ma che in se stessi non sono necessariamente riconducibili al modo in cui appaiono e non necessariamente appartengono alla dimensione della sensibilità. Dobbiamo, in altri termini, rendere conto del fatto che appartiene al concetto intuitivo di cosa il suo poter essere diversa da come percettivamente si dà a soggetti come noi. Mostrare che la cosa materiale è qualcosa di irriducibile al suo schema sensibile significa dunque questo: rendere conto del fatto che, nel caso delle cose materiali, è lecito supporre che vi sia una differenza tra essere così e manifestarsi così. Ora che di una simile differenza non sia possibile rendere conto semplicemente abbandonando la semplificazione metodologica che abbiamo preliminarmente assunto e che ci invitava a considerare esempi puramente statici è un fatto su cui non è opportuno soffermarsi a lungo: il mutamento può essere infatti inteso senza problemi come una mera modificazione degli schemi sensibili della cosa. Ma allora, se le cose stanno così, qual è il cammino da seguire per mostrare la genesi del concetto di materialità? E più in generale: se una cosa materiale è tale proprio perché il suo essere non è definitivamente vincolato al come del suo apparire, è davvero possibile indicare la genesi nell’esperienza di un momento di senso che consiste propriamente nell’annunciarsi dell’indipendenza della cosa dalla determinatezza che le deriva dal suo essere così esperita? In altri termini: non dovremmo intendere la materialità della cosa come un momento che segna il trapasso dalla dimensione dell’esperienza percettiva al terreno di un’oggettività non più esperita, ma inferita? Non è questa la conclusione cui Husserl ci invita, e per rendersene conto è sufficiente lasciar cadere la vera discriminante metodica cui ci siamo sin qui attenuti: dobbiamo in altri termini rivolgere lo sguardo alla cosa, riconnettendola al contesto cui appartiene e che è immediatamente chiamato in causa dal variare della sua datità sensibile. Le cose materiali non sono semplicemente oggetti della nostra percezione, non sono in altri termini soltanto ciò che si costituisce nella sintesi percettiva delle datità sensibili, ma sono oggetti esperiti che hanno il senso che hanno perché sono immersi nel contesto del mondo, nella trama reale delle sue relazioni. Ora, di questo rimando alla nozione di mondo non può più di tanto stupirsi chi conosce la riflessione fenomenologica e sa quale peso rivesta la struttura degli orizzonti nel pensiero husserliano. In molte delle sue pagine Husserl ci invita infatti a tenere conto del fatto che ogni oggetto che percepiamo è "qualcosa dal mondo" ed implica quindi nel suo senso le molte e stratificate certezze che fanno parte del vivere e che danno alle cose il loro giusto posto e il loro senso autentico. Così, un utensile — questo cacciavite, per esempio — è un oggetto che ha il senso che ha solo perché si dà insieme ad una rete di rimandi di natura operativa, ma insieme anche ad una serie di certezze che concernono la resistenza dei materiali, le leggi delle fisica, e così via. Il mondo, in questa luce, è dunque questo: quello sfondo di certezze e di presupposizioni che danno alle cose di cui abbiamo esperienza il loro giusto peso. Ma se le cose stanno così è evidente che non è questo il significato che in questo caso vogliamo attribuire alla nozione di mondo. Richiamare l’attenzione sul fatto che gli oggetti appartengono al mondo non significa, in questo contesto, rammentarsi del fatto che ogni percezione implica, nel suo senso, molte certezze, ma vuol dire piuttosto richiamare l’attenzione sul fatto che gli oggetti si danno come cose materiali solo perché il loro darsi così dipende dall’insieme delle cause e delle concatenazioni causali di cui, interagendo con gli altri oggetti del mondo, fanno parte. La possibilità di cogliere gli oggetti come oggetti materiali ci riconduce così al loro essere parti del mondo e al loro condividere il destino delle sue interazioni causali.
2. Dobbiamo ora lasciar cadere il presupposto metodico da cui ci siamo lasciati guidare, e ciò significa che dobbiamo rivolgere nuovamente lo sguardo alla cosa, posta al centro del contesto cui appartiene. Avremo allora ancora una volta di fronte a noi un qualche oggetto — questo libro, per esempio — che si manifesta sensibilmente come una cosa che ha certe proprietà e, tra queste, un colore. Questa proprietà, tuttavia, si dà in una relazione di evidente dipendenza dalla natura della luce che illumina l’oggetto, e questo significa che, nel caso del nostro esempio, noi esperiamo una stessa cosa in relazione alle sue proprietà ottiche, le quali nel mutare dell’illuminazione in accordo con il mutamento delle sorgenti di luce, mantengono la loro unità e la loro determinatezza. L’unità si attesta attraverso tutti gli schemi proprio in quanto sono cromaticamente riempiti. Ciò che così si costituisce è il colore "obiettivo", il colore che la cosa ha, sia che si trovi alla luce del sole o in una luce naturale fioca o nel buio di un armadio, e così in tutte le situazioni di illuminazione, cui ineriscono funzionalmente schemi sensibili interamente determinati, e tra questi anche il riempimento completo di uno schema visuale (ivi, p. 439). Quale sia il senso che dobbiamo attribuire a queste considerazioni è presto detto. Innanzitutto vi è questo libro, la cui copertina muta di colore con il mutare delle condizioni di illuminazione che ce la rendono accessibile. Ora questo di questa mutevolezza del colore apparente delle cose abbiamo discusso più volte, e a suo tempo avevamo osservato come in questa aperta possibilità del trascolorare degli oggetti fosse apparentemente possibile scorgere un argomento per sostenere il carattere immanente delle qualità secondarie. Monet che dipinge le sue cattedrali sottolineando come ad ogni ora del giorno si manifesti uno spettacolo nuovo sembra offrire al filosofo lockeano un argomento per rifiutare ai colori un’esistenza effettiva. E tuttavia non è affatto detto che di qui si debba trarre proprio questa lezione, ed anzi potremmo muovere proprio di qui per chiarire il senso di queste considerazioni husserliane. Ecco, di fronte a noi vi è la cattedrale di Rouen, con i giochi di colore che la luce nel suo mutare ci propone. A questo spettacolo, tuttavia, ci concediamo solo a patto di non tracciare la cornice che separa la scena percettiva dalla sua causa più prossima: dal diverso colore di cui si ammanta la luce ambientale. Certo, nell’aspetto della cattedrale vi è un cambiamento evidente, ma questo mutamento nello schema smette di assumere il significato di una mera variazione sensibile non appena riconnettiamo l’oggetto al contesto cui appartiene e da cui dipende — non appena cogliamo la relazione funzionale che lega la manifestazione sensibile del colore alla determinatezza della fonte di luce. Ora questa relazione funzionale è una relazione di natura causale: noi esperiamo la dipendenza del colore apparente dell’oggetto dalla natura della luce che lo illumina, e in questo nesso che si viene a creare tra determinati schemi sensibili da una parte e dall’altra sorge un senso apprensionale nuovo: ogni modificazione dello schema sensibile ci appare ora come l’annunciarsi [Bekundung] di un’identica proprietà obiettiva, che tuttavia non si manifesta nel gioco delle scene visive cui la sua percezione è legata, ma nella dipendenza che essa manifesta rispetto ad altre cose della natura. Ma ciò è quanto dire che nel nesso che la lega alle circostanze cui appartiene, la cosa smette di essere soltanto un oggetto che si costituisce nella mia esperienza e che dipende nel suo aspetto dalle scene in cui si manifesta sensibilmente, ma assume il senso di qualcosa che reagisce all’azione delle altre cose, rivelandosi da un lato come una sostanza che interagisce in vario modo con gli oggetti e che nella regola di questo interagire mostra, dall’altro, in che senso sia un nucleo sostanziale obiettivo, un’entità di un certo tipo. Guardo la copertina di libro e la vedo rossa, ma il colore di ciò che vedo si mostra poi nel nesso di dipendenza che lega le apparenze cromatiche al mutamento della sorgente di luce, ed il senso della mia percezione muta: ora ho esperienza di una cosa che mi appare così, perché è fatta in modo tale da reagire in modo determinato alla luce che su di essa causalmente agisce. Ne segue che il colore smette di essere soltanto l’aspetto visivo della cosa e diviene il nome che diamo alla sua proprietà di reagire al mutare della qualità della luce secondo un criterio costante, in cui si annuncia il colore come proprietà obiettiva, come identico che si attesta nella variazione ordinata e coerente ad una regola delle singole "risposte" che l’oggetto, in quanto cosa dotata di quella determinata proprietà obiettiva, dà al variare delle circostanze da cui causalmente dipende. Di qui la conclusione che deve essere tratta. Innanzitutto vi è l’oggetto percepito — l’oggetto trascendente e intersoggettivamente accessibile che tutti percepiamo e che fa da sfondo alla nostra prassi. Ma poi, a partire di qui, vi è la cosa come nucleo sostanziale che si costituisce non appena cogliamo le sue forme di manifestazione come effetti che rimandano necessariamente ad un sistema di nessi correlati causalmente. Ed in questo diverso modo di connettersi dei fenomeni si fa avanti un nuovo senso che la cosa acquisisce: lungi dall’essere soltanto qualcosa che si annuncia nella mia percezione, la cosa assume il senso di un quid che interagisce con gli altri oggetti e che si rivela nel modo in cui risponde alla loro azione. Così, proprio come la solidità si era venuta determinando come la capacità di un corpo di escludere ogni altro dal posto in cui esso si trova, così la nozione di materialità che ci viene qui proposta ci riconduce alla capacità delle proprietà reali di far valere la loro norma nelle relazioni funzionali che le connettono con l’ambiente circostante. In altri termini: è materiale tutto che offre una resistenza determinata agli oggetti che sono causalmente connessi con esso. Ora, disporsi in questa prospettiva di carattere generale significa anche, assumere un diverso atteggiamento rispetto alle stesse manifestazioni fenomeniche. Ora guardo un oggetto e colgo in tutte le manifestazioni un identico oggetto che sensibilmente si manifesta, ma poi le singole manifestazioni mi si danno come dipendenti funzionalmente da un sistema di cause e ciò è quanto dire che in esse non posso più cogliere semplicemente ciò che vedo, ma un determinato stato reale della cosa, un suo modo di manifestarsi che occupa un posto determinato nell’unico tempo nel mondo: Di fronte alla qualità reale e unitaria (nel nostro esempio: il colore obiettivo che non muta) vi è lo stato reale e momentaneo, che varia secondo una legge e che corrisponde alle "circostanze". Questo stato coincide con lo schema, ma non è meramente schema (la cosa non è un mero fantasma). All’apprensione modificata corrisponde un predicato modificato. Infatti nell’apprensione della cosa lo schema non viene percepito semplicemente come un’estensione riempita sensibilmente, ma è percepito come la "attestazione originaria" [Beurkundung] di una qualità reale e, appunto per questo, come stato della sostanza reale in un determinato punto del tempo (ivi, pp.440-441). Al fenomeno come forma di manifestazione soggettiva della cosa si è sostituito così lo stato della sostanza come forma della dipendenza funzionale di un oggetto dalle circostanze di mondo cui appartiene. Ed a partire di qui è evidentemente possibile delineare una radicale riformulazione del concetto di cosa, una riformulazione che si orienti in chiave fisicalistica e ripensi all’oggetto proprio muovendo dalla centralità delle relazioni causali. In un passo del Mondo come volontà e rappresentazione, Schopenhauer osservava che la lingua tedesca ha scelto una parola felice per esprimere il concetto di realtà: la parola Wirklichkeit. Ciò che spingeva Schopenhauer verso questa strana tesi è presto detto: la parola Wirklichkeit racchiude in sé il verbo wirken che significa agire, produrre e la parola Wirkung, che vuol dire effetto. Nel cuore (etimologico) del concetto di realtà vi è dunque l’idea stessa della relazione causale, e Husserl sembra condividere pienamente questa tesi poiché ci invita a sostenere che Realtà […], sostanzialità e causalità sono inseparabilmente inerenti. Le qualità reali sono eo ipso qualità causali. Perciò conoscere una cosa significa sapere per esperienza come si comporterà sotto una spinta, sotto una pressione, quando verrà piegata, quando verrà rotta, sottoposta al riscaldamento e al raffreddamento; vale a dire come si comporterà nel contesto delle sue causalità, in quali stati verrà a trovarsi e in che modo rimarrà la stessa attraverso tutti questi stati (ivi, p. 442). |
|||||||||||||||||||||
|
Lezione diciottesima 1. Nella lezione precedente abbiamo osservato come, in queste pagine husserliane, prenda forma una discussione del concetto di cosa materiale che si orienta in una direzione apertamente causalistica. Una cosa è una cosa materiale se e solo se appartiene al contesto causale del mondo, ma questa considerazione il cui senso dovrebbe esserci ormai chiaro allude di fatto ad un compito aperto all’infinito: gli oggetti che percepiamo sono infatti colti come un insieme aperto di proprietà che non sono necessariamente apprese nella loro dipendenza dal contesto reale del mondo. Ne segue che, nella norma, non è affatto vero che gli oggetti siano colti come entità realmente determinate in tutti i loro possibili aspetti. Finché ci muoviamo sul terreno della Lebenswelt le cose del mondo ci si danno come un intreccio di proprietà immediatamente sensibili cui si aggiungono alcune proprietà che dispongono la cosa nell’orizzonte di ciò che è reale. Ma dal terreno del mondo della vita si può prendere commiato, e di fatto l’indagine delle scienze naturali si pone il compito di sciogliere quell’intreccio e di comprendere ogni proprietà dell’oggetto alla luce dei nessi causali che proiettano le apparenze sensibili sul terreno obiettivo della realtà. Quale sia la via che questo cammino deve intraprendere Husserl ritiene possibile indicarcelo con un esempio. Una molla reagisce al peso che su di essa poggia modificando la propria forma, che muta secondo una regola che è direttamente riconducibile al crescere o al decrescere della pressione che viene di volta in volta esercitata. Alcune bilance funzionano proprio così: si aggancia il peso ad una molla e si misura quale sia lo scarto tra la lunghezza che la molla assume quando è gravata dal peso e quella che assumerà di lì a poco quando ne sarà liberata. Per ogni modificazione del peso vi è una corrispondente alterazione della lunghezza della molla, e ciò è quanto dire che di fatto esperiamo una relazione funzionale tra due schemi sensibili: l’uno varia con l’altro, e questo variare secondo una regola fa sì che le diverse estensioni della molla siano esperite come la forma sensibile che ci parla di una nuova proprietà reale dell’oggetto — la sua elasticità. La molla non ha più soltanto una forma, un colore, un peso, una durezza, ma è anche qualcosa che è fatta di un materiale tale da permetterle di variare e di riacquisire la propria forma al variare secondo una regola di determinate circostanze. Ora, l’elasticità non è un proprietà sensibile alla stessa stregua del colore o della forma: l’elasticità, per Husserl, è quella proprietà dell’oggetto che propriamente non percepiamo ma che sta a fondamento della regola percepibile che lega funzionalmente il variare sensibile delle circostanze (della pressione esercitata) al variare sensibile degli effetti (la tensione della molla). Ciò non toglie tuttavia che l’elasticità sia ancora una proprietà che si manifesta sensibilmente: anche se l’elasticità come fondamento di una relazione funzionale non è in sé una proprietà sensibile, sono invece direttamente percepiti quei comportamenti funzionalmente dipendenti in cui essa di fatto si annuncia. Di qui tuttavia è possibile muovere per compiere un ulteriore passo che ci conduce in un terreno ancor più lontano dall’immediatezza sensibile. Possiamo infatti osservare che il ferro è elastico solo in certe circostanze, e che basta variarle perché quella proprietà reale ci appaia come uno stato di una nuova proprietà sostanziale. La lama di un coltello è elastica, ma ora la surriscaldo sino a fonderla e l’elasticità viene meno: ora questa proprietà reale e il suo venir meno assumono un senso nuovo e ci appaiono come stati reali di una sostanza che deve essere tale da giustificare il suo essere o non essere elastica a seconda delle circostanze — del crescere e del decrescere della temperatura. Ed in questo caso il variare delle proprietà allude ad un nuovo strato reale della cosa che si situa su un piano ancor più remoto dall’esperienza sensibile, che viene così progressivamente emarginata in questo lento processo di ricostruzione dell’oggetto a partire dalle sue proprietà causali. Lungo questo cammino Husserl di fatto non si avventura e si accontenta di indicarci in linea generale quali siano le coordinate generali che lo determinano. Del resto, non è difficile scorgere che l’obiettivo di queste ultime considerazioni sul concetto di cosa materiale è un altro: Husserl non intende indicarci se non per grandi linee quanto diversa sia la cosa fisicalistica dall’oggetto intuitivo, poiché di fatto intende mostrarci come nel suo sorgere l’oggetto della fisica segua una regola che è già tracciata sul terreno dell’esperienza. Ora, questo tema tende ad assumere in queste pagine husserliane una formulazione relativamente oscura e sfuggente: Husserl si chiede infatti se i tre principi che (a suo dire) guidano la riflessione scientifica — ad eguali circostanze corrispondono eguali effetti; nessun mutamento avviene senza una causa; ogni cambiamento implica l’identità di un qualcosa che muta — sono principi metodologici che hanno un valore euristico o se sono invece regole che si radicano nella natura del concetto di realtà. Di fatto, credo che sia questa la domanda che Husserl si pone, ma la difficoltà di queste pagine nasce dall’intrecciarsi di questo interrogativo con una questione che sembra identica, ma non lo è: con la domanda che verte sulla legittimità di escludere a priori che qualcosa possa mutare senza una causa. Proviamo allora innanzitutto a separare queste domande, per cercare soltanto in seguito di stringerle nel nodo che Husserl ci propone. Ed il primo passo in questa direzione consiste nel chiedersi se i principi che abbiamo dianzi elencato siano o non siano già implicati nella genesi del concetto di sostanza (di cosa reale). Credo che a questa domanda si debba dare una risposta affermativa, e per rendersene conto è sufficiente cercare di comprendere quale nuovo strato di senso si costituisca nell’oggetto quando lo cogliamo come un oggetto reale. Rammentiamoci delle conclusioni cui siamo giunti proponendo nuovamente un esempio. Sul tavolo vi sono più biglie che innanzitutto vedo come corpi che hanno un colore ed una forma peculiare. Ma poi lancio una biglia contro l’altra, e quanto più ripeto quest’operazione tanto più facilmente scorgo la relazione che visibilmente lega secondo una regola l’urto al movimento che ne scaturisce, ed in questo nesso che così chiaramente percepisco la biglia diviene per me una cosa reale, e cioè qualcosa che secondo una regola risponde alle circostanze che la sollecitano. L’essere una sostanza reale è tutto qui: in questa discontinuità che la cosa impone al corso delle cose con cui interagisce. Lanciamo la biglia sul tavolo e osserviamo la sua traiettoria rettilinea e il suo movimento inerziale — lo osserviamo sino a quando la biglia non urta contro qualcosa che ne devia il tragitto o che senz’altro la ferma. Questo qualcosa che determina una discontinuità nel movimento della nostra biglia è appunto un che di reale, ma ciò che caratterizza la posizione di Husserl consiste propriamente in questo — nel suo invitarci a cogliere in questa discontinuità e nel suo regolare manifestarsi il ripetersi su un altro terreno delle condizioni che determinano il porsi dell’identità della cosa nel gioco delle sue manifestazioni. La regola che lega il come di questa discontinuità al variare delle circostanze diviene così il contrassegno della presenza di una cosa reale e la forma stessa della realtà. Vi è una cosa reale se vi è questa capacità di segnare secondo una regola una discontinuità nel corso delle cose con cui si interagisce. Ma ciò è quanto dire che nella nozione di realtà è implicita, per Husserl, la dipendenza di ogni evento reale da una causa e la corrispondenza tra eguali effetti ed eguale circostanze: se non vi fosse un nesso funzionale tra gli effetti e le circostanze, se la discontinuità fosse priva di una regola non vi sarebbe quell’unità del decorso che è condizione della posizione di una oggettualità nuova. Di qui appunto la risposta che Husserl dà alla domanda che abbiamo dianzi formulato: quando ci chiediamo se il principio che esclude cambiamenti senza una causa ha un significato euristico o è implicato dalla nozione di realtà, possiamo senz’altro optare per la seconda ipotesi, perché reale e tutto e solo ciò che si dà come causalmente efficiente. Di qui tuttavia non sarebbe lecito muovere per una risposta affermativa alla seconda domanda che avevamo formulato, e questo perché la tesi secondo la quale il momento della causalità è parte essenziale della grammatica del concetto di sostanza non è ancora un argomento per dire che non siano pensabili accadimenti privi di una causa. E non è ancora un argomento perché non è affatto detto che il mondo di cui abbiamo esperienza sia nella sua totalità riconducibile sotto il concetto di realtà. Anche se non abbiamo alcuna ragione per credervi ed anche se non potremmo dire che sono reali, i miracoli potrebbero accadere. Così, se improvvisamente e senza ragione nascesse un cavallo alato dovremmo reagire proprio come l’Ariosto che ci assicura del fatto che animali come l’ippogrifo
Sui monti Rifei nascono, ma rari, molto al di là degli agghiacciati mari.
E tuttavia se ci avventuriamo su questo insidioso terreno non è per rendere giustizia ad un animale improbabile come l’ippogrifo, ma perché a partire di qui è possibile cogliere un’inclinazione di senso che appartiene al discorso di Husserl. Se Husserl avverte la necessità di sostenere che non tutto ciò che esperiamo è necessariamente reale e se più volte osserva che l’oggetto intuitivo non è in linea di principio un oggetto concluso e non può quindi presentarsi come un tutto realmente determinato è perché intende rammentare che il processo di determinazione reale affonda le sue radici sul terreno della nostra esperienza intuitiva che è, in linea di principio, prima di ogni posizione di realtà. Così, se davvero ha un senso rammentare che non è esclusa a priori la possibilità di un cambiamento spontaneo non è per aprire un varco nel sistema della natura, ma è soltanto per ricordare che quel sistema si costruisce nell’esperienza e che non è in generale lecito anticipare un risultato che può essere invece solo empiricamente raggiunto.
2. Siamo giunti così alla fine delle considerazioni husserliane che intendevamo discutere e insieme anche alla fine del corso. Vorrei soltanto aggiungere qualche rapida considerazione conclusiva. Il corso aveva un obiettivo, che spero possa essere ora colto con relativa chiarezza: volevo mostrare che una teoria rappresentazionalistica dell’esperienza percettiva è per molte e diverse ragioni insoddisfacente. Questo intento ci ha guidato innanzitutto in una lettura particolare ma, spero, interessante delle prime pagine del secondo volume del Saggio di Locke, per spingerci poi ad una serie di considerazioni critiche su cui ci siamo soffermati a lungo e che non avrebbe senso rammentare ora se non per indicare la meta cui ci hanno condotto: le critiche al rappresentazionalismo di matrice lockeana ci hanno permesso infatti di distinguere con maggiore chiarezza di quanto forse non fossimo prima capaci due differenti significati della nozione di percezione — la percezione è innanzitutto un evento reale che accade nel mondo, ma è anche, in secondo luogo, il titolo generale cui ricondurre il nostro essere intuitivamente consapevoli di una certa classe di oggetti. Confondere queste due nozioni di percezione vuol dire avvilupparsi in un intrico di problemi da cui non si esce e in cui è, proprio per questo, meglio rinunciare senz’altro ad entrare. Venire a capo del rappresentazionalismo (o più modestamente: mostrare quanti ostacoli crei a chi vuole seguirne il cammino) non significa soltanto puntare l’indice sui problemi che ne derivano, ma anche cercare di rispondere in altro modo a quelle esigenze teoretiche che il rappresentazionalismo aveva saputo soddisfare. Su questo terreno abbiamo cercato di muoverci nell’ultima parte del corso, dedicata a mostrare come una prospettiva di realismo fenomenologico potesse far fronte a ciò che di significativo vi è nella distinzione tra qualità primarie e secondarie e nella tesi lockeana secondo la quale è comunque possibile pensare ad oggetti che siano interamente diversi da come sensibilmente si presentano. La riflessione husserliana sulla Raumkörperlichkeit e sulla natura del concetto di realtà ci hanno mostrato una possibile via per impostare diversamente questo problema — anche se ciò non significa ancora che tutto in questo via ci convinca e possa essere senz’altro riproposto. E dire che ci manca il tempo per affrontare questo problema è insieme vero e comodo. A questo tema centrale se sono affiancati altri durante lo svolgimento del corso che, del resto, si prefiggeva almeno altri due obiettivi. Il primo è di natura didattica e teorica insieme e nasce dalla constatazione che si legge e che, anche quando si leggono i classici della filosofia, li si legge spesso con un atteggiamento troppo colto, come se l'unico o anche soltanto il primo problema che ci pongono fosse quello di ascoltare le molteplici risonanze culturali che sanno ridestare in un lettore attento e preparato. E invece io volevo invitarvi a leggere le pagine di Locke e di Husserl non soltanto perché è importante sapere qualcosa di questi due grandi filosofi ma per fare innanzitutto filosofia. E ciò significa innanzitutto leggere senza farsi distrarre da altre domande; vuol dire leggere lentamente e, per così dire, a bassa voce, senza lasciarsi convincere troppo facilmente da quello che si legge e senza dimenticare nel piacere che si lega alla comprensione delle risposte il compito di appropriarsi delle domande, anticipandole. Rispetto a questo compito mi sento, almeno in parte, inadeguato, ma si tratta di un obiettivo che andava perseguito comunque. Il secondo obiettivo ci riconduce invece a un tema che abbiamo più volte sfiorato discorrendo di Locke e che abbiamo appena iniziato a mettere sul terreno nell’analisi delle pagine husserliane — intendo la descrizione fenomenologica del concetto di cosa materiale. Su questo tema Husserl dice molte cose e molto interessanti, ma — credo — si lascia troppo presto alle spalle il terreno della percezione sensibile e lascia cadere molte distinzioni importanti. Un accenno per il vero vi è, ed alludo a quella breve annotazione in cui Husserl osserva che nel tracciare la genesi del concetto di materialità si è lasciato guidare dal concetto di corpo solido, lasciando da parte le situazioni ambigue come il vetro o come quei materiali che non hanno di per sé una forma propria come l’acqua o l’aria. Si tratta di una considerazione importante che ci invita a tracciare una mappa del concetto di materialità — una mappa che ci mostra come questo concetto nasca con un suo centro più stabile i cui contorni si fanno via via più sbiaditi. Così, alla periferia del concetto di cosa troviamo i materiali senza forma e contorno — l’acqua e l’aria — quei materiali che essendo privi della durezza, ci costringono a raffinare il concetto di materialità. Quanto più la cosa ha contorni rigidi, tanto più netto è il discrimine che contraddistingue il suo esserci: la durezza è uno dei tratti che più evidentemente rendono visibile la materialità nel suo originario porsi come una proprietà delle cose. E tuttavia, la durezza della pietra può perdersi passo dopo passo nella plasmabilità del fango o dell’argilla — e al farsi melma della materia fa da contrappunto il divenire labile della cosa, il suo perdere una fisionomia definita. Sino a venir meno: quando la materia solida assume la forma di ciò che è liquido il gioco linguistico che fa della materialità un predicato delle cose si perde e con esso viene meno anche l’applicabilità del concetto di cosa. Alla materialità come tendenza dell’oggetto a mantenere la propria forma pur nel variare delle forze che su di esso agiscono fa così da riscontro la tendenza della liquidità a porsi come una vera e propria negazione intuitiva del concetto di cosa. Se le cose hanno una forma che si imprime e si consolida nella loro materialità, l’acqua — questa realtà ambigua che condivide con le sostanze eteree la trasparenza e la mobilità e con le sostanze materiali la pesantezza e la tangibilità — è una realtà amorfa che solo temporaneamente riceve una forma dal luogo che la ospita. Proprio come Proteo, il vecchio del mare, anche l’acqua è inafferrabile ed assume mille diverse forme che la rendono irriconoscibile. Ma se nell’acqua le forme si perdono così come si perdono le tracce che si disegnano sulla sua superficie, allora non è difficile comprendere perché l’acqua — e cioè la forma stessa della liquidità — tende a porsi come una cifra dell’oblio. Nell’acqua nulla di ciò che era permane, ed in questa proprietà dei liquidi vi è il motivo fenomenologico per cui l’acqua di un fiume che scorre — il Leté — può cancellare in chi si lascia bagnare dai suoi flutti il ricordo della vita. E l’immaginazione che ci guida nello scorgere le risonanze di senso che appartengono alla logica dei fenomeni, ci conduce lungo il cammino della teoria. L’acqua occupa un posto peculiare nei giochi dei bambini perché è il luogo in cui si fa visibile l’idea di una sostanza materiale che soggiace ai cambiamenti di forma e di stato. Questa vaga idea anima la prassi di molti giochi con l’acqua — il bambino travasa e riempie con la stessa acqua tanti diversi recipienti — ma assume per la prima volta la forma di un pensiero effettivo (di un pensiero pensato nelle parole del nostro linguaggio) nella mente di Talete, di questo primo filosofo che dà forma al concetto astratto di sostanza, senza per questo rescindere il nesso che lo lega all’intuizione concreta, all’immagine della liquidità dell’acqua. Il concetto astratto di materia nasce così dal pensiero intuitivo di una materia che è di fatto caratterizzata dal suo fare astrazione dalla cosa — che è, in altri termini, libera del vincolo che fa della materialità un predicato e che insieme la lega al contorno di un oggetto qualsiasi. La materia come sostrato delle forme ha dunque una sua origine intuitiva che sorregge i nostri primi passi sul terreno dell’astrazione e che sorge da un fantasticare coerente con la natura fenomenologica dell’acqua — questa materia informe che per la sua dimensione fenomenologica può aiutarci a pensare ciò che è in linea di principio al di qua della forma. Vi sono molte altre cose che dovrebbero essere dette, ma ora è proprio il caso di concludere. Lo faccio con una massima di La Rochefoucauld che dice così: Perdoniamo spesso chi ci annoia, ma non riusciamo a perdonare chi è annoiato da noi (Massime, 304). Dunque non ditemi nulla. |
|||||||||||||||||||||