1.
Considerazioni introduttive
2. Un quadro,
una lettera, uno specchio
1. Lettere e
raffigurazioni. La critica alla nozione di somiglianza.
2. La
raffigurazione e i sistemi simbolici
2. La
somiglianza e le immagini
1.
Raffigurazione e denotazione
2.
Raffigurazioni e carte geografiche
1. Il
riconoscimento: una prassi dinamica
2. La forma
obiettiva, gli aspetti, la competenza pittorica
2. La percezione di immagine: una descrizione
fenomenologica
1. Le
immagini, gli esperimenti
2. Il
concetto di raffigurazione e i suoi confini
1. La
geometria duplice delle immagini
1. Le
immagini: un oggetto culturale
2. Fenomenologia
ed ermeneutica delle immagini
Lo spazio e il concetto di raffigurazione
1. «Scrivo
uno quadrangolo di retti angoli»
2. Lo spazio
figurativo, lo spazio reale
1. Il
coinvolgimento: le sue forme spaziali
2. Il
coinvolgimento: i veicoli dell’immaginazione
1. Dal
coinvolgimento alla separatezza: l’icona
2. La
dimensione pragmatica dell’alterità dell’icona
1. La
transitività dell’immagine come relazione iconica
2. La
transitività metaiconica
Il tempo e il concetto di raffigurazione
2. Un
problema antico: il Laocoonte
di Lessing
1. La
narrazione e il presente esteso
Cenni sulla natura del metodo prospettico secondo le due regole del
vignola
1. La prospettiva come intersezione piana della
piramide visiva
Premessa
Queste pagine ripropongono nelle loro linee generali le lezioni del corso di filosofia teoretica che ho tenuto all’Università degli Studi di Milano nell’anno accademico 2002-03.
Delle lezioni hanno mantenuto la forma e, anche, l’apertura: non tutte le parti sono state trattate in modo egualmente approfondito e non è difficile ritrovare — anche solo sfogliando l’indice — quella miscela di programmazione e di imprevisti che caratterizza, credo, ogni corso e che si traduce nel passo sempre più rapido ed affannato con il quale gli argomenti sono affrontati e discussi. In modo particolare, la terza parte, che verte sul tema della narrazione pittorica, avrebbe richiesto più tempo di quello che è stato possibile dedicarle: va dunque letta con un po’ di indulgenza.
Durante il corso sono state proiettate più di 400 diapositive. Riproporle tutte sarebbe stato davvero troppo faticoso. Alcuni capitoli, tuttavia, rimandano alla pagina didattica del corso, dove ho raccolto almeno alcune delle immagini su cui più a lungo ci si è soffermati a lezione.
Una parola, infine deve essere spesa sul disegno così bello, e insieme così inquietante, che Ernst Fuchs ha reso disponibile su internet (http://www.ernstfuchs-zentrum.com) e che compare nella copertina di questa dispensa. Un ciclo di lezioni che, tra gli altri obiettivi, si proponeva anche quello di mostrare come le immagini sappiano e possano esercitare una funzione narrativa, può forse tentare di porsi sotto l’egida dell’Anti-Laocoonte di Fuchs.
Parte Prima
Il concetto di raffigurazione
Lezione prima
1. Considerazioni introduttive
Il corso di quest’anno ha un carattere teorico e non storico-espositivo: non avremo dunque di fronte a noi un testo da commentare o un autore di cui esporre il pensiero, ma solo un problema che dovremo cercare di dipanare quanto più ne saremo capaci, senza arretrare di fronte a questioni che ci sembreranno di volta in volta minute o insignificanti, nella convinzione che la solidità della nostra coscienza filosofica, come quella di una grossa corda, dipenda — per dirla con Wittgenstein — dall’accuratezza con cui sono state intrecciate le molte fibre che la compongono e non da un unico filo che per intero l’attraversi. Dovremo dunque immergerci in un problema particolare e per farlo leggeremo dei testi e li commenteremo, ma ciò non toglie che la parte più impegnativa del lavoro che vi propongo poggi infine sulla capacità di ciascuno di noi di riflettere su qualcosa che in un certo senso conosce già, ma su cui deve comunque cercare di avere le idee più chiare. In un passo delle sue Ricerche filosofiche Wittgenstein diceva che il compito della filosofia consiste nel raccogliere ricordi per uno scopo determinato, e io vi propongo di fare insieme qualcosa di simile: dobbiamo raccogliere i ricordi che ci consentono di delineare in modo perspicuo che cosa si debba intendere quando parliamo di raffigurazioni. Ora, di questo siamo certi: sappiamo usare bene questa parola e distinguiamo istintivamente un quadro da un grafico, una fotografia di un paesaggio dalla sua descrizione verbale, un ritratto da un contrassegno. E tuttavia, anche se sappiamo come si impiega questa parola, non sappiamo per questo vedere chiaramente i molti intrecci che ne scandiscono l’uso e che ne definiscono il posto nel sistema dei nostri concetti.
Si tratta di un vecchio problema su cui Wittgenstein ci invita a riflettere con la sua consueta ironia:
Se in filosofia si volessero proporre tesi, non sarebbe mai possibile metterle in discussione, perché tutti sarebbero d’accordo con esse (Ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino 1974, 128).
Le domande del filosofo hanno tutte, in un certo senso, una risposta ovvia: ai dubbi che dai suoi primi passi la filosofia avanza sull’esserci del mondo o di altre menti, non si può non dare una risposta scontata — quella risposta che per noi quotidianamente dà la vita. I problemi della filosofia sono, in un certo senso, risibili, come ci spiega l’aneddoto antico di Talete e della donna di Tracia che ride del filosofo che, per guardare il cielo, non vede la buca in cui cade. Eppure, è sufficiente che le inquietudini filosofiche si facciano avanti per avvertire la necessità di una risposta che non si accontenti del rimando alle ovvietà della prassi. Proprio come accadeva ad Agostino, anche per Wittgenstein la filosofia è un atteggiamento che getta un alone di stranezza su ciò che altrimenti ci sembra normale e che rende incerta la nostra prassi che di consueto corre su binari ben segnati:
quando filosofiamo siamo come selvaggi, come uomini primitivi che ascoltano il modo di esprimersi di uomini civilizzati, lo fraintendono e traggono le più strane conseguenze dalla loro erronea interpretazione (ivi, § 194).
All’immagine alta del filosofo che scruta dall’alto la vita
operosa e insensata del volgo che non può comprenderlo perché lontano dalla sua
più elevata spiritualità, si contrappone qui la scena risibile di uno strano
tipo che non sa come comportarsi e fa strane domande invece di fare ciò che gli
altri con sicurezza fanno. E tuttavia, il sorriso ironico non deve cancellare
la dimensione seria del problema: Wittgenstein vuole sostenere che l’attività filosofica risponde a problemi e
inquietudini che sono ridestate dalla filosofia stessa e che non hanno ragion
d’essere al di là dell’atteggiamento umano ed intellettuale che le crea. La filosofia è un tarlo che potrebbe venir
meno senza danni concreti per la vita; una volta che si è destato, tuttavia,
dal suo rodio ci si può liberare solo disponendosi seriamente sul terreno filosofico.
La filosofia ci appare così come un disagio e come una un’attività terapeutica,
come una malattia che chiede una cura omeopatica.
Come reagire a queste considerazioni? Semplicemente accettandole — io credo, e rendendoci conto dei limiti che dobbiamo dare alle nostre indagini e che sono dettati dalla natura del problema che ci proponiamo. Ci si può interessare in molti modi delle raffigurazioni, e sono molti gli interrogativi reali che possiamo sollevare intorno alla loro natura. Possiamo per esempio chiederci quali siano i presupposti psicologici e fisiologici che stanno a fondamento della nostra percezione di immagini, ma a questa domanda — che è evidentemente del tutto legittima ed importante — non possiamo nemmeno tentare di dare una risposta. La filosofia non una è psicologia senza esperimenti e non può anticipare a priori quale possa essere la genesi dei processi raffigurativi, né scegliere — sul fondamento di argomenti filosofici — l’immagine della mente che più le aggrada.
Ma la filosofia non è nemmeno una teoria dell’arte: come filosofi non siamo chiamati a scegliere una qualche poetica, che possa sembrarci vicina alle ragioni della filosofia che ci è più vicina. Per dirla altrimenti: l’obiettivo di queste lezioni non sarà quello di aiutarci a scegliere tra i molti percorsi che sono aperti all’arte contemporanea quello che ci sembra il migliore. Ancora una volta: il filosofo non è uno spettatore che abbia maturato un diritto particolare sulle opere che osserva e le sue riflessioni non sono la penna rossa con cui segnare gli errori che si presume che altri — gli artisti — abbiano compiuto. Una simile penna spetta a chiunque, così come chiunque può decidere se lasciarsi o non lasciarsi convincere dalle correzioni che pretende di tracciare.
Ma allora, se le cose stanno così, perché impegnarsi in un lavoro che non promette di farci sapere fatti nuovi sulla genesi percettiva delle immagini e che non ha in linea di principio la pretesa di guidarci nei sentieri complessi dell’arte? Per una buona ragione, credo: talvolta, più che di sapere cose nuove abbiamo bisogno di fare ordine in quelle che già sappiamo e che fanno parte di un abito intellettuale che ci è proprio da un tempo così lontano da sembrarci da sempre acquisito. E così stanno le cose anche per ciò che concerne il concetto di raffigurazione. Non abbiamo da imparare nulla di nuovo sulla natura delle raffigurazioni, ma ciò non toglie che possa, prima o poi, sembrarci importante guadagnare una diversa chiarezza su questo concetto ed abbracciare in un discorso coerente le molte distinzioni che lo riguardano e che determinano il nostro rapportarci ad un quadro, alla storia che narra, al messaggio che vuole rivolgerci. Può darsi che ci accada di sentire il bisogno di vedere chiaro nelle immagini — in questi oggetti che hanno un ruolo centrale nella vicenda umana sin dalle sue prime mosse. E se ciò accade siamo costretti a fare un poco di filosofia, nella convinzione che far luce sulla grammatica del concetto di raffigurazione e sul posto che esso occupa nel sistema dei nostri concetti possa voler dire anche fissare alcuni di quei punti fermi di cui abbiamo bisogno per capire qual è il nostro posto nel linguaggio.
Ma se questo è l’obiettivo verso cui tendono le nostre riflessioni, dobbiamo in primo luogo cercare di risvegliare qualche inquietudine filosofica sulle immagini.
2. Un quadro, una lettera, uno specchio
In un quadro di Gabriel Metsu (1629-1667) troviamo
raffigurata una scena particolare: da una lato vi è una giovane donna che legge
la lettera che le è stata appena recata, dall’altro vi è una fantesca che
scosta una tenda e rivela un dipinto di mari agitati il cui contenuto minaccioso
sembra rivelarci visivamente ciò che la  lettera
a fatica, parola dopo parola, asserisce. Sullo sfondo di questa storia angosciosa
di naufragi incombenti, uno specchio mostra ciò che casualmente cade sulla
sua superficie: il vano della finestra e gli scuri che lo proteggono.
lettera
a fatica, parola dopo parola, asserisce. Sullo sfondo di questa storia angosciosa
di naufragi incombenti, uno specchio mostra ciò che casualmente cade sulla
sua superficie: il vano della finestra e gli scuri che lo proteggono.
Sulla dimensione narrativa e descrittiva di questo quadro si potrebbero dire molte altre cose, e molte di fatto sono già state dette dai critici. Ma non è questo ora il nostro obiettivo: se di questo quadro vogliamo parlare è perché qui nella cornice ci si mostra racchiusa una distinzione, e insieme un confronto, su cui è opportuno riflettere: in questo dipinto appaiono infatti l’una accanto all’altra tre differenti forme di rappresentazione — vi è appunto una lettera, vi è un quadro, e vi è uno specchio. Tre forme di rappresentazione distinte le une dalle altre, e tuttavia connesse in unico quadro e legate l’una all’altra da una serie di vincoli. Vi è innanzitutto una lettera, e cioè una rappresentazione linguistica, che racconta parola dopo parola gli eventi su cui chi l’ha scritta intende richiamare la nostra attenzione. La lettera dice ciò che vuole e insieme tace i particolari che ritiene irrilevanti o forse poco opportuni: forse parla delle fatiche di un viaggio in mare, ma tace del rischio presente delle tempeste. O forse ne parla, ma senza dilungarsi sul colore del mare o sulla dinamica dei flutti. Una rappresentazione verbale è fatta così: può raccontare ciò che accade e insieme tacere molte cose che pure appartengono all’evento accaduto. E ancora: la lettera probabilmente racconta proprio ciò che il quadro ci mostra, ma per intenderla bisogna saper leggere e non basta guardarla o tenerla tra le mani. La lettera parla per la giovane signora, non forse per la domestica che ci volge le spalle. Diversamente stanno le cose per il quadro che si staglia sulla parete: qui per intendere è sufficiente scostare il drappo che nasconde il dipinto alla vista. L’immagine si mostra e non vi è bisogno di saper compitare i segni secondo un sistema di convenzioni poiché l’immagine si dispiega immediatamente allo sguardo. Nell’unità di uno sguardo: la scena dipinta non sembra essere vincolata alla regola della costruzione sintattica e alla linearità del linguaggio che ci costringe a costruire passo dopo passo ed enunciato dopo enunciato ciò che si vuole significare. Nel dipinto il messaggio è già tutto presente, anche se nulla è detto e scandito nella forma di un’asserzione esplicita, — un’osservazione il cui senso si comprende non appena riflettiamo su quante e diverse sono le possibili descrizioni verbali che di una stessa semplicissima scena possiamo dare. E l’immediatezza del dire ha come prezzo la difficoltà di tacere: Metsu non può semplicemente dire che nella stanza vi sono due donne, un cane o una scarpa spaiata, ma deve anche farci vedere il colore degli abiti e la loro foggia, e deve dare un colore e una posa al cane che sembra avvertire qualcosa del padrone lontano. In un quadro la libertà di dire si lega all’impossibilità di tacere molte altre cose. Così, anche se il dipinto che si svela dietro al drappo e la lettera che si libera dalla busta che la celava ci parlano forse di una stessa realtà, il modo in cui ce ne parlano è diverso e si rispecchia nella disposizione delle due donne che sembra dar forma visiva ad una contrapposizione teorica.
Alla rappresentazione verbale e pittorica si aggiunge l’immagine speculare, il suo proporsi come ripetizione di una scena visiva che ha come sua unica ragion d’essere il processo causale della propagazione della luce secondo le leggi dell’ottica geometrica. Sullo specchio si rappresenta qualcosa — vediamo appunto la finestra da cui giunge la luce — ma ciò che lo specchio mostra non è in realtà un messaggio che ci giunga da qualcuno. Lo specchio, in senso proprio, non dice nulla, poiché non vi è in questo caso la volontà di mostrare. E così come non vi è un dire dello specchio, così non sembra nemmeno esservi spazio per un tacere: il pittore può scegliere se raffigurare o non raffigurare qualcosa, lo specchio invece non può tralasciare di raffigurare tutto ciò che la luce reca sulla sua superficie. E così come non può tacere, così non può nemmeno mentire: lo specchio rivela ciò che c’è, e non altro. Ciò che si raffigura sullo specchio è davvero ciò che potremmo direttamente vedere, — se solo la luce obbedisse ad una diversa geometria.
Su queste differenze intuitive potremmo soffermarci ancora,
per renderle più perspicue e per dare una consistenza più salda ad un sapere
che permea di sé la nostra quotidianità. Ma non è questo il nostro obiettivo.
Tutt’altro: vogliamo infatti aprire un varco  alle
inquietudini della filosofia e lasciarci prendere da un ragionare coerente ma
negativo che tenda a minare ciò che altrimenti ci sembra solido.
alle
inquietudini della filosofia e lasciarci prendere da un ragionare coerente ma
negativo che tenda a minare ciò che altrimenti ci sembra solido.
E allora innanzitutto ci chiediamo: un quadro è davvero così diverso da una lettera? Vorremmo rispondere di sì, rammentando proprio quella convenzionalità dei segni linguistici su cui ci siamo già soffermati e che si mostra così chiaramente nel fatto che per leggere vi è bisogno di un addestramento che non sembra necessario nel caso delle immagini. I libri illustrati su cui si impara a leggere e a scrivere poggiano su questa convinzione: dapprima si disegna qualcosa, poi sotto il disegno si scrive la parola, e l’incertezza della lettura trova un appiglio nella certezza del riconoscimento visivo. Ora, di fronte a questo confortante quadretto potremmo reagire forse così, come Magritte ci suggerisce di fare — mettendo in dubbio la certezza di quel nesso che ci sembrava tanto evidente. Ma potremmo anche suggerire un’ipotesi più azzardata: potremmo sostenere che il nome scritto in caratteri corsivi sotto al disegno è in realtà la chiave di lettura che ci consente di interpretarlo, — un po’ come accade in certi quadri del primo Novecento che diventano “leggibili” per noi solo quando il titolo ci suggerisce che cosa dobbiamo cercare nell’intrico dei segni. Forse, quando lo sguardo cade su questo quadro di Picasso coglie solo un intrico di linee; ma è sufficiente leggere che cosa recita il titolo — Ritratto di Kahnweiler — perché si facciano avanti un volto, e poi il corpo di un uomo con le mani conserte.
A queste considerazioni potremmo forse reagire con un certo fastidio,
proprio come accade quando si ha l’impressione che qualcuno ci voglia ingannare
con un paradosso creato ad arte. E  forse
risponderemmo così: certo, talvolta le immagini non sono immediatamente perspicue,
ma questo non ci permette di accostarle ai segni linguistici. Che vi sia il ritratto
di un uomo nel dipinto di Picasso lo scorgiamo a fatica, ma ciò non toglie che
— guardando bene — un volto prende forma per noi. Possiamo invece guardare
quanto ci pare le parole «der
Kunstsammler Henry Kahnweiler» senza che per questo prenda
necessariamente forma qualcosa: se non sappiamo leggere e se non conosciamo la
lingua tedesca o il nome di quel gallerista la scritta resta muta per noi. E
non è un caso che le cose stiano così: i segni linguistici sono convenzionali,
mentre una raffigurazione non lo è, poiché somiglia a ciò che raffigura. Basta
tuttavia pronunciare questa parola — la somiglianza — perché sorgano nuovi problemi:
la somiglianza è un concetto vago, e non è chiaro in che senso un disegno assomigli
a ciò che raffigura. In fondo sulla tela vediamo colori e forme su di una superficie,
e un po’ di pigmenti disposti ad arte non sono simili a un viso, a una
battaglia, a un paesaggio. Somiglianza e rappresentazione sembrano avere poco a
che fare, se è vero che da un lato la somiglianza tra due gocce d’acqua non
basta per dire che l’una raffigura l’altra, mentre dall’altro diciamo che lo
scarabocchio di un bambino raffigura la sua famiglia accanto alla casa.
forse
risponderemmo così: certo, talvolta le immagini non sono immediatamente perspicue,
ma questo non ci permette di accostarle ai segni linguistici. Che vi sia il ritratto
di un uomo nel dipinto di Picasso lo scorgiamo a fatica, ma ciò non toglie che
— guardando bene — un volto prende forma per noi. Possiamo invece guardare
quanto ci pare le parole «der
Kunstsammler Henry Kahnweiler» senza che per questo prenda
necessariamente forma qualcosa: se non sappiamo leggere e se non conosciamo la
lingua tedesca o il nome di quel gallerista la scritta resta muta per noi. E
non è un caso che le cose stiano così: i segni linguistici sono convenzionali,
mentre una raffigurazione non lo è, poiché somiglia a ciò che raffigura. Basta
tuttavia pronunciare questa parola — la somiglianza — perché sorgano nuovi problemi:
la somiglianza è un concetto vago, e non è chiaro in che senso un disegno assomigli
a ciò che raffigura. In fondo sulla tela vediamo colori e forme su di una superficie,
e un po’ di pigmenti disposti ad arte non sono simili a un viso, a una
battaglia, a un paesaggio. Somiglianza e rappresentazione sembrano avere poco a
che fare, se è vero che da un lato la somiglianza tra due gocce d’acqua non
basta per dire che l’una raffigura l’altra, mentre dall’altro diciamo che lo
scarabocchio di un bambino raffigura la sua famiglia accanto alla casa.
Del resto, proprio il ritratto di Kahnweiler di cui discorriamo sembra suggerire un nuovo argomento per indebolire le nostre certezze. In fondo in quell’intrico di linee siamo disposti a cercare il ritratto di un uomo solo perché non è la prima volta che vediamo un quadro di Picasso. Ma proprio questo è il punto: forse vediamo un volto perché abbiamo imparato a comprendere lo stile in cui l’immagine è scritta, e ciò è quanto dire che la riconoscibilità dell’immagine passa per un addestramento che rammenta da vicino gli insegnamenti di cui abbiamo bisogno per leggere. Ed è sufficiente avanzare quest’ipotesi perché le riflessioni del filosofo trovino un qualche dato cui intrecciarsi: i resoconti di alcuni antropologi ci assicurano che vi sono uomini in terre lontane che non vedono la profondità in un’immagine prospettica o che rigirano stranamente tra le mani la fotografia di una persona ben nota. Dovremmo trarre allora questa conclusione: le immagini parlano — ma solo alla cultura che le ha prodotte, e questo deve valere come una buona ragione per mettere da parte la nostra distinzione tra rappresentazioni verbali e rappresentazioni pittoriche e sostenere che, in fondo, una lettera non è poi così diversa da un quadro, anche se si avvale di segni differenti.
 Alle
inquietudini che il filosofo convenzionalista solleva si affiancano tuttavia i
dubbi che sorgono da una considerazione orientata alla luce di un’istanza
realistico-naturalistica. Ed in questo caso è la distanza dalle immagini
speculari che deve sembrarci assai meno significativa. In fondo la pittura
rinascimentale era stata ben chiara su questo punto: il quadro è, dato un
punto, l’intersezione piana dei raggi luminosi che verso di esso convergono.
Così, se vi è un senso nelle incisioni di Dürer sull’arte della pittura è forse
proprio questo: farci riflettere su quanto esigua sia la differenza tra la tela
e lo specchio — una differenza che è tutta racchiusa nella distinzione tra riflessione
e intersezione. Certo, ma perché dovremmo credere a Dürer? Non potremmo sostenere
che la convinzione che in quelle incisioni si esprime altro non è che il frutto
dell’illusione rinascimentale che coglieva nella pittura una scienza esatta?
Certo, potremmo; ma solo a patto di chiudere gli occhi su un problema effettivo.
Non è evidentemente vero che solo ciò che rispecchia le regole della prospettiva
può dirsi davvero un quadro, ma resta egualmente il fatto che noi vediamo
nella tela uomini, palazzi, paesaggi e che questo può accadere soltanto perché
la luce che giunge ai nostri occhi reca con sé l’informazione necessaria per farci
vedere ciò che vediamo. Proprio come sulla superficie di uno specchio si
disegna qualcosa perché la configurazione dei raggi luminosi che su di essa si
riflettono mantiene un’ordinata struttura, così la pagina bianca può animarsi
di una qualche vicenda solo perché i pigmenti che lasciamo sulla carta
restituiscono un fascio di luce che ha una sua determinata struttura. Un quadro
non è uno specchio, ma deve comunque rispecchiare in un qualche modo la configurazione
luminosa che rende l’oggetto avvertibile per noi: in mancanza di questo, sul
foglio non vi sarebbe che inchiostro e colore, non un disegno. E se le cose
stanno così, se quest’osservazione ci sembra in qualche misura plausibile,
allora dovremo riconoscere che non vi è poi tanta differenza tra la rappresentazione
pittorica e la rappresentazione speculare. E ciò è quanto dire che il quadro di
Metsu è forse soltanto un bel quadro, ma non può servirci davvero per organizzare
le nostre idee sulla natura delle raffigurazioni.
Alle
inquietudini che il filosofo convenzionalista solleva si affiancano tuttavia i
dubbi che sorgono da una considerazione orientata alla luce di un’istanza
realistico-naturalistica. Ed in questo caso è la distanza dalle immagini
speculari che deve sembrarci assai meno significativa. In fondo la pittura
rinascimentale era stata ben chiara su questo punto: il quadro è, dato un
punto, l’intersezione piana dei raggi luminosi che verso di esso convergono.
Così, se vi è un senso nelle incisioni di Dürer sull’arte della pittura è forse
proprio questo: farci riflettere su quanto esigua sia la differenza tra la tela
e lo specchio — una differenza che è tutta racchiusa nella distinzione tra riflessione
e intersezione. Certo, ma perché dovremmo credere a Dürer? Non potremmo sostenere
che la convinzione che in quelle incisioni si esprime altro non è che il frutto
dell’illusione rinascimentale che coglieva nella pittura una scienza esatta?
Certo, potremmo; ma solo a patto di chiudere gli occhi su un problema effettivo.
Non è evidentemente vero che solo ciò che rispecchia le regole della prospettiva
può dirsi davvero un quadro, ma resta egualmente il fatto che noi vediamo
nella tela uomini, palazzi, paesaggi e che questo può accadere soltanto perché
la luce che giunge ai nostri occhi reca con sé l’informazione necessaria per farci
vedere ciò che vediamo. Proprio come sulla superficie di uno specchio si
disegna qualcosa perché la configurazione dei raggi luminosi che su di essa si
riflettono mantiene un’ordinata struttura, così la pagina bianca può animarsi
di una qualche vicenda solo perché i pigmenti che lasciamo sulla carta
restituiscono un fascio di luce che ha una sua determinata struttura. Un quadro
non è uno specchio, ma deve comunque rispecchiare in un qualche modo la configurazione
luminosa che rende l’oggetto avvertibile per noi: in mancanza di questo, sul
foglio non vi sarebbe che inchiostro e colore, non un disegno. E se le cose
stanno così, se quest’osservazione ci sembra in qualche misura plausibile,
allora dovremo riconoscere che non vi è poi tanta differenza tra la rappresentazione
pittorica e la rappresentazione speculare. E ciò è quanto dire che il quadro di
Metsu è forse soltanto un bel quadro, ma non può servirci davvero per organizzare
le nostre idee sulla natura delle raffigurazioni.
Possiamo per ora fermarci qui. Il compito di questa nostra prima lezione era del resto soltanto questo: sollevare un poco di polvere — quel tanto che basta per farci avvertire il bisogno di vedere con maggiore chiarezza[1].
Lezione seconda
1. L’immagine e lo specchio
Nella precedente lezione ci siamo soffermati su un quadro di Gabriel Metsu che sembra invitarci a riflettere sulla relazione che lega tra loro tre differenti forme di rappresentazione: un dipinto, uno specchio, una lettera. Queste tre forme c’erano parse dapprima chiaramente distinguibili, ma era stato sufficiente riflettere un poco perché i confini si facessero più labili e perché più incerta apparisse la fisionomia di un concetto che credevamo familiare. Di questo primo esito delle nostre indagini non possiamo lamentarci: volevamo provare il sapore delle inquietudini filosofiche e siamo stati subito accontentati. Ma adesso al disagio filosofico che abbiamo alimentato moltiplicando le domande, dobbiamo dare risposta e ciò significa che dobbiamo cercare di fare ordine nelle nostre idee, per comprendere quale sia la grammatica del concetto di raffigurazione e quale il luogo che le spetta nel sistema dei nostri concetti.
Ora, il primo passo in questa direzione consiste, io credo, nel cercare di cogliere quali siano gli esempi che debbono guidarci nelle nostre considerazioni. Non si tratta di una scelta facile: sappiamo bene che cos’è un’immagine e comprendiamo il termine “rappresentazione”, ma questo non significa ancora che ci sia già chiaro quale sia il cuore del problema, il punto da cui muovere per disporre in un ordine sensato le molte e diverse forme di rappresentazione di cui parliamo. Quando visitiamo una città, ci rechiamo dapprima nelle piazze e nelle strade più antiche che ne occupano il centro, per avventurarci poi nei quartieri via via più periferici, seguendo un cammino che ripete passo dopo passo la storia di una comunità di persone che ha dato forma nel tempo ad un intreccio di strade, di case, di sobborghi. E così dobbiamo fare anche noi per visitare la grammatica dei concetti: dobbiamo cercare dapprima quale sia il loro centro più antico, perché è di qui che è opportuno muovere per ordinare in modo sensato la trama dei giochi linguistici che appartengono ad uno stesso luogo teorico. Di qui, dunque, il senso della domanda che ci siamo posti: se per comprendere la natura delle rappresentazioni è necessario risalire alla loro forma più semplice e originaria, allora dobbiamo chiederci se sia più opportuno lasciarci guidare dal modello delle immagini speculari o dal paradigma linguistico della parola scritta o se invece la nostra attenzione debba essere rivolta alle raffigurazioni pittoriche, mettendo da parte analogie che potrebbero rivelarsi falsanti.
Per cercare di rispondere a questa domanda vogliamo innanzitutto riflettere sull’ipotesi che abbiamo formulato per prima, per vedere se sia legittimo vincolare la comprensione del concetto di raffigurazione all’esemplarità delle immagini speculari. Vi è un senso in cui, credo, che quest’analogia debba essere rifiutata: parlare di un’immagine speculare significa infatti alludere ad una forma di raffigurazione che presuppone l’esistenza di un oggetto esterno all’immagine e ad essa connesso da una relazione di natura causale. Che cosa ciò significhi è presto detto, Sulla superficie dell’acqua si riflette un volto e noi ci giriamo per vedere chi sia la persona cui volgiamo le spalle e che vediamo rispecchiata nell’acqua. Perché appunto una persona deve esserci: l’immagine riflessa vale come una garanzia del fatto che al di là dell’immagine vi è la causa obiettiva del suo esserci, — quel qualcosa che determina il fenomeno del rispecchiamento e di cui mediatamente l’immagine ci parla. Una garanzia sufficiente, ma anche una condizione necessaria: le immagini speculari hanno caratteristiche fenomenologiche che ci permettono di distinguerle da altre immagini, ed è per questo che riusciamo a riconoscere in un quadro uno specchio dipinto; tuttavia, parliamo con pieno diritto di immagini speculari solo quando siamo certi che ciò che vediamo sulla superficie dello specchio sia soltanto il riflesso di qualcosa che esiste indipendentemente da esso. Un’immagine è speculare non perché è fatta in un certo modo, ma perché vi è qualcosa che in essa si manifesta: la specularità non è in senso proprio un predicato fenomenologico dell’immagine e non concerne primariamente il suo modo di manifestarsi, ma rimanda direttamente al porsi di una relazione reale che ci consente di interpretare l’immagine come effetto di una causa. Ora, ciò che è vero delle immagini speculari, vale anche per le immagini fotografiche: una fotografia ci mostra qualcosa — vediamo un paesaggio e un volto ben noto, ma ciò che in essa si rende visibile parla anche in nome dell’esserci di quel paesaggio e di quel volto: il soggetto dell’immagine fotografica (ciò che in essa si manifesta) rende così testimonianza dell’esserci (o dell’esserci stato) di qualcosa che ha proprio le fattezze che la pellicola ha fermato. Ed anche in questo caso, la fotografia non è soltanto una ragione sufficiente per sostenere che vi è (o che vi è stato) ciò che in essa si mostra, ma è vero anche che l’esserci (o l’esserci stato) di ciò che una fotografia mostra è una condizione necessaria per poter dire che ciò che abbiamo sotto gli occhi è davvero una fotografia. Se sulla pellicola si formasse da sola, per una strana reazione chimica, l’immagine della chimera, noi non diremmo di avere una sua fotografia, ma solo un’immagine che, dal punto di vista fenomenologico, è indistinguibile da una fotografia autentica, anche se non lo è affatto. Possiamo trarre allora la conclusione cui tendevamo: anche nel caso delle fotografie, come nel caso delle immagini speculari, la relazione causale che le lega alla loro origine reale è un momento che appartiene essenzialmente al loro concetto, ma non alla loro datità fenomenologica.
Di qui, tuttavia, non sarebbe opportuno muovere per sostenere che le immagini in quanto tali hanno necessariamente un qualche rimando ad un oggetto ad esse esterno. Ciò che è vero per le fotografie e per le immagini speculari non vale, per esempio, per le raffigurazioni pittoriche. Qui il rimando ad un nesso causale che ci permetta di risalire da ciò che si raffigura ad un quid di cui la rappresentazione ci parli non può essere seriamente proposto, e questo semplicemente perché vi è un’infinità di quadri in cui si raffigurano cose che non esistono affatto. Non ogni raffigurazione è un’impronta, ed è per questo che di fronte ad un disegno o ad un dipinto non ha alcun senso pretendere che vi sia al di là di esso qualcosa che l’abbia generato e di cui si possa al contempo dire che l’immagine parla. Del resto, anche quando un disegno ricalca un modello ed anche se si è disposti ad intendere questa relazione come se fosse un nesso di natura causale (cosa su cui è lecito avanzare più di un dubbio), non è affatto detto che la raffigurazione ci parli davvero dell’oggetto reale da cui è tratto: Reni avrà ben avuto di fronte agli occhi una donna ed un uomo reali quando ha dipinto il suo Atalanta e Ippomene, ma quell’affresco non ci parla affatto di quei suoi contemporanei che gli hanno fatto da modelli. Quell’affresco ci parla di Atalanta e Ippomene — non di altri, e ciò è quanto dire che le raffigurazioni pittoriche non possono essere intese sotto questo riguardo alla luce del paradigma del rispecchiamento. Comprendere nella sua generalità il concetto di raffigurazione non significa prendere le mosse da una nozione di immagine che abbia come sua nota essenziale il rimando causale ad un oggetto ad essa esterno.
Sembrerebbe allora legittimo sostenere che il senso delle considerazioni che abbiamo sin qui proposto possa essere riassunto proponendo uno schema che distingua le raffigurazioni che sono anche impronte da quelle che non lo sono, e che l’opposizione rispetto al paradigma della specularità valga in questo caso come un invito a non intendere il tutto a partire da una sua parte:
|
|
Immagini |
|
||
|
determinate
causalisticamente (impronte) |
|
non
determinate causalisticamente (mere
raffigurazioni) |
||
|
fotografie |
immagini
speculari |
|
dipinti |
disegni |
Questo schema ci insegna forse qualcosa, ma anche se non vi è ragione per rifiutarlo, non per questo ci consente di comprendere meglio la natura delle raffigurazioni, e io credo che questa conclusione derivi direttamente dalla constatazione secondo la quale il rimando alla relazione causale, che pure è parte costitutiva delle immagini speculari e fotografiche, non appartiene tuttavia alla dimensione fenomenologica della raffigurazione, all’immagine in quanto immagine. Quando guardo una fotografia, vedo che è una raffigurazione anche se ignoro quale sia la sua origine reale e quale sia il rapporto che la lega all’esserci di qualcosa che sta al di là di essa: anche se è così ricca di dettagli e così vicina al reale, una fotografia potrebbe egualmente essere il frutto della perizia di un disegnatore e se ignorassi davvero qual è il legame che la stringe con la realtà potrei credere che nulla di ciò che in essa si raffigura debba necessariamente esistere al di là della carta che ne ospita l’immagine. E ciò che vale per le fotografie, vale anche per le immagini speculari: in fondo, anche un riflesso potrebbe essere soltanto un’immagine e non parlarci di un qualcosa che si rispecchia, e se potessimo leggere Ovidio un poco liberamente, potremmo dire che quando Narciso avverte l’inafferrabilità e la presenza irreale del volto di cui si è innamorato sta di fatto cogliendo la natura di immagine del riflesso prima ancora di averne avvertita la specularità e quindi il rimando ad un’oggettività altra e reale. Ma ciò è quanto dire che il rimando alla relazione causale che lega determinate raffigurazioni a ciò che le origina è sito al di là del concetto di raffigurazione e non incide in modo essenziale sul modo di questo raffigurare, ma prevalentemente sull’uso che possiamo farne, in virtù di un sapere che ci consente di andare al di là dell’immagine stessa.
Del resto, quest’ordine di considerazioni trova una nuova conferma non appena riflettiamo sul fatto che la presenza del nesso causale che lega la raffigurazione all’oggetto da cui deriva può restare ininfluente e non determinare l’uso che dell’immagine in quanto tale facciamo. Se non vi fosse l’oggetto reale che vi si raffigura, una fotografia non sarebbe una fotografia autentica, ma questo non significa che una fotografia sia necessariamente usata come testimonianza di un qualche evento reale o dell’esserci di qualcosa o di qualcuno. E gli esempi sono a portata di mano: quando abbandoniamo la platea di un teatro, ci imbattiamo spesso in fotografie che ritraggono le scene che abbiamo appena visto recitare, e così rivediamo Edipo che interroga Tiresia, Giocasta che comprende che cosa è accaduto, le figlie accanto al padre ormai cieco. Guardando quelle fotografie potremmo proprio esprimerci così: ciò che ci mostrano è in fondo soltanto questo — i diversi momenti e i personaggi di una trama narrativa da cui facciamo ancora fatica a staccarci. Di quelle immagini possiamo tuttavia fare un uso differente, e basta pensarle nella prospettiva degli attori o degli operatori teatrali perché esse acquistino un significato interamente nuovo: chi le guarda vi scorge ora una testimonianza del fatto che proprio in questo luogo vi è stata la recita di una tragedia di Sofocle e che proprio questi attori hanno di fatto prestato il loro volto a Edipo, a Giocasta, ad Antigone. E se le cose stanno così, allora sembra legittimo sostenere che anche se vi sono immagini che dipendono causalmente dall’oggetto che, di norma, in esse si raffigura e se è un fatto che, nella norma, una fotografia ci invita a risalire dall’immagine all’oggetto che l’ha causata, questo non significa ancora che il rimando alla relazione causale sia parte del concetto di raffigurazione. Le immagini sono innanzitutto immagini, ed anche se di solito una fotografia ci parla di oggetti reali, poiché tutti sappiamo qual è il processo reale da cui trae origine, ciò non significa che sia questo l’uso che necessariamente dobbiamo farne, proprio come l’indipendenza della raffigurazione pittorica dall’oggetto che eventualmente è servito da modello non ci impedisce di utilizzare un dipinto proprio così — come una testimonianza di un fatto, di un evento storico realmente accaduto di fronte allo sguardo del pittore.
Avremo modo di tornare su questo tema e sul nesso che lega le immagini all’uso che ne facciamo. Per ora ci basta trarre la conclusione che abbiamo anticipato: se l’immagine speculare può insegnarci qualcosa sulle raffigurazioni in quanto tali e sulle raffigurazioni pittoriche in particolare, ciò non può dipendere dalla comprensione della relazione causale che normalmente accompagna la nostra ricezione delle immagini speculari o delle fotografie. Ciò tuttavia non toglie che le immagini speculari potrebbero far valere la loro esemplarità in una direzione diversa verso cui dobbiamo ora volgerci. Per Leon Battista Alberti, l’inventore della pittura è Narciso e se l’origine delle immagini può essere cercata accostando lo specchio alla tela ciò accade perché il loro raffigurare rimanda alle stesse leggi, ad un’analoga obbedienza alla geometria della luce.
Di quest’affermazione così impegnativa dobbiamo cercare ora di rendere conto. E ciò significa, in primo luogo, richiamare l’attenzione sul fatto che se per esempio la superficie dell’acqua può fungere come uno specchio, ciò accade perché sa restituire, senza alterarne l’ordine, i raggi luminosi che la colpiscono, ripetendo per chi la guarda la configurazione di punti luminosi che deriva dagli oggetti riflessi che si fanno, proprio per questo, in essa mediatamente visibili. Qualcosa di simile deve valere anche per le immagini che la mano dell’uomo crea sulla tela o su un foglio: una raffigurazione deve essere una superficie fatta in modo tale da restituire in virtù dei suoi pigmenti e dell’ordine in cui sono disposti una configurazione di raggi luminosi simile a quella che colpirebbe il nostro occhio se vedessimo realmente l’oggetto raffigurato. La tela su cui disegniamo è uno specchio fatto ad arte, su cui il pennello traccia linee e contorni in modo tale da ricreare artificialmente ciò che naturalmente accade su una qualsiasi superficie riflettente.
Che le cose stiano proprio così è quanto sostiene James Gibson, in uno scritto degli anni sessanta, intitolato Pictures, perspective and perception («Daedalus», 1960)[2]. Si tratta di un articolo relativamente breve, scritto — come sostiene l’autore — da un psicologo sperimentale che ha dedicato la sua ricerca a far luce sulla natura della percezione visiva. Di questa rapida osservazione autobiografica si deve tenere conto perché di fatto ci aiuta a rispondere ad una domanda che occorre porsi non appena ci si addentra nelle pagine di un testo: dobbiamo infatti chiederci quale sia la prospettiva generale rispetto alla quale il tema discusso diviene problematico per l’autore che ne parla. Ed in questo caso non vi è davvero spazio per i dubbi: per Gibson, riflettere sulla nozione di raffigurazione non significa porsi una domanda che concerna la funzione delle immagini o la loro appartenenza alla classe più ampia delle rappresentazioni, ma vuol dire invece domandarsi come sia possibile che su un foglio di carta pochi tratti di penna ci consentano di vedere qualcosa d’altro — un volto, un paesaggio, una battaglia. Ne segue che tracciare una teoria della raffigurazione vuol dire in questa prospettiva muovere da una teoria generale della percezione visiva, per poi mostrare quali siano le condizioni da cui dipende la possibilità di scorgere su di una superficie ciò che in essa si raffigura.
Ora, se ci chiediamo che cosa in generale ci consenta di vedere ciò che vediamo siamo innanzitutto ricondotti ad un fatto di carattere generale. Vediamo perché vi è luce, e la luce giunge da un astro tanto lontano — il Sole — da permetterci di considerare paralleli gli uni agli altri i raggi che ne provengono. Questa marcia ordinata cessa non appena la luce penetra nell’atmosfera e lambisce gli oggetti di questo regno della generazione e corruzione: la luce diretta si trasforma nella luce ambientale, in quell’illuminazione diffusa che nasce dal fatto che, riverberandosi sulle superfici irregolari degli oggetti, i raggi luminosi si diffondono in sempre nuove direzioni, occupando lo spazio circostante e rendendo meno avvertibili i confini tra luce e ombra.
Ora, questo continuo gioco di rispecchiamenti ha un duplice significato per la percezione. Il primo è puramente geometrico: la luce ambientale è il frutto di una molteplicità di raggi che si propagano in linea retta in ogni direzione, e ciò fa sì che ogni punto di uno spazio pervaso dalla luce possa essere descritto come il luogo di intersezione di una molteplicità di raggi luminosi. Ma vi è anche un secondo significato: nel suo farsi ambientale, la luce si arricchisce di informazioni, poiché quando un raggio di luce viene riflesso da un oggetto muta tanto la sua intensità quanto la sua frequenza d’onda, e muta in ragione dei materiali delle superfici riflettenti. Per sottolineare questa sua nuova natura, Gibson ci invita ad una distinzione terminologica: non parla più di raggi, ma di pennelli [pencils] di luce, e la ragione di questa scelta è ben chiara — come un pennello, anche la luce è latrice di un colore e di una sua intensità. Basta connettere l’uno all’altro questi due momenti perché il senso delle considerazioni di Gibson si faccia avanti con relativa chiarezza: i raggi di luce si intersecano in ogni punto di un ambiente illuminato e proprio perché sono pennelli di luce rendono disponibile in quel punto una messe di informazioni sulla natura dell’oggetto da cui derivano. Possiamo sostenere allora che ogni punto di uno spazio illuminato è il luogo verso cui converge un cono di pennelli luminosi, che recano in sé — mantenendo inalterato l’ordinamento dei punti — informazioni sul colore dei punti corrispondenti delle superfici degli oggetti da cui derivano. Gibson parla a questo proposito di assetto ottico [optic array] e ciò che con questo concetto intende è ben chiaro: i raggi di luce che convergono verso un qualsiasi punto dello spazio ambientale non sono soltanto latori delle differenze qualitative della superficie da cui provengono, ma hanno una loro disposizione che è dettata dalla posizione che le superfici riflesse occupano. L’assetto ottico sarà allora determinato dalla qualità e dalla disposizione dei pennelli luminosi per un punto dato, e contiene quindi un insieme di informazioni relative alla natura degli oggetti e alla posizione che essi occupano nello spazio.
Ora, l’assetto ottico muta al variare del punto dello spazio ambientale rispetto al quale è individuato così come muta la determinatezza qualitativa dei pennelli luminosi quando la luce si fa più tenue o più intensa. E tuttavia al momento della variazione si affianca la regola delle invarianze: possiamo mutare quanto vogliamo l’intensità della luce e quindi la qualità assoluta dei pennelli luminosi, ma questa variazione mostra la permanenza dei rapporti che legano le une alle altre le aree omogenee dell’assetto ottico, e ciò è quanto dire che nell’informazione che è contenuta nell’assetto ottico e nel suo variare secondo una regola è già racchiuso ciò che basta per cogliere la permanenza delle determinazioni qualitative della superficie dell’oggetto riflettente. Una variazione totale dei valori qualitativi dei pennelli di luce che lasci inalterato l’assetto delle loro relazioni reciproche “parla” in nome della variazione della luce, non di un mutamento reale delle superfici riflesse. E ciò è vero anche nel caso della forma e della posizione degli oggetti. L’assetto ottico varia con il variare del punto rispetto al quale si dà, ma la variazione non è priva di una legge: nel continuo gioco delle variazioni dell’assetto ottico che deriva da un movimento determinato del punto che lo individua vi è spazio per individuare un insieme di invarianti — le invarianti che determinano la forma obiettiva dell’oggetto e la sua posizione obiettiva nello spazio. Nella variazione secondo una legge dell’assetto ottico è quindi contenuta l’informazione necessaria per cogliere la posizione e la forma delle superfici degli oggetti, proprio come è racchiusa la possibilità di cogliere la loro colorazione obiettiva, al di là della variazione delle condizioni di illuminazione. Gibson si esprime così:
when the
station point moves, the whole structure of the optic array undergoes
transformation. A new set of variables arises to confirm the information in
static perspective. The parameters of transformation are specific to the
permanent properties of the environment. The optic array has a unique structure
for every station point in the world. And the change in structure of the array
is unique for every change of station point in the world. This is essentially
what is meant by saying that ambient light carries information about the world
(ivi, p. 222).
Sin qui abbiamo parlato soltanto della luce ambientale e delle informazioni che se ne possono trarre, non ancora della percezione, e questo deve essere sottolineato, poiché l’assetto ottico in un punto dato vi è indipendentemente dal fatto che vi sia lo sguardo di chi lo coglie. L’assetto ottico è una proprietà strutturale della luce ambientale per un punto, non un fenomeno visivo. E del resto perché si possa disporsi sul terreno propriamente percettivo non è affatto sufficiente porre nel punto prescelto un occhio la cui retina registri nella forma di un’immagine la proiezione di un determinato assetto ottico. Su questo si deve insistere: per Gibson la percezione visiva non è riconducibile alla costituzione di un’immagine sul fondo della retina, ma è il risultato cui conduce il processo di afferramento e di elaborazione delle informazioni che sono contenute nella luce e che sono registrate nella forma di differenti input sul mosaico sensibile della retina. Che sulla retina si formi proprio un’immagine è un fatto inessenziale, che potrebbe semplicemente non esserci, — e gli occhi degli insetti, che sono composti da una molteplicità di recettori sensibili separati gli uni dagli altri, ne sono una prova: qui la retina agisce senz’altro come recettore di input, ma non per questo dà adito ad un’immagine unitaria che possa essere vista sul fondo dell’occhio. La percezione non termina nella ricezione di un’immagine, ma muove di qui per trarre le informazioni che sono contenute nella luce ambientale e che si dispiegano nel processo percettivo. Per dirla con Gibson:
The common
belief that vision necessarily depends on a retinal image is incorrect, since
the eyes of a bee, for example, does not have a retinal image. What eyes do is
to pick up all the useful information in light of which they are capable;
retinal images are merely incidental in the process (ivi, p. 223).
Del resto a queste conclusioni siamo ricondotti anche dalla constatazione della mutevolezza di quelle immagini cui la tradizione filosofica ha spesso ricondotto la percezione nel suo complesso. Le immagini retiniche variano di continuo a causa dei movimenti degli occhi, delle continue oscillazioni del capo e dei movimenti del corpo, ma di questo mutamento che si inscena in ciascuna delle nostre retine non vi è traccia nell’universo che percepiamo: ciò che vediamo è un mondo fermo e stabile, fatto di oggetti che hanno una loro forma visibile definita e costante, e se vediamo tutto questo è proprio in virtù di quella variazione continua che si registra a livello delle immagini retiniche e che consente al nostro sistema percettivo di cogliere nelle variazione le invarianti, nel flusso la struttura obiettiva.
Di qui, da questa generale impostazione del problema, si deve muovere per venire a capo della nostra percezione delle immagini. Una prima constatazione può essere fatta fin da principio valere: la percezione delle immagini non è una forma peculiare del percepire, ma è una percezione normale di un oggetto particolare. Ma ciò è quanto dire che per venire a capo della percezione delle immagini non dovremo interrogarci su un qualche atteggiamento soggettivo, ma sulla peculiare configurazione della superficie dell’oggetto che funge da immagine — una configurazione tale da determinare in chi la guarda la percezione di qualcosa d’altro. Ora, il modo in cui una superficie si dà percettivamente dipende dalla sua capacità di strutturare in un modo determinato l’assetto ottico che si rende disponibile a chi osserva; ne segue che se una tela o un foglio di carta sanno mostrare un volto o un paesaggio debbono essere modificati in modo tale da restituire allo spettatore quella disposizione di luce che contiene le informazioni sufficienti per percepire i tratti di un viso o quel succedersi di campagne e colline che fa da sfondo a tanti quadri:
Concretely,
a picture is always a physical surface, whether of canvas, paper, glass or some
other substance, which either reflects light or transmits it. It is an object,
in short, commonly a flat rectangular one, but what is unique about it is the
light coming from it. The surface has been treated or processed or acted upon
in such a way that the light causes a perception of something other than the
surface itself. It delivers a sheaf of light rays to a station point in front
of the surface, rays that contain information about quite another part of the
world, perhaps a distant world, a past world, a future world, or a wished-for
world […]; but at any rate a world which is not literally present at the
station point. If an eye is actually stationed in front of the picture, and if
the possessor can register the information contained in the sheaf of rays, then
the picture has served its fundamental purpose. There has occurred a perception
at second hand — a vicarious acquaintance with an absent scene (ivi, p. 225).
Basta formulare questo compito perché si faccia avanti più di un dubbio sulla sua realizzabilità. Possiamo mettere la massima cura nel disporre sulla tela i pigmenti, ma non potremo mai ricreare effettivamente un assetto ottico del tutto identico a quello cui ci troveremmo di fronte se osservassimo direttamente l’oggetto raffigurato: anche il quadro più luminoso non può gareggiare per intensità e vivacità dei colori con una qualsiasi scena reale, e ciò che vale per l’intensità luminosa può dirsi anche per la determinatezza dei dettagli. Di queste considerazioni si può rendere conto osservando, in primo luogo, che il nostro occhio risponde più alla transizione e alla relazione reciproca delle grandezze che al loro valore assoluto, ma riconoscendo anche, in secondo luogo, che vi sono gradi di fedeltà di un’immagine e che è quindi lecito distinguere tra immagini che rendono disponibili solo le informazioni più importanti per cogliere l’oggetto raffigurato ed immagini che possono dirsi fedeli, perché pur non ricreando un assetto ottico identico all’originale sanno tuttavia ingannare l’occhio (sono funzionalmente identiche ad esso, — per esprimerci con Gibson). E tuttavia a questi limiti interni alla raffigurazione occorre affiancarne altri:
But at best
the perception aroused fails in three respect to be lifelike. First, the viewer
cannot look around the scene. Second, he cannot look around in the scene nor
can he observe anything moving in it. Third, he cannot obtain the binocular
parallax resulting from the use of both eyes (ivi, 228).
Una raffigurazione non sa creare l’effetto di parallasse: non determina infatti quello slittamento di prospettiva tra i due occhi che determina parte della percezione di profondità. Ma una rappresentazione presenta sempre anche una scena limitata: per quanto possa essere grande, una raffigurazione non si integra con lo spazio circostante ed è quindi impossibile lasciar correre lo sguardo su di essa, senza imbattersi prima o poi nei confini che la delimitano. Infine — ed è forse il limite principale — una raffigurazione ci presenta una scena congelata, e ciò è quanto dire che non è possibile raffigurare né il movimento di un oggetto nella scena dipinta, né osservare la sua variazione rispetto al movimento dello spettatore. Ne segue che nel caso della percezione di immagine non ci si può avvalere di una parte delle informazioni che la percezione ambientale attinge, poiché non vi è modo di attingere le invarianti che si attestano nella mutevolezza delle singole scene percettive. Se un’immagine non può essere fino in fondo realistica è dunque proprio perché ci invita a percepire una scena senza consentirci di coglierla alla luce dei normali decorsi percettivi. Non è un caso allora se il pittore deve apparirci come un percipiente
who pays
special attention to the points of view from which the world can be seen, and
one who catches and records for the rest of us the most revealing perspective
on things (ivi, 224):
proprio come sostenevano i pittori rinascimentali, anche Gibson sembra dunque convinto che una buona raffigurazione è, per così dire, vincolata alla rappresentazione di quegli aspetti della cosa che più la rendono riconoscibile. Si tratta di un precetto ben noto, che informa di sé la pittura quattrocentesca dapprima e, in generale, il classicismo, e che ritroviamo nella formula di un precetto teorico in autori come Lipps o Cornelius. Ma in Gibson quest’affermazione non assume il tono di un precetto estetico, ma ci riconduce senz’altro sul terreno percettologico. Se il pittore deve saper cogliere gli aspetti salienti delle cose e se è tuttavia necessario insistere così tanto sui limiti di accuratezza dell’immagine è perché è necessario da un lato riconoscere che ciò che ogni raffigurazione ci propone è soltanto una selezione parziale delle informazioni obiettive che la luce veicola, ma anche perché si deve rammentare dall’altro che vi sono limiti alla libertà del raffigurare.
Soffermiamoci innanzitutto sul primo punto. Ciò su cui Gibson ci invita a riflettere è che ogni raffigurazione implica una selezione delle informazioni racchiuse nella luce, radicalizzando un processo di decisione e di scelta che è comunque già presente sul terreno della percezione oggettuale. Quando guardiamo gli oggetti che ci circondano, mettiamo a frutto solo parte dell’informazione che la luce ci porge: molti indizi restano negletti, poiché ciò che innanzitutto conta è quel riconoscimento che garantisce la nostra presa sul mondo. Nel caso delle raffigurazioni, tuttavia, la selezione dell’informazione è guidata da un criterio di scelta che si intreccia con le scelte stilistiche dell’autore e con le abitudini rappresentative di un’epoca, ed è per questo che ogni stile figurativo ci propone insieme un certo di modo di guardare il mondo. Raffigurare in un certo modo vuol dire allora insegnare a vedere in un certo modo; o più esattamente: insegnare a rivolgere l’attenzione a certi aspetti delle cose, mettendo a frutto proprio queste e non altre informazioni racchiuse nella luce ambientale.
La selezione dell’informazione diviene così il fondamento della storicità del raffigurare, del suo porsi come un processo di educazione dell’attenzione visiva:
if there is
actually information in light, and if it is unlimited in amount, them each
perceiver must select that part of the potential information he needs. When
perceiving is mediated by a picture, some part of the selecting has already
been done. Even a photograph is selective in its own way; but a painting is
more selective, and in a different way. Each painter has his own habits and
skills of selecting information from light. Each age of painting and each
culture has its way of selecting what is important to see. If the artist emphasizes
the information about the world that people need, he has done them a service.
If they can register such information, he has made their vision more acute.
Their eyes will become more sensitive, not at the level of anatomy or
physiology, to be sure, but at the level of psychology. At this level, the subtleties
and complexities of light are enormous. And hence the different ways of seeing
the world are equally variable, though all may be valid (ivi, p. 230).
E tuttavia questa libertà ha limiti, ed è proprio questa constatazione che ci riconduce al secondo punto che avevamo dianzi sottolineato. Raffigurare vuol dire pur sempre modificare una superficie in modo tale da renderla capace di restituire un assetto ottico che sia funzionalmente simile a quello che l’oggetto raffigurato saprebbe mettere a nostra disposizione, e ciò esclude evidentemente la possibilità di una raffigurazione che non si subordini ad un insieme di condizioni di carattere strutturale. Così, il pittore può certo selezionare l’informazione che la luce normalmente offre, ma non può alterarla e, soprattutto, non può fare a meno di trascriverla sulla superficie della tela avvalendosi delle regole di proiezione che la prospettiva ci ha insegnato e che sono racchiuse nella natura stessa della propagazione della luce. Se qualcosa deve potersi vedere in un disegno, allora la sua superficie dovrà restituire la luce così come si dà in un punto determinato, e ciò è quanto dire che ogni raffigurazione deve essere intesa come una proiezione dell’oggetto per un punto, — come un’immagine approssimativamente prospettica. Ogni raffigurazione è raffigurazione di un aspetto, e quindi della cosa così come si potrebbe con qualche approssimazione vederla dato un certo punto di osservazione:
from what I
know of the perceptual process, it does not seem reasonable to assert that the
use of the perspective in paintings is merely a convention, to be used or
discarded by the painter as he chooses. Nor is it possible that new laws of
geometrical perspective will be discovered to overthrow the old ones. It is
true that the varieties of painting at different times in history, and among
different people, prove the existence of different ways of seeing, in some
sense of the term. But there are no differences among people in the basic way
of seeing — that is, by means of light, and by way of the rectilinear
propagation of light. When the artist transcribes what he sees upon a
two-dimensional surface, he uses perspective geometry, of necessity. Human visual
perception is learned, but not in the same way we learn a language. It can be
acquired by education, but not by the kind of education that consists in
memorizing a new set of symbols. What the artist can do is not to create a new
kind of vision, but to educate our attention (ivi, p. 231).
La libertà del raffigurare trova così nelle condizioni di visibilità del raffigurato la sua necessaria limitazione.
2. Considerazioni critiche
Sin qui abbiamo cercato di rendere conto delle argomentazioni di Gibson. Il senso delle sue tesi è relativamente chiaro: venire a capo del concetto di raffigurazione significa infatti, a suo avviso, interrogarsi sulle condizioni cui una superficie deve sottostare per poter restituire un assetto ottico tale da poter consentire ad uno spettatore di vedere ciò che l’immagine stessa raffigura. L’abbiamo già detto: la percezione di un’immagine non è, per Gibson, una percezione particolare, poiché particolare è soltanto il suo oggetto. Ne segue che venire a capo della natura delle immagini vuol dire soltanto sottolineare la possibilità che una superficie opportunamente modificata sappia restituire un cono di luce funzionalmente simile, se non identico, a quello che ci invierebbe un qualche oggetto reale. Se la superficie di un quadro ci mostra qualcosa è perché la luce che ci invia racchiude l’informazione di cui abbiamo bisogno perché la percezione possa raggiungere il proprio scopo.
Di fronte ad una simile argomentazione sembra tuttavia legittimo avanzare qualche dubbio. Il primo potremmo forse formularlo così: un quadro è una superficie il cui aspetto è stato modificato in vario modo con dei pigmenti, per rendere visibile qualcosa che non c’è, ed è per questo che noi, osservandolo, vediamo ciò che in esso si raffigura. Ma la possibilità di questo consapevole inganno si scontra con ciò che altrimenti Gibson ci dice, poiché la tesi che attraversa tutte le sue riflessioni è che nell’assetto ottico e nelle sue coerenti variazioni è racchiusa l’informazione necessaria per cogliere la natura complessiva dell’ambiente che ci circonda. Ma ciò è quanto dire che è di fatto racchiusa anche l’informazione che dovrebbe consentici di vedere che ciò che abbiamo di fronte quando osserviamo un quadro non è un volto e un paesaggio lontano, ma semplicemente una tela su cui sono stati disposti ad arte diversi pigmenti: il più piccolo movimento di fronte alla tela ci mostrerebbe infatti che le figure dipinte non ci consentono quell’ordinata serie di variazioni dell’assetto ottico da cui normalmente dipende il risultato cui la percezione conduce. Di qui una difficoltà che non è facile risolvere pienamente: se la determinatezza delle nostre percezioni riposa per intero sulla nostra capacità di cogliere le informazioni che l’assetto ottico e le sue variazioni racchiudono, perché continuiamo a vedere in un quadro il disegnarsi di una figura e non percepiamo invece ciò che evidentemente c’è e che si attesta ad ogni nostro movimento — una superficie piana che si suddivide in aree cromaticamente differenti? Anche se Gibson non nega che ogni percezione di immagine è anche percezione del suo sostrato ed anche se non sostiene che la percezione di immagine sia la percezione di un’illusione, ciò non toglie che l’orizzonte entro cui la sua spiegazione si muove non sappia rendere conto delle ragioni per le quali possiamo dire di vedere una tela e dei pigmenti, e di vedervi un volto e un paesaggio lontano. Percepire un’immagine in quanto tale significa sempre percepire una superficie piana su cui (o in cui) appare qualcosa, e non è affatto chiaro come possa accadere, per Gibson, che una scena percettiva non tolga l’altra, come accade invece quando per esempio crediamo di vedere un manichino in una vetrina e poi ci accorgiamo che si tratta di una persona vera.
Le difficoltà della teoria di Gibson non si riducono tuttavia a questa considerazione di carattere generale, ma si manifestano anche non appena ci interroghiamo sui vincoli che egli pone ad ogni raffigurazione che voglia ottenere il suo scopo. Certo, non sempre i disegni sono raffigurazioni fedeli della realtà, e talvolta disegnare vuol dire deformare volontariamente i tratti di ciò che si vuole raffigurare: una caricatura è il risultato evidente di una precisa scelta espressiva, volta ad alterare la corrispondenza tra l’immagine e ciò cui essa si riferisce e degli stili pittorici si parla talvolta proprio così — come deformazioni coerenti della realtà. E tuttavia, anche se Gibson riconosce apertamente che chi disegna ha sempre un margine di libertà e di scelta, sembra dover poi necessariamente sostenere che ogni immagine è di per se stessa raffigurazione di un aspetto della cosa, di una sua possibile percezione. La tela è uno specchio che riflette una realtà immaginaria, ed anche se si concede che la superficie riflettente possa essere più o meno levigata, e quindi più o meno deformante, è un fatto che un’immagine deve in qualche modo comportarsi proprio come si comporta uno specchio: restituendo la stessa configurazione di raggi luminosi che riceve dall’oggetto che vi si riflette.
Credo che le ragioni per cui Gibson ci invita a sostenere questa tesi non possano essere semplicemente accantonate — in fondo dobbiamo davvero chiederci come sia possibile che una superficie possa farci vedere ciò che non c’è — e tuttavia è difficile non rendersi conto che il paradigma della specularità è difficilmente proponibile. Ciò che infatti sembra difficile sostenere è che sia davvero sempre possibile asserire che un disegno sia o voglia anche soltanto essere la riproduzione di una possibile veduta dell’oggetto, di un suo aspetto.
Il disegno infantile non sembra, per esempio, essere riconducibile ad un simile paradigma ed almeno dai tempi di Luquet si è sostenuto che un bambino non disegna affatto ciò che vede, ma ciò che sa dell’oggetto. Così, molti disegni infantili non sembrano essere affatto riconducibili ad un qualsiasi criterio di carattere proiettivo, e basta pensare a come un bambino disegna una casa per rendersene conto. Del resto, prendiamo come esempio il disegno di un cubo — quel disegno apparentemente prospettico che tutti noi faremmo se ci si chiedesse di disegnare un dado alla lavagna. Prendiamo il gesso e disegniamo così — un cubo in prospettiva “cavaliera”. Si tratta appunto di una proiezione cui potremmo tentare di attribuire anche un significato percettivo immediato: la proiezione cavaliera è quella proiezione in cui i raggi procedono parallelamente, e ciò è quanto approssimativamente accade quando siamo molto lontani dall’oggetto osservato. Potremmo allora dire che il cubo disegnato così è un cubo visto da un punto di osservazione molto lontano — ma è sufficiente dare forma esplicita a questa ipotesi per rendersi conto della sua falsità. Nel tracciare così quel cubo non intendevamo affatto dire che lo vediamo da lontano, ma volevamo invece mostrare ciò che più chiaramente lo caratterizza — il suo avere facce quadrate, proprio come quella che mostriamo con chiarezza tracciandola in bella mostra sul foglio. Così, prima tracciamo un quadrato sulla pagina e poi tracciamo i lati paralleli a due per far vedere appunto che anche le altre facce debbono essere eguali a questa che abbiamo così chiaramente mostrato. E se poi ciò che risulta non è ancora una volta composta da facce visibilmente quadrate è solo perché sul foglio questo risultato non lo si può proprio ottenere. Meglio di così, verrebbe proprio voglia di dire, non si può proprio fare.
Del resto, anche se tralasciamo il disegno infantile e limitiamo i nostri esempi al campo più propriamente artistico, ci rendiamo conto che la domanda «da quale punto di vista è osservata questa scena?» non è sempre legittima. Qual è il punto di vista da cui dobbiamo pensare una classica raffigurazione dell’arte egizia? Un disegno ci mostra uno stagno circondato da papiri e nell’acqua vediamo dei pesci — ma tutto questo lo vediamo costruirsi sotto i nostri occhi che seguono i tratti di un disegno che ha sempre di mira l’obiettivo di mostrarci le cose così come sono, e non come ci apparirebbero da una qualunque prospettiva. E qual è il punto di vista che dovremmo assumere di fronte alla scena della creazione che ci viene presentata da un mosaico del Duomo di Monreale? Dobbiamo davvero pensare di essere di fronte alla scena? Per poter cogliere così ciò che in quel mosaico si raffigura, dovrebbe essere possibile percepire ai margini dell’immagine il venir meno della centralità, dovremmo poter cogliere la possibilità di un altrimenti che è invece del tutto assente. Vorrei allora dire così: proprio perché non vi è la possibilità dello scorcio così non vi è nemmeno la possibilità della frontalità, e ciò è quanto dire che in questo contesto figurativo la domanda che abbiamo dianzi formulato è fuori luogo, proprio come sarebbe fuori luogo cercare un risultato per l’operazione 5-7 nel campo dei numeri naturali. Nel campo dei numeri naturali quell’operazione allude ad un compito che non può essere svolto e che non deve per questo essere formulato. E alla stessa stregua dovremmo dire che un’immagine che in linea di principio non conosce lo scorcio non è riconducibile ad una veduta frontale. La frontalità è un valore di scorcio (è il valore in cui lo scorcio è eguale a zero) e c’è solo quando ci muoviamo sul terreno di raffigurazioni che non siano chiuse a questo ordine di variazione. Ma ciò è quanto dire che vi sono immagini che non possono essere semplicemente intese come se fossero una proiezione: un disegno infantile, una pittura egizia, un mosaico bizantino non possono essere intesi come se fossero specchi che rendono visibile, sia pure in modo approssimativo, un aspetto. Del resto, nella pittura bizantina (e non solo in essa) ci si imbatte talvolta in ciò che molti critici hanno chiamato “prospettiva rovesciata”: può capitare infatti che le linee oblique cui è affidato il compito di mostrare l’incedere dello spazio in profondità divergano invece di convergere, creando così una sorta di inversione della regola della diminuzione prospettica. Ora, quando osserviamo le icone che manifestano questa strana regola costruttiva, avvertiamo che qualcosa “non va”, ma non per questo l’immagine si fa per noi incomprensibile o priva di una sua apparente tridimensionalità: la comprensione delle icone non sembra in altri termini, lasciarsi turbare troppo da questa così evidente infrazione al paradigma della specularità.
Talvolta comprendiamo le immagini anche quando non si comportano come specchi; in altri casi, tuttavia, ci sembra di saper guardare un quadro solo quando abbiamo imparato qualcosa sullo stile che gli è proprio. Forse, quando guardiamo per la prima volta una pittura kwakiutl rimaniamo perplessi e non sappiamo dove volgere gli occhi; ma poi, con il tempo, impariamo il criterio di simmetria che le pervade, e l’immagine si fa leggibile. Ma appunto: se parliamo di leggibilità e se sottolineiamo il carattere culturale e storico di ogni stile figurativo è perché qualcosa non ci persuade nel paradigma della specularità. Certo, Gibson sottolinea la possibilità dell’apprendimento percettivo e anche la sua teoria concede uno spazio alla storicità degli stili figurativi, e tuttavia le osservazioni di Gibson sembrano comunque inadatte per venire a capo di questo problema in tutta la sua ampiezza. È difficile infatti convincersi che la totalità degli stili figurativi possa essere davvero compresa e ordinata semplicemente facendo riferimento ad un processo di selezione delle informazioni, alla possibilità di costruire ed interpretare le immagini semplicemente aprendo o chiudendo gli occhi su ciò che la luce in se stessa racchiude. Per dirla in breve: la storia degli stili figurativi non è il luogo in cui si è di volta in volta deciso che cosa dire e che cosa tacere del reale — quali pennelli di luce lasciar correre sino alla tela e quali invece oscurare, ma è anche il risultato di una prassi che ha modificato l’aspetto delle cose, reinterpretandole in ragione di una molteplicità di istanze espressive.
Molte altre cose potrebbero essere dette a questo proposito. E tuttavia, piuttosto che soffermarmi ancora sul terreno degli esempi, vorrei invitarvi a riflettere un poco. Abbiamo proposto una teoria della raffigurazione e, subito dopo, abbiamo mostrato che vi sono buone ragioni per ritenere che essa sia in qualche misura improponibile. E ora ci chiediamo: che cosa dimostrano le nostre critiche, sempre che qualcosa dimostrino davvero? Dov’è il punto esatto in cui mettono l’indice, per mostrare l’errore di Gibson? Rendersi conto di una difficoltà serve davvero a poco se non si comprende di preciso di che difficoltà si tratti.
Ora, si potrebbe forse sostenere che Gibson avanzi una richiesta troppo forte alle raffigurazioni e che non è affatto necessario ricondurre alla sola costruzione prospettica la scelta del metodo di proiezione che ci consente di ricondurre la tridimensionalità della scena alla bidimensionalità dell’immagine. Per venire a capo di questa necessaria opera di traduzione ci si potrebbe avvalere anche di altri metodi proiettivi che hanno comunque una loro legittimazione sul terreno delle configurazioni obiettive dei raggi di luce — ed è questa la tesi che Margaret Hagen ha sviluppato in un libro, intitolato Varieties of Realism (1985), che merita di essere letto. Ma si potrebbe anche sostenere che le condizioni cui una raffigurazione deve soddisfare per garantire la percepibilità del raffigurato non sono prevalentemente di natura proiettiva, ma ci riconducono invece alla dimensione più articolata delle invarianti degli assetti ottici — ed è questa la via che qualche anno più tardi lo stesso Gibson ha seguito nel suo The Ecological Approach to Visual Perception (1979).
Ma forse questi tentativi di correggere la proposta di Gibson che abbiamo rammentato non colgono pienamente nel segno e non individuano sino in fondo la radice effettiva dell’errore — ed io credo che le cose stiano proprio così: anche se ci mettiamo nella prospettiva di The Ecological Approach to Visual Perception le tesi di Gibson sembrano troppo inclini a risolvere la percezione di immagine nella percezione di un oggetto tra gli altri, ed io penso che qui sia la radice dell’errore di Gibson.
Ma forse può sembrare necessario assumere un atteggiamento più radicale. Forse non è affatto vero che la percezione di un’immagine sia una percezione qualsiasi; forse il pensare di venire a capo della natura delle raffigurazioni semplicemente nei termini di un’analisi delle strutturazioni dell’assetto ottico è un errore in cui necessariamente si cade quando si dimentica che una raffigurazione è un prodotto culturale, un mezzo di cui gli uomini si avvalgono per comunicare ad altri uomini le loro idee e le loro emozioni. Le raffigurazioni sono mezzi per dire, e il dire implica un linguaggio e quindi un insieme di convenzioni che debbono essere apprese.
Alla naturalità del rapporto di rispecchiamento sembra sostituirsi così il richiamo alla convenzionalità del linguaggio. Il quadro di Gabriel Metsu deve indicarci un nuovo cammino: ora non dobbiamo più guardare allo specchio come al luogo da cui trarre una possibile spiegazione del concetto di immagine, poiché a guidarci, ora, deve essere il paradigma della lettera, un paradigma di cui io vi invito fin d’ora a diffidare, ma cui Goodman ha dato in un libro famoso, intitolato non a caso I linguaggi dell’arte (1968), una qualche credibilità. È nelle pagine di questo libro che dovremo cercare di addentrarci fin dalla prossima lezione[3].
Lezione terza
1. Lettere e raffigurazioni. La critica alla nozione di somiglianza.
Le nostre considerazioni critiche sulla teoria della raffigurazione di Gibson ci invitano a guardare in modo nuovo il quadro di Metsu da cui abbiamo preso le mosse. Ora non rivolgiamo più la nostra attenzione allo specchio, ma alla lettera e al quadro e al loro narrarci una stessa vicenda — la storia di una tempesta, di una nave e della minaccia di un naufragio. Non penso che il compito che questo quadro ci propone consista davvero nel rendere meno avvertibile la differenza tra una pagina scritta e una tela dipinta e credo anzi che Metsu, come forse ognuno di noi, sia innanzitutto portato a cogliere le diversità tra parole ed immagini; eppure quanto più prendiamo sul serio le critiche che abbiamo rivolto a Gibson e quanto più ci lasciamo tentare da una loro coerente radicalizzazione, tanto più plausibile ci appare la tesi secondo la quale tra una lettera e un quadro non vi è poi una distinzione così radicale. Proprio come il quadro che la fantesca scopre, così anche la lettera che la fanciulla apre e legge reca in sé un messaggio: ci parla di un evento lontano, e ce ne parla attraverso una molteplicità di segni, proprio come accade sul piano figurativo.
Certo, tra i segni pittorici e i segni linguistici vi sono differenze importanti, e tuttavia la trama dei pensieri in cui ci stiamo immergendo sembra invitarci a cogliere ciò che, al di là delle differenze, li unifica: la lettera e il quadro constano di simboli, e se sono vere le affermazioni di chi sottolinea la relatività degli stili figurativi, si deve riconoscere che la possibilità di risalire dalla rappresentazione (pittorica o verbale) all’oggetto che essa denota implica l’apprendimento di un “linguaggio” e, quindi, di un insieme di convenzioni più o meno complesse. In fondo, non abbiamo letto tante volte i resoconti di antropologi che testimoniano come gli uomini di una qualche sperduta tribù non abbiano reagito come noi reagiremmo di fronte ad un disegno a tratto o ad una fotografia? E lo stupore dell’indigeno di fronte al ritratto di un volto non è un segno evidente del fatto che le immagini parlano un linguaggio che deve essere appreso, proprio come si deve apprendere il sistema complesso della scrittura?
Ora, basta enunciare una simile tesi perché si facciano avanti le obiezioni del buon senso, cui vorrei dare parola nella loro forma più immediata: può darsi che la lettera narri di una nave e di una tempesta, ma i segni di cui consta l’espressione «il mare è in tempesta e la nave corre il rischio di naufragare» non assomigliano affatto a ciò che vedremmo se osservassimo di fronte la scena descritta, mentre sembra essere del tutto evidente che una qualche somiglianza vi è tra la scena dipinta e il quadro che la raffigura. Sulla tela, come è ovvio, il mare non c’è, proprio come non c’è nella lettera che la fanciulla legge; sul quadro e sulla lettera — si potrebbe allora argomentare — vi sono invece due diversi insiemi di segni che rimandano al mare come alla loro denotazione. E tuttavia all’arbitrarietà dei segni linguistici sembra far eco la naturalezza dei segni pittorici, il cui senso sembra dispiegarsi immediatamente e proprio in virtù del nesso di somiglianza che li lega alle cose che sono così denotate.
È in questo contesto che si pone il saggio di Nelson Goodman di cui vogliamo ora discorrere e che significativamente si intitola proprio così — I linguaggi dell’arte (1968). Di questo rimando al linguaggio e alle sue differenti forme ci accorgiamo fin dalle primissime battute di questo libro poiché Goodman ci invita a sostenere che un quadro è in primo luogo una rappresentazione e che è quindi in linea di principio legittimo chiedersi per quale oggetto stiano i colori e le forme che vediamo sulla tela.
Si tratta di un’affermazione importante e ricca di conseguenze impegnative. Su questo punto, tuttavia, non siamo affatto chiamati a discutere, ma semplicemente ad accettare una tesi che ci viene presentata come se non avesse alternative possibili:
la verità è che un quadro, per rappresentare un oggetto, deve essere un simbolo di esso, stare per esso, riferirsi ad esso […]. Un quadro che rappresenta — come un passo che descrive — un oggetto si riferisce ad esso e, più precisamente, lo denota. La denotazione è il nocciolo della rappresentazione (I linguaggi dell’arte, (1968), trad. it., a cura di F. Brioschi, Il saggiatore, Milano 1976, p. 13).
Ora, se si accetta questo assunto di carattere generale e se si dà per scontato che le immagini abbiano, in quanto rappresentazioni, una funzione essenzialmente denotativa, la mossa che Goodman ci invita a compiere perde gran parte della sua paradossalità. Quale sia questa mossa è presto detto: abbiamo di fronte a noi un’immagine — un dipinto A che raffigura B (Napoleone, per esempio) — e ci chiediamo se sia lecito sostenere che A rappresenta, e quindi denota, B perché assomiglia apprezzabilmente a B. Ora, basta dare forma di definizione a questa tesi del senso comune perché si faccia avanti una molteplicità di problemi e di difficoltà irrisolte. In primo luogo, osserva Goodman, la somiglianza è una relazione riflessiva: un oggetto A assomiglia a se stesso più che ad ogni altra cosa, ma nella norma una cosa non è raffigurazione di se stessa.
Ma la somiglianza non è soltanto riflessiva; è anche una relazione simmetrica: se A è simile a B, B è a sua volta simile ad A. Ancora una volta, tuttavia, questo non vale per la relazione rappresentativa: il fatto che un quadro rappresenti il duca di Wellington non è una buona ragione per dire che il duca di Wellington rappresenta a sua volta quel quadro. Del resto, due cose possono essere del tutto simili senza per questo essere legate da un nesso rappresentativo: le gocce d’acqua del proverbio si assomigliano quanto più non si potrebbe, ma non sono l’una il ritratto dell’altra. La somiglianza non basta perché si possa parlare di un nesso rappresentativo, e ciò è quanto dire che l’essere simili non è di per sé un criterio sufficiente per parlare di rappresentazione:
in molti casi, nessuno fra due oggetti molto simili rappresenta l’altro: […] un uomo, normalmente, non è una rappresentazione di un altro uomo, neppure di suo fratello gemello. Con ogni evidenza, la somiglianza, quale che ne sia il grado, non è una condizione sufficiente per la rappresentazione (ivi, p. 12).
Ma non è nemmeno una condizione necessaria. Se la nozione di rappresentazione viene ricondotta alla presenza di un nesso denotativo, allora è evidente che di un rimando necessario alla somiglianza non è lecito parlare. Che cosa qui Goodman abbia in mente è presto detto: se ti mostro una fotografia sfocata e mossa che mostra un volto irriconoscibile e poi ti dico che quella fotografia rappresenta Bertrand Russell tu non hai ragione per sostenere che ho mentito, anche se puoi senz’altro lamentarti del fatto che da una simile immagine si può capire ben poco dell’aspetto di quell’uomo famoso. Non ho mentito: che quella sia una fotografia di Russell non dipende dal tuo saper riconoscere quel volto con maggiore o minore facilità, ma dal fatto che proprio Bertrand Russell fosse davanti all’obiettivo quando qualcuno ha scattato quella fotografia. Alla stessa stregua, quando un bambino agitando un foglio su cui si vede una triste figura, dice contento che ha disegnato proprio me non posso appellarmi alla mancata somiglianza (o al fatto che non riesco a scorgere una somiglianza) per negare l’assenso: che cosa quel disegno denota non lo decide un nesso di somiglianza, ma la sua scelta di usare così quell’immagine — come un mio ritratto.
Nelle Ricerche filosofiche, Wittgenstein aveva osservato che un’immagine non contiene in sé il modo della sua applicazione e che, proprio per questo, è sempre possibile trovare un’interpretazione che la metta in accordo con i fatti, comunque stiano le cose. Goodman ci invita a trarre una conclusione analoga e a negare un qualsiasi ruolo alla somiglianza nella determinazione della relazione denotativa che è propria delle immagini:
rappresentare non è imitare, nessun grado di somiglianza è richiesto tra un quadro, anche il più letterale, e ciò che rappresenta (ivi, p. 48).
Ora, le considerazioni che abbiamo raccolto sin qui permettono a Goodman di sostenere che la somiglianza non è né una condizione necessaria, né una condizione sufficiente del nesso di denotazione e quindi anche di quella relazione raffigurativa che è chiamata in causa dalle immagini. Ma di questo risultato Goodman non si accontenta, ed è per questo che ci invita a riflettere sulla sostanziale vaghezza che, a suo dire, è implicita nella tesi secondo la quale un’immagine A assomiglia ad un oggetto B.
Questa tesi è vaga perché ogni cosa si perde in una molteplicità di aspetti e di forme, che non possono essere raffigurate tutte insieme:
l’oggetto che ho di fronte è un uomo, un fascio di atomi, un complesso di cellule, uno strimpellatore di violino, un amico, un idiota e molte altre cose ancora. Se nessuna di queste costituisce l’oggetto così com’è, quale altra cosa lo potrebbe? Se tutti sono modi di essere dell’oggetto, allora nessuno è il suo modo di essere. Non posso copiarli tutti insieme; e quanto più mi avvicinassi a questo obiettivo, tanto meno ne risulterebbe un quadro realistico (ivi, pp. 13-14).
Certo, non posso raffigurare Giovanni come un amico e, insieme, come un fascio di atomi, ma questa difficoltà non sembra più di tanto turbarci, ed io credo che ciascuno di noi direbbe che una raffigurazione può proporci una copia delle qualità propriamente visibili di un oggetto: in un dipinto possiamo rendere l’aspetto di un viso e ciò che della sua espressività traspare perché queste sono le sue qualità sensibili — chiederci di ritrarre una persona il cui numero telefonico sia un numero primo non avrebbe senso, poiché non è ragionevolmente questo che si può cercare di vedere in un volto. Ma anche per questa (ragionevole) obiezione, Goodman ha una risposta: parlare delle proprietà visibili di qualcosa significa presupporre un criterio per discernere una volta per tutte che cosa sia l’oggetto così come lo vediamo, al di qua di ogni determinazione intellettuale, di ogni decisione culturale. Ma ciò è quanto dire che la possibilità di parlare dell’oggetto così come appare visibilmente fa tutt’uno con la tesi filosofica dello «sguardo innocente», con la convinzione che vi sia un aspetto puramente sensibile della realtà che non può sfuggire alla nostra attenzione non appena ci liberiamo dei nostri pregiudizi e di quelle attese percettive che sono lentamente maturate nel nostro rapporto con il mondo. Ma di questo sguardo primigenio sul mondo non è lecito parlare:
quando si pone al lavoro, l’occhio è sempre antico, ossessionato dal proprio passato e dalle suggestioni vecchie e nuove che gli vengono dall’orecchio, dal naso, dalla lingua, dalle dita, dal cuore e dal cervello. Esso funziona non come uno strumento isolato e dotato di potere autonomo, ma come membro obbediente di un organismo complesso autonomo e capriccioso. Non solo come vede, ma ciò che vede è regolato da bisogni e presunzioni. Esso seleziona, respinge, classifica, analizza, costruisce. Non tanto rispecchia, quanto raccoglie ed elabora; e ciò che raccoglie ed elabora , esso non lo vede spoglio, come una serie di elementi senza attribuiti, ma come cose, cibo, gente, nemici, stelle, armi. Non si vede nulla schiettamente o nella sua schiettezza (ivi, pp. 14-15).
Anche lo sguardo costruisce la realtà. E la costruisce sulla base di un sapere socialmente condiviso, di una presa di posizione complessiva sulle cose e sul mondo. Ma ciò che è vero per la percezione è ancora più vero sul terreno rappresentativo. Rappresentare non significa copiare, ma proporre una interpretazione nuova della realtà. La raffigurazione, dunque, non copia un aspetto già presente, ma lo crea: raffigurare non significa allora aderire ad una realtà per riprodurla, ma escogitare una forma nuova che ci consenta di comprenderla in una diversa luce. Ad una concezione dei processi rappresentativi — artistici o linguistici che siano — fondata su una filosofia di stampo realistico si contrappone così la tesi secondo la quale la realtà è qualcosa che si costruisce nella prassi rappresentativa dell’uomo. Non è un caso allora se al motto che apre il primo capitolo di questo libro — «l’arte non è una copia del mondo reale. Di queste dannate cose basta che ci sia un solo esemplare» (Virginia Woolf) — faccia eco la tesi secondo la quale
Che la natura imiti l’arte è una massima troppo prudente. La natura è un prodotto dell’arte e del discorso (ivi, p. 36).
2. La raffigurazione e i sistemi simbolici
Abbiamo cercato di mostrare nell’ora precedente le ragioni che spingono Goodman ad abbandonare il tentativo di fondare il concetto di raffigurazione sulla relazione di somiglianza. A questa pars destruens segue tuttavia una pars construens, la cui idea cardine può essere così indicata: del concetto di raffigurazione si deve poter rendere conto a partire da una riflessione generale sulla natura dei sistemi simbolici. Non si tratta di una mossa che possa stupirci: come abbiamo già osservato, le riflessioni di Goodman muovono dall’assunto secondo il quale la relazione di raffigurazione ci riconduce ad un nesso di denotazione e quindi, in linea di principio, ad una relazione di natura linguistica. Parlare di immagini vorrà dire allora parlare di simboli il cui interesse riposa in primo luogo sulla loro capacità di rimandare ad altro — agli oggetti intesi.
Sottolineare il nesso che lega le raffigurazioni ad una più generale riflessione sui sistemi simbolici vuol dire, per Goodman, pensare alla relazione di raffigurazione secondo un modello di carattere generale ed astratto che si può cercare di ricondurre a questi cinque punti:
1. La relazione di raffigurazione è, in primo luogo, una relazione denotativa. La raffigurazione è dunque un predicato a due posti, e ciò è quanto dire che, in una prima accezione del termine, parliamo di una raffigurazione solo quando vi è un’immagine A che rappresenta un oggetto B: il ritratto della Dama con l’ermellino di Leonardo sta per Cecilia Gallerani, la Veduta di Delft di Vermeer per la città di Delft, e così via. Questa relazione è, per così dire, la relazione primaria chiamata in causa dai fenomeni rappresentativi e ne caratterizza in profondità la natura. In altri termini, una rappresentazione è una rappresentazione se e solo se è lecito chiedersi che cosa essa denoti, anche se poi si deve talvolta riconoscere che alla legittimità della domanda fa eco una risposta negativa:
La regola che correla i simboli con i denotata può anche non assegnare alcun denotatum effettivo ad alcun simbolo, di modo che il campo di riferimento sia nullo; ma gli elementi diventano rappresentazioni solo in congiunzione con una qualche correlazione di questo tipo, effettiva o teorica (ivi, p. 197).
Sulla possibilità che un’immagine non abbia un referente (che denoti l’insieme vuoto) dovremo tra poco tornare; ora dobbiamo invece sottolineare il punto che Goodman ci invita a far nostro: possiamo, a suo avviso, parlare di una raffigurazione se e solo se è in linea di principio possibile domandare qual è l’oggetto di cui essa ci parla. Così, proprio come il riconoscimento che vi sono descrizioni definite che hanno la forma sintattica del nome ma sono prive di un denotato non toglie che i nomi veri e propri siano caratterizzati dal loro rimandare ad un referente, così Goodman ci invita a cercare la radice prima delle raffigurazioni in quelle immagini che rimandano ad un oggetto ad esse esterno.
2. Come abbiamo appena osservato, tuttavia, non ogni immagine ha un oggetto che le corrisponda, e ciò è quanto dire che non sempre un’immagine denota davvero un oggetto. Un quadro può avere un soggetto mitologico: può, per esempio, rappresentare Apollo e Marsia nell’epilogo drammatico della loro contesa. Ora, né Apollo, né Marsia esistono realmente e ciò è quanto dire che il quadro di Tiziano che li rappresenta non denota nulla: parlare di raffigurazione, in questo caso, non vorrà dire accostare l’immagine ad un nome per cogliere in entrambi un’analoga funzione denotativa, ma significherà piuttosto rammentarsi del fatto che un sintagma nominale («il più grande numero primo», per esempio) può essere privo di un referente, ma avere egualmente una funzione descrittiva — può indicare un predicato per cui non esiste un oggetto capace di soddisfarlo. Così, quando dico che un quadro raffigura un unicorno non voglio sostenere che vi sia davvero un unicorno o che sia lecito parlare di un’entità fittizia che esiste in un mondo mitico: voglio sostenere invece che la figura dipinta di cui parliamo è fatta così. Di conseguenza, parlare di un quadro che rappresenta un unicorno non significa null’altro se non descrivere quale sia la natura di quella rappresentazione, e come sia possibile classificarla: abbiamo di fronte a noi un dipinto che ci mostra una figura fatta così e così, anche se noi sappiamo che non vi è nulla che possa soddisfare quella descrizione che prende forma sotto i nostri occhi. Ne segue che, in questo caso, la relazione di raffigurazione è un predicato ad un posto che ci consente di etichettare e classificare le raffigurazioni, senza asserire nulla su di un loro eventuale oggetto.
Di fronte al concetto di raffigurazione il primo compito del filosofo consiste nel porre l’indice su di un’ambiguità di significato che deve essere senz’altro rimossa:
quando dico che una figura rappresenta una talcosa, resta perciò profondamente ambiguo se sto dicendo che cosa la figura denoti oppure che tipo di figura sia. Si può evitare in qualche misura tale confusione se nel secondo caso noi parleremo piuttosto di una «figura-che-rappresenta-Pickwick» o di una «figura-che-rappresenta-un-unicorno» o di una «figura-di-uomo»; o ancora, per brevità, di una «figura-di-Pickwick», o «figura-di-unicorno» o «figura-di-uomo». Ovviamente una figura non può, escludendo ogni gioco di parole, rappresentare Pickwick e non rappresentare nulla. Ma una figura può essere di un certo genere — una figura-di-Pickwick o una figura-di-uomo — senza rappresentare alcunché (ivi, p. 27).
Non ogni rappresentazione, dunque, denota qualcosa, poiché si può parlare di rappresentazioni anche soltanto nel caso in cui si ha a che fare con una figura-di-qualcosa: al rappresentare come relazione denotativa si affianca così il rappresentare come predicato ad un posto, come termine che descrive una classe di oggetti.
3. Una volta che si sia tracciata con chiarezza questa distinzione, Goodman si interroga sulla relazione che lega tra loro queste due differenti accezioni del concetto di rappresentazione. Normalmente una raffigurazione che denota un uomo lo raffigura anche come un uomo (è cioè anche una figura-di-uomo). In questo senso si può sostenere che il raffigurare in seconda accezione non si limita a descrivere la natura dell’immagine di cui si parla, ma ci permette anche di indicare come deve essere caratterizzato ciò che l’immagine denota. La Veduta di Delft di Vermeer non ci mostra soltanto Delft, ma — proprio in quanto è una figura-di-città-su-un-canale — ci dice anche che dobbiamo rappresentarci Delft come una città fatta così e così. L’etichetta che applichiamo all’immagine e che ci consente di classificarla in un certo modo vale dunque anche come un predicato che si applica a ciò che la raffigurazione denota: dire di un’immagine che è una «figura-di-P» vuol dire anche sostenere che raffigura X come P. La proprietà dell’immagine (l’etichetta che ci permette di contraddistinguerla da altre immagini) si riflette così sul modo in cui ci raffiguriamo un qualche oggetto:
Una figura che rappresenta un uomo lo denota; una figura che rappresenta un uomo immaginario è una figura-di-uomo; e una figura che rappresenta un uomo come un uomo è una figura-di-uomo che lo denota. Così mentre il primo caso riguarda solo ciò che la figura denota, e il secondo solo che genere di figura sia, il terzo invece riguarda sia la denotazione che la classificazione (ivi, pp. 31-32).
E tuttavia, anche se è importante far luce sulla possibilità del raffigurare-come, non vi è dubbio che, in linea di principio, il senso denotativo e il senso descrittivo che si legano ambiguamente nel concetto di raffigurazione siano reciprocamente indipendenti. Per dirla con Goodman:
la denotazione di una figura non determina il suo genere più di quanto il genere di figura determini la denotazione. Non ogni figura-di-uomo rappresenta un uomo; inversamente, non ogni figura che rappresenta un uomo sarà una figura-di-uomo (ivi, pp. 30-31).
Di primo acchito il senso di quest’affermazione sembra relativamente ovvio: ci dice che è, in linea di principio, possibile raffigurarsi Napoleone come lo sconfitto-di-Waterloo ma che, d’altro canto, non basta né che un’immagine sia una figura-di-sconfitto-a-Waterloo perché si possa dire che denota Napoleone, né che una figura denoti Napoleone per dire che lo raffigura come sconfitto-a-Waterloo — potrebbe infatti rappresentarlo come il-vincitore-di-Jena. Ma la conclusione cui Goodman mira è più impegnativa: di fatto, la tesi che di qui Goodman ci invita a trarre è che ciò che un’immagine denota non ha nulla a che spartire con le caratteristiche che l’immagine raffigura come ad esso pertinenti. Il referente di un’immagine non può essere ricondotto al come del suo raffigurare, ed a partire di qui la tesi secondo la quale ogni rappresentazione può raffigurare ogni oggetto ci appare in una luce più determinata: in questa affermazione così apertamente paradossale si esprime di fatto la richiesta di separare ciò di cui l’immagine ci parla dalla determinatezza sensibile dell’immagine stessa, dalla pretesa di ancorare la meta della rappresentazione al suo aspetto intuitivo. La critica alla fondazione del nesso raffigurativo sul concetto di somiglianza ci si mostra così sotto una nuova luce.
4. La riconduzione del rapporto di raffigurazione ad una relazione, in senso lato, linguistica e convenzionale trova una nuova conferma nella constatazione che tanto la dimensione denotativa quanto la dimensione descrittiva di un’immagine sono necessariamente relative ad un sistema simbolico. Un’immagine denota ciò che denota solo all’interno di un determinato sistema simbolico e di una prassi che renda esplicite le regole che determinano l’uso dei segni. Ma ciò è quanto dire che un’immagine guadagna la sua relazione raffigurativa rispetto all’oggetto per cui sta non in virtù di una qualche proprietà interna al suo contenuto intuitivo (non in virtù del suo apparirci simile all’oggetto raffigurato) ma sul fondamento di una regola d’uso dei segni pittorici, di una convenzione che, in un dato sistema stilistico, ci invita ad interpretare i simboli di cui constano le nostre immagini riconducendoli agli oggetti denotati. Ma appunto: l’interpretazione che proietta i simboli figurativi sull’universo degli oggetti appartiene ad un qualche “linguaggio” figurativo e varia, in linea di principio, con il variare del sistema di segni cui appartiene. Sistemi simbolici differenti hanno differenti principi di correlazione per proiettare i segni figurativi sugli oggetti che loro corrispondono, e proprio come uno stesso segno linguistico significa in latino «legname» e in italiano «materia» così uno stesso disegno può denotare una persona alta se posto in un contesto pittorico realistico ed una persona importante in un mosaico bizantino. E se le cose stanno così, se il valore denotativo di una raffigurazione è diretta funzione del sistema simbolico cui appartiene, allora abbiamo un nuovo motivo per sostenere che
quasi ogni quadro può rappresentare quasi ogni cosa; vale a dire, dati un quadro e un oggetto esiste di regola un sistema di rappresentazione e un piano di correlazione, secondo il quale il quadro rappresenta l’oggetto (ivi, p. 40).
Ma non è solo il valore di denotazione del segno che dipende, per Goodman, dal sistema simbolico cui il segno appartiene: anche le forme del rappresentare-come dipendono dal sistema simbolico entro cui sono formulate. Anche in questo caso il rimando al linguaggio fatto di parole ci permette di dare un senso più definito alle considerazioni che Goodman propone. Osserveremo allora che in inglese il futuro si esprime facendo ricorso ad una forma che reca in sé il ricordo del nesso che lega il futuro alla dimensione progettuale del volere: ciò che segue il presente si rappresenta come se fosse sotto l’egida di una decisione. Ma basta mutare sistema simbolico perché ciò non accada: in italiano, ad una simile costruzione non si potrebbe affatto attribuire un’analoga funzione connotativa. Ciò che vale per le forme linguistiche, vale anche per i segni figurativi. Nell’arte egizia il disegno di un volto di profilo non ha una funzione espressiva particolare: i volti si raffigurano appunto così, e l’essere di profilo di un uomo in una raffigurazione non ha né una funzione denotativa particolare (non rappresenta un profilo), né è espressione di un peculiare rappresentare-come (non è, in questo senso, una figura-di-profilo). Basta tuttavia mutare il sistema simbolico entro cui ci si muove perché le cose cambino: in un affresco di Giotto che raffigura il bacio di Giuda, il profilo è sicuramente una forma del raffigurare-come ed è evidente che il significato dell’immagine non può essere disgiunto dalla eccezionalità del rapporto che si viene a creare tra i volti di Gesù e di Giuda, che finalmente si guardano, a dispetto di una tradizione figurativa che costringeva l’immagine ad attribuire il pieno volto solo alle raffigurazioni di dio o dei re. Si può concludere allora che il valore descrittivo e denotativo di un segno dipende dalla sua appartenenza a questo e non ad un altro sistema simbolico, — a questo, e non ad un altro universo stilistico.
Ora, di fronte a queste considerazioni che vincolano la raffigurazione nel suo complesso all’orizzonte linguistico e convenzionale dello stile che le è proprio, sembrerebbe lecito avanzare un’obiezione di carattere generale: sembrerebbe infatti legittimo sostenere che la necessità di conoscere la regola di proiezione che ci consente di interpretare i simboli di un linguaggio figurativo si fa avanti soltanto quando la raffigurazione si fa convenzionale, allontanandosi da uno stile realistico: solo in questo caso lo sguardo sull’immagine deve tradursi in una lettura che ha bisogno di un addestramento preventivo. Così se immaginiamo un quadro dipinto realisticamente e secondo le regole della prospettiva rinascimentale vedremo subito dispiegarsi uno spazio ordinato, laddove avremo forse bisogno dell’aiuto di un esperto per comprendere le relazioni spaziali che correlano le une alle altre le figure di un dipinto eseguito secondo le regole della cosiddetta prospettiva rovesciata. La dipendenza della funzione rappresentativa del segno pittorico dallo stile figurativo sarebbe così indice del suo allontanarsi dalla piena figuratività, per orientarsi verso uno stile in cui le convenzioni hanno un ruolo maggiore.
Non vi è dubbio che non sia questa la posizione di Goodman: posto di fronte ai due quadri del nostro esempio
l’assolutista all’erta argomenterà che per il secondo quadro avremo bisogno di una chiave, ma non per il primo. La differenza sta piuttosto nel fatto che per il primo la chiave è a portata di mano. Per una lettura appropriata del secondo quadro dobbiamo scoprire le regole di interpretazione e applicarle deliberatamente. La lettura del primo è assicurata da abitudini virtualmente automatiche; la pratica ha reso i simboli così trasparenti che non siamo consapevoli di alcuno sforzo, di alcuna alternativa, o addirittura di alcuna interpretazione da parte nostra. Precisamente qui, a mio avviso, è dato di trovare la pietra di paragone del realismo: non nella quantità di informazione, ma nella facilità con cui è trasmessa. E ciò dipende da quanto stereotipato è il modo di rappresentazione, da quanto banali sono divenute le etichette e i loro usi (ivi, p. 39).
Non è difficile cogliere in queste osservazioni un’eco che ci riconduce al tema empiristico dell’abitudine. L’esperienza ci dà soltanto idee e successioni di idee, ma l’abitudine getta sul gioco etereo dei nostri vissuti una consistenza che ci fa credere che sia reale ciò che è soltanto consueto. Anche Goodman fa sua questa tesi, e nelle sue pagine le raffigurazioni realistiche debbono assumere le vesti dimesse di immagini scritte in un linguaggio che ci è tanto noto da non costringerci nemmeno all’onere della lettura. L’abitudine rende inavvertito il trascorrere della mente dalla parola alla cosa, e così come ci è difficile spogliare un segno linguistico ben noto dall’eco presente della sua significatività, allo stesso modo lo stile figurativo in cui siamo cresciuti ci sembra ripetere il dettato immediato delle cose così come sono. Ma appunto: il realismo di uno stile è soltanto indice della sua ovvietà e una raffigurazione ci sembra tanto più realistica quanto più ripete le forme di comprensione e di riproduzione della realtà cui siamo stati educati. Ne segue che non ha davvero senso parlare di una forma di raffigurazione che sia in se stessa realistica, poiché uno stile è tale solo in relazione ad una cultura che l’abbia a lungo praticato, sino al punto di non rammentare più la possibilità dell’altrimenti:
Il realismo è relativo, determinato dal sistema di rappresentazione corrente in una data cultura o persona, in un dato tempo. I sistemi nuovi, arcaici o stranieri sono considerati artificiali o maldestri. Per un egiziano della quinta dinastia, il modo più chiaro per rappresentare qualcosa non è il medesimo che vale per un giapponese del xviii secolo; e nessuno dei due è quello che vale per un inglese del Novecento. Ognuno di costoro dovrebbe in qualche misura imparare a leggere un quadro dipinto in uno degli altri due stili. Questa relatività è offuscata dalla nostra tendenza a non specificare un sistema di riferimento quando è il nostro. Così «realismo» finisce spesso per essere usato come il nome di uno stile o sistema di rappresentazione particolare (ivi, p. 39).
Ma ciò quanto dire che l’efficacia figurativa di un’opera realistica non ha davvero nulla a che fare con una qualche obiettiva convenienza dell’immagine all’oggetto raffigurato, poiché dipende invece esclusivamente dalla familiarità con la quale sappiamo interpretare i segni di cui consta. L’immagine realistica non è più vera di altre; è solo più facile da leggere poiché siamo da tempo abituati ai suoi caratteri, tanto da dimenticarci della loro convenzionalità:
Il realismo non ha nulla a che vedere con una relazione costante o assoluta tra un quadro e il suo oggetto, ma dipende dalla relazione tra il sistema di raggruppamento usato nel quadro e il sistema standard. Per lo più, naturalmente, il sistema tradizionale è inteso come standard; e il sistema letterale o realistico o naturalistico di rappresentazione è semplicemente quello consueto. La rappresentazione realistica, in breve, non dipende dall’imitazione, dall’illusione o dall’informazione, ma dall’addottrinamento (ivi, p. 40).
La conclusione che se ne deve trarre è allarmante: verrà un giorno, sembra necessario concludere, in cui una natura morta di Braque ci sembrerà più realistica di un dipinto del Caravaggio, e questo accadrà quando avremo smarrito la familiarità che ci lega allo stile figurativo di un’arte tramontata da secoli e avremo finalmente imparato a leggere con disinvoltura nella sintassi complessa del cubismo.
Che, a partire di qui, la teoria della raffigurazione come somiglianza debba apparirci ancor più lontana è evidente. Se il realismo di un’immagine è solo il nome che diamo all’acquisita facilità con la quale, quasi inavvertitamente, passiamo dai segni pittorici alla loro interpretazione, allora anche l’ultima ragione per invocare una relazione interna tra la dimensione intuitiva dell’immagine e le sue funzioni raffigurative può dirsi definitivamente accantonata.
Non vi è dubbio che, per Goodman, le cose stiano davvero così. E tuttavia quella stessa somiglianza che non può fungere da fondamento della raffiguratività di un’immagine può farsi poi nuovamente avanti come suo prodotto. Uno stile figurativo non è soltanto un certo modo di usare e di intendere un sistema di segni figurativi: è anche un modo per rappresentare il reale, organizzandolo secondo un insieme determinato di categorie concettuali. L’abbiamo già osservato: per Goodman, «la natura è un prodotto dell’arte e del discorso» (ivi, p. 36), e ciò è quanto dire che ogni immagine della natura che ci consenta di guardarla secondo il dettato di uno stile figurativo consueto è insieme un invito a riconoscere ciò che da tempo ci è familiare. Proprio perché abbiamo imparato a rappresentarci così le cose, proprio perché queste e non altre sono le proprietà del reale che abbiamo imparato a valorizzare come caratteristiche degli oggetti, proprio per questo ogni immagine che ce le ripresenti assume per noi una valenza illusionistica e ci sembra simile alla realtà che raffigura:
dire che un quadro appare come la natura spesso significa soltanto che esso appare nel modo in cui la natura è di solito dipinta. Ancora, ciò che mi farà illusoriamente supporre che mi stia di fronte un oggetto di un certo tipo dipende da ciò che ho notato intorno a siffatti oggetti, e su di questo a sua volta influisce il modo in cui sono solito vederli raffigurati. La somiglianza e la capacità di trarre in inganno, lungi dall’essere fonti e criteri costanti e indipendenti della pratica rappresentativa, ne sono in qualche misura i prodotti (ivi, 41).
La voce dello stile figurativo cui siamo avvezzi diviene così il calco in cui la nostra esperienza si adagia, assumendo le forme che noi stessi abbiamo per lei predisposto.
5. Sin qui le riflessioni di Goodman si sono lasciate guidare da un paradigma che ha esercitato un’influenza dominante su tutta la filosofia del secondo Novecento: il paradigma linguistico. In un certo senso, tutte le tesi che abbiamo raccolto in queste nostre considerazioni espositive potrebbero essere riformulate e comprese con maggiore facilità se ci dimenticassimo del fatto che Goodman ci parla di raffigurazioni (di affreschi, di quadri, di disegni, di fotografie, ecc.) ed immaginassimo di avere direttamente a che fare con i nomi e con le descrizioni del nostro linguaggio.
Ora, che l’analogia con il linguaggio verbale possa essere effettivamente resa più ricca e articolata è un fatto che ben difficilmente potrebbe essere messo in discussione. E tuttavia è lo stesso Goodman a richiamare la nostra attenzione su una differenza di cui non è possibile rendere conto nel linguaggio empiristico dell’abitudine:
si sarebbe tentati di usare a proposito di un sistema di raffigurazione, il termine «linguaggio»; ma qui mi arresto. Il problema di che cosa distingua i sistemi rappresentativi dai sistemi linguistici esige un attento esame. Si potrebbe supporre che valga anche qui la pena di far ricorso al criterio del realismo; che i simboli si dispongano su una scala, dalle raffigurazioni più realistiche a quelle sempre meno realistiche, alle descrizioni. Sicuramente non è così; la misura del realismo è l’assuefazione, ma le descrizioni non diventano raffigurazioni attraverso l’assuefazione. I nomi più ricorrenti della lingua italiana non sono diventati quadri (ivi, p. 43).
Si tratta di un’osservazione sottile. Di primo acchito sembrerebbe infatti che queste considerazioni ci invitino a cercare la differenza tra raffigurazioni e descrizioni verbali nel diverso modo in cui le une e le altre presentano i loro oggetti, ma quest’ipotesi viene subito scartata: il rimando al problema del realismo ci riconduce infatti fin da principio al di là di ogni discussione che concerna una qualche relazione interna tra la rappresentazione e il suo oggetto poiché il realismo, per Goodman, fa tutt’uno con la familiarità che un certo sistema di segni ha per chi lo usa. Ma anche la via humeana dell’abitudine deve essere messa da parte, proprio perché una parola non diviene una raffigurazione solo per il fatto che ci è da sempre familiare. Sappiamo da sempre che cosa significa la parola «casa» e ci è impossibile leggerla senza comprenderla; e tuttavia, questa parola così vecchia non raffigura ma intende linguisticamente il suo oggetto. Di qui la via che Goodman ci invita a seguire: se si deve distinguere una raffigurazione da una descrizione verbale si deve muovere esclusivamente dalla specificità dei simboli di cui l’una e l’altra si avvalgono. Una descrizione è fatta di parole, una raffigurazione di colori e forme: di qui, da un’analisi attenta della natura dei segni, si dovrà muovere per comprendere che cosa debba in ultima analisi trattenerci dal ricondurre le raffigurazioni sotto l’egida del linguaggio.
Ora, per venire a capo di questa difficoltà, Goodman ci costringe ad un lungo cammino che deve permetterci di affinare alcuni strumenti teorici, e il primo passo della complessa digressione cui ci invita ha il sapore da fiaba di una storia di falsari del secolo scorso. L’eroe negativo di questa vicenda si chiama Hans Antonius van Meegeren, un pittore modesto che nel 1937 balza agli onori della cronaca perché annuncia al pubblico dei critici di aver trovato un’opera giovanile di Vermeer. Il quadro è subito riconosciuto come autentico e van Meegeren vende alla Rembrandt Society una Cena ad Emmaus per 550.000 fiorini — un compenso decisamente alto per la sua fatica. L’opera viene accolta come un capolavoro e van Meegeren, visto il successo del suo primo falso, non si sottrae al compito di accrescere il patrimonio artistico del Seicento olandese dipingendo una Benedizione di Giacobbe, una Testa del Redentore, un Cristo e l’adultera, e un’Ultima cena — tutti, naturalmente, a maggior gloria del nome di Vermeer. Ma le truffe, qualche volta, si scoprono: van Meegeren vende a Hermann Goering un suo Vermeer — Cristo e l’adultera — e così nel ‘45 viene accusato per crimini di guerra: ha venduto a un gerarca nazista un capolavoro dell’arte olandese. Così, per salvarsi da un’accusa più grave è costretto a confessare le sue colpe, — e non gli sarà facile farsi credere. Da questa breve storia dobbiamo trarre una morale — filosofica naturalmente, e la morale che qui ci interessa è soltanto questa: che se anche van Meegeren avesse riprodotto esattamente dei quadri di Vermeer andati perduti, le sue opere sarebbero comunque state dei falsi. Un quadro è irripetibile, e il pittore che lo fa produce una copia o un falso; il musicista no: il pianista che in una sala da concerto ci propone una sonata di Chopin non fa un falso e nemmeno una copia, ma esegue quell’identica opera che anni prima il musicista aveva composto. Vi sono dunque arti autografiche ed arti allografiche:
Diremo che un’opera d’arte è autografica se e solo se la distinzione tra falso ed originale è significativa; meglio, se e solo se anche la più esatta duplicazione non conta per questo come genuina. Se un’opera d’arte è autografica, potremo chiamare autografica anche quell’arte. Così la pittura è autografica, la musica non autografica o allografica (ivi, p. 102).
Forse, posti di fronte a questa differenza così risaputa tra musica e pittura, vorremmo argomentare così: una sonata non è un oggetto che esista al di là del suo essere eseguita ora, e proprio questo è il motivo che non ci consente di parlare di un falso nei confronti di una nuova esecuzione, perché questo ripetersi dell’opera è la condizione del suo potersi effettivamente manifestare. Di falso o di copia parliamo invece nel caso di un quadro, poiché ogni opera pittorica è un individuo che esiste nel tempo e non vi è bisogno di produrne uno nuovo e simile per poterne cogliere il messaggio.
Una spiegazione plausibile ma falsa, almeno per Goodman: una poesia ha una sua stabile esistenza nel libro che la ospita, ma non per questo avrebbe senso sostenere che solo la versione scritta dalla mano dell’autore è autentica. Un libro di cui si vendano molte copie non è un libro che abbia subito molti plagi, e la copia autografa originale ha forse un fascino da amatore ma non ci autorizza a considerare false le molte repliche a stampa. Dobbiamo così rivolgere la nostra attenzione altrove, e Goodman ci invita a esaminare la relazione che lega il brano musicale allo spartito che gli corrisponde. Si tratta di una relazione particolare: lo spartito identifica l’opera e insieme determina, tacendone, le caratteristiche di un’esecuzione che possono variare e che sono inessenziali per definire l’individualità dell’opera. La natura allografica della musica riposa qui: nel suo ricondurci ad un sistema notazionale che definisce le proprietà essenziali di un brano musicale, determinando insieme le variazioni che non toccano la natura dell’opera e che caratterizzano occasionalmente ogni singola esecuzione. Ma se un brano musicale e un testo letterario hanno uno spartito, un quadro ne è invece privo:
il fatto che un’opera letteraria sia composta in una notazione definita, che consiste di certi segni o caratteri che debbono essere combinati in successione, fornisce in effetti il mezzo per distinguere le proprietà costitutive dell’opera da tutte le proprietà contingenti — cioè a dire, per fissare i tratti necessari e, per ciascuno di essi, i limiti di variazione ammissibile. Semplicemente accertando se la copia che abbiamo davanti è compitata correttamente possiamo accertare se essa rispetta tutti i requisiti dell’opera in questione. Nella pittura, al contrario, dove manca un alfabeto analogo di caratteri, nessuna delle proprietà pittoriche — nessuna delle proprietà che il quadro possiede in quanto tale — è distinta dalle altre come costitutiva; nessun tratto può essere trascurato come contingente, nessuna deviazione come insignificante. L’unico modo per accertare se la Lucrezia che abbiamo davanti è autentica consiste pertanto nello stabilire il fatto storico che si tratta dell’oggetto materialmente prodotto da Rembrandt (ivi, pp. 104-105).
Di qui il percorso che Goodman ci invita a seguire: dobbiamo chiederci infatti quale la sia la ragione per la quale non vi è qualcosa come uno spartito per le arti figurative.
Ora, ciò che caratterizza uno spartito è, come abbiamo osservato, la sua capacità di identificare un’opera, ed in questo uno spartito sembra essere qualcosa di simile ad una definizione: una definizione (proprio come uno spartito) deve determinare in modo non ambiguo gli oggetti che ad essa si conformano. A uno spartito, tuttavia, si chiede di più: non ci accontentiamo di poter determinare quali sia la classe di oggetti che lo soddisfa, ma chiediamo anche che — dato uno qualunque di tali oggetti — si possa determinare univocamente lo spartito di cui è esecuzione. Questo con le definizioni non accade: se indico un oggetto e ti chiedo una definizione, tu puoi scegliere tra molte e diverse possibilità, a seconda di quale sia il punto di vista che assumi. Uno spartito, invece, determina una classe di esecuzioni che, a sua volta indica in modo univoco un identico spartito. Per dirla con Goodman:
Non solo uno spartito deve determinare univocamente la classe di esecuzioni appartenenti all’opera, ma lo spartito (in quanto classe delle copie o iscrizioni che definiscono l’opera in tal modo) deve essere determinato univocamente, una volta data un’esecuzione e il sistema notazionale (ivi, p. 115).
Far luce su questa duplice caratteristica degli spartiti vuol dire cercare di comprendere che cosa definisca per Goodman la natura di un sistema notazionale. A questo tema è dedicato per intero il quarto capitolo di I linguaggi dell’arte, ed anche se questa è forse la parte più interessante e complessa del libro vorrei limitarmi qui ad alcune considerazioni di carattere introduttivo, intrecciandole con la discussione di un esempio. Muoviamo allora da un sistema notazionale: il sistema della notazione musicale. La notazione musicale ha, innanzitutto, alcune caratteristiche sintattiche su cui è opportuno soffermarsi un poco. La prima è questa: se io traccio un segno di nota sul pentagramma, questo segno non ha, in quanto tale, nessuna peculiare individualità: ciò che conta è esclusivamente la sua posizione sul rigo e quindi il suo essere una possibile realizzazione di un carattere del linguaggio musicale. E ciò è quanto dire che tutto ciò che caratterizza individualmente il segno al di là del suo essere la realizzazione di un carattere dato è inessenziale rispetto alla sua funzione. Goodman parla a questo proposito di indifferenza di carattere:
il tratto essenziale che contraddistingue un carattere in una notazione è che i suoi membri possano essere liberamente scambiati l’uno con l’altro senza alcuna conseguenza sintattica; o, più precisamente […] che tutte le iscrizioni di un carattere dato siano sintatticamente equivalenti. In altre parole, il fatto di essere esemplari di un carattere in una notazione deve costituire una condizione sufficiente perché i segni siano «copie vere» o repliche l’una dell’altra (ivi, pp. 116-117).
Ma i caratteri sul pentagramma hanno un’altra importante proprietà: per quanto io possa tracciare disordinatamente i segni sul pentagramma, è sempre in linea di principio possibile dire di che carattere è segno un segno. Un segno di nota può stare sul rigo o tra i righi, ma la posizione esatta del segno — il suo essere più o meno centrato sul rigo o il suo essere più meno perfettamente adagiato tra le righe — è ininfluente dal punto di vista sintattico. Sul pentagramma i tratti di penna che segnano le note possono occupare un’infinità di posizioni poiché lo spazio è continuo; i caratteri invece marcano posizioni discontinue, e ciò è quanto dire che sono finitamente differenziati o articolati. Non importa dove esattamente sia il tratto di penna che ho tracciato: ciò che conta è il suo essere riconoscibile come realizzazione di una o di un’altra posizione definita e significante sul pentagramma. In altri termini: tra il segno che ora faccio per indicare un do e il segno che ho appena tracciato per indicare un re vi sono infinite posizioni sul pentagramma e ciascuna di esse potrebbe essere occupata da un tratto di penna; e tuttavia tra quei due segni che ho tracciato non vi è nemmeno una posizione che possa essere occupata da un carattere — i caratteri sono appunto finitamente differenziati.
Non si tratta di una proprietà ovvia. La lancetta di un orologio segna in ogni istante una posizione determinata e ad ogni posizione corrisponde un carattere che ci consente di leggere il tempo; e tuttavia tra due posizioni della lancetta è sempre possibile indicarne una terza cui pure spetta un significato: l’orologio con le lancette non rispetta dunque il requisito della differenziazione sintattica e data una posizione della lancetta non è sempre possibile dire se essa sta per questa o per quest’altra determinazione temporale — ed è proprio questa indecidibilità che, per Goodman, caratterizza gli strumenti analogici. Agli strumenti analogici si possono tuttavia contrapporre quelli digitali, ed in questo caso il requisito della differenziazione sintattica è chiaramente rispettato: un orologio che segna il tempo modificando la cifra sul display ci consente di ricondurre ogni lettura dell’orologio ad una univoca determinazione temporale. Possiamo trarre allora una seconda conclusione: un sistema notazionale è per sua natura digitale, proprio perché è finitamente differenziato. Di contro, un sistema analogico è denso, poiché presenta infiniti caratteri ordinati in modo tale che per ogni copia di essi ne esiste comunque uno in mezzo.
Sin qui ci siamo soffermati su due requisiti sintattici. Ma perché si possa effettivamente parlare di un sistema notazionale è necessario chiamare in causa anche la dimensione semantica e quindi il campo dei referenti del sistema simbolico in questione. Ed anche in questo caso l’esempio del pentagramma ci guida verso l’identificazione di due proprietà peculiari.
La prima: un segno tracciato in una certa posizione sul pentagramma deve necessariamente stare sempre per la stessa nota. In altri termini: un carattere non deve essere ambiguo e deve essere legato a ciò che denota da una relazione stabile tale che, dato un segno, vi sia uno ed un solo denotato che gli corrisponde.
Ma vale anche la reciproca: due segni sul pentagramma — ed è il secondo requisito cui alludevamo — non possono avere in comune un oggetto denotato, perché ciò cancellerebbe la possibilità di risalire dal terreno oggettuale al piano linguistico in modo univoco. Alla discretezza dei segni fa così eco un’analoga discretezza dei denotati che debbono essere organizzati come punti differenziati e disgiunti, al di là di ogni eventuale e originaria appartenenza ad un continuum. Quest’ultima è un’osservazione importante: lo spazio sonoro è continuo, ma il discorso musicale si avvale di elementi discreti — le note — e Goodman sembra suggerire che all’origine di questa decisione per il discreto vi sia l’esigenza di fissare la fuggevolezza del musicale in uno spartito, — in qualcosa di simile ad un sistema notazionale, dunque.
Le considerazioni che abbiamo proposto sono ormai sufficienti per venire a capo dei nostri problemi. Possiamo, in primo luogo, comprendere le ragioni del carattere allografico della musica e autografico della pittura. La musica è allografica perché possiamo scrivere lo spartito di una sonata, e possiamo farlo perché di fatto vi è da tempo una prassi consolidata che ci consente di effettuare una segmentazione del continuum sonoro così da poterlo piegare alle esigenze di uno schema notazionale. Lo spazio sonoro è continuo, ma quanto più si impone l’esigenza di fissare su uno spartito l’identità di un’opera, tanto più doveva farsi avvertire l’esigenza di piegare la continuità alla discontinuità e di trarre di qui il fondamento per fare dello spartito un’immagine delle sue possibili esecuzioni, un sistema di segni capace di porsi in una relazione di corrispondenza biunivoca con il brano musicale di cui è espressione.
Ora, per la pittura un simile linguaggio non è in sé inconcepibile, ma di fatto non si dà, così come non vi è una prassi consolidata che ci consenta di ricondurre secondo una regola condivisa la continuità delle forme e dei colori di una raffigurazione ad un sistema di segni disgiunti. E non è un caso che non vi sia: le raffigurazioni sono oggetti materiali che durano nel tempo e non è necessario fissare la loro identità sul piano linguistico. Certo, ci si può avvalere di uno schizzo per condurre a termine secondo un progetto un quadro o un affresco, ma questo non significa che un disegno preparatorio denoti o addirittura definisca l’identità della raffigurazione che sta per sorgere. Gli schizzi non si usano così e non vi è, in generale, una convenzione che ci consenta di considerare inessenziali e prive di significato determinate variazioni in un disegno: uno schizzo, proprio come una raffigurazione, vale per noi per quello che è, e lo schema continuo delle variazioni possibili — insieme alla mancanza di un criterio convenzionale consolidato che ci consenta di fissare il limite della loro trascurabilità — ci impedisce di parlare di una raffigurazione come di un identico che ha molte possibili esecuzioni. Di qui il carattere autografico delle arti figurative, il loro essere prive di un criterio di identità dell’opera diverso da quello che si applica all’opera come oggetto materiale, — il suo avere una sua storia di produzione ed una sua definita origine e persistenza nel tempo.
Possiamo ora, finalmente, dimenticarci di van Meegeren e dei suoi falsi, per cercare di comprendere che cosa ci abbia insegnato questa lunga digressione. Il punto cui siamo giunti è questo: abbiamo constato che la pittura non è un sistema notazionale e che non vi è una prassi definita che ci consenta di imporre sul piano figurativo il requisito della differenziazione sintattica. Le raffigurazioni sono dunque sistemi simbolici densi, poiché dati due segni figurativi per quanto simili, esiste comunque tra questi un terzo segno dotato a sua volta di un significato rappresentativo. Come le posizioni del quadrante di un misuratore analogico, anche i segni di cui una raffigurazione consta sono dunque privi di differenziazione sintattica. Di qui, da queste considerazioni generali, si deve muovere per comprendere il problema da cui avevamo preso le mosse, e cioè quale sia la natura delle rappresentazioni e che cosa le distingua dalle descrizioni verbali. Rispondere a questa domanda significa infatti, per Goodman, indicare una differenza che concerne esclusivamente la natura dei simboli: lungi dall’implicare un rimando ad una qualche somiglianza tra il segno e il denotato, ciò che caratterizza una raffigurazione in quanto tale e la distingue da altri sistemi simbolici di denotazione è proprio la densità del suo schema simbolico, la sua mancanza di differenziazione sintattica. Uno spartito non rappresenta un brano musicale ma lo definisce e lo descrive, perché i sui simboli sono finitamente differenziati; al contrario, un quadro o un termometro non graduato non descrivono un paesaggio o la temperatura, ma la raffigurano (rappresentano) perché ogni posizione del tratto sulla tela o del mercurio nella colonnina è un valore in una scala continua che non permette un’ulteriore articolazione e una scansione finita. La mancanza di differenziazione sintattica diviene così la caratteristica distintiva di quei sistemi simbolici che ci consentono di raffigurare, ma non di descrivere.
Di questo primo risultato non possiamo accontentarci e di fatto la possibilità di abbracciare sotto il concetto di rappresentazione sia un dipinto, sia un orologio con le lancette ci costringe a tracciare una distinzione ulteriore in seno ai sistemi rappresentativi — ai sistemi sintatticamente densi. Una distinzione necessaria, se vogliamo distinguere un disegno da un diagramma:
confrontiamo un elettrocardiogramma momentaneo con un disegno del monte Fujiyama di Hokusai. Le linee nere segmentate su sfondo bianco possono essere esattamente le stesse in entrambi i casi. Tuttavia, uno è un diagramma, l’altro è una figura. Che cosa produce la differenza? Ovviamente qualche tratto dei due diversi schemi secondo i quali i due segni funzionano come simboli. Ma, essendo entrambi gli schemi densi (e partendo dal presupposto che siano disgiunti) quale tratto? La risposta non sta in ciò che è simbolizzato; le montagne possono essere diagrammate e i battiti cardiaci disegnati. La differenza è sintattica: gli aspetti costitutivi del carattere diagrammatico, a paragone del carattere pittorico, sono espressamente e fortemente ristretti. I soli tratti rilevanti del diagramma sono l’ordinata e l’ascissa di ciascuno dei punti attraversati dal centro della linea. La sottigliezza della linea, il suo colore, la sua intensità, la dimensione assoluta del diagramma, ecc., non contano; che un supposto duplicato del simbolo appartenga o no allo stesso carattere dello schema diagrammatico non dipende affatto da tali tratti. Quanto invece allo schizzo, il discorso è diverso. Qualsiasi assottigliamento o ispessimento della linea, il suo colore, il suo contrasto con lo sfondo, la sua dimensione, persino le qualità della carta — nessuno di questi tratti può essere trascurato o ignorato. Per quanto i due schemi, pittorico o diagrammatico, siano simili per il fatto di non essere articolati, alcuni tratti, che sono costitutivi nello schema pittorico, sono tralasciati come contingenti nello schema diagrammatico; i simboli nello schema pittorico sono relativamente saturi (ivi, pp. 198-199).
Esiste così da un lato una differenza netta, almeno dal punto di vista teorico, tra uno schema articolato (una descrizione) e uno schema denso (una rappresentazione), mentre esiste una distinzione di grado tra il rappresentazionale diagrammatico e il rappresentazionale figurativo, poiché la proprietà dell’essere saturi è una proprietà che ha gradi — in un disegno, per esempio, il colore dell’inchiostro può essere irrilevante rispetto alla funzione di rappresentazione che gli compete, laddove in un dipinto il colore del tratto di pennello ha nella norma una funzione figurativa.
Siamo giunti così al risultato cui tendevamo: abbiamo infatti mostrato come, per Goodman, sia possibile venire a capo della natura del concetto di rappresentazione figurativa senza chiamare in causa il concetto di somiglianza, ma solo due generali proprietà dei sistemi simbolici: una rappresentazione figurativa è appunto un sistema simbolico denso e relativamente saturo. E tuttavia a partire di qui, da questo intreccio complesso di considerazioni, è possibile una duplice conclusione su cui vale forse la pena di soffermarsi. La prima è di carattere generale e ci costringe a trarre una morale dichiaratamente convenzionalistica e a rifiutare di tracciare sul terreno ontologico la distinzione tra descrizioni e rappresentazioni:
Le descrizioni sono distinte dalle raffigurazioni non per il fatto di essere più arbitrarie, ma per il fatto di appartenere a schemi articolati anziché densi; e le parole sono più convenzionali delle figure solo se si intende la convenzionalità in termini di differenziazione e non di artificialità. Nulla dipende, qui, dalla struttura interna di un simbolo; perché ciò che in certi sistemi descrive può raffigurare in altri. La somiglianza scompare come criterio di rappresentazione, e la somiglianza strutturale come requisito dei linguaggi notazionali o di qualsiasi altro genere (ivi, pp. 199-200).
Ma vi è una seconda conclusione che dobbiamo trarre. Espungere dal terreno dei fondamenti del concetto di rappresentazione il rimando alla somiglianza vuol dire anche riconoscere apertamente che una raffigurazione non deve necessariamente avvalersi di figure e può fondarsi su rapporti di proiezione molto diversi da quelli consueti. In una raffigurazione ogni colore può stare per il suo complementare; ma può anche rimandare ad un suono, ad una grandezza, ad una virtù, e così via. Se l’essere una raffigurazione è una caratteristica meramente sintattica, non vi è davvero ragione per chiedere che un quadro consti di figure che stanno per figure, di colori che stanno per gli stessi colori — anche se è questo che accade di norma nella nostra cultura. Disporsi nella prospettiva di Goodman significa dunque riconoscere
la piena relatività della rappresentazione, e [la possibilità] che la rappresentazione sia fatta con cose diverse dalle figure. Oggetti ed eventi, visivi e non visivi, possono essere rappresentati da simboli visivi e non visivi. Le figure possono funzionare entro sistemi molto diversi da quello che a noi è accaduto di considerare come normale; i colori possono stare per il loro complementare o per le loro dimensioni, la prospettiva può essere rovesciata o trasformata in altri modi, e così via. D’altro canto i quadri, quando sono presi come puri contrassegni […] o sono usati come simboli in un altro schema articolato, non funzionano come rappresentazioni (ivi, p. 200).
La nozione di rappresentazione ci appare così nelle vesti astratte di un concetto formale che ha definitivamente preso commiato dalla greve miscela terrestre di cui la nostra percezione è intrisa.
Con ciò le nostre considerazioni espositive possono dirsi concluse, e insieme ad esse può dirsi concluso il nostro tentativo di dare una veste plausibile all’analogia tra la percezione di immagine e la lettura che il quadro di Gabriel Metsu ci proponeva. Ma alle considerazioni espositive dobbiamo ora affiancare una discussione critica, che deve dare voce teorica al senso di insoddisfazione che ci pervade e che sembra trarre origine dalla difficoltà di riconoscere nella coerenza lucida delle argomentazioni di Goodman la natura di un oggetto — le raffigurazioni — che crediamo di conoscere bene[4].
Lezione quarta
1. Dubbi
Nella lezione precedente abbiamo raccolto le ragioni che sembrano consentirci di sostenere che tra un dipinto ed un testo non vi è poi una differenza così radicale. Certo, una differenza permane anche per Goodman, e di fatto le riflessioni su ciò che separa i linguaggi e i sistemi notazionali dai sistemi densi e relativamente saturi hanno la funzione di tracciare un confine tra ciò che, per esempio, una lettera dice e ciò che un quadro ci mostra. La lettera che narra la tempesta e il quadro che la mostra sono diversi, ma solo per questo — perché è diversa la struttura sintattica dei sistemi simbolici in questione e non certo perché le raffigurazioni abbiano una qualche relazione di somiglianza con ciò che denotano.
Si tratta di un’affermazione importante, cui Goodman giunge seguendo un percorso che ha il sapore sottile del paradosso e che sembra, proprio per questo, costringerci a vergognarci delle nostre vecchie convinzioni, come se fossero il frutto di opinioni maturate prima di essersi cibati dei frutti dell’albero della conoscenza. Credevamo che un quadro dovesse assomigliare alla scena raffigurata più di quanto non vi assomigliasse la grafia della lettera che ci narra quello stesso argomento, ma ci sbagliavamo, proprio come è accaduto a chi, prima di noi, era fermamente convinto che la terra fosse piatta e comodamente seduta nel centro dell’universo. Del resto, la verità è fatta così: ha poco rispetto delle nostre credenze e nel pathos filosofico dell’empirismo vi è spesso il malcelato orgoglio di chi si libera senza rimpianti delle credenze del senso comune — di quelle convinzioni sorde che alla mente illuminata del filosofo debbono senz’altro apparire come pregiudizi se non addirittura come superstizioni.
Non credo che le cose stiano così, ed anzi temo che, talvolta, il gesto di libertà intellettuale con il quale il filosofo si libera di ciò che, dal suo punto di vista, è soltanto un’immotivata credenza sia invece espressione di un atteggiamento intellettuale che nei modi del paradosso nasconde un tendenziale disinteresse per i fatti, — per quei fatti che tutti semplicemente constatiamo e di cui non si deve rendere ragione, anche se è necessario tenerne conto. I fatti ci sono e dobbiamo accettarli anche se non sempre sappiamo comprenderne sino in fondo la natura, e non credo che sia un comportamento naif riconoscere che un dipinto è diverso da una lettera perché soltanto l’uno e non l’altra ci mostra quella tempesta di cui le parole rendono conto passo dopo passo. Di qui, dalla convinzione che sia semplicemente sbagliato chiudere gli occhi su ciò che da sempre sappiamo sulle immagini, vorrei muovere per invitarvi a rileggere con uno sguardo critico le considerazioni di Goodman.
Ora, il primo punto su cui credo si debba riflettere consiste nella distinzione che Goodman traccia tra i due differenti significati del verbo “raffigurare”. Questa distinzione ha una chiara eco sul terreno linguistico: è la distinzione tra denominazione e predicazione. E si tratta di una distinzione che può, in linea di principio, essere condotta sino alle ultime conseguenze: un nome sta per un oggetto e lo indica senza dirne alcunché, laddove un predicato si pone come una descrizione che può essere soddisfatta da un qualche oggetto — per esempio dall’oggetto che abbiamo appena denominato. Questo stesso ordine di considerazioni deve valere anche per le raffigurazioni: anche su questo terreno si deve distinguere, per Goodman, la raffigurazione come predicato a due posti (la raffigurazione come forma nominale denotante) dalla raffigurazione come predicato ad un posto (come forma predicativa), per poi sottolineare che il senso denotativo e il senso descrittivo che si legano ambiguamente nel concetto di raffigurazione sono reciprocamente indipendenti.
Basta tuttavia soffermarsi un poco su queste considerazioni perché quest’analogia ci si mostri nella sua problematicità. Un nome può denotare un oggetto senza dirne nulla, ed è proprio questo che accade per esempio quando diamo un nome ad un bambino: decidiamo di chiamarlo Luca o Michele, ed anche se questa scelta può sembrarci molto impegnativa, di fatto le cose non stanno così: un nome non dice nulla sulla persona che lo porta, proprio come non dice nulla l’indice che lo addita. Ma nel caso di una raffigurazione le cose possono davvero stare così? Possiamo dire davvero che un quadro rappresenta Socrate senza per questo raffigurare il volto di un uomo che abbia una lunga barba e gli occhi sporgenti — di un uomo che ricordi almeno un poco le statue dei fauni sileni? E se non ci sembra possibile raffigurare Socrate senza raffigurarlo così, allora sembra lecito concludere che una raffigurazione non è un nome proprio e non può stare per qualcosa senza caratterizzarla: non ha dunque senso parlare di una raffigurazione che abbia una mera funzione denotativa.
Si potrebbe tuttavia obiettare che l’esempio da cui abbiamo preso le mosse è tutt’altro che sufficiente per venire a capo del nostro problema. Per trovare un dipinto della morte di Socrate dobbiamo rivolgerci a David, ma se ci accontentiamo di un disegno di un bambino forse le cose stanno diversamente da come abbiamo detto. Un bambino ha di fronte a sé un foglio e una matita, e la felicità motoria di un movimento ripetuto si ferma in una traccia che si fa sempre più sicura e marcata, quanto più il bambino si esercita in questo strano gioco. E ora il bambino prende tra le mani il disegno e dice un nome: ciò che si vede sul foglio è la mamma o il papà o, per citare mio figlio Michele, un virus. Di qui la conclusione che sembra necessario trarre: il disegno denota un oggetto, proprio come lo denota un nome del nostro linguaggio, poiché è davvero difficile riconoscere in quegli schizzi qualcosa di più di un groviglio di linee.
Si tratta, credo, di una conclusione avventata e per rendersene conto è sufficiente chiedersi come di fatto reagiamo quando un bambino ci mette di fronte a quel groviglio di linee che ha casualmente tracciato. Di fronte a quelle linee faremo delle domande, indicheremo sul foglio dei punti per tentare qua e là un riconoscimento, e solo quando in una linea chiusa saremo riusciti a scorgere un volto o un corpo potremo dire di aver visto che cosa quel disegno raffigura. Questo riconoscimento può talvolta riuscire; ma può anche fallire: nonostante i nostri sforzi e le istruzioni che ci vengono date non riusciamo a vedere ciò che ci si chiede di vedere, e allora accettiamo di lasciarci guidare dalle parole e usiamo quel disegno senza lasciarci fermare dal fatto che gli occhi non sanno suggerire nulla alla nostra prassi. Ma se così stanno le cose, nessuno dirà che quel disegno raffigura un oggetto — qui c’è qualcosa che va contro la grammatica del nostro linguaggio e che ci impedisce di parlare di raffigurazione in assenza di un riconoscimento. Nell’intreccio delle linee che il bambino ci porge un disegno non c’è; vi è invece, nelle sue parole, l’invito ad un gioco in cui il libero sviluppo di una trama narrativa fa affidamento su un oggetto reale che può essere concretamente afferrato e che trae una sua più ricca funzione ludica dalla consapevolezza che altri fogli sanno mostrare ciò che purtroppo questa volta non è dato vedere. Il bambino ci invita a giocare con il suo scarabocchio, e ciò è quanto dire che siamo invitati ad assumere che ciò che viene agitato di fronte ai nostri occhi sia, per esempio, una bestia feroce: questa è la regola del gioco che ci viene proposta. Ma accettarla non significa altro che dichiararsi disponibili ad un gioco: per farlo basta volerlo, e non avrebbe in questo caso nessun senso dire che proprio non riusciamo a fare come se nel gioco quel foglio rappresentasse un pericolo, proprio come non avrebbe senso dire che non riusciamo ad assumere che un certo segnalino colorato stia per il posto che occupiamo sul percorso del Monopoli.
Questo fatto è importante, perché ci consente di comprendere il motivo della scelta linguistica cui alludevamo. Un segno linguistico ha un significato in virtù di una convenzione che può nel tempo divenire familiare, sino a sembrarci del tutto naturale e scontata; tuttavia, perché una convenzione valga non è necessaria la familiarità: è sufficiente che venga stipulata. Così, possiamo talvolta stupirci delle consuetudini che appartengono ad un mondo diverso dal nostro e potremmo rifiutarci di condividere comportamenti che ci sembrano apertamente insensati. Erodoto, per esempio, reagisce così alle convenzioni degli egizi:
I greci allineano i caratteri e le pietruzze che servono per fare i calcoli, portando la sinistra verso destra; gli egiziani fanno il contrario, cioè scrivono e fanno di conto procedendo da destra verso sinistra e, facendo così, pretendono di scrivere diritto, mentre, secondo loro, sarebbero gli altri a scrivere alla rovescia (Erodoto, Storie, I, II, 2, § 36).
Le convenzioni degli altri possono sembrarci insensate e possiamo guardarle con quella punta di sospetto che traspare in queste pagine di Erodoto, e tuttavia ciò non toglie che non avrebbe davvero alcun senso dire che non sappiamo convenire con una certa prassi di calcolo. Una convenzione può essere accettata o rifiutata, stipulata o respinta, ma è in linea di principio insensato dire che non riusciamo a stipularla o ad accettarla: questa possibilità di fallimento è esclusa dalla grammatica del concetto di convenzione. Di qui la differenza con le immagini. Se mi mostri la Vergine annunciata di Antonello da Messina e mi chiedi di assumere per un attimo che si tratti del ritratto di un uomo, posso senz’altro seguirti in questa strana richiesta. Ma se poi tu mi chiedessi di vedere in quel ritratto il volto di un uomo non saprei davvero come fare: non possiamo vedere come vogliamo e non possiamo dimenticarci del fatto che ciò che in un quadro si raffigura dipende appunto da ciò che sappiamo riconoscervi.
A partire di qui i primi dubbi sulle argomentazioni di Goodman trovano una conferma. Goodman si lascia guidare dall’analogia tra raffigurazioni e descrizioni linguistiche e distingue la raffigurazione come nesso denotativo dalla raffigurazione come funzione predicativa. Ma questa distinzione non si può tracciare con troppa disinvoltura, poiché riferire un’immagine ad un oggetto non significa affatto convenire sull’uso di un segno, ma proporre un possibile impiego di un’immagine — un impiego la cui possibilità è decisa dal modo in cui le immagini si adoperano, e cioè guardandole.
Credo che il senso di queste considerazioni non sia difficile da cogliere. Se qualcuno mi porge una matita e mi chiede di assumere che sia un martello posso forse trovare sciocca la richiesta che mi si avanza, ma non impossibile. Ma se mi si chiede invece di prendere quella matita e di conficcare un chiodo nel muro, allora dovrei semplicemente rispondere che ciò che mi si domanda è privo di senso: non basta assumere che qualcosa sia uno strumento per poterlo usare come si vuole. Lo stesso vale per le immagini: non basta chiedere che raffigurino qualcosa perché effettivamente sappiano farlo. Le immagini si usano, e come ogni strumento debbono poter far fronte alle condizioni che pone loro il fine cui debbono mettere capo. Le raffigurazioni, dunque, più che segni sono strumenti che si prefiggono un fine: farci vedere e riconoscere qualcosa.
Forse le considerazioni che ho proposto sin qui possono esservi sembrate un po’ sbrigative e, in fondo, troppo vicine a quel senso comune da cui Goodman ci invita così risolutamente a prendere le distanze. E tuttavia, piuttosto che cercare di difendermi da questa accusa, vorrei invitarvi ad indugiare ancora un poco sulle riflessioni che sorgono non appena cerchiamo di venire in chiaro sulla grammatica del concetto di raffigurazione così come noi normalmente lo intendiamo. Per Goodman, l’abbiamo dianzi osservato, disegni e dipinti sono sistemi simbolici convenzionali, e ciò è quanto dire che la funzione denotativa e descrittiva dei simboli figurativi non si fonda affatto su una qualche relazione interna tra le raffigurazioni e i loro oggetti, ma dipende esclusivamente dalla grammatica e dal vocabolario del linguaggio figurativo in questione. Che cosa denoti un simbolo e quale sia il suo contenuto descrittivo non lo si può dire una volta per tutte, poiché la funzione di un segno dipende dal linguaggio cui appartiene e dalle regole che lo caratterizzano — questo è quanto avevamo osservato nel quarto punto delle nostre considerazioni volte a rendere la teoria della raffigurazione che Goodman ci propone.
Ora, che questo sia vero per il linguaggio verbale è una tesi in qualche misura plausibile. Il linguaggio è fatto di parole e ogni parola è un segno che guadagna una relazione con il mondo in virtù di un nesso di proiezione che appartiene al linguaggio e che deve essere appreso da chi voglia intendere ciò che in quel linguaggio si dice. Imparare a comprendere una lingua straniera significa del resto proprio questo: apprendere passo dopo passo il significato dei termini (il vocabolario della lingua) per poi imparare le regole di composizione delle parole nell’unità di un intero proposizionale — la sua grammatica.
Sappiamo tutti che si tratta di un cammino faticoso: l’avere appreso qualche frase in una lingua straniera non è ancora una garanzia sufficiente per comprendere altre proposizioni e questo semplicemente perché il conoscere il valore di alcuni segni non è affatto una garanzia per poter intendere gli altri. Se qualcuno mi spiega che in tedesco «die Äpfel sind auf dem Tisch» significa che le mele sono sul tavolo non per questo ho un motivo sufficiente per comprendere che «die Birnen sind im Korb» vuol dire che le pere sono nel cesto. Per poter intendere questa nuova proposizione non mi basta avere inteso la prima e nemmeno sapere che cosa sono pere e ceste — ho bisogno anche di un dizionario.
Basta dare uno sguardo a ciò che sappiamo delle immagini per rendersi conto che anche qui il paragone zoppica. Forse di fronte ad un quadro di Cézanne uno spettatore un po’ sprovveduto potrebbe rimanere perplesso. Ma non appena avrà acquisito una qualche competenza pittorica nello stile figurativo di Cézanne saprà poi senz’altro riconoscere che cosa gli si presenta nelle diverse nature morte che quel pittore ha dipinto. Se avrà imparato a riconoscere le mele dipinte su un tavolo, non avrà difficoltà a riconoscere gli altri frutti che altri suoi quadri ci mostrano. Ma ciò è quanto dire che nel caso delle raffigurazioni l’interpretazione non sembra chiedere l’apprendimento di un dizionario e di una grammatica particolari. Flint Schier in un bel libro intitolato Deeper into Pictures. An Essay on Pictorial Representation (1986) ha sostenuto che nel caso delle immagini, una volta che si sia acquisita una qualche familiarità con uno stile figurativo, l’interpretazione di nuove raffigurazioni si genera naturalmente, senza bisogno di un addestramento ulteriore o dell’apprendimento di un vocabolario che ci consenta di proiettare i simboli pittorici sugli oggetti intesi:
Pictorial
competence in a symbol system is the ability to generate naturally interpretations
of arbitrarily many novel members of the system. When an initial interpretation
of some symbol does in fact effect an ability in someone to interpret novel
symbols without further ceremony, then that initial interpretation was iconic
or pictorial, the symbol so interpreted was a picture, the system containing
the symbols which he is then able to interpret without any prior baptismal song
and dance is iconic and he may be said to have pictorial competence in the
system. So the theory of natural generativity is a power […] to reckon with: it
tells us what counts as a picture, what counts as a pictorial system and what
counts as a pictorial competence (F. Schier, Deeper into Pictures. An Essay
on Pictorial Representation, Cambridge University press, Cambridge, 1986,
p. 46).
Certo, la capacità di interpretare un dipinto dipende dall’aver acquisito una qualche familiarità con le scelte pittoriche che lo caratterizzano, ed è un fatto che, per Schier, la competenza pittorica sia comunque relativa ad un determinato stile figurativo: saper riconoscere ciò che raffigura un dipinto di Boccioni vuol dire aver imparato ad orientarsi nel sistema simbolico della pittura futurista. E tuttavia, anche in questo caso, accentuare l’analogia tra raffigurazioni e descrizioni verbali significa fraintendere la natura del problema. Imparare quale sia in inglese il significato della parola «squirrel» vuol dire imprimersi nella memoria qualcosa: la definizione di un dizionario o l’aspetto di uno scoiattolo. Nulla di simile accade quando cerchiamo di acclimatarci ad un nuovo stile figurativo. Anche in questo caso c’è qualcosa da imparare, ma l’apprendimento non si dispiega nel fissare nella memoria una regola di proiezione che connetta i segni di un sistema simbolico alla loro interpretazione oggettiva: consiste invece nel saper attivare quei meccanismi di riconoscimento che sono alla base dei nostri processi percettivi e che sono comunque già all’opera, insieme a molti altri, nella nostra esperienza quotidiana. E se le cose stanno così, acquisire una competenza pittorica in relazione ad un determinato stile figurativo non significa affatto impossessarsi di un sistema di convenzioni che rendano leggibili i segni di un sistema simbolico, ma vuol dire piuttosto sintonizzare le proprie capacità di riconoscimento visivo su alcuni aspetti particolari, su un insieme circoscritto di invarianti. Non è un caso allora se per acquisire una competenza pittorica non è necessario un addestramento effettivo e non vi è bisogno di qualcuno che si assuma la funzione di dar voce alla comunità per illustrare le convenzioni cui è necessario adeguarsi; di tutto questo non c’è un bisogno assoluto, e di fatto è ben raro che di fronte ad un’immagine si debba davvero spiegare qualcosa. Del resto, l’unico aiuto che ci può essere dato si riduce a questo — a mostrarci che cosa dobbiamo guardare e quale sia la meta cui dobbiamo innanzitutto rivolgerci. Il resto spetta a noi, alle nostre naturali capacità di riconoscere ciò che si può riconoscere in un’immagine.
Quest’ordine di considerazioni vale anche quando ci disponiamo in una prospettiva nuova e ci chiediamo se sia possibile lasciarsi guidare dall’analogia con il linguaggio almeno per ciò che concerne la dimensione sintattica e grammaticale. Dobbiamo, in altri termini chiederci se per trovare il fondamento dell’analogia che Goodman ci invita a seguire non sia possibile confrontare una descrizione verbale ed un dipinto prendendo in esame il momento della loro interna composizione.
Che cosa questo significhi sul terreno linguistico non è difficile dirlo. Una proposizione consta di parole e le parole si connettono in un’unità più ampia sul fondamento di regole che sono definite dalla struttura grammaticale del linguaggio. Non è invece facile comprendere che cosa voglia dire parlare in generale delle parti di una raffigurazione, e questo è un fatto su cui sarebbe forse opportuno riflettere: una proposizione consta di elementi che hanno una loro codificazione linguistica e ciò fa sì che la sua scansione in parti non sia affatto arbitraria. Nel caso delle immagini le cose stanno diversamente, e dato un dipinto qualsiasi non esiste una sua ovvia articolazioni in parti. E tuttavia, anche se si ritiene possibile venire a capo di questa difficoltà, la differenza balza agli occhi: se debbo ricomporre un’immagine non ho bisogno di conoscere un insieme di regole, poiché è sufficiente vedere in quale modo si debbano accostare le sue parti per riguadagnare un intero dotato di senso. Non così stanno le cose se ci si dispone sul terreno di una qualche lingua empirica: se ho una serie di parole inglesi come «red, apple, the, is on, green, the, table» non so ancora quale sia l’ordine in cui debbo disporle per dire che la mela rossa è sul tavolo verde. In italiano l’aggettivo sta di solito dopo il nome; in inglese, invece, deve anticiparlo, e se non voglio commettere errori debbo sapere come stanno le cose. Per costruire una proposizione corretta è necessario disporre di una grammatica e di un dizionario, e ciò significa che dobbiamo avere imparato una molteplicità di regole che avrebbero potuto essere diverse; per costruire un puzzle no: è sufficiente accostare i pezzi e vedere se ogni nuova sintassi contribuisce alla possibilità di un riconoscimento. La regola di unità delle parti di un’immagine non è grammaticale, ma iconica. Ancora una volta è al libro di Schier che si può fare riferimento:
of course
icons have iconically significant parts; an iconically significant part is
an icon. The truth of the whole icon depends upon the truth of its iconic parts
[…]. Understanding the whole icon entails understanding its parts. But note
that these parts do not get their meaning by stipulation; their meanings do not
have to have been previously learnt and memorized, and going from part to whole
does not require a grammar […]. The mode of composition of icons into whole is
itself iconic. An icon is built iconically out of its parts just if anyone able
to recognise the objects or states of affairs represented by those parts can
generate an interpretation of the whole based simply on these recognitional abilities
(ivi, pp. 66-67).
Possiamo tuttavia spingerci un passo in avanti e chiederci se non vi siano ragioni più profonde che contribuiscono a rendere così dubbio il tentativo di discorrere di una grammatica delle immagini, — una grammatica cui spetterebbe il compito di indicare le regole da cui dipende il connettersi delle parti nell’unità di una rappresentazione. È tuttavia sufficiente porsi questa domanda per cogliere una differenza significativa tra linguaggio ed immagini. Le proposizioni complesse ci riconducono a proposizioni semplici, ma le proposizioni semplici non constano a loro volta di proposizioni, ma di parole che sono tra loro distinguibili per ciò che concerne la funzione che svolgono nel contesto proposizionale. In una proposizione vi sono nomi, aggettivi, verbi, congiunzioni, preposizioni, ecc., ed anche se possiamo liberarci dell’armamentario concettuale della grammatica appresa sui banchi di scuola è un fatto che ogni analisi grammaticale traccia comunque distinzioni funzionali tra le parti del discorso e che infine riconduce l’unità della proposizione ad un qualche rapporto di fondazione tra significati indipendenti e non indipendenti, tra argomenti e funzioni. Non credo che si possa riproporre questo stesso ordine di considerazioni sul piano delle immagini e questo perché ogni immagine può essere articolata in parti, ma ogni parte è, a sua volta, un’immagine e non differisce per forma e per funzione sintattica dall’intero di cui è parte. Per dirla in breve: le parti che compongono un’immagine non sono articolate grammaticalmente ed è per questo che la loro composizione nell’unità di un intero risponde ad un criterio intuitivo e non ad una qualche regola della grammatica. Una parte di un’immagine è soltanto un’immagine, e ci mostra ciò che ci mostra: un corpo, un viso, una mano o anche soltanto un arco di cerchio, e se di incompletezza ci sembra il caso di parlare quando osserviamo (per esempio) il disegno di un volto privo di un occhio (o di un occhio privo di un volto), è evidente che ciò che giustifica un simile giudizio non è una qualche presunta forma grammaticale che spetti alla raffigurazione in quanto è parte di un intero sintatticamente formato, ma è solo il rimando alla forma normale dell’oggetto ritratto. Di per sé tuttavia l’immagine è completa: ci mostra ciò che ci mostra — un volto senza un occhio, appunto. Non così, per esempio, un aggettivo, la cui incompletezza non si giustifica facendo riferimento alla forma normale delle cose con cui abbiamo a che fare. Certo, il rosso è necessariamente il colore di una superficie, ma questo non implica che alla parola «rosso» spetti una funzione non indipendente: «rosso» può essere il nome di un oggetto di cui si predicano varie proprietà («il rosso è il colore con la frequenza d’onda più bassa»), ma può evidentemente essere anche un aggettivo che si dice di qualcosa e che ad esso rimanda necessariamente («il fiore della cidonia è rosso»).
A queste considerazioni si potrebbe forse obiettare di essere troppo rapide e di non tenere conto del problema in tutta la sua complessità. Una raffigurazione, abbiamo detto, consta di parti iconiche, ed il modo in cui tali parti si connettono in un tutto è di natura intuitiva e non grammaticale. E tuttavia non è difficile mostrare che le cose sono almeno in parte più difficili poiché, come abbiamo osservato, non è facile comprendere che cosa valga come parte di una raffigurazione. Se si vuole mantenere valida l’analogia con il linguaggio sembrerebbe legittimo sostenere che parte di una raffigurazione non è ogni singolo punto cromatico di cui consta, ma solo ogni tratto (o insieme di tratti) che svolga una qualche funzione significativa nell’unità del disegno, proprio come in una proposizione chiamiamo parti del discorso non le singole lettere, ma solo le parole. Ora prendiamo il disegno di un bambino: qui abbiamo sicuramente a che fare con un insieme di tratti significanti, e tuttavia il senso percettivo che attribuiamo ad ogni singolo tratto varia con il variare del contesto di cui è parte. In un disegno infantile la bocca è una semplice linea diritta ed uno stesso discorso vale per le gambe e le braccia o per i capelli, che si dipartono a raggiera dal capo o per la terra su cui tutte le cose ordinatamente poggiano. Una linea può significare tutte queste cose: sembra allora necessario riconoscere che non abbiamo qui a che fare con una parte che è già di per se stessa un’immagine, ma con un segno che acquista un significato soltanto in un determinato contesto. Le immagini consterebbero infine di parti che immagini non sono e che hanno carattere subiconico, anche se hanno comunque un significato nell’unità del contesto. Perché non affermare allora che almeno per le parti subiconiche vi è qualcosa di simile ad un significato non indipendente e con esso il farsi avanti di una composizione grammaticale delle parti della raffigurazione nell’unità di un enunciato figurativo? In fondo, come si debba “leggere” il tratto orizzontale che funge da bocca lo comprendiamo soltanto così: guardandolo in un contesto determinato e quindi vedendolo alla luce di ciò che ci invita a vedere l’unità sintattica cui appartiene.
Dovremo in seguito tornare su queste considerazioni in cui si cela, io credo, un nocciolo di verità. Ma la conclusione che si vuole trarne mi sembra comunque sbagliata, e per rendersene conto è sufficiente osservare qual è la funzione che ogni singolo tratto assume nell’economia di un disegno. Certo, che la linea diritta ci mostri una bocca e non invece le infinite altre cose che potrebbero essere colte in una simile traccia dipende dal contesto dell’opera e dallo stile in cui è delineata; ciò non toglie tuttavia che quel segno che la matita lascia sul foglio faccia qualcosa, e che il suo senso dipenda da ciò che in virtù di esso si rende visibile. Una linea su un foglio può essere molte cose perché può apparire in molti modi diversi: può rappresentare un oggetto che si contraddistingue per la lunghezza e non per la larghezza come le braccia e le gambe di un pupazzo infantile; può segnare il profilo che consente ad un oggetto di stagliarsi su di un qualsiasi sfondo; ma può rappresentare anche un’apertura sottile o una fenditura in un corpo, ed è evidentemente questo ciò che vediamo in quella breve linea diritta che il bambino ha disegnato nell’ovale del volto. È dunque il contesto a definire il significato di quel segno, ma il modo in cui il definirsi del significato ha luogo non dipende dalla funzione semantica del contesto, — dal suo eleggere nell’ambiguità di un carattere il valore che risulta appropriato. Nel caso delle raffigurazioni questa descrizione non sembra attagliarsi: se la linea che segna la bocca ci appare proprio così non dipende dal fatto che, dato un volto, a quel segno ambiguo non è possibile attribuire un altro significato, ma dal fatto che quel tratto, accanto ad altri tratti, contribuisce a realizzare un’apparenza complessiva.
Vorrei cercare di chiarire meglio il senso di queste considerazioni. Nel caso del linguaggio verbale una parola può avere più significati e spetta al contesto decidere come sia possibile venire a capo dell’equivocità del segno nell’unicità di un significato. Quando dico «cane» è come se avessi aperto il dizionario su tre voci differenti lasciando poi al contesto della proposizione decidere quale sarà la sola pagina da prendere in considerazione — quella in cui si descrive un animale, una costellazione o il percussore di un archibugio. Quando traccio invece una linea su un foglio una simile scelta non c’è, poiché ciò che per il momento ho fatto è solo questo: ho segnato una visibile discontinuità, che può essere piegata in una direzione o nell’altra alterando il segno e continuandolo in un disegno più ricco e complesso. Quando disegno l’ovale di un volto intorno alla linea diritta che ho in precedenza tracciato non ho raffigurato il contesto che consente di scegliere tra i significati di un segno, ma ho modificato la situazione fenomenologica della scena che osservo, poiché ora la linea scura che ho tracciato appare necessariamente come un’alterazione di una superficie — come una fessura che si apre in essa (la bocca, appunto) o come una sua coloritura locale (le sopracciglia, per esempio) — e non può più essere percepita come raffigurazione di un profilo o di un corpo stretto e sottile. Ma ciò è quanto dire che in virtù del contesto muta non la funzione del segno — il suo nesso denotativo — ma il significato fenomenologico del tratto, il suo apparirci come un contorno, come una fessura o come un oggetto allungato.
Ora, ciò che si mostra procedendo dalla parte al tutto si manifesta anche se seguiamo il cammino opposto e ci chiediamo che cosa accade se, dato un segno, lo separiamo nei suoi elementi costituenti. Un segno linguistico complesso può articolarsi in segni linguistici semplici: la proposizione può essere analizzata nelle sue componenti elementari — le parole. Ma anche le parole possono essere ulteriormente suddivise poiché constano di lettere; le lettere, tuttavia, non hanno un significato e nel loro legarsi per determinare l’unità di una parola non apportano ciascuna un contributo che dipenda dalla loro peculiare natura: che queste lettere, ed in questo determinato ordine, formino una parola è soltanto una convenzione la cui libertà è limitata soltanto da quell’intreccio di natura e cultura che determina l’universo dei possibili fonemi di una lingua. Così stanno appunto le cose nel caso dei segni linguistici, ma non delle raffigurazioni. Possiamo suddividere quanto vogliamo un disegno, separando l’unità fenomenica di un’apparenza unitaria in parti sempre più piccole, ed è certo che in questo lavoro di dissezione la raffigurazione perderà passo dopo passo la sua capacità di mostrarci genti e castelli e campagne lontane. Ma per quanto ci si spinga in avanti in questo processo di suddivisione del segno pittorico non ci imbatteremo mai in elementi che siano privi di un valore iconico, di una loro funzione peculiare e specifica nella costituzione di una scena visibile. In una raffigurazione non si può giungere per suddivisione a qualcosa di simile alle lettere dell’alfabeto, a parti che si connettono in un’unità significativa soltanto in virtù di una mera convenzione. E non è un caso che le cose stiano così: una parola è composta dalle lettere dell’alfabeto, laddove una raffigurazione si fa nei tratti che la compongono.
Di qui la differenza cui alludevamo risulta con relativa chiarezza ed anche se dovremo ritornare su alcuni dei temi che abbiamo appena sollevato, le considerazioni che abbiamo proposto sono forse già in grado di gettare qualche dubbio sulla legittimità delle riflessioni di Goodman. Forse, anche se è banale dirlo, una lettera e un quadro sono davvero molto diversi ed ogni tentativo di ricondurre il concetto di raffigurazione sotto l’egida di un’indagine generale dei sistemi simbolici corre il rischio di condurci in un vicolo cieco poiché le immagini non sono dei segni, ma degli oggetti da guardare.
2. La somiglianza e le immagini
Nell’ora precedente abbiamo raccolto un insieme di dubbi che
sorgono non appena cerchiamo di comprendere le pagine di Goodman alla luce
della grammatica del concetto di raffigurazione. Se ci si pone in questa
prospettiva, i dubbi si affiancano ai dubbi, e quasi ad ogni pagina avvertiamo
la strana sensazione di immergerci in un disegno tanto coerente, quanto lontano
dai fatti che vorrebbe spiegare. Così, quando leggiamo che il realismo è
questione di abitudine possiamo forse sentirci per un attimo pervasi dal
piccolo orgoglio di chi non si lascia condizionare dal giudizio sommario che ha
bollato con un marchio di infamia l’intera arte contemporanea, ma poi quanto
più tentiamo di prendere sul serio una simile affermazione, tanto più rimaniamo
perplessi. Il secolo che abbiamo appena lasciato alle spalle ha fatto della
deformazione dei volti e dei corpi una regola pittorica pressoché mai contraddetta,
e agli eccessi delle avanguardie ci siamo ormai tutti abituati e forse
assuefatti; non per questo, tuttavia, le deformazioni scompaiono e le immagini
ci sembrano realistiche. Abbiamo visto mille e mille volte corpi e volti contorti
secondo la lezione de Les Demoiselles d’Avignon, ma ciò non rende meno
deformati quei tratti. E per fortuna: il giorno in cui davvero le tre
danzatrici di Picasso ci apparissero con i tratti delicati e con la perfezione
dei corpi delle figure della Primavera del Botticelli non avremmo più
alcun argomento per capire ciò che Picasso intendeva dirci. Se Goodman avesse
davvero ragione tutti i quadri col tempo ci parlerebbero con lo stesso tono di
voce: con il linguaggio tedioso del realismo. Non solo. Le abitudini sono
figure solitarie e non tollerano di dividere la scena della coscienza con ciò
che in altri tempi era consueto: acquisire un’abitudine nuova vuol dire anche
svestire i panni un tempo consueti. Così ci siamo abituati a Picasso e Braque e
ci siamo disabituati a Caravaggio — ma nessuno direbbe, io credo, che l’avere
acquisito una qualche familiarità con lo stile figurativo del cubismo ha fatto
sì che la Giuditta e Oloferne o la Testa di Medusa perdessero il
loro aspetto realistico. E ancora: se il realismo fosse questione di abitudine,
la storia dell’arte non dovrebbe averci mai presentato la questione del realismo
come una nuova proposta artistica, come un obiettivo verso cui tendere. E invece
il realismo pittorico è stato evidentemente una meta ed una parola carica di
significato innovatore, e basta guardare come Masaccio dipinge Adamo ed Eva
nella Cappella Brancacci e come li aveva in precedenza dipinti Masolino perché il
discorrere del realismo come mera assuefazione ci sembri un discorso vuoto.
Credo che tra i compiti cui un lettore deve far fronte vi sia davvero anche questo: un lettore deve dapprima cercare di comprendere e dare ascolto quanto più può e sa alle argomentazioni che gli vengono proposte, ma poi non deve esimersi dal tentare di dare una forma più definita ai dubbi che pagina dopo pagina gli si sono affacciati alla mente. Ecco, io credo che i dubbi che vi ho sinora descritti siano tutti in qualche modo legittimi, ed è proprio questa loro plausibilità che ci spinge a domandarci per quale ragione un filosofo come Goodman ha potuto chiudere gli occhi di fronte a queste difficoltà, come se si trattasse di un male minore, di un tributo che era necessario pagare per non imbattersi in ben altre difficoltà.
Rispondere a questo interrogativo significa, io credo, rammentare quale sia la tesi da cui di fatto hanno origine le riflessioni di Goodman. Si tratta di una tesi polemica: la prima vittima verso cui si orientano gli strali polemici di I linguaggi dell’arte è la tesi classica secondo la quale le raffigurazioni avrebbero il loro fondamento nella relazione di somiglianza che le lega all’oggetto raffigurato. Questa tesi deve essere ridotta al silenzio, per dimostrare che «la denotazione è il nocciolo della rappresentazione» (I linguaggi dell’arte, op. cit., p. 13) — ma con quali argomenti?
Alcuni ci sembrano decisamente deboli. Una cosa — leggiamo — ha molti aspetti e questo dovrebbe impedirci di proporne sensatamente una copia, poiché non è affatto detto che gli infiniti riguardi rispetto ai quali un oggetto può essere inteso possano essere unificati nell’unità di una rappresentazione. Una persona è un amico, un fascio di atomi, un uomo dal carattere difficile, un organismo pluricellulare, un medico e non è certo facile dire come tutte queste caratteristiche possano essere insieme raffigurate. Un’osservazione vera, ma che non tocca affatto il problema che ci sta a cuore: due gemelli si assomigliano anche se pensano a cose diverse, se — come è senz’altro opportuno — non hanno sposato la stessa moglie e non indossano gli stessi vestiti. La somiglianza è una relazione selettiva: si è simili rispetto a qualcosa, non rispetto ad ogni possibile aspetto, e se due gemelli si dicono simili è perché tali sono i loro tratti del volto e spesso anche il loro aspetto complessivo. E nel caso di una raffigurazione le cose stanno proprio così: quando guardo un ritratto di un amico posso dire che gli assomiglia molto, anche se con questo non intendo affatto affermare che non vi sia una molteplicità di aspetti rispetto ai quali una somiglianza non vi è. Anche se non vi è alcun bisogno di dirlo, l’unica somiglianza che qui è chiamata in causa concerne l’aspetto visivo — e del resto, quando diciamo che qualcosa è simile ad un’altra abbiamo raramente bisogno di dire sotto quel riguardo: alle somiglianze siamo tanto sensibili da non avere bisogno di ulteriori suggerimenti.
Ora, che la somiglianza sia, nella norma, percepita è un fatto difficilmente discutibile, ma Goodman ritiene che si possa mettere da parte questo fatto così ovvio invitandoci a riflettere sull’intreccio tra percezione e cultura e sulla relatività culturale del percepire. Debbo dire che questo generico rimando alla tesi secondo la quale non vi sarebbe un “occhio innocente” non mi sembra poi così ricco di significato. Goodman lo dà come un fatto scontato e dimostrato una volta per tutte, ma tutto lascia pensare che le cose non siano affatto così semplici come ci si vuol far credere. Non credo che per trovare simili due gocce d’acqua ci si debba davvero appellare ad uno sguardo innocente, anche se forse può trovarle dissimili solo uno sguardo colpevole che pecchi di un eccesso ermeneutico. Certo, non tutte le somiglianze si impongono con la stessa immediatezza e può darsi (anche se non è affatto certo) che in questo caso l’addestramento e la cultura abbiano da dire la loro: normalmente, non abbiamo bisogno di dire rispetto a che cosa una scena ci sembra simile ad un’altra, ma può darsi che culture diverse (o differenti età) rendano meno immediato il fondamento su cui poggia il nostro giudizio. Talvolta dobbiamo dire che A e B ci sembrano simili sotto questo riguardo, e forse può capitare che sia necessario parlare un poco per mostrare ciò che intendiamo e per far cadere lo sguardo su una somiglianza che non vuole lasciarsi afferrare; e tuttavia, questi ed altri ostacoli che possono frapporsi all’afferramento di una somiglianza non significano affatto che una somiglianza obiettiva non vi sia, ma solo che non è sempre facile coglierla. «Ricorda davvero sua madre» — qualcuno dice così, e noi cerchiamo di ritrovare una somiglianza che sapremmo cogliere se fossimo stati anche noi colpiti da un certo modo di socchiudere gli occhi, di sorridere, di camminare. Se soltanto avessimo colto quei tratti sapremmo cogliere anche noi quella somiglianza, che non è affatto qualcosa di meramente soggettivo o convenzionale, ma è un fatto tra gli altri — un fatto che ci si può sforzare di cogliere ma che può anche sfuggirci o che può essere apertamente negato.
Del resto, per scorgere una somiglianza l’attenzione talvolta non basta: può essere necessario un addestramento e forse anche il formarsi di un’abitudine percettiva. Questo tuttavia non è un argomento per concludere di avere a che fare con una convenzione, e per la buona ragione che non è affatto vero che si possano apprendere soltanto convenzioni. Un nesso che debba essere insegnato non è un nesso convenzionale, e l’argomento empiristico che fa dell’apprendimento un segno della mera soggettività di un legame è un argomento sbagliato che trae la sua presunta legittimità soltanto da una concezione dell’esperienza che non tiene in debito conto la differenza tra ciò che in una qualsiasi scena percettiva è propriamente colto e compreso e ciò che invece si può in linea di principio afferrare. Così, dei discutibili esempi che Goodman attinge dai repertori antropologici e che ci narrano le reazioni di sconcerto di un qualche indigeno cui si sia mostrata una fotografia o un disegno prospettico non è affatto chiaro quale uso fare: può darsi che vi sia davvero qualche strana tribù che non veda ciò che un bambino di pochi mesi (che non sa ancora parlare) riconosce con sicurezza, ma questo non significa ancora che non possa imparare a vedere, proprio come tutti noi abbiamo imparato a vedere un cruccio nascosto nello sguardo di una persona amica. Insomma: di tutti gli argomenti che Goodman raccoglie per mostrare che una raffigurazione non è simile a ciò che raffigura non credo ve ne sia uno che abbia dalla sua una qualche plausibilità. Quanto poi alle pagine de I linguaggi dell’arte in cui si cerca di dimostrare il carattere meramente convenzionale della prospettiva e l’arbitrarietà del disegno prospettico che fa convergere le perpendicolari ma non le verticali rispetto al piano figurativo, — bene questo è soltanto un segno del fatto che i grandi filosofi quando sbagliano non si accontentano di piccoli errori.
Dalle considerazioni che abbiamo proposto si potrebbe trarre una prima conclusione: potremmo infatti sostenere che non vi è davvero nulla di male nel dire che una raffigurazione assomiglia a ciò che raffigura e a costo di sembrare banali direi che è del tutto legittimo sostenere che vi sono stili figurativi in cui questa somiglianza è maggiore e altri in cui è minore e che tutto ciò non ha davvero nulla a che fare con l’abitudine — questo deus ex machina di ogni filosofia empiristica. E tuttavia, per quanto importante possa essere questa conclusione, non credo che ciò che abbiamo detto sin qui possa davvero bastare per rispondere a Goodman. In realtà, basta rammentare le poche cose che abbiamo detto per cercare di far luce sulla sua teoria per rendersi conto che la polemica contro il concetto di somiglianza ha la sua vera ragion d’essere nella tesi secondo la quale «la denotazione è il nocciolo della rappresentazione». Il problema è tutto qui: se un’immagine è innanzitutto caratterizzata dalla sua funzione denotativa, allora è evidente che il rimando alla somiglianza non può essere risolutivo, poiché — come osserva Goodman — la somiglianza non è né una condizione necessaria, né una condizione sufficiente della denotazione. Non è una condizione sufficiente: due gocce d’acqua si assomigliano, ma l’una non è il ritratto dell’altra. Ma non è nemmeno una condizione necessaria: se il compito di una raffigurazione è rimandare ad altro, allora il vero senso di un disegno non è in ciò che ci si mostra ma in ciò che si ritiene che sia l’oggetto che si intende denotare. E se non è né una condizione necessaria, né una condizione sufficiente, allora la somiglianza deve essere espunta dal novero degli argomenti che ci consentono di addentrarci nel concetto di raffigurazione. Di qui la via che dobbiamo seguire. Se, come mi sembra, la nozione di rappresentazione cui Goodman allude è davvero troppo lontana da ciò che sembra caratterizzare la grammatica di questo concetto e se, come credo, Goodman ha ragione quando sostiene che la somiglianza non è un possibile fondamento cui ricondurre il nesso denotativo, allora dovremo cercare di mostrare che in realtà le raffigurazioni non hanno affatto la funzione di rimandare ad altro. Un’immagine non denota un oggetto, non è un simbolo che rimandi ad altro da sé: è, più semplicemente, un oggetto da guardare — qualcosa in cui ci si mostrano uomini e campagne e paesaggi dipinti.
Lezione quinta
1. Raffigurazione e denotazione
«La denotazione è il nocciolo della rappresentazione» — è questo l’assunto teorico da cui, come abbiamo osservato nelle precedenti lezioni, Goodman si lascia guidare e che in fondo dovrebbe giustificare anche ai nostri occhi il continuo gioco di paradossi entro cui il concetto di raffigurazione si involve, rinunciando pagina dopo pagina a ciò che a noi sembra costituirne la grammatica.
Da questo assunto io credo ci si debba liberare. Per farlo, tuttavia, vorrei innanzitutto chiedervi di lasciare per il momento da parte le osservazioni che abbiamo letto ne I linguaggi dell’arte per rivolgere l’attenzione al concetto di raffigurazione così come normalmente lo intendiamo e così come è implicitamente definito dal linguaggio e dalla nostra prassi. E se ci poniamo in questa prospettiva, la tesi della centralità della denotazione sembra sollevare fin da principio più di un sospetto poiché il vocabolario che si attaglia alla funzione denotativa sembra applicarsi assai male alle immagini.
Gli esempi non sono difficili da proporre. Se mostro un mio disegno a un amico, può capitare che mi guardi perplesso e che mi chieda di che si tratti o che cosa intendevo fare con quell’intreccio di linee, ma a meno che il mio disegno non venga del tutto frainteso e che non lo si riconosca nemmeno per quello che è — per una raffigurazione più o meno felice — non mi chiederà affatto per che cosa stia o che cosa denoti: in una rappresentazione non si cerca di scorgere un segno che rimandi ad altro, ma si vuole innanzitutto vedere qualcosa — quel qualcosa che vi è disegnato. Su questo punto è necessario essere un poco più precisi, poiché si potrebbe obiettare che il verbo «vedere» lo usiamo in contesti molto differenti, e che non sarebbe difficile trovare casi in cui attribuiamo agli occhi una responsabilità che loro non compete. In modo particolare questo accade proprio nel caso delle relazioni simboliche: ciò che si vede è il segno, ma diciamo egualmente di vedere il designato. Così, nessuno avrebbe nulla da obiettare se qualcuno, mostrandoci un termometro, esclamasse «Guarda un po’ che caldo che fa!». Ora, da un simile uso linguistico non sarebbe legittimo dedurre che le temperature si vedano; ma allora perché pretendere di trarre una qualche conclusione dal fatto che noi tutti diciamo di vedere in un quadro un paesaggio dipinto? Non si potrebbe sostenere che, anche in questo caso, ciò che vediamo è soltanto un segno? Credo che a questa domanda si debba dare una risposta negativa e che non sia poi difficile rendersi conto di quanto siano diversi i casi che abbiamo qui accostato. Quando diciamo che un termometro ci permette di vedere quale sia la temperatura di una stanza intendiamo dire che l’altezza percepibile della colonnina di mercurio rispetto all’asta graduata che l’affianca ci consente di sapere che temperatura c’è; se faccia caldo o freddo, tuttavia, non lo vediamo affatto: vediamo invece una posizione del mercurio che è segno di una temperatura determinata. Non è difficile rendersi conto che nel caso delle immagini la percezione visiva ha un ruolo ben diverso. Quando dico che un quadro rappresenta una battaglia campale non intendo asserire che ciò vedo è segno del fatto che qualcosa del genere è avvenuto o sta accadendo da qualche parte; sulla tela non vedo un segno che rimanda ad altro e il mio sguardo non è rivolto a cogliere i pigmenti e le pennellate che scorgo anzi solo come caratteristiche interne alla scena che per me si raffigura: ciò che vedo altro non è se non una battaglia campale dipinta. Così, se dico che il termometro ci dà una rappresentazione adeguata della temperatura dico che posso vedere nella posizione del mercurio un segno che ci consente di risalire ad essa. Nel caso delle immagini, invece, parlare di rappresentazione significa soltanto questo: che ciò che vediamo ha lo statuto etereo delle datità meramente fenomeniche, delle apparenze.
Si tratta, indubbiamente, di osservazioni che non fanno altro che dare una forma filosofica a ciò che caratterizza il nostro consueto discorrere di raffigurazioni, e tuttavia vorrei egualmente invitarvi a prendere sul serio queste ed altre espressioni che fanno parte del modo in cui normalmente parliamo delle immagini. È per questo che invece di tornare su un terreno più “filosofico” vorrei invitarvi a giocare ancora un poco con le parole e richiamare l’attenzione su un altro uso linguistico molto comune che tende a stringere in un unico nodo la prassi del disegnare e l’oggetto del disegno. Che cosa con ciò intenda è presto detto: i disegni innanzitutto si fanno e il disegnare è un’attività più o meno complessa; ma se un bambino ci chiede di disegnargli qualcosa si esprimerà a sua volta proprio così: fammi, per esempio, un coccodrillo e fammelo proprio così — con la bocca spalancata e lo sguardo feroce. E se ne siamo capaci, noi facciamo appunto un coccodrillo, e cioè costruiamo tratto dopo tratto un oggetto nuovo — un oggetto soltanto visibile: un coccodrillo disegnato, appunto. La prassi che realizza il disegno è dunque insieme la prassi che mette capo ad un oggetto nuovo, e non credo che si possa rendere conto di questa forma espressiva leggendola alla luce della forma retorica della metonimia. Il bambino che chiede di fare un coccodrillo non risparmia le parole e non ci chiede di fare propriamente un disegno e che quel disegno stia per un coccodrillo: il verbo «fare» non è qui impiegato in modo ambiguo poiché fare un disegno significa anche fare — e fare proprio così — un oggetto disegnato.
Dovremo tra breve tornare sulla peculiarità di questo oggetto e sul senso che si può dare a questo nostro discorrere di oggetti raffigurati in quanto tali: ora vorrei sottolineare invece che dal punto di vista della grammatica del linguaggio non sembra affatto convincente la tesi di chi sostenga che ciò che disegnando prende forma è soltanto un segno che sta per un qualche oggetto, e non un oggetto in quanto è dipinto. Se ci muoviamo sul terreno dell’analisi del linguaggio nulla sembra giustificare una simile asserzione, poiché il modo in cui ci esprimiamo sembra chiaramente alludere al fatto che gli oggetti della rappresentazione sono proprio quegli stessi che vediamo dipinti sul muro o sulla tela. Così, se guardo gli affreschi della Cappella Brancacci posso dire — indicando di volta in volta un diverso punto dell’affresco — che questo è Adamo, che questa è Eva e che questo è l’arcangelo Michele, e un simile uso linguistico non avrebbe alcun senso se gli oggetti della raffigurazione non fossero proprio gli oggetti che abbiamo sotto i nostri occhi. Possiamo dire che questo è Adamo guardando l’affresco del Masaccio perché di fronte a noi vi è effettivamente Adamo — anche se soltanto dipinto, mentre non avrebbe evidentemente alcun senso usare una simile espressione se invece di un affresco avessimo di fronte a noi le parole che descrivono quell’evento biblico. Del resto, che il riferimento deittico non sia qui fuori luogo e non sia da imputare ad un capriccio linguistico lo si può desumere anche per altra via. Guardiamo un quadro famoso del Caravaggio ed esclamiamo: questa è la testa della Medusa, ed è questa proprio perché è davvero di fronte a noi e guarda con occhi pieni di angoscia qualcosa che deve essere a pochi passi dal luogo in cui siamo. Se la testa di Medusa fosse altrove e se davanti a noi si potesse scorgere soltanto un simbolo che la denota, una parte del senso di ciò che vediamo andrebbe semplicemente perduta.
Forse, di fronte a queste considerazioni si può reagire con un po’ di fastidio e sostenere che di ciò che il linguaggio e i suoi usi ci insegnano non sappiamo che farcene. In fondo il linguaggio registra il “sapere” del senso comune, e se abbiamo avvertito il bisogno delle virgolette è perché di un sapere non si può in questo caso parlare. Il senso comune è il nome che diamo a quelle nostre convinzioni che non sappiamo né motivare, né argomentare, e dunque non sembra che sia davvero opportuno dargli ascolto e rinunciare a decidere altrimenti che cosa sia una rappresentazione.
Non credo che queste considerazioni debbano essere sino in fondo condivise e penso che una riflessione sugli usi linguistici ci permetta di fissare i contorni del problema e insieme le caratteristiche di cui si deve poter rendere conto sul terreno delle analisi concettuali. E tuttavia, anche se torniamo sul piano della teoria e ci rammentiamo delle cose che abbiamo detto seguendo le pagine di Goodman, la tesi della centralità del momento denotativo non sembra così facilmente sostenibile. Che una simile affermazione destasse qualche problema è un fatto su cui ci siamo già soffermati: molti quadri non ritraggono affatto personaggi o paesaggi reali, e quasi tutta la pittura moderna ha per tema scene mitologiche o religiose, e qualunque sia la nostra posizione rispetto alla religione o al mito è relativamente ovvio che non si può parlare del Ratto di Proserpina come di un dipinto che abbia dei referenti reali. Sappiamo che per questa difficoltà Goodman ha una risposta: alla raffigurazione come predicato a due posti si deve affiancare la raffigurazione come predicato ad un posto — come etichetta che attesta di un quadro un predicato particolare: non il suo essere un pezzo di legno rettangolare, dipinto nel 1465 da Paolo Uccello, ma il suo porsi come una figura-di-profanzione-dell’ostia, come un quadro che ha questo particolare contenuto.
Si tratta, a ben guardare, di un modo piuttosto strano di dire le cose, ma anche se non ritengo che sia opportuno avvalersene, credo egualmente che sia da questa seconda accezione del concetto di raffigurazione che si debba muovere, poiché ciò che innanzitutto ci è dato non è una qualche relazione che leghi un’immagine ad un oggetto esterno ad essa, ma un fatto di natura percettiva: su quel pezzo di legno rettangolare vediamo, raffigurata, una narrazione suddivisa in diverse scene — la narrazione della profanazione dell’ostia, così come Paolo Uccello la racconta nella predella di Urbino. Il fatto primario è questo: il nocciolo della rappresentazione non è il suo porsi come un simbolo che rimanda ad altro, ma come il luogo di una messa in scena che ci consente di vedere raffigurate proprio qui, di fronte ai nostri occhi, le gesta che il pittore ha creato.
Su questo punto è necessario insistere. Ed il primo passo in questa direzione consiste nel rammentare uno dei dubbi che avevamo sollevato nella precedente lezione. Allora ci eravamo chiesti come fosse possibile sostenere che non vi fosse una necessaria relazione tra la dimensione descrittiva e la dimensione denotativa di una raffigurazione e i nostri dubbi ci erano parsi legittimi perché ci richiamavamo alla grammatica del concetto di raffigurazione così come si dà nel nostro linguaggio; basta tuttavia abbandonare questo terreno di discussione e porsi nella prospettiva di Goodman perché il problema apparentemente si dissolva: una raffigurazione denota qualcosa solo perché è possibile istituire una relazione di proiezione che la connette ad un referente, e poiché la somiglianza non ha nulla a che fare con il nesso che lega il nome a ciò che denota, allora possiamo sostenere che anche le raffigurazioni sono connesse all’oggetto denotato da una regola di proiezione convenzionale.
Si tratta di una conclusione coerente, che poggia tuttavia su un assunto — la centralità della denotazione — su cui avevamo sin da principio attirato l’attenzione e su cui vorremmo sollevare ora qualche dubbio. Un nome denota un oggetto, e non serve se non perché sa rimandare ad altro; un’immagine, invece, ci basta guardarla e non vi è necessariamente bisogno di ricordarsi di un qualche altro evento. Ma se un’immagine ha già di per sé una funzione, non si vede perché non ci si debba accontentare di ciò che ci offre: per quanto vari e diversi siano gli usi che di un’immagine possiamo fare, resta comunque vero che un disegno ci mostra qualcosa e che a noi spetta, in primo luogo, di guardarla. Vorrei dunque suggerirvi di orientare le nostre analisi muovendo da un assunto differente da quello di Goodman, — un assunto che deriva dalle considerazioni che abbiamo proposto e che vorrei formulare così: un’immagine basta a se stessa e la sua prima caratteristica consiste nel saperci mostrare qualcosa che ha lo statuto effimero delle apparenze.
Certo, riconoscere che le immagini bastano a se stesse non significa asserire che non sia possibile che ci parlino di qualcosa d’altro: un’immagine è un oggetto che appartiene alla nostra cultura e che può essere usato per adempiere molte e differenti funzioni, e tra queste è ben possibile che vi sia spazio per una funzione, in senso lato, denotativa. E tuttavia sapere che un’immagine non è di per sé un simbolo che debba condurci ad un referente è un fatto importante anche perché ci spinge a chiederci come possa accadere che una raffigurazione in quanto tale possa anche parlarci di qualcosa d’altro. Due possibili risposte debbono essere senz’altro scartate. La prima ci riconduce al terreno delle intenzioni soggettive dell’autore: si potrebbe cioè argomentare che un quadro rappresenta Isaac Newton perché chi l’ha dipinto voleva appunto tramandare ai posteri il volto di quel grande scienziato: il pennello e la capacità di usarlo determinerebbero così l’aspetto del quadro, mentre spetterebbe all’intenzione soggettiva di chi l’ha dipinto il compito di orientare la freccia che ci riconduce dall’immagine al mondo e ai suoi oggetti.
Ora, la volontà del pittore gioca senz’altro un ruolo nell’attribuzione di un ritratto ad una persona determinata, ma di per sé non basta per stabilire in modo definitivo quale sia il referente dell’immagine. Così, anche se di solito acconsentiamo alle pretese di chi ha dipinto un ritratto non sempre ci è possibile venirgli incontro, e del resto anche l’autore potrebbe riconoscere che voleva rappresentare Newton ma che purtroppo non c’è riuscito — e se possibile distinguere in un quadro il suo effettivo rimandare ad A dal fatto che qualcuno intendesse, dipingendolo, rimandare ad A, allora è evidente che l’intenzione non può essere il nerbo su cui poggia la possibilità delle immagini di avere un oggetto ad esse esterno.
Ma vi è anche una seconda possibile soluzione che deve essere scartata. Un nome può avere un referente perché vi è una relazione reale che li connette — c’è un bambino appena nato e qualcuno pronuncia un nome ad alta voce, e questo evento reale fa sì che tra quel suono cui ci abitueremo e quella persona a cui ci affezioneremo si crei un legame effettivo: un nome che abbiamo scelto è diventato il suo nome di battesimo.
Così stanno appunto le cose per i nomi, ma nel caso delle raffigurazioni questo non basta. Certo, potremmo assumere che una figura stia per qualcosa di reale, e lo stemma del serpente che ha in bocca un bambino e che sta per la città di Milano è un possibile esempio di ciò di cui discorriamo. E tuttavia nessuno direbbe che quello stemma raffigura Milano; e a ragione: del nesso che lega lo stemma alla città non si può rendere conto muovendo da ciò che l’immagine ci propone. Ma forse potremmo intendere diversamente le considerazioni che abbiamo appena proposto e sostenere che un quadro acquista un referente reale se è stato tracciato in presenza di una persona che abbia fatto da modello: un ritratto di Tiziano ci parla di Pietro Bembo perché proprio il Bembo ha evidentemente posato per lui.
E tuttavia è evidente che anche questo nesso non basta per rendere conto di come una raffigurazione in quanto tale possa parlarci di qualcosa che sta di là da sé. L’abbiamo già osservato: molti pittori hanno dipinto Maria lasciandosi guidare dal volto di una qualche modella, ma sarebbe davvero curioso sostenere che la Madonna di Senigallia raffigura una donna di cui non conosciamo nemmeno il nome e che forse ha posato per altri quadri che, al di là del loro soggetto, dovrebbero tutti denotare una stessa persona di cui non sappiamo nulla.
Se le cose stessero davvero così, la funzione comunicativa delle immagini andrebbe interamente perduta e noi dovremmo senz’altro sostenere che gli innumerevoli quadri della Madonna con il bambino che sono stati commissionati da confraternite devote e da Chiese grandi e piccole non parlano della stessa persona e non debbono essere intesi come se si riferissero a quella stessa figura di cui si parla nei Vangeli. Ed invece la Madonna di Senigallia non ci mostra soltanto una donna che tiene in braccio un bambino ma intende aiutarci a rivolgere il pensiero proprio a Maria, e può farlo perché quel quadro possiamo usarlo proprio così — secondo una tradizione consolidata e condivisa che ci consente di avvalercene come un sostegno visivo per pensare ad una persona che nella nostra cultura è oggetto di un culto particolare.
Così, ogni immagine basta a se stessa poiché ci presenta una
scena visibile racchiusa nei quattro legni della cornice; ma delle immagini
possiamo fare anche un uso determinato: possiamo anche usarle per
riferirci al mondo reale o al mondo animato delle nostre credenze, — possiamo
farlo se solo è possibile dar vita o richiamarsi ad un gioco linguistico che ce
lo consenta. Ad un gioco linguistico o, per essere più esatti, ad una
molteplicità di giochi linguistici, poiché di fatto delle raffigurazioni ci
avvaliamo non per denotare oggetti, ma per ricordare il volto di persone
care, per celebrare eventi importanti, per rendere vicino ciò che
è lontano, per sentirci osservati dallo sguardo dell’autorità, e per
un’infinità aperta di altri possibili impieghi. Le immagini bastano a se stesse,
ma sono strumenti che usiamo nel mondo per agire sul mondo in una qualche forma
determinata, ed è per questo che parlare
della centralità del nesso di denotazione non è soltanto sbagliato, ma è anche
fortemente riduttivo poiché è davvero ben raro che le immagini si usino per indicare
un oggetto.
Su tutti questi problemi
dovremo in seguito soffermarci. Ora tuttavia il tema che dobbiamo sottolineare
è un altro: dobbiamo cercare di comprendere meglio la tesi secondo la quale
un’immagine può guadagnare una relazione, in senso lato, denotativa perché è
uno strumento che può essere usato per rimandare ad altro. Uno strumento
appunto: sostenere che le raffigurazioni ci parlano di qualcosa di altro da sé
perché possiamo usarle così vuol dire fin da subito richiamare l’attenzione
sulla specificità della loro natura, sul loro contenuto propriamente intuitivo.
Uno strumento non può essere usato in qualunque modo, poiché le possibilità del
suo impiego sono in linea di principio circoscritte dalla determinatezza della
sua forma. Possiamo usare un cacciavite per rinsaldare una vite o per scalzare
un chiodo, e nell’uno e nell’altro caso ci avvarremo del fatto che un
cacciavite è un’asta di metallo con un filetto.
Ma proprio questa forma che
consente una molteplicità di usi ne vieta infiniti altri: la cassetta degli
attrezzi non può contenere un solo strumento perché la forma di un utensile
dipende banalmente dalla funzione cui deve far fronte. E ciò che è vero per un
cacciavite o per un martello vale anche per un’immagine: anche in questo caso
le diverse possibilità di impiego di un’immagine vincolano la sua forma ad una
serie di imperativi ipotetici. Possiamo usare un ritratto per ricordarci di una
persona cara solo se ci è facile riconoscerla in ciò che vediamo sulla
tela, proprio come possiamo comprendere la funzione di protezione che i leoni
scolpiti sulla porta di Micene esercitavano solo perché sappiamo ritrovare in
quei tratti la forza maestosa di un animale terribile.
Di qui possiamo trarre una conclusione importante: proprio perché le immagini sono oggetti importanti e proprio perché esercitano una molteplicità di funzioni, dobbiamo chiederci quali siano le richieste cui la loro forma deve poter far fronte. La forma deve poter garantire la possibilità dell’uso, e nel caso delle immagini ciò ci riconduce ad una prima richiesta di carattere generale: le immagini debbono essere tali da garantire la possibilità di un riconoscimento.
Ne consegue che dire che le immagini bastano a se stesse si rivela così non come un modo per negare che le immagini possano assolvere molte funzioni e che, tra queste, un posto significativo spetti a quelle immagini che si riferiscono in vario modo al mondo delle cose e degli eventi reali, ma come un motto che intende rammentare che in ogni immagine dobbiamo poter riconoscere qualcosa, poiché questa è la condizione cui è vincolata la sensatezza di ogni suo possibile uso.
2. Raffigurazioni e carte geografiche
Nell’ora precedente abbiamo pronunciato sottovoce una conclusione importante: abbiamo esplicitamente preso le distanze dal cuore dell’ipotesi di Goodman e abbiamo sostenuto che le raffigurazioni non soltanto non hanno necessariamente una funzione denotativa, ma sono caratterizzate da una forma che, lungi dall’essere meramente convenzionale, è determinata dalle funzioni cui ogni immagine può assolvere, una volta che sia divenuta per noi il luogo di un riconoscimento.
Le immagini ci fanno vedere qualcosa e non sono segni che rimandino ad altro — non lo sono mai, anche se possiamo usarle per celebrare, per ricordare o per sapere qualcosa di più di una persona, come accade nei ritratti.
Su questo punto è opportuno riflettere, per non cadere in un possibile fraintendimento. Quale sia il fraintendimento è presto detto: si potrebbe infatti credere che le raffigurazioni siano talvolta segni, simili a ciò che raffigurano.
Non credo che le cose stiano così, e per farlo vorrei invitarvi a riflettere un poco sulla natura di una figura di confine tra ciò che è segno e ciò che è raffigurazione: le carte geografiche. Che normalmente si tracci una qualche differenza tra una carta geografica e una raffigurazione pittorica in senso stretto è appena il caso di dirlo; la Veduta di Delft di Vermeer è una raffigurazione, mentre non lo è una qualsiasi mappa di Delft — o almeno, questo è quello che diremmo se qualcuno ce lo chiedesse, prima di ogni ulteriore considerazione filosofica:
|
|
|
Una qualche differenza vi è, e tuttavia non è difficile comprendere perché le carte geografiche possano qualche volta finire sulle pareti delle nostre case, come se fossero un quadro. Le carte geografiche hanno, per così dire, una loro tendenza alla figuratività che ci consente di riconoscere nella forma delle linee tracciate in scala il percorso reale delle vie e delle piazze che conosciamo.
Di questa vicinanza tra le immagini e la carte geografiche ci si può rendere conto rammentando un proprietà che per Schier caratterizza i sistemi iconici: la «generatività naturale» dell’interpretazione dei segni pittorici. Le immagini, avevamo osservato, sono fatte così: se hai acquisito una certa pratica in uno stile figurativo non hai bisogno del vocabolario per riconoscere ciò che le immagini di volta in volta ti presentano anche se non le hai viste prima poiché l’interpretazione dell’immagine si genera naturalmente. Insomma: se sai come Caravaggio dipinge e se hai già visto i frutti della vite, non avrai alcuna difficoltà a riconoscere che ciò che vedi sono grappoli d’uva e foglie in un canestro — l’interpretazione sorge appunto naturalmente e non vi è bisogno che nessuno ci dica quale convenzione dobbiamo stipulare per vedere ciò che così chiaramente scorgiamo.
Ora, un simile criterio sembra almeno in parte valere anche per le carte geografiche, poiché se ho imparato a riconoscere una piazza in una mappa, saprò poi riconoscere senza ulteriori spiegazioni che cosa è segno di un viottolo, di una strada, di uno slargo o di un incrocio. Così, se mi mostri dov’è il nord, saprò dirti qual è l’orientamento della costa e mi basta guardare la scala in calce alla mappa per saperti dire quanto è vasto un mare e quanto è sottile il lembo di terra di un istmo: un’interpretazione genera l’altra secondo una regola che si illustra esemplarmente nelle prime mappe che ci vengono presentate e che poi ci accompagna in ogni nostro avere a che fare con una carta geografica. Una carta geografica descrive la realtà in modo intuitivo proprio come fa un quadro, e forse è proprio questo il motivo che spinge Vermeer a porre così di frequente nei suoi quadri una carta geografica appesa ad una parete o aperta su un tavolo: il compito del pittore e il lavoro del geografo sono accomunati da un’identica passione descrittiva. Il pittore narra, ma soprattutto descrive, ed è per questo che (lo nota Svetlana Alpers) nell’Arte della pittura Vermeer rappresenta una fanciulla con in mano un libro di Tucidide (la narrazione), ma sullo sfondo pone una grande carta geografica dell’Olanda, su cui campeggia la scritta latina «Descriptio». Questo appunto Vermeer, ma le ragioni che lo spingono ad accostare le une alle altre le rappresentazioni pittoriche e le carte geografiche non sono un argomento sufficiente per cancellare la sensazione che qualcosa comunque le distingua. Goodman, come sappiamo ha una sua risposta a questa domanda: la differenza tra un disegno ed una carta geografica dipende dal grado di saturazione del segno, dal suo essere più o meno impegnato nella sua dimensione fenomenica dal compito del rimando figurativo. Non credo che questa via sia percorribile e non soltanto perché poggia sulla riconduzione dell’immagine alla sua funzione denotativa, ma anche perché ci costringe ad annoverare tra i grafici i disegni infantili (in cui il segno è relativamente insaturo) e tra le raffigurazioni un grafico in cui si convenisse che ad avere un valore simbolico non sia soltanto l’andamento della linea rispetto alle ascisse e alle ordinate, ma anche il variare del colore e dello spessore apparente del tratto.
Non credo che sia opportuno pagare questo prezzo e del resto credo che vi sia un modo per venire a capo della distinzione che ci sta a cuore che non ci costringe a modificare la grammatica dei nostri concetti e che è strettamente coerente con le conclusioni cui siamo dianzi giunti. La distinzione tra una carta geografica e una raffigurazione non chiama in causa la natura del segno e la sua relativa saturazione, ma non si fonda nemmeno sul criterio della «natural generativity»: se una carta geografica deve essere distinta da una raffigurazione pittorica è perché soltanto la prima, ma non la seconda è necessariamente connessa in un’applicazione possibile ad un oggetto determinato. Una raffigurazione basta a se stessa poiché ci mostra ciò che c’è da vedere, anche se poi una determinata regola d’uso ci invita a fare della percezione che quell’immagine ci porge un mezzo per celebrare o per ricordare una persona realmente esistita. In un ritratto di Tiziano, vediamo Pietro Bembo dipinto, e quest’immagine che abbiamo di fronte agli occhi può servirci per ricordarci che vi è stato davvero chi nel 1505 ha pubblicato gli Asolani: ma un vecchio dipinto lo vediamo comunque, se solo sappiamo riconoscerlo nei tratti del quadro che Tiziano ci porge.
Nel caso di una carta geografica le cose stanno diversamente: in questo caso non è affatto necessario che, per esempio, la città di Delft si scorga disegnata nella mappa, poiché ciò che attribuisce un significato ai segni che la compongono non è il farsi avanti di un riconoscimento percettivo, ma la presenza di una regola di proiezione che ci dice come l’immagine possa toccare la realtà, per descriverla. Una carta geografica può essere più o meno caratterizzata da dettagli figurativi, e la mappa di Delft di cui discorriamo è evidentemente ricca di elementi pittorici che la rendono assai simile a un quadro. La differenza tuttavia permane ed è una differenza di carattere strutturale che si manifesta con chiarezza non appena riflettiamo sul fatto che una carta geografica, proprio perché trae la sua sensatezza da una regola di proiezione che fa dei tratti di cui consta segni dotati di un valore descrittivo, dipende da una regola di proiezione convenzionale che potrebbe essere interamente mutata. Così, è utile che in una carta geografica i mari siano segnati in azzurro e le pianure in verde, ma nulla ci costringe a fare così — nulla se non una convenzione tacita, che potrebbe essere comunque sostituita da un’altra: in una carta geografica non si deve vedere ciò che in essa si rappresenta (anche se può accadere), poiché il senso di una mappa è insito soltanto nella sua applicazione. Comprendere una mappa vuol dire sapere come è fatto il mondo (una sua parte) se essa è affidabile, e ciò implica che insieme al disegno del cartografo ci deve essere data la regola di proiezione che ci consente di applicarlo al mondo. Così, anche se questo non significa che una carta geografica debba necessariamente avere qualcosa che nella realtà le corrisponde, è egualmente vero che la sua condizione di sensatezza fa tutt’uno con l’esistenza di una regola che determina il modo della sua possibile applicazione alla realtà.
Ma appunto, nel caso di un quadro le cose non stanno così: una raffigurazione basta a se stessa e quando guardiamo la Veduta di Delft di Vermeer non abbiamo bisogno di conoscere nessuna regola di proiezione poiché in questo caso non vi è davvero nessun bisogno di applicare l’immagine alla realtà. Ciò che vediamo ci basta: nel quadro di Vermeer vediamo, dipinta, la città di Delft, così come si mostra a chi la guardi al di là del canale, di fronte alle due porte della città. Certo, nessuno ci vieta di utilizzare la Veduta di Vermeer come se fosse una carta geografica: farlo, tuttavia, significa solo supporre l’esistenza di una relazione di proiezione che consente di fare delle scene dipinte segni di una realtà che è sita di là da essi. E poiché una relazione di proiezione è comunque espressione di una regola che potrebbe essere diversamente formulata, della Veduta di Delft si dovrebbe parlare così — come di una tra le molte rappresentazioni equivalenti di un determinato stato di cose. Se invece quella Veduta ci sembra unica è perché il suo senso è tutto racchiuso nella sua datità percettiva: nel suo proporci una percezione determinata — la visione, secondo un taglio prospettico, della città di Delft dipinta.
Forse, a partire di qui, la differenza tra una carta geografica ed una raffigurazione pittorica può essere colta con relativa chiarezza. Si tratta, certo, di una distinzione sottile poiché — come abbiamo osservato — è in linea di principio possibile che anche una raffigurazione come la Veduta di Delft valga per noi come una carta geografica: in questo caso, tuttavia, non saremo più invitati ad un riconoscimento percettivo sia pure generico (non cercheremo di vedere sulla tela una città dipinta che si affaccia su un canale), ma dovremo cercare di cogliere in ciò che ci è dato il mezzo che, sul fondamento di una regola di proiezione, ci consente di anticipare la configurazione di una parte del mondo. In questo diverso orientamento rispetto al reale, la carta geografica assume di fatto la forma di segno che le compete: se deve parlarci del mondo e deve consentirci di sapere come stiano le cose se è vera, allora il suo aspetto fenomenico dovrà essere interpretabile esclusivamente in relazione alla regola che ci consente di proiettare la mappa sulla parte di mondo che in essa si raffigura. Ogni tratto della mappa che non cada sotto la regola di proiezione sarà semplicemente priva di senso, poiché nulla nell’aspetto di una carta geografica ha senso di per sé, per la sua dimensione fenomenica: così, il diverso azzurro dei mari in una pagina dell’atlante non ci invita a cogliere una diversità dell’apparire che abbiamo appreso dal mondo, ma ci parla della profondità che spetta alle acque, e ce ne parla in virtù di una regola che potrebbe essere riformulata, cancellando ogni generico rimando alla figuratività. Ben diversamente stanno le cose sul piano delle immagini: qui non vi è una regola di proiezione che ci dica come dobbiamo procedere per attribuire un senso al segno — vi è, invece, un riconoscimento percettivo che attribuisce alla scena una sua visibile sensatezza. Il vettore che unisce il mondo alla rappresentazione è mutato di segno; non abbiamo più un segno che debba essere proiettato sul mondo, per descriverlo, ma una scena che sa mostrarci uomini e paesaggi dipinti perché l’eco del mondo che anima le nostre percezioni ci consente di riconoscere queste e altre cose in ciò che la tela ci mostra. Alla regola di proiezione che ci guida dalla mappa a ciò di cui essa ci parla si sostituisce così la prassi del riconoscimento percettivo che ci consente di ritrovare in un quadro ciò che sappiamo e di farcelo vedere esemplarmente in scena.
Di qui, da queste riflessioni sul discrimine che separa le immagini dalle mappe, siamo ricondotti ad una riflessione più generale sulla nozione di riconoscimento, su quella forma della nostra esperienza percettiva che sa far risuonare la scena presente dell’eco più o meno remota del mondo[5].
Lezione sesta
1. Il riconoscimento: una prassi dinamica
Nella lezione precedente siamo giunti a formulare una conclusione importante: abbiamo infatti sostenuto che le raffigurazioni non sono segni che rimandino ad altro, ma oggetti che chiedono di essere guardati e che sanno mostrarci qualcosa — una persona, un paesaggio, un evento. Lo spazio figurativo è dunque il luogo di un riconoscimento, ed è proprio questa prima definizione cui siamo così faticosamente giunti a porci una serie di domande che dobbiamo dapprima formulare per poi tentare una risposta.
Venire a capo delle difficoltà che questa definizione implica vuol dire riflettere su come sia possibile riconoscere in un disegno ciò che in esso si raffigura. Non è facile comprendere come ciò accada per molte e diverse ragioni, che tuttavia alludono infine ad un identico nodo: crediamo di sapere bene che cosa voglia dire riconoscere la via che ci conduce a casa, ma ci sembra molto più difficile comprendere che cosa voglia dire riconoscere un volto in un intreccio di linee che forse suggeriscono solo a fatica ciò che comunque pretendiamo di vedere. Un bambino ci porge un foglio e noi vediamo che vi è disegnato un uomo con in testa una corona. Lo vediamo, appunto, e ciò significa che sappiamo vedere e riconoscere in quei pochi tratti che la matita ha lasciato sul foglio una figura relativamente complessa. Qui una difficoltà si lega all’altra, perché non soltanto ci sembra difficile capire come si possa vedere qualcosa in un disegno, ma anche perché in questo caso le informazioni che si danno allo sguardo sembrano essere davvero troppo scarne per trarre una qualsiasi conclusione. Eppure: nel disegno di un bambino di norma vediamo proprio ciò che dobbiamo vedere e anche se l’immagine non ha pretese illusionistiche riconosciamo senza difficoltà ciò che ci viene mostrato. Ora, ciò che accade quando abbiamo a che fare con il disegno di un bambino vale anche in molti altri casi. Nel caso delle caricature, per esempio. Le caricature si fanno così: storpiando ad arte le proporzioni di un volto, ingigantendone una parte o modificandola secondo una direzione ritenuta significativa per l’immaginazione. Trasformiamo il volto in una maschera dai lineamenti deformati, e tuttavia riconosciamo l’uno e l’altra come raffigurazioni di un volto umano. O di un determinato volto: la caricatura è un genere che spesso chiede di essere riferito ad un individuo determinato e ciò rende ancor più complessa l’opera di riconoscimento che per esempio ha luogo quando osserviamo il ritratto di una persona nota. La caricatura deforma e distorce, ma non per questo il risultato ci sfugge: vediamo senza difficoltà chi sia il soggetto della caricatura e ci sembra ovvio che sia così — anche se forse dovremmo stupirci di quante cose sanno fare gli occhi.
Di qui il primo dubbio che sembra necessario avanzare: possiamo dire davvero che vediamo e riconosciamo ciò che un’immagine ci presenta? Non sarebbe più opportuno sostenere che siamo stati addestrati a interpretare così quei pochi segni che propriamente vediamo e che assumono un senso solo perché l’abitudine consente di proiettare ciò che sappiamo su ciò che ci è dato?
Per rispondere almeno parzialmente a questa domanda dobbiamo addentrarci almeno un poco nella natura del riconoscimento per cercare di comprendere che cosa possa significare sostenere che il vedere si intreccia con l’esperienza passata. Ora, che questo accada è indiscutibile: non vi è dubbio, infatti, che la capacità di riconoscere forme, luoghi e persone sia di estrema importanza per la vita, e noi condividiamo questo sapere sensibile con moltissimi animali che, come noi, non hanno difficoltà a riconoscere la tipicità di certe situazioni e l’individualità di certi luoghi e di certe persone. Ciò che ieri abbiamo appreso deve valere per oggi, e la capacità di riconoscere è una delle forme che ci consentono di adattare il presente al passato, superando ciò che li distingue l’uno dall’altro. Non vi è nulla che si ripeta nello stesso identico modo ed è per questo che la capacità di riconoscere implica sempre la capacità di chiudere gli occhi sulle differenze per rivolgerli a ciò che permane.
Su questa caratteristica di fondo del riconoscimento è opportuno insistere: il riconoscimento non implica soltanto l’identità, ma anche il superamento di una differenza, di un altrimenti di cui dobbiamo avere ragione. Quest’ordine di considerazioni vale, in qualche misura, anche quando abbiamo a che fare con una percezione ininterrotta di uno stesso oggetto: se osserviamo un uccello che vola nel cielo permanenza e cambiamento si intrecciano l’uno con l’altra, ma la continuità del processo rende non problematica la posizione di identità — ciò che osserviamo è sempre lo stesso oggetto, e se di un riconoscimento si può parlare è solo per sottolineare che da un lato la percezione persiste nella posizione di un medesimo referente oggettuale e che, dall’altro, insieme al tempo possono mutare altre cose — muta, per esempio, la posizione di un oggetto di cui seguiamo la traiettoria nel cielo. In questo caso il riconoscimento si gioca prevalentemente sul terreno della passività e non sembra esservi uno spazio significativo (se davvero vi è) per il rimando all’esperienza passata: se vediamo un identico oggetto è perché vi sono condizioni fenomenologiche che determinano la forma della nostra percezione e che connettono le sue fasi nell’unità di un decorso che ha di mira uno stesso oggetto.
Diverso almeno in parte è il caso in cui l’identità non è mantenuta nell’unità di un processo, ma è riguadagnata superando un ostacolo. In questo caso comprendiamo bene perché si possa sostenere che il riconoscimento è una funzione dinamica, e che il suo dinamismo si esercita in misura variabile nel suo venire a capo di differenti indici di mutamento. Riconosciamo una persona quando la ritroviamo in un differente contesto: il riconoscimento è dinamico rispetto al cambiamento di luogo, e lo stupore che ci coglie quando ritroviamo una persona in un posto che solitamente non le appartiene è insieme misura della sollecitazione cui la prassi del riconoscere è stata sottoposta. Ma il riconoscimento è dinamico anche rispetto al tempo: possiamo riconoscere dopo anni una città che avevamo un tempo visitato e la memoria dei luoghi può accompagnarsi al silenzio effettivo dei ricordi — riconosciamo le strade e le piazze, anche se non ci ricordiamo più di quando le abbiamo percorse. E talvolta col passare del tempo mutano anche le forme, ed anche in questo caso il riconoscimento ha una sua dinamicità: scorgiamo nella folla un vecchio compagno di scuola e ci riconosciamo a vicenda, anche se il tempo ha disegnato una duplice caricatura sotto la quale non è poi così facile vedere ciò che conserviamo nella memoria.
Ora, gli indici di variazione rispetto ai quali il riconoscimento visivo si rivela dinamico sono molteplici, così come mutevole è il grado di variazione che può essere tollerato da noi uomini, e anche soltanto la possibilità (che pure ci sembra così banale) di riconoscere un albero o un frutto in una fotografia in bianco e nero potrebbe mostrarci quali e quanto sensibili siano le direzioni di variazione che il riconoscimento tollera. Di qui dunque un compito che sembrerebbe necessario porsi in via preliminare: prima ancora di riflettere sulle ragioni che ci spingono a ricondurre il vedere ciò che si dà in un’immagine sotto il titolo generale del riconoscere e prima ancora di soffermarci sulle diverse forme in cui di un riconoscere si può comunque parlare dovremmo chiederci quali siano, in linea di principio, le condizioni cui una raffigurazione deve far fronte per consentirci di vedere ciò che in essa prende forma. Il riconoscimento visivo è dinamico, ma ha limiti che variano da specie a specie, e quindi ha senso domandarsi quali siano i limiti empirici entro cui è possibile un riconoscimento e quindi una raffigurazione. Questa domanda ha senso e dovremmo preliminarmente porcela se fossimo degli psicologi: una risposta effettiva passa infatti attraverso riflessioni di natura psicologica e non può essere in nessun modo affrontata e risolta se non disponendosi sul terreno delle indagini sperimentali. Quali siano i meccanismi della visione, come operi il sistema percettivo, quali siano le procedure computazionali che ci permettono di trasformare le informazioni raccolte dai nostri organi di senso nel mondo stabile in cui siamo e ci muoviamo — tutto questo è argomento di indagine empirica ed è, come tale, sito al di là delle pretese legittime della filosofia.
Così, piuttosto che addentarmi in un terreno che non mi spetta, vorrei invitarvi ad osservare che la tesi secondo la quale il riconoscimento ha natura dinamica si lega ad una considerazione importante: proprio perché il riconoscimento implica un vedere la somiglianza al di là degli ostacoli che possono renderla non immediatamente evidente, ha senso affermare che al riconoscere si lega una prassi cui possiamo essere addestrati e che possiamo apprendere. Per me le formiche sono tutte eguali, ed anche se dubito che abbiano una spiccata individualità è possibile imparare a coglierne le differenze di specie. Che ci piaccia o no, sulla tovaglia del pic-nic è possibile allenarsi a distinguere la Crematogaster scutellaris dalla Tapinoma nigerrimum e dalla Tetramorium caespitum.
Del resto, comunque stiano le cose con questi insetti, è un fatto che il tempo ci insegna a cogliere le differenze e a vedere aspetti che dapprima ci sembravano invisibili. Non si potrebbe sostenere allora che la nostra percezione, quando è sotto la presa del riconoscimento, si libera dalla morsa della passività per assumere la forma di un’interpretazione dei dati sensibili, che si lascia guidare da ciò che la cultura e le tradizioni sanno insegnarci? Riuscire a vedere un re con la corona nelle poche linee del disegno di un bambino non sarebbe soltanto una manifestazione di affetto, ma anche il risultato cui ci conduce un addestramento complesso che sa indicare la via che dal sapere conduce al vedere.
Non credo di dire nulla di inatteso se vi invito a rifiutare un simile modo di porre le cose. Certo, il riconoscimento può implicare una prassi, ma questo non significa ancora che si possa vedere ciò che si vuole o che il risultato cui la percezione conduce sia nelle nostre mani: potrebbe infatti significare soltanto che possiamo imparare a comportarci nel modo migliore perché non ci sfugga ciò che è possibile cogliere.
Si tratta di un’affermazione che può sembrarci di primo acchito oscura, ma io credo che sia necessario esprimerci così: tutti sappiamo che non si può vedere ciò che si vuole, e che nella percezione c’è un elemento di passività di cui non si può non rendere conto e che può essere espresso in modo soddisfacente osservando che il mio vedere è qualcosa che si dà e che posso fare molte cose che mi mettano nella condizione di vedere, ma non ne posso fare alcuna che abbia come suo esito l’inscenarsi di ciò che semplicemente desidererei percepire. Che io veda questo quest’altro non dipende da me poiché è qualcosa che accade o non accade, non qualcosa che faccio o che non faccio. Nella figura di Boring posso cercare di vedere il volto di una vecchia o la figura di una giovane donna, ma non basta voler vedere l’una o l’altra di queste immagini per poterla vedere: che ci riesca o che non ci riesca non dipende da me. Così, per quanti legami possa stringere con la prassi, il vedere non ne è il risultato: il vedere è e resta uno stato il cui effettivo presentarsi non dipende da noi. Ma ciò è ancora una volta quanto dire che il vedere non è una questione di gusti e che il riconoscimento percettivo può implicare un processo di apprendimento ma non coincide con esso.
 Da
queste strane considerazioni che ci hanno insensibilmente condotto dalle
formiche alle immagini possiamo trarre qualche insegnamento che ci aiuti a
sciogliere i problemi che abbiamo lasciato insoluti nella precedente lezione.
In modo particolare possiamo ricavare una prima delimitazione del senso che
deve essere attribuito al nesso che lega la percezione delle raffigurazioni al
costituirsi di una competenza pittorica. Questo nesso non può essere lasciato
nel vago e non è possibile renderne conto facendosi guidare ora dalle tesi di
una filosofia convenzionalistica che dissolva la specificità materiale della
percezione nel gioco soggettivistico della storicità e della cultura, ora dal
richiamo piuttosto vago alla naturalità del sapere visivo. Per cogliere il
nesso che lega la percezione all’apprendimento dobbiamo comprendere in che
senso la percezione visiva, e più propriamente il riconoscimento visivo, siano
connessi ad una prassi che possiamo seguire. Questo è quello che si può
culturalmente apprendere: si può imparare a seguire una prassi. Non possiamo
invece, in senso stretto, imparare a vedere, più di quanto si possa imparare
ad assimilare i carboidrati: li assimiliamo, punto e basta. Ed uno stesso
discorso deve valere anche per le immagini: se in un quadro vediamo qualcosa
non può dipendere da noi, anche se — paradossalmente — può essere colpa nostra
se non riusciamo a vedere ciò che pure potremmo scorgere se sapessimo rivolgere
diversamente lo sguardo.
Da
queste strane considerazioni che ci hanno insensibilmente condotto dalle
formiche alle immagini possiamo trarre qualche insegnamento che ci aiuti a
sciogliere i problemi che abbiamo lasciato insoluti nella precedente lezione.
In modo particolare possiamo ricavare una prima delimitazione del senso che
deve essere attribuito al nesso che lega la percezione delle raffigurazioni al
costituirsi di una competenza pittorica. Questo nesso non può essere lasciato
nel vago e non è possibile renderne conto facendosi guidare ora dalle tesi di
una filosofia convenzionalistica che dissolva la specificità materiale della
percezione nel gioco soggettivistico della storicità e della cultura, ora dal
richiamo piuttosto vago alla naturalità del sapere visivo. Per cogliere il
nesso che lega la percezione all’apprendimento dobbiamo comprendere in che
senso la percezione visiva, e più propriamente il riconoscimento visivo, siano
connessi ad una prassi che possiamo seguire. Questo è quello che si può
culturalmente apprendere: si può imparare a seguire una prassi. Non possiamo
invece, in senso stretto, imparare a vedere, più di quanto si possa imparare
ad assimilare i carboidrati: li assimiliamo, punto e basta. Ed uno stesso
discorso deve valere anche per le immagini: se in un quadro vediamo qualcosa
non può dipendere da noi, anche se — paradossalmente — può essere colpa nostra
se non riusciamo a vedere ciò che pure potremmo scorgere se sapessimo rivolgere
diversamente lo sguardo.
Credo sia questo il punto su cui dobbiamo riflettere per rispondere alla domanda che ci eravamo posti, e per farlo dobbiamo ancora una volta rammentare che le raffigurazioni implicano un riconoscimento: per poter dire di aver colto un’immagine dobbiamo riuscire a vedere nelle linee e nei colori sulla tela il volto, la vicenda o il paesaggio che essa ospita. Ma appunto: ogni riconoscimento è dinamico e ciò consente all’immagine di essere in qualche misura e sotto qualche riguardo diversa da ciò che raffigura. Sulla diversità più consistente e ovvia dovremo in seguito tornare: per vedere in un ritratto un volto è necessario che il riconoscimento sia dinamico rispetto alla raffigurazione stessa — alla differenza che separa un volto vero e proprio da ciò che scorgiamo sulla superficie della tela. Gli uomini, in generale, sono capaci di compiere quest’operazione senza alcuno sforzo e sin da quando sono molto piccoli, e vi sono varie evidenze empiriche che suggeriscono che questa capacità sia semplicemente innata. Su questo punto, come ho detto, torneremo: ora vorrei invece attirare l’attenzione sul fatto che ogni stile pittorico mette alla prova in modo diverso la nostra capacità di riconoscimento e ne saggia in modo diverso il dinamismo. Ma ciò è quanto dire: ogni stile pittorico ci propone una differente prassi percettiva che dobbiamo seguire ed eventualmente apprendere, se vogliamo scorgere il senso della raffigurazione che abbiamo sotto ai nostri occhi.
Che cosa voglia concretamente dire imparare ad apprendere un comportamento percettivo lo si può mostrare immergendoci rapidamente sul terreno degli esempi. Ci sono quadri in cui è solo la grandezza dell’immagine a indicarci la distanza da cui dobbiamo osservarli; ve ne sono altri, invece, che sono dipinti con una tecnica che ci vieta uno sguardo troppo ravvicinato: la funzione del riconoscimento ha così, come suo postulato, il nostro saper scegliere la giusta distanza — quella che determina il comporsi delle macchie di colore nel gioco misurato delle superfici e delle profondità. Ai comportamenti motori possono tuttavia affiancarsi comportamenti in senso stretto percettivi. Talvolta riconoscere significa sapere già quale senso spetta a determinate scelte pittoriche. Un corpo ha una sua struttura di adombramento: ci si dà percettivamente insieme alle ombre proprie in cui si annuncia la sua tridimensionalità. Sulla tela le ombre possono tuttavia assumere le forme più varie, ed anche se non credo che tra le molte tecniche cui la storia della pittura ci ha abituato ve ne siano alcune che non godano di una loro peculiare immediatezza, è tuttavia possibile che, abituati a scorgere l’ombreggiatura in un reticolo regolare di linee, si faccia poi fatica a ritrovarla nel suo schematizzarsi in una diversa forma intuitiva. Può allora farsi avanti ciò che la competenza pittorica ha da dirci: se vuoi riconoscere ciò che l’immagine ti porge, prova a guardare a quel gioco di colori come ad un modo per rendere le ombre proprie degli oggetti, i loro molteplici adombramenti, la loro corposa volumetria. Una raffigurazione di questo tipo bisogna guardarla così, anche se è opportuno ripetere ancora una volta che non basta obbedire a un precetto per riuscire a vedere, perché il vedere, a dispetto della sua forma verbale, non è affatto un’azione che sia in nostro potere compiere.
2. La forma obiettiva, gli aspetti, la competenza pittorica
Nell’ora precedente la nozione di competenza pittorica ha cominciato ad assumere un contorno più definito e si è venuta stringendo alla prassi che rende possibile il riconoscimento nell’immagine. In modo particolare, ci eravamo soffermati su un punto: avevamo infatti osservato che non è banale che si dia un riconoscimento, e che la necessità del rimando alle diverse forme della competenza pittorica è appunto un segno del fatto che è talvolta necessario vincolare il nostro comportamento percettivo ad un insieme di regole che gli diano una direzione particolare — quella che rende effettivamente afferrabile il senso dell’immagine.
 Si
tratta di una conclusione che mi sembra valida, ma che non è tuttavia
sufficiente per venire interamente a capo del nostro problema e questo
perché le raffigurazioni non sono soltanto diverse da ciò che pure ci
consentono di riconoscere, ma contengono talvolta elementi fenomenici che
sembrano dover suggerire una differente interpretazione percettiva. Un esempio
può chiarire ciò che intendo dire: in questo salterio, vediamo un palazzo con
un grande portale, e per i fedeli di un tempo le figure dipinte erano di per sé
sufficienti per narrare una storia — l’uomo in groppa all’asino è Balaam e davanti
a lui vi è l’angelo che, con la spada sguainata, spiega prima il senso degli
strani incidenti che l’animale che gli fa da cavalcatura ha sofferto nel
viaggio e poi gli intima di fermarsi, e di non prestarsi a maledire il popolo
di Israele. Naturalmente dobbiamo già conoscere questa storia se vogliamo
ritrovarla nelle poche cose che questa raffigurazione ci mostra, e tuttavia è
già degno di nota che sia possibile riuscire a vederla ambientata in modo
plausibile, anche se uomini, animali e palazzi sembrano contendersi e negarsi
il sostegno che potrebbe offrire loro l’esigua striscia di terra che fa da orizzonte.
Se guardiamo con attenzione l’immagine, forse non sapremo dire con precisione
come si collochino nello spazio i personaggi di questo racconto e in
particolare è difficile dire se l’angelo sia dietro o davanti all’asino, ma
questo fatto non sembra turbarci: lo sguardo non si lascia intimorire da queste
domande e si preoccupa di altre cose. Importante è che la spada dell’angelo sia
davanti al corteo e che l’asino si volga verso Balaam come a dire «e io che
avevo cercato di dirtelo in tutti i modi!»: questo è importante vedere e questo
vediamo, quasi che la competenza pittorica ci consenta di cogliere l’immagine
al di là dei suoi stessi “errori” e delle imprecisioni che la caratterizzano.
Lo stesso accade quando guardiamo il disegno di un bambino: vi sono figure
accostate le une alle altre ma noi le vediamo proprio come il bambino
voleva che le vedessimo: da una parte vi è la porta di casa, dall’altra la
parete con la finestra e ciò che sulla carta poggia su un’unica linea si deve
vedere come se si disponesse su diversi piani, su diverse profondità. Noi vediamo
così, ed è quasi come se la competenza pittorica si sostituisse qui alla
fenomenicità della raffigurazione per correggerne il senso — un compito,
questo, che non sembrava affatto possibile assegnarle sulla base delle considerazioni
che avevamo dianzi proposto.
Si
tratta di una conclusione che mi sembra valida, ma che non è tuttavia
sufficiente per venire interamente a capo del nostro problema e questo
perché le raffigurazioni non sono soltanto diverse da ciò che pure ci
consentono di riconoscere, ma contengono talvolta elementi fenomenici che
sembrano dover suggerire una differente interpretazione percettiva. Un esempio
può chiarire ciò che intendo dire: in questo salterio, vediamo un palazzo con
un grande portale, e per i fedeli di un tempo le figure dipinte erano di per sé
sufficienti per narrare una storia — l’uomo in groppa all’asino è Balaam e davanti
a lui vi è l’angelo che, con la spada sguainata, spiega prima il senso degli
strani incidenti che l’animale che gli fa da cavalcatura ha sofferto nel
viaggio e poi gli intima di fermarsi, e di non prestarsi a maledire il popolo
di Israele. Naturalmente dobbiamo già conoscere questa storia se vogliamo
ritrovarla nelle poche cose che questa raffigurazione ci mostra, e tuttavia è
già degno di nota che sia possibile riuscire a vederla ambientata in modo
plausibile, anche se uomini, animali e palazzi sembrano contendersi e negarsi
il sostegno che potrebbe offrire loro l’esigua striscia di terra che fa da orizzonte.
Se guardiamo con attenzione l’immagine, forse non sapremo dire con precisione
come si collochino nello spazio i personaggi di questo racconto e in
particolare è difficile dire se l’angelo sia dietro o davanti all’asino, ma
questo fatto non sembra turbarci: lo sguardo non si lascia intimorire da queste
domande e si preoccupa di altre cose. Importante è che la spada dell’angelo sia
davanti al corteo e che l’asino si volga verso Balaam come a dire «e io che
avevo cercato di dirtelo in tutti i modi!»: questo è importante vedere e questo
vediamo, quasi che la competenza pittorica ci consenta di cogliere l’immagine
al di là dei suoi stessi “errori” e delle imprecisioni che la caratterizzano.
Lo stesso accade quando guardiamo il disegno di un bambino: vi sono figure
accostate le une alle altre ma noi le vediamo proprio come il bambino
voleva che le vedessimo: da una parte vi è la porta di casa, dall’altra la
parete con la finestra e ciò che sulla carta poggia su un’unica linea si deve
vedere come se si disponesse su diversi piani, su diverse profondità. Noi vediamo
così, ed è quasi come se la competenza pittorica si sostituisse qui alla
fenomenicità della raffigurazione per correggerne il senso — un compito,
questo, che non sembrava affatto possibile assegnarle sulla base delle considerazioni
che avevamo dianzi proposto.
Non credo che sia necessario correggere radicalmente la conclusione cui eravamo dianzi giunti, e tuttavia il problema in cui ci siamo ora imbattuti ci costringe a procedere con cautela e a rammentarci di un fatto che rende problematico il riconoscimento nell’immagine: una raffigurazione non può semplicemente restituirci la forma obiettiva delle cose — quella forma tridimensionale e priva di un riferimento ad un punto di vista che si costituisce nell’unità dei nostri decorsi percettivi — ma deve trovare un modo (che resta comunque parzialmente insoddisfacente) per renderla visibile sulla superficie pittorica. Qualunque sia la nostra capacità di disegnare e qualunque sia lo strumento di cui avvaliamo per creare una raffigurazione — una matita, un pennello o una macchina fotografica — vi è in ogni caso una qualche regola che guida il nostro trasporre le cose e le persone che si danno nella nostra esperienza visiva nelle cose e nelle persone che raffiguriamo su un piano. Richiamare l’attenzione sulla presenza di queste regole vuol dire allora affermare che ogni raffigurazione si avvale di forme che ci consentono di vedere e riconoscere qualcosa che tuttavia non può nella sua interezza farsi avanti nello spazio figurativo che lo ospita. La raffigurazione è una procedura operativa che deve comunque fare delle rinunce e che si avvale di schemi intuitivi, e uno schema intuitivo è una regola che ci consente di tradurre parzialmente una forma obiettiva in una forma visibile — una regola in cui considerazioni fenomenologiche e vincoli stilistici si legano secondo una modalità che dobbiamo comprendere meglio.
Ora, per capire quali siano le ragioni che ci hanno spinto a sottolineare i limiti che ineriscono ad ogni raffigurazione dobbiamo spingerci al di qua delle immagini: dobbiamo infatti chiederci che cosa voglia dire parlare della forma percettiva di un oggetto. Si tratta di un problema che appartiene ai luoghi classici della riflessione fenomenologica. Vi è un oggetto qualsiasi — un libro sul tavolo, per esempio — e vi è il mio vederlo secondo un’angolatura prospettica che ne determina l’aspetto fenomenico. Si tratta di una distinzione molto semplice e che non dice davvero nulla di nuovo: tutti sappiamo bene che le cose si danno per aspetti e tutti sappiamo che ad ogni nostro movimento corrisponde una variazione della datità fenomenica che è conforme ad una regola determinata. Basta tuttavia riflettere un poco perché l’ovvietà di queste considerazioni ceda il campo ad una questione che merita di essere discussa. Noi vediamo le cose per aspetti che variano al variare della nostra posizione, e tuttavia questo continuo mutamento non sembra avere voce in capitolo nella determinazione della forma degli oggetti e nella configurazione dell’ambiente in cui ci muoviamo: noi vediamo un mondo stabile, fatto di cose che hanno una forma obiettiva assoluta e un loro posto obiettivo. Gli oggetti sul mio tavolo hanno la forma che hanno e io li vedo così come sono: il tavolo è molto grande e non diventa più piccolo se mi allontano, il portapenne è un cilindro, il libro che sta alla mia destra un parallelepipedo regolare, il foglio davanti a me un rettangolo, e nulla cambia se mi muovo — nulla se non la mia posizione rispetto a tutte queste cose. Così, se dovessimo descrivere ciò che vediamo entrando in una stanza non ci perderemmo nel vocabolario complesso degli aspetti, non cercheremmo di rendere a parole il gioco delle occlusioni che necessariamente si danno quando si osserva una scena da una prospettiva determinata, ma diremmo che vi è, per esempio, un tavolo rettangolare, degli scaffali e, sugli scaffali, dei libri. Che poi di questi libri sia visibile solo la costa e che l’immagine prospettica delle librerie sia scorciata e variamente distorta è un fatto irrilevante, poiché nel senso della nostra esperienza quei volumi e quegli scaffali vi sono nella loro interezza e nella determinatezza della loro forma, — come dimostra lo stupore da cui saremmo pervasi se, provando a prendere uno di quei volumi, ci accorgessimo di avere a che fare con un inganno, con qualcosa di simile ad una quinta teatrale.
Possiamo trarre di qui una prima conclusione. Le cose si danno fenomenicamente per aspetti, ma quando parliamo della forma degli oggetti visivi intendiamo innanzitutto la loro forma obiettiva assoluta. È questa forma quella che caratterizza il nostro mondo percepito, il suo scandirsi visivamente in oggetti che hanno una loro stabile configurazione tridimensionale che non tiene conto del fatto che vi è comunque un punto di vista da cui li osserviamo: che poi sulla retina si disegnino proiezioni bidimensionali degli oggetti è un fatto di cui lo psicologo deve tener conto, ma di cui il filosofo può disinteressarsi poiché il suo compito non è quello di spiegare come accadano i processi percettivi, ma di descrivere il senso che attribuiamo agli oggetti della nostra esperienza — un senso la cui attribuzione non ha nulla a che spartire con il fatto che vi sia la retina e, poco più in là, un sistema computazionale che elabora le informazioni ricevute.
E tuttavia, anche se abbiamo innanzitutto esperienza della forma obiettiva degli oggetti, ciò non toglie che la percezione dell’aspetto si faccia talvolta avanti. Vi sono, per esempio, oggetti che hanno un aspetto privilegiato e che, per essere riconosciuti, chiedono di essere visti da una certa prospettiva. Così, un conto è vedere la nuca, un altro vedere il volto di una persona: una prospettiva cela (o può celare) l’identità che l’altra così inequivocabilmente disvela. E ancora: il viso di una persona ci appare stravolto se lo vediamo dal basso verso l’alto, secondo un taglio molto prospettico accentuato: in questo caso, non sono soltanto le modalità espressive che vengono meno, ma è la stessa umanità del volto che può risultarne colpita. La storia della pittura ci offre molti esempi: dal Cristo in scurto del Mantegna alla figura in primo piano del giovane morto nella Zattera di Gericault, il taglio prospettico accentuato suggerisce un’identica constatazione — la morte rende irriconoscibile l’umanità del corpo, e ciò che nella realtà ci riconduce all’avvertimento doloroso della mancanza di quella viva gestualità che dà alle membra il loro aspetto consueto e il loro senso espressivo, si traduce sul piano delle immagini nella deformazione prospettica che rescinde il nodo che lega l’aspetto alla cosa, il manifestarsi al suo esser così.
Naturalmente non è soltanto l’esperienza percettiva del volto a richiamare la nostra attenzione sulla dimensione e sulla varietà degli aspetti: quasi ogni oggetto può apparirci in una prospettiva falsante (un’espressione su cui vi invito a riflettere) e può costringerci ad uno sguardo ravvicinato o diversamente orientato. Qualche volta anche gli oggetti più familiari chiedono un diverso punto di vista per essere riconosciuti, ed anche se normalmente il nostro aggirarci in una stanza non assume affatto la forma di un affollarsi di punti interrogativi cui faccia eco una rasserenante teoria di punti esclamativi, è difficile negare che qualche domanda possa sorgere e che talvolta il riconoscimento sia frutto di uno sforzo ulteriore.
Possiamo trarre così una seconda conclusione. Anche se gli oggetti in cui si scandisce il mondo della nostra esperienza hanno una forma obiettiva che si costruisce in una tridimensionalità che non conosce punto di vista, è comunque necessario affermare che da un lato ciascuna di queste forme obiettive si rende riconoscibile soltanto nella sua manifestazione fenomenica e quindi nel suo consegnarsi alla varietà degli aspetti e che, dall’altro, è proprio là dove la riconoscibilità viene meno o si vincola ad un aspetto particolare che la dimensione prospettica si fa avanti e guadagna una sua eco linguistica.
Su questo punto è forse opportuno insistere. Il riconoscimento visivo della forma passa necessariamente per la percezione degli aspetti, così come si dipanano nel realizzarsi di un decorso percettivo che esibisce una regola peculiare — quella regola che mostra ciò che permane nel gioco delle variazioni. E tuttavia, il sistema di invarianze che si fa avanti nel decorso percettivo e che permette il manifestarsi della forma obiettiva, si dà fenomenologicamente attraverso fasi (o più precisamente: intorni di fase) che non consentono di scorgere con eguale facilità la regola che li attraversa.
Non è certo facile essere precisi su questo punto, ed io credo che sarebbe possibile liberarsi di questa vaghezza solo disponendosi sul terreno di indagini matematicamente complesse. Ma se ci accontentiamo di considerazioni vaghe, forse per comprendere il senso di queste considerazioni basta un disegno:

Potremmo descrivere così ciò che abbiamo disegnato: vediamo
le diverse fasi del movimento di una freccia che, ancorata ad un’estremità,
ruota su un piano che è parallelo al terreno e che è all’altezza del nostro sguardo.
Ora ogni singola fase di questo decorso percettivo ci presenta la freccia
proprio come deve; e tuttavia, benché sia conforme a una regola, la fase
che ci appare in (4) ci presenta una freccia solo perché è preceduta da altre
fasi in cui quell’oggetto ci appare in una manifestazione più chiara e quella
regola in una forma in cui è più facile derivarla. Il nesso che stringe il
senso del fenomeno al decorso cui appartiene si mostra così in tutta la sua
evidenza: la cosa può manifestarsi nel fenomeno solo se il fenomeno sa
suggerirla o se il decorso percettivo, ripercorrendone le singole datità, la
rende effettivamente esplicita. Così, anche se diciamo di vedere uno stesso
oggetto nella totalità dei suoi aspetti, non per questo dobbiamo negare che
tra le diverse manifestazioni di una cosa ve ne siano alcune il cui senso è evidente,
altre che ci sembrano oscure e che ricevono una loro sensatezza solo quando le
connettiamo al decorso percettivo che, sviluppandole, rende esplicita la regola
che attribuisce loro un senso. In altri termini: non tutti gli aspetti hanno lo
stesso grado di manifestatività, ed è
per questo che lo sguardo che corre di cosa in cosa in un’immediata acquisizione
di ciò che ci circonda deve talvolta fermarsi, per dar vita ad un processo di
esplorazione percettiva che da un aspetto della cosa muova ad altri aspetti,
che sappiano mostrare ciò che altrimenti non aveva potuto manifestarsi.
Possiamo allora proporre la seguente tesi fenomenologica: quanto più la manifestazione di un oggetto
è in grado di farci riconoscere l’oggetto stesso indipendentemente dal suo occorrere
nell’unità del decorso cui appartiene, tanto più il fenomeno tende a restituirci la forma obiettiva di ciò che percepiamo.
Così, anche se ogni fase di decorso ci presenta l’oggetto nella sua forma e se ciò che diciamo di vedere è sempre la configurazione oggettiva della cosa che ci sta di fronte, dobbiamo riconoscere che ogni processo percettivo culmina nelle sue fasi ottimali, si orienta verso alcuni punti di gravitazione, in assenza dei quali l’intero sistema di fasi della percezione di un oggetto è privo di un interno equilibrio. In queste fasi la forma dell’oggetto non è colta solo nell’inerenza del fenomeno alla regola del decorso, ma è parzialmente data nel fenomeno stesso, nella sua pienezza intuitiva: nelle fasi ottimali di un decorso il fenomeno si fa icona, raffigurazione paradigmatica (anche se parziale) dell’oggetto.
Quali e quante siano le fasi che, nella percezione di un oggetto, hanno valore di icona dipende dalla natura dell’oggetto stesso, dalla molteplicità ma anche dalla natura delle caratteristiche che ci permettono di riconoscerlo. Possiamo far ruotare liberamente una sfera e ogni fenomeno ci mostrerà l’oggetto nella sua forma e lo renderà riconoscibile. Diversamente stanno le cose per un cubo, la cui forma si annuncia con chiarezza in alcuni aspetti, ma non in tutti.
Come abbiamo osservato, queste considerazioni hanno un significato soltanto relativo poiché di fatto nessuna percezione è interamente slegata da un decorso più ampio ed è comunque sita in un contesto che rende improbabile il sorgere di ambiguità percettive. Così, più che del rapporto tra una singola fase e il decorso percettivo, si dovrebbe forse parlare delle condizioni di derivabilità della forma obiettiva da differenti segmenti del decorso percettivo, e credo che si potrebbe dimostrare che tali condizioni variano con il variare delle fasi prescelte.
Non è questo, tuttavia, il terreno su cui dobbiamo muoverci. Vorrei invece osservare come da queste considerazioni si possa trarre spunto per comprendere meglio il nostro problema. Anche nel caso delle raffigurazioni, infatti, si fa avanti il problema del riconoscimento, poiché anch’esse debbono rendere riconoscibile la forma obiettiva delle cose affidandosi a ciò che si può fermarne in un’immagine. Si ripresenta qui, dunque, la dialettica minimale che anima la percezione delle cose, ma si presenta evidentemente in una forma esacerbata, poiché un’immagine non può rendere riconoscibile ciò che raffigura semplicemente affidandosi ad una regola che ne integri il senso, e questo per la buona ragione che un’immagine non è una scena che tragga il suo significato dall’appartenenza ad un decorso percettivo. Anche in questo caso dunque, seppure in una diversa accezione, possiamo dire che le immagini debbono bastare a se stesse: il loro senso deve potersi manifestare nella singolarità del loro apparire e la loro riconoscibilità deve essere garantita dai tratti di cui constano. Di qui la ragione e il senso delle nostre considerazioni sulla relativa indipendenza degli aspetti iconici dall’unità del decorso percettivo, poiché di fatto ciò che gli aspetti iconici o prototipici ci mostrano è una possibile via per rendere riconoscibile in un’immagine ciò che per sua natura non si può racchiudere nella superficie di un foglio.
Una possibile via, appunto, poiché di fatto nella nozione di aspetto prototipico è racchiuso il rimando ad una variazione prospettica e ad un punto di vista, e noi abbiamo già visto in che senso non si possa sostenere, come riteneva Gibson, che ogni raffigurazione si fondi infine sulla geometria proiettiva della luce. E tuttavia gli aspetti iconici, più delle altre manifestazioni fenomeniche in cui si scandisce la nostra percezione degli oggetti, hanno molto da insegnare alle nostre tecniche figurative, poiché ci mostrano quali forme intuitive sappiano rendere riconoscibili le caratteristiche invarianti degli oggetti, quelle loro caratteristiche di forma, dimensione o colore che lo sguardo coglie nei suoi decorsi percettivi. Così, anche se disegnare non significa necessariamente riproporre un aspetto delle cose, ogni raffigurazione deve infine fare i conti con il fatto che ciò che si vede sulla carta deve essere riconoscibile e deve quindi trarre dall’intuizione le regole che lo rendano immediatamente evidente. La raffigurazione nasce giocando con i materiali della percezione e con le regole che si fanno in essi evidenti, ed in questo gioco con le strutture fenomenologiche della percezione gli aspetti iconici (sia pure liberamente connessi e ordinati dalla prassi pittorica) rappresentano i mattoni più semplici ed affidabili, quelli con cui più è opportuno avviare il gioco. Il vocabolario della pittura, e quest’espressione va presa con tutte le cautele del caso, poggia sulle strutture fenomenologiche della percezione, e questo sia perché la forma obiettiva degli oggetti si fa manifesta nella percezione e si mostra nei suoi aspetti prototipici, sia perché sul foglio il disegno deve essere riconoscibile e può esserlo soltanto se ci parla nel linguaggio della percezione.
A partire di qui le nostre considerazioni sulla nozione di schema intuitivo acquistano un senso più definito e una più chiara possibilità di sviluppo. Quando disegniamo, abbiamo in mente la forma obiettiva ed assoluta di un oggetto, ma dobbiamo renderla in qualche modo visibile su un foglio di carta, — su di una superficie che osserviamo da qui. Per farlo possiamo seguire strategie differenti che potremmo disporre su un scala che, muovendo dagli schemi intuitivi che ripetono nella forma visibile del disegno la forma obiettiva dell’oggetto a dispetto della prospetticità del riconoscimento, giunga infine a quegli schemi in cui l’assolutezza della forma è consegnata ad un disegno che sembra ripetere, congelandola, una fase del decorso percettivo, — ed in questo caso la possibilità di vedere facilmente da qui la scena raffigurata è ottenuta rinunciando a mantenere invariate le forme dell’oggetto rappresentato cui si chiede di assumere le sembianze distorte del fenomeno. Nessuna soluzione è, dunque, indolore e le une e le altre chiedono allo spettatore di rinunciare a qualcosa e di assumere rispetto ai risultati raggiunti un atteggiamento di tolleranza e di cooperazione che debbono così essere messe nel conto della competenza pittorica.
Vorrei essere chiaro su questo punto, e ciò significa addentrarsi un poco sul terreno degli esempi. Il disegno infantile si colloca all’origine della scala cui alludevamo e gli schemi intuitivi di cui si avvale sono senz’altro caratterizzati da un lato dall’assoluta mancanza di un riferimento prospettico, dall’altro da una tendenziale interpretazione volumetrica dei tratti figurativi.
Il senso di quest’ultima affermazione va chiarito. Un tratto sul foglio può rappresentare un contorno visibile dell’oggetto — il modo in cui un corpo si manifesta quando lo osserviamo da una certa angolatura. Ma la sua funzione può essere differente: il segno che la matita traccia può essere anche il modo in cui sulla carta si costruisce un corpo, circoscrivendolo. Ed in questo caso la prassi pittorica non è guidata dall’obiettivo di rendere visibile la proiezione dell’oggetto rispetto ad un punto, ma dal fine pratico di costruire, “ritagliandola” nella carta, una figura che rende quanto più possibile presente la forma obiettiva dell’oggetto raffigurato. Credo che le cose stiano davvero così, e per rendersene conto è possibile rammentare uno strano fenomeno che caratterizza talvolta i disegni dei bambini: il fenomeno della trasparenza. Si tratta di una conseguenza diretta della funzione costruttiva delle linee pittoriche: se la linea non delimita un contorno visibile ma circoscrive e ritaglia uno spazio figurativo, allora è possibile far vedere ciò che vi è all’interno del corpo che si è così disegnato. Così come talvolta nei dipinti prospettici la superficie del quadro si pone come la parete mancante che ci consente di gettare uno sguardo nell’intimità dello spazio chiuso di una stanza, così la linea chiusa del disegno infantile costruisce uno spazio che può essere svuotato e riempito come una scatola e in cui è possibile custodire gli oggetti più disparati.
Vi è comunque un prezzo che si deve pagare per attribuire al segno una simile valenza costruttiva, e di fatto — per fare soltanto un esempio — nei disegni dei bambini più piccoli non è possibile la funzione del nascondimento: se il tratto ritaglia un oggetto nello spazio figurativo del foglio, è evidente che la forbice della matita non potrà più tagliare là dove si è già fatto il vuoto, — e ciò è quanto dire che non si può sovrapporre segno a segno e quindi raffigurare un oggetto che sia parzialmente coperto da un altro oggetto. Naturalmente la grammatica del disegno infantile ha una sua evoluzione ed una sua conseguente complessità. Così, ai segni che hanno un immediato valore volumetrico si affiancano in seguito i segni che hanno valore di superficie, e non vi è dubbio che in questo farsi avanti di linee che possono descrivere ciò che si disegna sulla superficie di un corpo — le linee della bocca, il profilo del naso, i punti degli occhi, per esempio — la grammatica del tratto si faccia più ricca e complessa: ora ai segni che “ritagliano” nella pagina un corpo si affiancano i segni che determinano il suo aspetto superficiale. Seguire almeno un poco nel dettaglio le linee di questa evoluzione (che John Willats mostra in un suo bel libro intitolato Art and Representation. New Principles in the Analysis of Pictures, Princeton, 1997) sarebbe molto interessante, ma ci condurrebbe al di là dei confini che è opportuno dare alle nostre considerazioni.
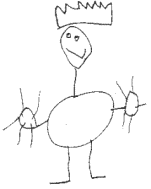 Così,
piuttosto che addentrarmi in un problema che appartiene in linea di principio
alla psicologia cognitiva, vorrei limitarmi a qualche rapido cenno che ci
consenta di far luce sul nostro problema e insieme di ancorare le nostre
riflessioni alla dimensione intuitiva degli esempi. Rivolgiamo allora lo
sguardo al disegno infantile di un uomo; di fronte a noi avremo una figura
fatta così: una linea chiusa delineerà il corpo, un’altra la testa, e dei
segmenti diritti daranno forma alle gambe, al collo e alle braccia. Quanto alle
mani, il palmo avrà la forma di un corpo da cui si dipartono a raggiera le dita,
che saranno invece sottili come spine. Si tratta di un disegno in cui non
facciamo fatica a scorgere un uomo — in questo caso un uomo importante, poiché
la corona ci avverte che abbiamo a che fare con un re. E tuttavia quanto più
osserviamo questo disegno, tanto più ci sembra difficile venire a capo della nostra
percezione. In quello strano giustapporsi di linee vediamo un uomo e nessuno,
credo, sosterrà che si tratta di una mera convenzione. Eppure, basta guardare
bene quello che c’è sul foglio perché si facciano avanti quei dubbi su cui ci
eravamo dianzi soffermati. Guardiamo, per esempio, gli inserti di gambe e
braccia sul corpo: la struttura fenomenologica che li caratterizza è quella che
attesta la presenza di una differente dislocazione di piani tra le parti, e
invece noi vediamo le gambe e le braccia che si attaccano al corpo, senza fuggire
dietro ad esso. E ancora: il corpo e la testa di questa strana figura sono delineati
ciascuno da un’unica linea che traccia una circonferenza imperfetta nel foglio,
segregando un duplice spazio. Eppure, se qualcuno ci chiedesse se la figura
così disegnata è magra o grassa o se il suo volto è pieno o scavato, noi non sapremmo
affatto che cosa rispondere. Quel corpo e quel volto non sono né magri né
grassi: semplicemente sono, e queste domande non soltanto non trovano risposta
nel disegno, ma sembrano essere del tutto fuori luogo per chi, comprendendolo,
lo guardi. Ma anche se un bambino non fa queste domande, come filosofi, siamo costretti
a porci questi oziosi quesiti. E allora ci chiediamo come mai le linee che
fungono da gambe e da braccia sono prive di qualsiasi larghezza mentre le mani
sono così evidentemente corpose? E per rispondere a questa domanda non basta
dire che un bambino non sa disegnare come si deve poiché il problema è un
altro: il problema è capire come sia possibile che, per noi che guardiamo,
questo disegno possa effettivamente raffigurare gambe e braccia e mani
e, intorno alle mani, il fiorire delle dita. E ancora: gambe e braccia ci
appaiono in molte e diverse prospettive e non sembra che vi sia una ragione di
ordine probabilistico che ci autorizzi a pensare che sia più probabile vederle
così — come se fossero necessariamente disposte su un piano posto di fronte
allo spettatore.
Così,
piuttosto che addentrarmi in un problema che appartiene in linea di principio
alla psicologia cognitiva, vorrei limitarmi a qualche rapido cenno che ci
consenta di far luce sul nostro problema e insieme di ancorare le nostre
riflessioni alla dimensione intuitiva degli esempi. Rivolgiamo allora lo
sguardo al disegno infantile di un uomo; di fronte a noi avremo una figura
fatta così: una linea chiusa delineerà il corpo, un’altra la testa, e dei
segmenti diritti daranno forma alle gambe, al collo e alle braccia. Quanto alle
mani, il palmo avrà la forma di un corpo da cui si dipartono a raggiera le dita,
che saranno invece sottili come spine. Si tratta di un disegno in cui non
facciamo fatica a scorgere un uomo — in questo caso un uomo importante, poiché
la corona ci avverte che abbiamo a che fare con un re. E tuttavia quanto più
osserviamo questo disegno, tanto più ci sembra difficile venire a capo della nostra
percezione. In quello strano giustapporsi di linee vediamo un uomo e nessuno,
credo, sosterrà che si tratta di una mera convenzione. Eppure, basta guardare
bene quello che c’è sul foglio perché si facciano avanti quei dubbi su cui ci
eravamo dianzi soffermati. Guardiamo, per esempio, gli inserti di gambe e
braccia sul corpo: la struttura fenomenologica che li caratterizza è quella che
attesta la presenza di una differente dislocazione di piani tra le parti, e
invece noi vediamo le gambe e le braccia che si attaccano al corpo, senza fuggire
dietro ad esso. E ancora: il corpo e la testa di questa strana figura sono delineati
ciascuno da un’unica linea che traccia una circonferenza imperfetta nel foglio,
segregando un duplice spazio. Eppure, se qualcuno ci chiedesse se la figura
così disegnata è magra o grassa o se il suo volto è pieno o scavato, noi non sapremmo
affatto che cosa rispondere. Quel corpo e quel volto non sono né magri né
grassi: semplicemente sono, e queste domande non soltanto non trovano risposta
nel disegno, ma sembrano essere del tutto fuori luogo per chi, comprendendolo,
lo guardi. Ma anche se un bambino non fa queste domande, come filosofi, siamo costretti
a porci questi oziosi quesiti. E allora ci chiediamo come mai le linee che
fungono da gambe e da braccia sono prive di qualsiasi larghezza mentre le mani
sono così evidentemente corpose? E per rispondere a questa domanda non basta
dire che un bambino non sa disegnare come si deve poiché il problema è un
altro: il problema è capire come sia possibile che, per noi che guardiamo,
questo disegno possa effettivamente raffigurare gambe e braccia e mani
e, intorno alle mani, il fiorire delle dita. E ancora: gambe e braccia ci
appaiono in molte e diverse prospettive e non sembra che vi sia una ragione di
ordine probabilistico che ci autorizzi a pensare che sia più probabile vederle
così — come se fossero necessariamente disposte su un piano posto di fronte
allo spettatore.
Ma allora, se le cose stanno così, come possiamo vedere un uomo in questa figura? Rispondere a questa domanda significa porre finalmente le mani sull’intreccio tra l’effettività di un’immagine e i vincoli grammaticali di uno stile.
Un’immagine deve essere effettiva: nei suoi tratti si deve poter vedere ciò che vediamo. Così, in una circonferenza tracciata su un foglio si può cogliere visivamente la raffigurazione di un corpo, poiché la caratteristica fenomenologica peculiare di un oggetto percepito è la sua chiusura. Alla stessa stregua, gambe e braccia sono parti relativamente indipendenti dal corpo — sono le sue appendici mobili — e non è quindi privo di una logica percettiva il disegno che ce li propone come se fossero parti giustapposte al corpo e non semplicemente fuse con esso. Ed un analogo discorso vale anche per le dita delle mani che un bambino rappresenta secondo una logica che è percettiva e motoria insieme: le dita non sorgono soltanto visibilmente come spine dal palmo, ma sono motoriamente distinte da esso, come ci si rivela quando guardiamo lo scheletro sotto la pelle e ritroviamo disgiunte le falangi dal carpo e dal metacarpo. Quanto poi alla unidimensionalità degli arti e alla loro disposizione priva di ogni dimensione di scorcio, valgono le considerazioni che abbiamo proposto sulla esemplarità di certe manifestazioni fenomeniche: se sul foglio dobbiamo mostrare un uomo con gambe e braccia dovremo tracciare quello che gambe e braccia innanzitutto sono — delle parti del corpo che spiccano per la loro lunghezza e che hanno una larghezza trascurabile. Ma se l’effettività di un’immagine, e quindi la sua capacità di mostrarci ciò che essa intende mostrarci, dipende dal suo obbedire ad un insieme di strutture fenomenologiche e di vincoli cognitivi, il suo dirci solo ciò che intende dirci ci riconduce invece alla dimensione dello stile e, correlativamente, della competenza pittorica. Certo, possiamo vedere in una circonferenza un corpo perché la chiusura è una proprietà fenomenologica cui è vincolata la presenza percettiva degli oggetti, ma se invece sosteniamo che non ha un senso domandarsi se quel corpo sia magro o grasso è solo perché il tratto che circoscrive il corpo non si dà come se fosse una scelta tra alternative possibili, ma come la realizzazione grafica di una distinzione elementare che assorbe per intero ciò che in quel segno di penna si manifesta. Alla stessa stregua, nel contesto del disegno infantile le giunture a T, che normalmente rendono figurativamente il sovrapporsi dei piani, debbono “dimenticarsi” della loro capacità di veicolare questa informazione visibile poiché in generale una simile sovrapposizione è negata dalla grammatica implicita nel tratto figurativo.
Potremmo insistere a lungo sugli aspetti che caratterizzano fenomenicamente il disegno infantile ma che non sembrano contribuire alla realizzazione del suo senso percettivo — alla delineazione degli schemi intuitivi di cui si avvale, così come potremmo mostrare come questo stesso ordine di considerazioni valga anche per altre forme stilistiche. Pensiamo, per esempio, all’arte egizia. Anche qui la raffigurazione tende ad assumere una valenza obiettiva e a rappresentare non un aspetto della cosa così come potrebbe darsi in una qualche fase del decorso percettivo, ma la cosa stessa nella assolutezza della sua forma. Ci imbattiamo così in costruzioni figurative che rinunciano alla coerenza dell’aspetto per assumere una piena manifestatività; nel disegno di un uomo, per esempio, tutto ci appare nelle sue manifestazioni iconiche: gli occhi sono visti frontalmente, il volto di profilo, il corpo in un’alternanza di orientamenti che garantisce la massima visibilità delle parti, a dispetto dell’impossibilità di connetterle nell’unità dell’intero cui appartengono. E tuttavia piuttosto che soffermarci su questi e altri possibili esempi, vorremmo tentare di dare una prima risposta al problema che abbiamo da tempo sollevato. Di fatto, se possiamo vedere in una pittura egizia il disegno di un uomo e non un sommarsi incoerente di parti e se di fronte alla strana figura coronata sappiamo tacitare in noi le domande che il testo del disegno non tollera, ciò accade perché la competenza pittorica che si attaglia agli stili figurativi di cui discorriamo ci insegna quali siano gli aspetti cui nel disegno si deve prestare attenzione.
Non ogni tratto sul foglio appartiene allo schema intuitivo, anche se evidentemente ne determina complessivamente l’aspetto, il come della sua realizzazione. Imparare a guardare un’immagine significa allora comprendere che cosa in essa è frutto di una scelta tra alternative possibili e che cosa invece dipende esclusivamente dalla casualità della realizzazione. Lo stile ci invita a guardare differenze: ci chiede di fare attenzione alla forma allungata degli arti e delle dita e a distinguerla dalla piena corporeità del busto, della testa o del palmo delle mani. Questo ci invita a guardare; ma ci esorta anche trascurare ciò che pure fenomenicamente appare: ci chiede di non dare ascolto alla dimensione fenomenica che sembra spingerci a cogliere nell’immagine di un volto di un’antica pittura egizia uno sguardo rivolto allo spettatore. Quel taglio degli occhi non può farsi carico di una così complessa possibilità espressiva, perché non gli è concessa la possibilità dell’altrimenti — e ciò è quanto dire che la competenza pittorica ci insegna a ignorare ciò che nel disegno si mostra e ci invita a concludere che le figure nella pittura egizia hanno occhi, ma sono egualmente prive di sguardo, poiché lo sguardo ha una meta e la meta si disegna insieme all’accettazione di un qualche indice prospettico.
Ma se le cose stanno così, stile e competenza pittorica possono invitarci ad aprire e a chiudere gli occhi su ciò che un disegno ci porge, ma non possono ancora una volta farci vedere ciò che non c’è. All’immagine soggettivistica di una percezione che si lascia prendere per mano da ciò che le consuetudini e la cultura le dettano si deve così contrapporre un’istanza di carattere obiettivistico che ci rammenta che davvero non possiamo vedere altro se non ciò che abbiamo davanti a noi. Così, se si può parlare di libertà delle immagini e se si può insistere sul fatto che ogni stile pittorico ci invita ad un atteggiamento ricettivo particolare ciò non vuol dire ripetere un improbabile appello alla storicità della visione: vuol dire soltanto rammentarsi che ciò che vediamo è un insieme di voci cui possiamo concedere o negare la nostra attenzione, una volta che altre simili immagini ci abbiano permesso di riconoscere la parola dal rumore che l’accompagna, che cosa parli in nome di una diversità dello schema intuitivo e che cosa sia invece una differenza accidentale nel come della sua realizzazione.
Dalle considerazioni che abbiamo sin qui esposto è tuttavia possibile trarre un’ulteriore conclusione. Se infatti riflettiamo sulla funzione che la competenza pittorica esercita sulla nostra percezione delle immagini, un dato emerge con relativa chiarezza: imparare a guardare il disegno di un bambino (o anche una pittura parietale egizia) significa, tra le altre cose, soffocare un insieme di domande e tollerare alcune incongruenze. Vuol dire soffocare certe domande: non possiamo domandare come sia possibile che nel disegno di un bambino case e alberi poggino tutti sulla linea sottile dell’orizzonte, né ci è lecito chiedere come retroceda lo spazio nelle architetture improbabili delle icone bizantine. Avere acquisto una competenza pittorica rispetto a queste immagini significa appunto questo: sapere quali sono gli interrogativi cui una certa immagine può dare risposta, e quali invece quelli su cui per sua natura tace. Ma vuol dire anche imparare a tollerare le incongruenze che si legano alla scelta di determinati schemi intuitivi. Posso rappresentare una casa affiancando sulla stessa linea di orizzonte la visione frontale e la visione laterale, ma questo significa evidentemente accettare di “chiudere un occhio” su più di un aspetto della scena che ci si presenta. Riconoscere uno stile significa allora imparare anche una lezione di tolleranza: la competenza pittorica diviene così un modo per congelare le richieste avanzate dall’esigenza dell’effettività dell’immagine, dal suo volersi porre come un’adesione piena al postulato della riconoscibilità. Si potrebbe anzi osservare che talvolta — ed è proprio questo ciò che accade nel disegno dei bambini — il compromesso che viene di volta in volta pattuito tra la tolleranza dello stile e le esigenze dell’effettività dell’immagine segna le tappe di un percorso che si viene gradualmente dipanando. Se il bambino abbandona gradualmente le forme stilistiche che caratterizzano i suoi primi disegni e se nelle sue raffigurazioni la prospettiva ottiene un ascolto crescente, ciò non significa che nel disegnare egli si rivolga con sempre maggiore convinzione al nesso proiettivo che lega la cosa alla sua immagine; tutt’altro: il suo sguardo resta ancorato alla pagina e lo costringe passo dopo passo a modificare le regole che gli consentono di riportare la forma assoluta dell’oggetto sulla superficie del foglio. Di queste regole il bambino avverte sempre più decisamente i limiti percettivi sul piano dell’immagine, ed è per questo che la solidità e la semplicità del tratto infantile si viene stemperando in un segno che garantisce una maggiore effettività, ma ci costringe ad ascoltare il dettato delle apparenze al di là della consistenza della forma obiettiva.
Su questi temi si potrebbero dire molte cose, ed io credo che il libro di Willats cui ho fatto cenno abbia molte cose da insegnarci. La tesi secondo la quale un’immagine si comprende nel linguaggio della geometria proiettiva e quindi delle diverse forme di proiezione che possono creare un’immagine di un oggetto su un piano è una tesi che dimentica il fatto che le raffigurazioni, nonostante ciò che Plinio ci dice, non nascono dal gesto di chi ricalca nella sabbia l’ombra che il sole proietta sul suolo, ma sono il frutto di una prassi che muove dal disegno interno — dalla forma obiettiva ed assoluta che abbiamo appreso percettivamente — al disegno esterno: allo schema intuitivo che consente di trasporre sulla geometria superficiale della pagina una forma tridimensionale assoluta. Per dire le cose con un ultimo esempio: il pittore cinese che dipinge i suoi paesaggi e che rappresenta con linee oblique ma parallele le ortogonali al piano non costruisce affatto un’immagine prospettica in cui i raggi siano divenuti paralleli per la distanza infinita dell’oggetto che ce li restituisce, ma si lascia guidare nella sua prassi da una regola ben precisa — dalla regola che gli consente di rappresentare le superfici disposte frontalmente nella loro forma obiettiva e le facce ortogonali al piano pittorico con linee oblique parallele.
Ma appunto, su questo tema non vorrei insistere oltre e vorrei limitarmi a dare uno sguardo a ciò che accade quando ci poniamo negli ultimi gradini della scala su cui abbiamo ordinato le diverse tipologie degli schemi intuitivi. Qualcosa naturalmente muta: quanto più gli schemi sensibili si fanno carico dell’apparenza e degli aspetti — quanto più si approssimano alla forma prospettica — tanto più si può lasciare allo sguardo la libertà di cogliere ciò che gli si presenta nell’immagine, senza dover chiudere gli occhi su questo o su quel momento della dimensione fenomenica.
Nel suo porsi come una possibile fase di un decorso percettivo l’immagine guadagna una sua piena effettività: quando la osserviamo dal punto che essa costruttivamente ci assegna, la raffigurazione prospettica si dispiega come un tutto coerente che non chiede di essere corretto e che non sembra invitarci ad assumere un atteggiamento di tolleranza rispetto a ciò che si costruisce sulla tela. E tuttavia ciò non significa che la competenza pittorica non si traduca, anche in questo caso, in una serie di norme volte a salvare l’immagine e a metterla al riparo da un cattivo modo di avvalersene. Anche in questo caso la competenza pittorica ci parla nel linguaggio delle richieste e dei divieti.
Ci parla nel linguaggio delle richieste, poiché ci invita a considerare l’immagine come uno spettacolo di cui possiamo cogliere il senso solo se l’osserviamo come una scena di un decorso percettivo che ha guadagnato una sua parziale indipendenza e che ci rammenta la sua separatezza nel vincolo ideale della fissità del punto di osservazione cui è costruttivamente vincolata l’immagine.
Ma ci parla anche nel linguaggio dei divieti. Un’immagine prospettica può assumere una piega illusionistica e può colpirci con l’evidenza della sua resa percettiva; ciò non toglie tuttavia che la peculiarità della sua costruzione ci costringa a rinunciare ad usare il disegno come un’eco reale della cosa raffigurata. In un’immagine prospettica le dimensioni non vengono salvate e lo stesso vale per le forme: possiamo vedere in un cubo disegnato prospetticamente l’eguaglianza delle facce, la perpendicolarità e il parallelismo dei lati o l’eguaglianza degli angoli, ma non possiamo ritrovarla come una caratteristica che spetti geometricamente al disegno. Ma ciò è quanto dire che anche qui la competenza pittorica ci invita a tacitare sul nascere una possibile prassi: dobbiamo dimenticarci della possibilità di impiegare il disegno come se fosse esso stesso una cosa, come se fosse possibile operare con esso come con un sostituto della realtà. Quanto più ci muoviamo in un’immagine che si fa attenta alla dimensione fenomenica degli aspetti tanto meno possiamo dimenticarci del suo porsi come una mera apparenza, come uno spettacolo che non tollera di essere solidificato e trattato come un oggetto.
Lezione settima
1. Riconoscere in altro
Nella lezione precedente avevamo osservato come la dinamicità del riconoscimento fosse innanzitutto messa alla prova dalla capacità di vedere qualcosa in una raffigurazione, anche se poi avevamo rimandato l’analisi di questa questione complessa ad un momento più opportuno. Questo momento è giunto e dobbiamo quindi cercare di rendere conto della particolarità del riconoscimento che guida e sorregge la nostra percezione delle raffigurazioni. Un fatto balza agli occhi. Quando, per esempio, diciamo che abbiamo riconosciuto in una persona che intravediamo nella folla un amico che non vedevamo da tempo proponiamo una relazione di identità: per quanto significative possano essere le differenze che potrebbero avere reso difficile quel riconoscimento, sosteniamo che il ricordo e la percezione ci parlano di una stessa persona. Se così non stessero le cose, se ci dovessimo rendere conto che la persona che vediamo assomiglia ma non è l’amico di un tempo, allora diremmo semplicemente che ci siamo sbagliati: di un riconoscimento si può parlare infatti solo quando al di là del gioco delle manifestazioni si fa avanti uno stesso ed identico denotato.
 Non
è difficile rendersi conto che nel caso delle immagini le cose non
stanno così. In questo disegno noi riconosciamo Freud in una sua famosa
caricatura, e tuttavia nessuno direbbe a mezza voce, dopo avere guardato questo
disegno, che Sigmund è davvero invecchiato o che si è imbruttito. Questa conclusione
non sarebbe legittima, mentre potremmo senz’altro trarre una conclusione
analoga a proposito dell’amico che abbiamo per caso incontrato dopo tanti anni.
Di fronte ad una differenza così evidente siamo costretti a domandarci il
perché, ma si tratta evidentemente di un enigma a buon mercato per cui abbiamo
subito pronta una soluzione: come abbiamo appena osservato, quando incontriamo
una persona e la riconosciamo, proponiamo una relazione di identità che non può
invece sussistere tra l’uomo Freud e la sua immagine. Ne segue che quando diciamo
di riconoscere Freud in questo disegno o esclamiamo «questo è l’autore
della Interpretazione dei sogni» di fatto vogliamo banalmente
asserire che ciò che vediamo è soltanto una raffigurazione di quell’uomo
famoso, non lui stesso in persona — anche se resta ancora da spiegare che cosa
propriamente significhi qui «soltanto».
Non
è difficile rendersi conto che nel caso delle immagini le cose non
stanno così. In questo disegno noi riconosciamo Freud in una sua famosa
caricatura, e tuttavia nessuno direbbe a mezza voce, dopo avere guardato questo
disegno, che Sigmund è davvero invecchiato o che si è imbruttito. Questa conclusione
non sarebbe legittima, mentre potremmo senz’altro trarre una conclusione
analoga a proposito dell’amico che abbiamo per caso incontrato dopo tanti anni.
Di fronte ad una differenza così evidente siamo costretti a domandarci il
perché, ma si tratta evidentemente di un enigma a buon mercato per cui abbiamo
subito pronta una soluzione: come abbiamo appena osservato, quando incontriamo
una persona e la riconosciamo, proponiamo una relazione di identità che non può
invece sussistere tra l’uomo Freud e la sua immagine. Ne segue che quando diciamo
di riconoscere Freud in questo disegno o esclamiamo «questo è l’autore
della Interpretazione dei sogni» di fatto vogliamo banalmente
asserire che ciò che vediamo è soltanto una raffigurazione di quell’uomo
famoso, non lui stesso in persona — anche se resta ancora da spiegare che cosa
propriamente significhi qui «soltanto».
Del resto, che si tratti di due cose distinte non è certo difficile constatarlo: un’immagine può scolorire, divenire illeggibile, e può bruciare senza che nulla accada al soggetto che in essa si raffigura, proprio come, al contrario, è ben possibile che un quadro sopravviva a ciò che raffigura — come ci dimostrano le fotografie e i ritratti che ci ricordano di persone che non ci sono più. Se, dunque, di un riconoscimento si può parlare, si deve almeno ammettere che si tratta di un riconoscimento sui generis che non implica l’identità dei due termini tra cui occorre.
Forse queste considerazioni sono sufficienti; ma forse no, e potrebbe sorgerci un dubbio: potremmo infatti chiederci se non abbiamo cercato il riconoscimento nel luogo sbagliato. Si potrebbe infatti sostenere che il riconoscimento ha luogo nell’immagine e non tra l’immagine e l’oggetto di cui ci parla. Potremmo, in altri termini, sostenere che è nelle linee e nelle macchie di cui l’immagine consta che riconosciamo il ritratto di Freud, ed in questo caso una qualche identità sembra sussistere: se cancello le tracce lasciate dalla matita anche l’immagine viene meno. L’una esiste soltanto in virtù delle altre, anche se naturalmente non vale la reciproca: posso riconoscere nelle macchie di una roccia la sagoma di un animale solo se vi sono venature che rendono percepibile un disegno; di per se stesse, tuttavia, quelle venature non sono ancora un’immagine: è necessario infatti che sia possibile riconoscervi qualcosa — e se nulla di simile esistesse nel nostro mondo, quelle venature sarebbero mute per noi e non potremmo scorgervi alcuna raffigurazione.
Ora, asserire che l’oggetto, in quanto oggetto raffigurato, consta proprio delle linee che sono tracciate sul foglio non significa tuttavia sostenere che la percezione di immagine sia senz’altro riconducibile alla forma normale del riconoscimento, e basta porsi sul terreno descrittivo perché si faccia avanti una differenza rilevante che non può essere trascurata. Quando ha luogo un riconoscimento esplicito di una persona accade qualcosa di simile a questo: dapprima vediamo un volto, un corpo, una certa andatura, e poi improvvisamente ritroviamo un gesto o un tratto che ci è noto e così si fa avanti nella memoria un nome e, insieme ad esso, un orizzonte di consuetudini antiche che si proiettano sulla scena presente, orientandone le aspettative. Qualcosa è dunque mutato anche a livello percettivo, poiché ciò che ora vediamo assume sempre più chiaramente il significato di una conferma e si propone come una attestazione di un’identità ritrovata — e tutto ciò accade in un decorso percettivo che non muta di orientamento e che non cambia il proprio oggetto, ma che cerca anzi di farsi sempre più vicino ad esso, di osservarlo meglio, per coglierne sempre più chiaramente le proprietà che ci consentono di ritrovare nella scena presente l’orizzonte del ricordo, vincendo le difficoltà che la distanza del tempo ha creato. Tutto questo ha una sua eco linguistica: quando finalmente riconosciamo un volto dopo averlo più volte guardato non ci limitiamo ad enunciare un nome che ce lo renda familiare, ma sentiamo il bisogno di sostenerlo con un tono di voce particolare e di affiancarlo con le espressioni contrastanti che indicano tanto l’avversità dell’ostacolo, quanto il nostro averlo infine superato — «ma è proprio Sigmund!».
Diversamente stanno le cose quando abbiamo a che fare con un’immagine, perché anche nel caso in cui ci appaiano dapprima soltanto linee confuse e poi, finalmente, prenda forma un ritratto, il senso della nostra percezione non è dominato dall’idea di una conferma e di un’identità ritrovata. Tutt’altro: quando si fa avanti la percezione d’immagine, le linee perdono la loro individualità e balza in primo piano il risultato cui mettono capo — in quelle linee vediamo comparire qualcosa di nuovo: il volto di Freud, per esempio. Ma ciò è quanto dire che il riconoscimento, in questo caso, non cancella l’alterità della scena nella posizione di un’identità ritrovata, ma fa del riconoscimento il mezzo per attribuire a ciò che vediamo un significato interamente nuovo.
Ad un enigma da poco abbiamo dato una risposta che si è fatta via via più complessa e che sembra ora invitarci a mettere in discussione la legittimità di una scelta terminologica su cui non abbiamo a lungo pensato. Abbiamo parlato sin qui di un riconoscimento nelle immagini, — ma si può farlo se non sembra aver luogo quella relazione di identità che apparentemente ne costituisce la caratteristica principale? E se le cose stanno così, perché non rinunciare a un termine che rischia di essere semplicemente equivoco?
Credo che vi siano alcune buone ragioni che possono convincerci dell’opportunità di un impiego sui generis di questo termine. La prima è la più ovvia: quando, per esempio, in una nuvola in cielo vediamo improvvisamente disegnarsi la sagoma di un animale accade davvero qualcosa di molto simile ad un riconoscimento. Prima vedevamo una nuvola con una forma qualunque e ora ci vediamo invece un cavallo al galoppo: almeno per quello che riguarda la forma ha avuto dunque un luogo un riconoscimento effettivo. In quella nuvola si può riconoscere questo: la sagoma di un cavallo, o — come potremmo anche esprimerci — la sua figura. Lo stesso accade nel caso di un disegno: le linee che si disegnano sulla carta hanno un aspetto particolare che ci consente di riconoscervi la sagoma di un volto e anche il gioco di ombre e di luci che su di esso si manifesta — riconosciamo così su quel foglio di carta l’aspetto del volto di Freud. Ma ciò è quanto dire che la percezione di immagine implica un riconoscimento: per vedere ciò che si disegna sulla pagina dobbiamo riuscire a ritrovare la forma di un volto nei tratti di un disegno. Quei tratti disegnano una forma che noi riconosciamo e che osserviamo lasciandoci guidare dalle attese che quel riconoscimento sostiene: ora vediamo il contorno di un volto, gli occhi, il naso e poi, a dispetto della pochezza dei tratti, vediamo appunto disegnarsi una bocca sottile circondata da una grande barba bianca. Un riconoscimento, dunque, ha luogo, ma si tratta di un riconoscimento soltanto parziale che non ci consente di dire che sulla tela vi è il volto di un uomo, anche se ci permette di vedere disegnata la sua visibile apparenza. Il riconoscimento che ha luogo nelle immagini è, dunque, un riconoscimento che resta sospeso e che non pretende di distoglierci dall’ambito circoscritto della mera visibilità. Ciò che vediamo (il disegno) ripropone la stessa apparenza visibile di qualcosa che ci è noto — nella pagina si fa avanti così la figura di qualcosa[6].
Ci muoviamo ancora in quest’ordine di considerazioni e comprendiamo meglio le ragioni per cui è comunque opportuno parlare di un riconoscimento sui generis se rivolgiamo l’attenzione ad alcune proprietà formali della percezione di immagine. La prima di queste caratteristiche è strettamente connessa con ciò che abbiamo detto quando ci siamo soffermati sullo statuto meramente visibile del riconoscimento che ha luogo in un’immagine. Ciò che conta nell’immagine è il fenomeno, il suo essere percepita così da qualcuno, e ciò ci invita a sostenere che l’essere un’immagine non è una proprietà reale di una qualche superficie o di un qualche oggetto, ma è una proprietà intenzionale che implica necessariamente il rimando ad un soggettività. Di un quadro posso dire che è in sé pesante, di forma rettangolare e che è composto da certe sostanze chimiche complesse: il fatto che abbia queste proprietà si può accertare infatti attraverso un insieme di criteri che non chiamano direttamente in causa una soggettività percipiente, ma le relazioni reali che un oggetto stringe con altri oggetti. Il quadro ha un peso perché cade se non è sorretto da un chiodo e non perché io avverto la sua pesantezza, e non è rettangolare perché io lo percepisco così, ma perché ha quattro angoli eguali la cui somma è pari a 360° e può quindi combaciare con altre figure secondo una regola che può essere facilmente determinata. Queste sono, appunto, proprietà obiettive di un quadro; non lo è invece il suo essere una raffigurazione, poiché in questo caso il rimando ad una soggettività percipiente non può essere eluso: se in un quadro nessuno sapesse scorgere che qualcosa vi si disegna non avrebbe alcun senso dire che abbiamo a che fare con una raffigurazione, poiché verrebbe meno il riconoscimento in funzione del quale l’immagine propriamente si pone. Un criterio che ci consenta di dire che qualcosa è una raffigurazione e che sia indipendente dal nostro coglierlo come tale non vi è, ed è per questo che se tu non riesci a vedere nulla di più di una rottura nell’intonaco in quella crepa nel muro in cui io vedo uno strano paesaggio non ho alcun argomento per dimostrarti che ciò che abbiamo di fronte agli occhi è una raffigurazione. Un simile argomento non c’è, perché una cosa è una raffigurazione se e solo se è possibile riconoscere qualcosa nelle sue forme. E ciò è quanto dire che la proprietà di essere una raffigurazione è una proprietà intenzionale che spetta ad una superficie visibile se e solo se è l’oggetto di un riconoscimento — se e solo se è il correlato di una determinata relazione cognitiva.
Ma vi è una seconda caratteristica delle raffigurazioni che ci riconduce ancora una volta alla struttura formale del riconoscimento. In una linea spezzata vediamo il profilo delle montagne; lo vediamo perché abbiamo una certa consuetudine con il disegno e perché abbiamo già visto che da lontano le montagne ci appaiono proprio così — come una linea spezzata. Ne segue che perché un disegno raffiguri qualcosa non basta che vi sia una soggettività percipiente e che sussista una qualche somiglianza tra l’aspetto visibile della cosa raffigurata e la forma delle linee che la raffigurano: è necessario anche un soggetto che abbia già avuto esperienza di un mondo — di quel mondo che deve in qualche modo ritrovare nell’immagine. È appena il caso di dire che di questa caratteristica delle raffigurazioni si può rendere conto riconducendole sotto l’egida del riconoscimento. Possiamo riconoscere (a) in (b) se e solo se abbiamo già avuto esperienza di (a) e sappiamo quale sia il suo aspetto e come si possa ritrovarlo nella sua identità, al di là delle diverse, possibili forme di manifestazione. Così, anche se questo non significa affatto sostenere che le raffigurazioni siano soltanto una copia della realtà e che sia quindi legittimo riproporre l’intero armamentario delle critiche platoniche all’immagine, vorrei sostenere che la possibilità di ogni raffigurazione poggia sulla nostra originaria esperienza del mondo e che anche un quadro astratto ha per noi una funzione rappresentativa solo perché ripropone colori e forme — quei colori e quelle forme di cui abbiamo già avuto infinite volte esperienze ed in cui risuona con una voce nuova e più facilmente percepibile l’eco del mondo.
Si tratta di un’osservazione ovvia, che ha tuttavia ricadute significative poiché ci invita a pensare alle immagini come a un luogo in cui qualcosa, seppure in forma nuova, si ripete. Le immagini implicano un riconoscimento e dunque chiedono che qualcosa in esse si ripeta. Ma la ripetizione è insieme la forma che attribuisce un senso nuovo all’eco del mondo che nell’immagine risuona. Nelle raffigurazioni gli oggetti e gli accadimenti della nostra esperienza si ripetono esemplarmente: ciò che si ripropone in un’immagine e che si fa riconoscere nel suo disegno è insieme qualcosa che viene nuovamente gettato sulla scena, liberandolo tuttavia dalla trama dei nessi esperibili e delle relazioni reali che normalmente lo rendono un momento in un contesto più ampio. La realtà ha questa forma: ogni evento si connette agli altri in una trama di relazioni complesse, in cui si stempera l’indipendenza e l’autonoma sensatezza di ogni singolo anello della catena. La realtà è sotto la presa del principio di ragion sufficiente, — un principio che (come aveva ben visto Schopenhauer) è insieme il riconoscimento del fatto che ogni singolo evento è di per sé privo di una ragione che lo giustifichi. Spetta alla forbice della ripetizione recidere la trama che lega ogni singolo evento alla totalità del reale, per riproporcelo per quello che è — un evento che dobbiamo cogliere nella sua autonoma datità e che assume, proprio per questo, una forma paradigmatica.
Credo che questa esemplarità sia una caratteristica dell’immagine e che sia possibile coglierla tanto nelle raffigurazioni che aspirano a mostrare un carattere nella sua peculiarità, quanto nei quadri che tentano di fissare un momento della vita, una sua occasionale vicenda. Così, un ritratto può voler fissare la verità di un volto, il suo essere così al di là delle singole occasioni o delle molteplici manifestazioni espressive che di volta in volta lo animano, e può farlo anche perché nel suo ripetersi sulla tela mantiene la sua riconoscibilità, ma guadagna una nuova indipendenza dai contesti mutevoli dell’esistenza. Ma anche una scena occasionale può assumere una valenza paradigmatica e divenire, per dir così, esempio di se stessa. In un quadro di Vermeer si mostra una scena come tante: davanti ad una grande carta geografica si vede una ragazza che sorride ad un uomo che, probabilmente, la corteggia. Una scena del genere avremmo forse potuto vederla anche noi, se solo avessimo spalancato all’improvviso la porta di una casa di Delft tre secoli e mezzo fa; ora, tuttavia, quella scena individuale siamo chiamati a riconoscerla sulla tela e ciò che vediamo assume un senso nuovo, poiché non abbiamo più il diritto di stemperare la sua autonomia e la sua sensatezza nel porla come un anello di una catena, ma dobbiamo coglierla per quello che è — come una scena che deve bastare a se stessa. Anche in questo caso, dunque, la ripetizione scioglie, i nodi che stringono l’evento alla realtà, rescindendo il nesso motivazionale che ci spinge a risalire dagli effetti alle cause e dalle cause agli effetti futuri. Proporre qualcosa nel gioco della ripetizione — e l’immagine è, in quanto tale, sotto la presa del riconoscimento e della ripetizione — significa allora chiedere che la raffigurazione venga colta per sé, come un’entità autonoma che non deve trovare al di là di se stessa un possibile completamento. E ciò è quanto dire che le raffigurazioni mettono in scena ciò che ci mostrano e lo recitano per noi, — una parola, questa, che nella sua stessa etimologia contiene un rimando esplicito alla ripetizione.
Sulla funzione “irrealizzante” della ripetizione e sulla particolare presenza che spetta agli oggetti raffigurati dovremo in seguito tornare. Ora invece, piuttosto che soffermarci su questi temi, è opportuno sottolineare un’ulteriore caratteristica che all’immagini deriva dal loro porsi sotto l’egida del riconoscimento. Dire che le raffigurazioni mettono nuovamente in scena ciò che ci presentano e che ci invitano a riconoscere ciò che ci mostrano non significa infatti sottolineare soltanto la separatezza che caratterizza l’universo figurativo: vuol dire anche puntare l’indice sull’analogia che lega le immagini alla dimensione della reminiscenza e del ricordo. Di questa analogia la poetica dell’immagine ha fatto da sempre una delle sue linee dominanti. Il tempo cambia di continuo l’aspetto delle cose e infine le cancella definitivamente; le immagini, invece, restano e danno consistenza alle parvenze, strappandole dalla loro inerenza all’attimo. Non è un caso che il ritratto sorga insieme al culto dei morti: le immagini restano, e consentono di salvare ciò che altrimenti si dissipa nel tempo ed è affidato alla mutevolezza dei ricordi, alla loro possibilità di svanire. Gli antichi — scrive Debray — opponevano alla decomposizione della morte la ricomposizione dell’immagine, e la statua o il dipinto ci appaiono così sotto il segno di una reazione alla morte, al suo porsi come dissolvimento dell’individualità. Il corpo passa e la statua o l’immagine trattengono l’umanità di una forma, animandola della gestualità viva ed espressiva di una posa, di un’espressione.
Ma forse non è necessario porre l’accento su questa piega cupa delle raffigurazioni e forse non è vero che l’arte antica sia necessariamente mortuaria. Nelle grotte di Lascaux o di Altamira non si raffigurano corpi umani, ma cavalli e bisonti, e non credo si possa cercare in questi antichissimi dipinti una reazione alla morte. Si può invece cogliere il desiderio di fermare ciò che si è visto, di dare consistenza ai fenomeni, per opporsi alla loro fuggevolezza e per creare insieme un mezzo per impadronirsene una volta per tutte. Il lavoro dello sguardo è sotto il segno del mito di Sisifo: è una fatica che non lascia traccia e che si perde insieme al trascorrere delle scene percettive. Le immagini, invece, restano, e forse il bambino trae proprio di qui il suo primo impulso al disegno: dalla scoperta che basta tenere in mano una matita per avere poi ben fermo di fronte agli occhi l’entusiasmo motorio di un gesto. Nel groviglio di linee che la matita ha lasciato sul foglio il gesto che l’ha formato è ancora presente e possiamo impossessarcene. E ciò che è vero per gli scarabocchi infantili, vale a maggiore ragione per le immagini in cui una scena si ferma e diviene un possesso stabile e sempre di nuovo disponibile, — un nostro possesso.
Le immagini non sono dunque soltanto il luogo in cui si ripete l’eco del mondo: sono anche il mezzo che ci consente di sentirlo più facilmente nostro — una funzione, questa, che ci è ben nota e cui evidentemente non sappiamo sottrarci quando nei viaggi o nelle occasioni importanti sentiamo il bisogno di fare mille fotografie, per essere certi di poter archiviare ordinatamente il presente — quando sarà passato.
2. La percezione di immagine: una descrizione fenomenologica
Nelle riflessioni che abbiamo appena proposto abbiamo cominciato intravedere un problema su cui dobbiamo riflettere. Le immagini, abbiamo detto, implicano un riconoscimento parziale che si ferma alla dimensione visibile di ciò che la tela ci mostra, dimenticandosi apparentemente del fatto che i segni e i colori che vediamo hanno comunque una consistenza reale e sono proprietà che appartengono ad una superficie e che dovrebbero essere quindi descritte proprio così, dicendo che abbiamo di fronte a noi un pezzo di tela variamente colorato e non, per esempio, la scena raffigurata di San Giorgio che uccide il drago.
Si tratta di un problema in cui ci siamo già imbattuti quando, discutendo le tesi di Gibson avevamo osservato quanto fosse difficile nel contesto delle sue argomentazioni rendere conto della persistenza dell’immagine accanto alla consapevolezza percettiva del suo essere in realtà null’altro che una certa configurazione della superficie materiale di un oggetto.
A questa difficoltà dobbiamo cercare ora di dare risposta, senza per questo dimenticarci della natura delle nostre riflessioni e quindi anche dei limiti entro cui debbono necessariamente essere contenute. Ciò significa, in primo luogo, che dobbiamo fare attenzione a formulare con cura la domanda che ci siamo posti. Questo interrogativo non può essere formulato così: come può accadere che la percezione della materialità della tela non tolga la percezione illusoria della scena raffigurata? A questa domanda non si può rispondere a colpi di filosofia, poiché essa chiama in causa la dinamica reale della percezione, il suo essere il frutto di una molteplicità di fattori fisici, fisiologici, neurologici di cui non si può venire a capo con qualche descrizione fenomenologica ed una serie di considerazioni grammaticali. Il fenomenologo non è uno psicologo cui sia misteriosamente risparmiata la fatica dell’esperimento e non può, proprio per questo, spiegare come qualcosa accada nella nostra mente: può invece cercare di chiarirne meglio il senso, ragionando su una molteplicità di esempi intuitivi. Per dirla con Wittgenstein: della percezione di immagini non ci interessano qui le cause, ma il concetto ed il posto che esso occupa nel sistema delle nozioni che caratterizzano l’esperienza percettiva. Ne segue che l’interrogativo cui possiamo dare risposta è meno ambizioso: possiamo soltanto chiederci quale sia il senso che attribuiamo da un lato alla percezione di immagine e, dall’altro, al suo coesistere accanto alla consapevolezza percettiva che di fronte a noi vi è soltanto una superficie materiale che non può certo ospitare realmente le cose che pure vi scorgiamo.
Che una simile dualità di piani sia in qualche modo implicata dalla percezione di immagine è un fatto che è difficile negare e di cui ci rendiamo conto non appena riflettiamo sulla natura dello spazio figurativo e sul rapporto che esso stringe con lo spazio reale. Se consideriamo la tela come un oggetto materiale la sua spazialità non pone problemi: la cornice circoscrive, in questo caso, un luogo tra gli altri ed ogni suo punto è in una qualche relazione obiettiva di natura spaziale con ogni altro oggetto del mondo. Ma se, come accade quando percepiamo un quadro, guardiamo la scena che in esso si raffigura, allora tutto cambia e la relazione tra la spazialità reale e la spazialità dell’immagine si fa avanti in tutta la sua problematicità. Questo rapporto è caratterizzato infatti, in primo luogo, da una reciproca estraneità e da una radicale differenza: cogliere una rappresentazione pittorica in quanto tale significa essere percettivamente consapevoli del fatto che non vi sono né possono esservi relazioni spaziali tra gli oggetti che circondano il quadro e ciò che appartiene alla sua dimensione figurativa. Si tratta di un’affermazione evidente da un punto di vista descrittivo e che non è difficile esemplificare. Se guardo un dipinto, vedo che il muro continua al di sotto del quadro; ma vedo anche allo stesso titolo — e quindi nella forma di ciò che Kanizsa chiamava presenza amodale — che le montagne che sulla tela sono dipinte soltanto a metà continuano al di là di essa scivolando al di sotto del legno che ne occulta la vista: ciò non toglie tuttavia che, ancora una volta, io sia percettivamente consapevole del fatto che non vi è nessun punto sotto la cornice in cui il muro e la montagna nel loro movimento si incontrino. Ciò che vedo sono due spazi separati l’uno dall’altro, ed è per questo che ciò che la cornice racchiude non è un luogo tra gli altri, ma uno spazio nuovo che non confina con lo spazio reale, ma irrompe in esso. E così come non vi è un confine che li separi, così non vi sono relazioni reciproche tra gli oggetti che loro appartengono. Per dirla con un esempio: il San Giorgio che uccide il drago di Bellini è nella predella di un quadro famoso, appeso sul muro di un palazzo di Pesaro, ma il drago che vedo dipinto non è in quel palazzo e non è vicino alla scalinata che dà accesso alla pinacoteca o a pochi passi dall’interruttore della luce. Nessuno si esprimerebbe così, e del resto nel luogo verso cui quelle descrizioni ci orientano il drago non può esserci, poiché in quel posto vi è già qualcos’altro — la tela che lo ospita. E sarebbe un errore credere che queste affermazioni implichino un qualche ragionamento complesso o ci chiedano di rammentare la diversa grammatica degli oggetti reali e degli oggetti dipinti; tutt’altro: che le cose stiano così è un fatto che è già tutto racchiuso nel senso della scena esperita e che non chiede ulteriori riflessioni poiché sorregge e guida la nostra percezione.
Che le cose appaiano così ad un corpo e ad una mente che appartengano ad una realtà animale simile all’uomo è un fatto che — è bene ripeterlo — ha cause complesse che sono tutt’altro che ovvie, ed è evidente che le nostre considerazioni fenomenologiche non possono certo spiegare come sia possibile la nostra esperienza della separatezza tra lo spazio figurativo e lo spazio reale. Possono invece aiutarci a fissarla con maggiore chiarezza. Alla complessità delle cause fa così eco l’ovvietà della situazione descrittiva: noi vediamo che lo spazio figurativo non è un luogo nello spazio reale, e questo ci invita a dire che la nostra esperienza delle immagini ha una forma fenomenologicamente complessa che si articola su due differenti livelli, che si fondano l’uno nell’altro.
Il primo livello — il livello percettivamente ineludibile — è quello della percezione ambientale: vedo una stanza, dei muri e, su di essi, una tela variamente colorata. Alla tela normalmente non presto alcuna attenzione, ma non per questo sarebbe lecito escluderla dal novero di ciò di cui sono ora percettivamente consapevole. E questo è vero indipendentemente dal genere pittorico del quadro che si osserva: anche nel caso della pittura in trompe l’œil — con buona pace di Zeusi e Parrasio — è davvero difficile smarrire la consapevolezza visiva del fatto che ciò che davvero potrei toccare, se solo stendessi la mano verso l’immagine che ho davanti agli occhi, è soltanto una tela o la superficie di un muro. Le ragioni di questo fatto ci sono ormai note e potremmo richiamare alla mente le considerazioni che abbiamo proposto quando ci siamo soffermati sulle tesi di Gibson; e tuttavia, anche se davvero ci capitasse di stendere la mano per afferrare il velo dipinto di cui Plinio ci narra, ad essere venuta meno sarebbe solo la coscienza di immagine, non la percezione ambientale, che si sarebbe anzi tanto ampliata sino ad abbracciare anche l’immagine, trasformandola in una falsa apparenza. Ed è proprio quest’espressione — falsa apparenza — che ci mostra che qui abbiamo abbandonato il terreno dell’esperienza di immagini: un’immagine non è affatto una falsa apparenza, poiché — come abbiamo osservato — la visione della scena dipinta convive con la certezza percettiva che di fronte a noi vi sia una tela, su cui si vedono vari disegni.
Forse, di fronte ad un simile modo di argomentare qualcuno potrebbe storcere la bocca ed osservare che un trompe l’oeil è comunque una raffigurazione anche quando non ci siamo ancora accorti dell’inganno che ci tende e crediamo effettivamente di avere a che fare con un oggetto reale che potremmo toccare ed afferrare con le mani. E se le cose stanno così (ed è difficile negarlo) che diritto ha una teoria della raffigurazione di rifiutarsi di rendere conto di un caso così ovviamente ostile alle sue tesi? Non vi è dubbio: una teoria della raffigurazione dovrebbe rendere conto anche di questo caso particolare e spiegare che cosa accada quando un trompe l’oeil ci inganna. Come filosofi, tuttavia, non siamo chiamati a far fronte a questo compito, e per la buona ragione che la nostra non è una teoria della raffigurazione e non si prefigge in alcun modo di spiegare perché percepiamo immagini e quale sia il criterio obiettivo che ci consente di dire come debba essere fatta una superficie qualsiasi per poter essere colta come una rappresentazione. Dalle nostre considerazioni fenomenologiche simili spiegazioni non si possono trarre e dobbiamo accontentarci di questo: di una serie di descrizioni che ci permettano di chiarire qual è la grammatica delle immagini e, quindi, che cosa caratterizzi la nostra esperienza quando qualcosa assume per noi il carattere di una raffigurazione. E se ci si pone in questa prospettiva è evidente che i trompe l’oeil non hanno molto da insegnarci: si danno come raffigurazioni solo quando l’inganno (se mai effettivamente si dà) si disvela e la coscienza di ciò che è raffigurato si lega alla consapevolezza che si tratta soltanto di una raffigurazione.
Del sostrato reale dell’immagine siamo dunque percettivamente consapevoli — eppure ne siamo consapevoli soltanto come di uno sfondo che si nasconde al nostro sguardo, poiché ciò che al suo posto vediamo è la scena dipinta con i suoi paesaggi e le sue immaginate vicende. Nella percezione di immagine vi è dunque un secondo livello: vediamo appunto San Giorgio che uccide il drago, e non badiamo alla tela e ai pigmenti su cui e da cui l’immagine nasce, anche se è proprio qui che il nostro sguardo cade. Sul fondamento della percezione ambientale si è dunque innestato un nuovo e diverso vedere, che ora ci occupa ma che può sussistere solo sul fondamento del primo: così, mentre è in linea di principio possibile disobbedire a Leonardo e percepire un muro scrostato senza accorgersi del disegno che le sconnessure dell’intonaco casualmente tracciano, non è possibile invece cogliere una rappresentazione in quanto tale senza che questo vedere poggi sulla presenza percettiva del sostrato reale che “sorregge” l’immagine.
Di qui si può muovere per trarre una prima conclusione. Se posso vedere la scena dipinta ed essere insieme percettivamente consapevole che, più o meno nascosta dall’immagine, vi è la tela con i suoi pigmenti, ciò accade perché ciò che vedo e ciò di cui sono percettivamente consapevole si dispongono su due diversi piani dell’esperienza che si escludono vicendevolmente come meta dell’interesse soggettivo, ma che sono tuttavia così nettamente distinti da poter sussistere l’uno accanto all’altro, senza per questo negarsi. Il guardare un’immagine è un’esperienza complessa: implica innanzitutto una percezione semplice che si rivolge al sostrato dell’immagine e che si lega alle altre percezioni che mi danno una piena consapevolezza dell’ambiente in cui sono. Ma sul fondamento di questo percepire si innesta un vedere il cui oggetto ha la grammatica delle raffigurazioni. Ciò che vedo sulla tela è soltanto un oggetto dipinto, un’immagine il cui essere si consuma nel mio percepirla.
Non è difficile scorgere in queste considerazioni l’eco delle riflessioni di Richard Wollheim sulla duplicità di piani (Wollheim parla di “twofoldness”) della percezione di raffigurazioni, di quel «vedere in» che a suo avviso caratterizza ogni afferramento percettivo di una rappresentazione in quanto tale. E tuttavia riconoscere il debito è importante anche per prendere almeno in parte le distanze dal modo in cui la dualità di piani della percezione di immagine trova una sua formulazione nella teoria del «vedere in». Alla sua origine vi è una considerazione in parte autocritica: non si può, per Wollheim, assimilare la percezione di immagine ad una forma di appercezione dell’oggetto che ci permetta di coglierlo alla luce di un qualche nesso di somiglianza, e questo perché quando cogliamo x come y di fatto cancelliamo la presenza di x e la rileggiamo alla luce del suo essere y. Ma questo non accade nella percezione di immagine perché la tela e i pigmenti non smettono di essere di fronte ai nostri occhi quando vediamo disegnarsi in essi la scena che il quadro raffigura. Di qui la tesi della duplicità insita nella percezione di immagine: per Wollheim, non è possibile vedere la raffigurazione di una scena senza che a questa percezione se ne leghi una seconda che ci mostri lo scheletro di quell’immagine, — la tela e i colori da cui è materialmente costituita.
Non credo che questo cammino debba essere percorso, e non per ragioni di carattere introspettivo che pure sembrano imporsi con particolare insistenza — chi davvero crede di vedere ad un tempo sia la tela sia il disegno che la anima? — ma per motivi di ordine concettuale: se anche fossimo capaci di vedere insieme i poli tra cui può muoversi la percezione di un quadro non avremmo ancora compreso l’ambiguità insita nel concetto di raffigurazione. E non a caso: per Wollheim, al di là delle sue stesse intenzioni, il guardare un quadro implica il mero coesistere di due percezioni che sono site sullo stesso piano e che sono connesse da una correlazione esterna, in virtù della quale l’una — la percezione di immagine — assume carattere illusorio, l’altra — la percezione del sostrato — tiene desta la presa dell’osservatore sulla realtà cui appartiene.
Ma le cose non mi sembra stiano così. Non mi sembra infatti che sia vero che percezione del sostrato e percezione di immagine siano atti percettivi del tutto comparabili, e per rendersene conto basta rammentare ciò che abbiamo dianzi osservato: mentre è possibile una percezione del quadro come realtà materiale indipendentemente dall’occorrere di una percezione di immagine, non è possibile invece percepire qualcosa come una raffigurazione se nel contenuto di senso della percezione stessa non è in qualche modo implicato il rimando al sostrato su cui la rappresentazione sorge. Posso non accorgermi dei resti di un affresco che ricopre il muro di una chiesa e cogliere nei colori che raffigurano la scena dipinta nulla di più che il colore della parete; non è possibile invece cogliere in quanto tale la scena raffigurata senza che sia in qualche modo presente anche il piano cui aderisce: se infatti un dipinto ci ingannasse a tal punto da non farci scorgere la tela che lo ospita, allora dovremmo semplicemente riconoscere che ciò che in sé è una raffigurazione non lo è più per noi, poiché per noi è divenuto un momento della realtà, una sua parte integrante. Ne segue che la consapevolezza del nesso che lega la scena raffigurata alla superficie su cui poggia non è qualcosa che si aggiunga dall’esterno alla percezione di ciò che nel quadro si raffigura, ma è piuttosto un suo momento interno: se ciò che vedo fa sì che io percepisca la battaglia che ho di fronte come una raffigurazione, questo non accade perché a questa percezione se ne affianca una nuova — quella del muro, ma perché il muro qua sostrato dell’immagine è colto come ciò che è nascosto, ma non negato dalla scena cui rivolgo principalmente il mio sguardo. Di qui il carattere di finzione della scena stessa: proprio perché percepisco la scena dipinta senza dover per questo «perdere di vista» la superficie cui appartiene posso intendere ciò che il quadro mi mostra come un’irruzione dell’immagine nel reale, dello spazio della figurazione nello spazio delle cose. In altri termini: proprio perché vedo nella scena raffigurata l’aderenza al sostrato reale che la pone, debbo poi disporre in un orizzonte solo figurativo ciò che osservo nel quadro.
Ritroviamo quest’ordine di considerazioni se riflettiamo un poco su un tema che a Wollheim sta molto a cuore e che lo costringe a spingersi in prossimità delle osservazioni che abbiamo fatto valere: anche se non si rinuncia a porre una relazione esterna tra i due piani della percezione di immagine è difficile non rendersi conto che vi sono casi in cui una qualche relazione tra il piano figurativo e i mezzi di cui il pittore si avvale è direttamente implicata sul piano stilistico. Non è difficile comprendere che cosa Wollheim ha in mente. Vi sono pittori ed epoche storiche in cui tra i compiti del pittore vi è quello di celare quanto più è possibile la materialità della tela e dei pigmenti, ed una parte interessante della storia della pittura ci invita a riflettere sulle tecniche e sui materiali che sono stati di volta in volta scelti per rendere difficilmente percepibile la prassi concreta del dipingere, il fatto che ogni raffigurazione consta infine di pigmenti distesi su una superficie materiale. Tutto questo «deve parere per niente» come scrive il Lomazzo, ed allora il pittore deve stendere con infinita pazienza il colore, cancellando ad ogni nuova mano i segni che il pennello ha lasciato nell’impasto dei colori. Ma vi sono artisti ed epoche storiche che non si lasciano sedurre da questo precetto e che ci invitano a cogliere nel disegno il segno e nella scena pittorica la resistenza materiale del sostrato che la ospita. Così Wollheim ci invita a osservare che vi sono pittori che sfruttano la duplicità di piani della percezione di immagine per istituire corrispondenze e analogie tra il medio della rappresentazione e il suo oggetto, e ciò fa sì che il pittore sia costretto a non lasciare fluttuare questi due livelli dell’immagine, per metterli invece in una qualche relazione. Gli ultimi quadri di Tiziano ci offrono un possibile esempio di ciò cui Wollheim mira: il colore non è solo colore delle membra, ma anche materia cromatica che si lascia cogliere nella sua corposa consistenza. E ciò che vale per la seconda maniera di Tiziano vale evidentemente in misura maggiore per un pittore come van Gogh o per lo sperimentalismo del xx secolo.
Si tratta di un’osservazione importante, e tuttavia non credo che si possa venire a capo di questo problema istituendo una relazione tra due diversi piani in cui si scandisce la percezione di immagine. Ciò che mi pare infatti determinare il senso di questo come (in diversa proporzione) di ogni altro quadro non è l’essere accanto ma il trasparire della materia cromatica e del tratto pittorico nel contesto figurativo. Le immagini pittoriche vivono su una superficie che può essere facilmente scrostata e che ha una sua greve materialità. E tuttavia, il riconoscimento della natura materiale del segno non si traduce nella tesi secondo la quale i pigmenti in quanto tali sarebbero chiamati in causa dalla fruizione dell’immagine. Ciò che in quadro come Apollo e Marsia di Tiziano ci colpisce non è il suo essere fatto di un impasto di terre e olio, ma il porsi delle figure nel loro essere visibilmente costruite dal tocco di un pennello carico di materia cromatica. Possiamo allora esprimerci così: l’essere fatto da pennellate di colore chiaramente percepibili non è una proprietà materiale del quadro ma è una caratteristica della scena raffigurata in quanto tale, che si manifesta percettivamente proprio così — come un’immagine che ha queste e non altre caratteristiche fenomenologiche. E ciò è appunto quanto dire che la percezione di immagine non è una rappresentazione di qualcosa cui, per caso, si affianchi la percezione del sostrato materiale della raffigurazione, ma è il risultato di una percezione complessa che, senza cancellare la consapevolezza percettiva del fatto che di fronte a noi vi è un oggetto tra gli altri, ci consente di cogliere quella configurazione di linee e di colori che anima la sua superficie come se fosse un volto o un paesaggio.
Questo mi sembra essere il senso di ciò che vediamo in un’immagine; come ciò possa accadere non spetta alla fenomenologia spiegarlo.
Lezione ottava
1. Sotto una diversa luce
Nella lezione precedente abbiamo cercato di comprendere meglio il nesso che lega la forma del riconoscimento che ha luogo nelle immagini alla struttura complessa della loro percezione, ed ora vorrei tentare di fissare meglio i punti cui siamo giunti.
Potremmo formulare così la prima conclusione che abbiamo tratto: la percezione di immagine implica un riconoscimento che non tocca la dimensione materiale dell’immagine (il suo essere, per esempio, un foglio di carta su cui vi sono alcune tracce di grafite) ma solo la dimensione fenomenica di ciò che su di essa ci si mostra. Riconosciamo nelle linee che la matita ha tracciato un volto e lo vediamo appunto così — come un ritratto, e cioè a dire come un volto raffigurato. Di qui la nostra seconda conclusione: il riconoscimento parziale che ha luogo quando vedo nel segno il disegno ha la sua eco nella natura complessa della percezione di immagine, nel suo porsi come una forma di esperienza che si fonda sulla percezione ambientale e che ci consente di cogliere sul fondamento di uno spazio reale uno spazio figurativo. Queste due tesi, tuttavia — ed è questa la terza conclusione cui eravamo giunti — si sostengono reciprocamente: il riconoscimento nella percezione di immagine può dirsi parziale proprio perché concerne esclusivamente l’oggetto raffigurato e non tocca il sostrato reale della raffigurazione — il suo porsi come un elemento del mondo che non è affatto identico con ciò che, in quanto tale, l’immagine ci mostra. D’altro canto, la percezione di immagine può porsi come una percezione che si fonda sulla percezione ambientale e che lascia trasparire in forma nuova le caratteristiche fenomeniche del sostrato dell’immagine solo perché vi è un riconoscimento che fa presa su di esse e che le sceglie tra le altre proprietà sensibili della tela. Sul fondamento della percezione ambientale può costituirsi una percezione di immagine solo perché ciò che vediamo consente un riconoscimento parziale che seleziona, tra le proprietà che riempiono lo spazio reale occupato dalla tela, solo quelle che possono giocare, seppure in una nuova forma, un ruolo nello spazio figurativo.
Di qui le osservazioni che abbiamo più volte proposto per descrivere la natura degli oggetti raffigurati. Che ciò che vediamo dipinto su una tela o raffigurato in una fotografia non sia, in senso proprio, un oggetto è una conclusione che abbiamo più volte tratto e che è già racchiusa nella tesi secondo la quale ciò che si disegna sulla tela ha natura meramente fenomenica e non possiede una realtà che vada al di là del suo essere percepito e riconosciuto da chi guarda l’immagine. Quando, guardando un quadro, diciamo che vi vediamo dipinto un paesaggio intendiamo di fatto sostenere che al nostro vedere così non corrisponde affatto un oggetto reale. Qui la parola “dipinto” vale come un predicato modificante e non aggiunge quindi al soggetto di cui si predica una proprietà che ci consenta di saperne qualcosa di nuovo, ma ci dice soltanto che quel paesaggio non c’è, se non nelle pieghe fenomeniche dell’immagine: un paesaggio soltanto dipinto non è affatto un paesaggio reale che abbia questa proprietà, proprio come un falso amico non è un amico che, tra le altre cose, sia anche falso.
Tutto questo ci è noto, e tuttavia di queste stesse considerazioni dobbiamo cercare di rendere conto seguendo un cammino nuovo, che ci consenta di coglierle sotto una diversa luce. Dobbiamo, in altri termini, cercare di ricomprendere la specificità delle raffigurazioni ponendo in primo piano la loro peculiare spazialità ed il rapporto che esse stringono con lo spazio reale. Le immagini sorgono dove possono — dove qualcosa consente di far presa ad un riconoscimento raffigurativo; una superficie variamente colorata è un possibile esempio di ciò che intendiamo. Ora, ciò che in una simile superficie si scorge è un fenomeno che irrompe nello spazio reale senza per questo metterlo in discussione: ciò che vediamo disegnarsi su una parete affrescata non ha la pretesa di dire come stiano in realtà le cose ed è per questo che il suo apparire non nega — e non è negato — dalla consapevolezza che là dove vediamo villaggi e campagne vi è soltanto un muro intonacato con calce mischiata a diverse tempere. E come per ogni fenomeno, anche per gli oggetti della raffigurazione vale la regola che connette l’esse al percipi e che li vincola quindi alla presenza di uno spettatore: le immagini sono oggetti per un soggetto, e questo le distingue dalle cose reali che nel loro senso non implicano una soggettività che le percepisca.
Quale forma si debba dare a queste considerazioni non appena ci disponiamo sul piano della spazialità è presto detto. Lo spazio figurativo è fenomenologicamente distinto dallo spazio reale: tra gli oggetti raffigurati e gli oggetti reali che circondano il quadro non ha senso porre alcuna relazione spaziale, così come non ha senso cercare la linea che fa da confine allo spazio figurativo distinguendolo dallo spazio reale — una simile linea non vi è perché lo spazio reale e lo spazio dell’immagine appartengono a due differenti scene dell’esperienza e non possono essere unificati in unico spazio. Su questo punto ci siamo già soffermati: non avrebbe davvero senso dire che San Giorgio uccide il drago in un luogo definito di un palazzo di Pesaro, poiché in quel luogo San Giorgio non c’è e tanto meno il drago — vi sono invece la tela, i pigmenti e la cornice, che di fatto occupano proprio il luogo in cui vediamo ripetersi quel famoso combattimento. La percezione di immagine tuttavia non implica soltanto, ma si fonda necessariamente sul terreno della percezione diretta, e ciò fa sì che la tela e i colori ci appaiano alla lettera trasfigurati nella scena rappresentata. Così stanno le cose anche per ciò che concerne la spazialità dell’immagine. Certo, il drago che San Giorgio uccide non è racchiuso nella cornice: gli oggetti che si danno nell’immagine non esistono e quindi non occupano un posto nello spazio obiettivo. Eppure quel drago ci appare raffigurato in un luogo dello spazio che possiamo indicare: il drago lo vediamo proprio qui, davanti a noi. La percezione visiva assegna dunque alle scene raffigurate un luogo nello spazio: anche se non sono in nessun luogo, è comunque possibile sostenere che le scene raffigurate hanno una loro localizzazione — almeno dal punto di vista fenomenico.
Sappiamo già in che modo sciogliere questa contraddizione apparente. Davanti allo spettatore, dal punto di vista obiettivo, vi è soltanto la tela, ed è questa relazione spaziale che prende forma nella percezione ambientale in cui di fatto si costituisce per noi il mondo della nostra esperienza. Questa relazione obiettiva può tuttavia mutare di segno non appena ci poniamo sul terreno figurativo: la tela è qui di fronte a me, ma proprio per questo la scena che sulla tela si raffigura guadagna per chi l’osserva una sua collocazione fenomenica. La scena dipinta e la tela hanno dunque qualcosa che le accomuna poiché entrambe si rapportano ad una soggettività che le esperisce e che le vede proprio qui, di fronte a sé. Così, anche se non vi è nessuna relazione tra le regioni dello spazio reale e le regioni dello spazio figurativo, vi è tuttavia una coincidenza parziale nella deissi: l’indice dello sguardo si orienta in entrambi i casi nella stessa direzione e propone un identico cammino, anche se allude a due mete differenti. Possiamo sostenere allora che la relazione percettiva che lega lo spettatore all’immagine diviene il tramite di una relazione spaziale sui generis tra gli elementi dello spazio figurativo e chi li osserva.
Che non si tratti di una relazione reale è appena il caso di dirlo: non vi è, per esempio, un metro che ci consenta di misurarla, poiché non è possibile porre un regolo rigido tra lo spettatore e ciò che vede nell’immagine, per la buona ragione che ciò che appare raffigurato non c’è e non può quindi essere toccato dall’estremità del metro. Un discorso analogo vale per le dimensioni dello spazio figurativo: anche in questo caso non è possibile constatarne obiettivamente la profondità o la grandezza poiché un metro reale può consentirci di misurare la distanza tra i legni della cornice o tra determinati punti della tela, ma non può toccare con i suoi punti estremi gli oggetti raffigurati, mentre un metro che appartenga allo spazio figurativo può misurare lo spazio tanto poco quanto una bilancia dipinta può valutare un peso. E non a caso: lo spazio figurativo si risolve nel suo essere percepito e non consente nessun’altra misurazione se non quella apparente che si determina nell’esperienza visiva e che ci fa dire che le cose sembrano ora vicine, ora lontane.
Del resto, per sottolineare il carattere meramente fenomenico dello spazio figurativo ed il significato nuovo che su questo terreno spetta ad ogni termine che alluda alla spazialità avremmo potuto seguire un diverso cammino: avremmo potuto osservare che se si può parlare di una relazione spaziale sui generis tra l’immagine e chi la guarda è solo perché, sia pure implicitamente, abbiamo fatto valere una restrizione importante: in senso stretto, davanti alla scena raffigurata vi è solo lo spettatore in quanto tale, non il suo corpo come oggetto reale nel mondo. Su questo punto è opportuno spendere qualche parola. Davanti a un quadro vi sono molte cose e tra queste posso esserci anch’io, ed è del tutto indifferente se lo osservo o se gli volgo le spalle: perché io sia davanti al quadro e ad una certa distanza da esso è sufficiente che sia possibile raggiungermi dopo un numero finito di passi muovendo dalla tela in una direzione determinata. È difficile sostenere che le cose stiano così quando abbiamo a che fare non con la tela, ma con ciò che in essa si raffigura. Davanti alla scena raffigurata in un quadro non vi sono molte cose, ma vi è soltanto lo spettatore in quanto tale, ed è per questo che il drago che San Giorgio uccide non è dietro di me, quando gli volgo le spalle, poiché il porsi di questa relazione spaziale sui generis fa tutt’uno con la specificità dell’orientamento dello sguardo che mi lega all’immagine[7].
Non solo la scena raffigurata, ma anche la soggettività che la osserva deve essere colta a partire dalla relazione cognitiva che la lega all’immagine: la relazione spaziale sui generis che si dà nella percezione raffigurativa non ha luogo tra due termini reali, ma si dispiega interamente sul terreno percettivo. Lo spazio figurativo si rapporta alla soggettività percipiente dello spettatore, non all’esserci obiettivo del suo corpo — anche se evidentemente l’orientamento e la localizzazione fenomenica che caratterizzano l’esperienza percettiva dello spettatore si fondano su un fatto: ogni esperienza è esperienza di una corporeità viva che occupa un posto obiettivo nello spazio.
Di qui, da queste considerazioni sulla natura dello spazio figurativo, possiamo muovere per cogliere in una nuova prospettiva la tesi secondo la quale il porsi di qualcosa come un’immagine è un predicato intenzionale che implica il rimando ad una soggettività. Questa tesi deriva direttamente da ciò che abbiamo detto sin qui, ma assume una caratterizzazione intuitiva più ricca non appena ci immergiamo nelle nostre riflessioni sulla spazialità dell’immagine. Lo spazio figurativo, avevamo osservato, non è un luogo tra gli altri e questa sua peculiarità si rivela nell’impossibilità di istituire sensatamente una relazione spaziale tra gli oggetti che gli appartengono e gli oggetti reali. Ora, questa tesi non è negata dal fatto che l’immagine stringa una relazione spaziale con lo spettatore: sappiamo infatti che non si tratta di una relazione obiettiva e che lo spettatore non è posto come un oggetto tra gli altri. Di qui, tuttavia, si può trarre una conclusione nuova: si può sostenere infatti che la peculiarità della relazione spaziale che lega l’immagine allo spettatore è la controparte intuitiva del nesso di dipendenza che in quanto tale lega l’immagine ad un io. Ogni immagine è caratterizzata dal suo essere volta a: proprio perché inerisce alla tela, l’immagine può catturare lo sguardo dello spettatore — quello sguardo in virtù del quale soltanto l’immagine si fa immagine. L’immagine ha dunque bisogno dello spettatore, ma è insieme volta ad esso: il disporsi della scena dipinta sulla tela indica allo spettatore dove sia lo spazio figurativo e dove gli oggetti in esso raffigurati. Ma ciò è quanto dire che lo spazio figurativo racchiude in sé il rimando ad un luogo cui si rivolge e rispetto al quale si dispiega: il luogo dello spettatore. Questo luogo non appartiene allo spazio reale, poiché è posto dalla scena dipinta e dal suo rivolgersi in una direzione determinata verso uno spettatore ideale: la funzione dello spettatore e il suo luogo appartengono quindi al dispositivo della raffigurazione. Vi è dunque un luogo, al di là dello spazio figurativo, che la scena dipinta in quanto tale addita e che lo spettatore deve occupare, e questo luogo non può essere compreso se non a partire dalla raffigurazione stessa. Allo spazio figurativo in senso stretto si deve affiancare così da un lato il luogo che lo spettatore occupa e dall’altro, tra lo spettatore e il quadro, lo spazio di risonanza dell’immagine — quello spazio cui alludiamo quando diciamo che la scena raffigurata è distante da noi o quando affermiamo che qualcuno si protende dall’immagine verso lo spettatore per parlargli o per porgergli qualcosa.
La dipendenza dell’immagine dallo spettatore diviene così il mezzo che consente all’immagine di aprirsi un varco verso chi la guarda coinvolgendolo nello spazio soltanto fenomenico della raffigurazione.
2. Un esempio
Nell’ora precedente abbiamo proposto varie considerazioni di natura teorica sul rapporto tra l’immagine e lo spettatore, e ora — anche se non abbiamo ancora detto tutto quello che è necessario per poter parlare di un quadro — vorrei invitarvi a riflettere un poco su un dipinto di Velázquez, intitolato Las Meninas. Di questo quadro famoso vorrei parlare anch’io ma da filosofo, ed è proprio qui che sorge il nostro primo problema: parlare di un quadro significa innanzitutto riflettere sulle sue qualità estetiche e pittoriche, cercare di coglierne i debiti stilistici e le fonti iconografiche, per tentare poi un’interpretazione complessiva del suo significato — e non vi è dubbio che per ciascuno di questi compiti le mie conoscenze siano semplicemente inadeguate. E questo sembra suggerirmi una conclusione impietosa: forse, per un filosofo, il miglior modo di parlare di un quadro è il parlarne a voce bassa, se proprio non riesce a tacere.
Si tratta di una conclusione che non vi invito a condividere e questo perché sono convinto che in molte delle grandi immagini della nostra come delle altre culture figurative, proprio come in molti altri prodotti dell’immaginazione artistica in generale, siano racchiuse suggestioni che ci danno da pensare, e su cui il filosofo non può chiudere gli occhi proprio perché lo invitano a riflettere su temi e problemi che possono di fatto appartenere all’orizzonte teorico che gli compete. Certo, in un quadro o in un racconto vi è molto di più di quanto non sia di stretta pertinenza della riflessione filosofica, ma ciò non toglie che il filosofo possa egualmente sfogliare il catalogo delle opere d’arte per trarre qualche suggerimento utile per il proprio lavoro. Talvolta la filosofia dell’immagine può procedere così: cercando nelle immagini una conferma ed un’illustrazione dei temi che le sono propri. Così, se nonostante tutto e tra mille cautele mi avventuro in una riflessione su Las Meninas è perché credo che una lettura attenta di alcuni aspetti di questo capolavoro di Velázquez ci inviti a riflettere su un tema che appartiene di diritto all’universo teorico di una filosofia dell’immagine — il rapporto che lega ogni raffigurazione allo spettatore che la contempla.
 Guardiamo
questo quadro. È in primo luogo il ritratto di una bambina di cinque anni —
Margherita, l’infanta di Spagna. Andrà in sposa a Leopoldo I d’Austria e morirà
giovanissima, lasciando di sé quasi solo
quest’immagine. Ma sarebbe insensato dire che Las Meninas è soltanto il ritratto di Margherita: il quadro ritrae
anche una piccola vicenda della vita di corte. La bambina ha chiesto
dell’acqua che le viene portata in un bucchero rosso da María Augustina de
Sarmiento, una giovane aristocratica cui fa da contrappunto la figura di
un’altra giovane, Isabel de Velasco, figlia del Conte di Colmenares. Ma il
quadro si complica ancora se abbandoniamo progressivamente il suo centro tematico,
ampliando il raggio della nostra visuale. Compaiono allora le figure dei due
Velázquez: l’uno, il pittore, intento a dipingere una grande tela che si nega
al nostro sguardo, l’altro un maresciallo di palazzo che in comune con il
pittore ha solo il cognome e che — prima di abbandonare la scena del dipinto —
si volge verso di noi, disponendo la sua persona nella cornice della porta. In mezzo ai due, uno specchio riflette una coppia
illustre: Filippo IV di Spagna con sua moglie, la regina Marianna d’Austria. E
se alla nostra sinistra il dipinto è occupato dalla grande tela cui Diego
Velázquez lavora, sulla destra compaiono altri personaggi minori: in primo piano
vi sono due nani — l’una con le mani giunte, l’altro intento a stuzzicare un
grosso e pacifico cane — mentre sullo sfondo si sono due servitori, che
conversano tra loro, anche se uno si è proprio ora rivolto verso di noi.
Immerse nell’oscurità sulla parete che chiude la stanza vi sono infine alcune
grandi tele di soggetto mitologico: Atena
che punisce Aracne di Rubens e una copia della Contesa di Apollo e Pan di Jordaens.
Guardiamo
questo quadro. È in primo luogo il ritratto di una bambina di cinque anni —
Margherita, l’infanta di Spagna. Andrà in sposa a Leopoldo I d’Austria e morirà
giovanissima, lasciando di sé quasi solo
quest’immagine. Ma sarebbe insensato dire che Las Meninas è soltanto il ritratto di Margherita: il quadro ritrae
anche una piccola vicenda della vita di corte. La bambina ha chiesto
dell’acqua che le viene portata in un bucchero rosso da María Augustina de
Sarmiento, una giovane aristocratica cui fa da contrappunto la figura di
un’altra giovane, Isabel de Velasco, figlia del Conte di Colmenares. Ma il
quadro si complica ancora se abbandoniamo progressivamente il suo centro tematico,
ampliando il raggio della nostra visuale. Compaiono allora le figure dei due
Velázquez: l’uno, il pittore, intento a dipingere una grande tela che si nega
al nostro sguardo, l’altro un maresciallo di palazzo che in comune con il
pittore ha solo il cognome e che — prima di abbandonare la scena del dipinto —
si volge verso di noi, disponendo la sua persona nella cornice della porta. In mezzo ai due, uno specchio riflette una coppia
illustre: Filippo IV di Spagna con sua moglie, la regina Marianna d’Austria. E
se alla nostra sinistra il dipinto è occupato dalla grande tela cui Diego
Velázquez lavora, sulla destra compaiono altri personaggi minori: in primo piano
vi sono due nani — l’una con le mani giunte, l’altro intento a stuzzicare un
grosso e pacifico cane — mentre sullo sfondo si sono due servitori, che
conversano tra loro, anche se uno si è proprio ora rivolto verso di noi.
Immerse nell’oscurità sulla parete che chiude la stanza vi sono infine alcune
grandi tele di soggetto mitologico: Atena
che punisce Aracne di Rubens e una copia della Contesa di Apollo e Pan di Jordaens.
Basta dare uno sguardo al quadro che si è venuto delineando sotto i nostri occhi, per rendersi conto che di un semplice ritratto non si può davvero parlare, e nemmeno di una scena di corte. Tutt’altro: al ritratto si affianca l’autoritratto, al quadro dipinto la tela che viene dipinta, ai personaggi che recitano la loro piccola storia le molte figure che si rivolgono allo spettatore. E poi, in fondo, sulla parete, uno specchio, e quindi un’allegoria della pittura che anticipa concettualmente la competizione mimetica in cui il pittore è impegnato, — una competizione che si ripete nei soggetti mitologici dei quadri appesi alla parete e riprodotti da Velázquez. Ce n’è quanto basta per giustificare il nostro assunto iniziale: tra le molte pieghe di questo quadro vi è anche una riflessione sul concetto di raffigurazione.
Del resto, nel proporre questa tesi non facciamo altro che ripercorrere un cammino più volte intrapreso, ed in particolar modo è il nome di Foucault che deve essere fatto. In un saggio intitolato Le damigelle d’onore, raccolto in Le parole e le cose (1966), Foucault ha cercato di cogliere in questo capolavoro di Velázquez l’eco visiva di un concetto che riveste un ruolo centrale nella filosofia moderna. Il dramma che si agita sotto i nostri occhi è il dramma del concetto filosofico di rappresentazione, di questo concetto che si radica nella soggettività ma non può parlarci del soggetto e che, d’altro canto, proprio perché è immerso nella coscienza, non può racchiudere in sé ciò che è trascendente — l’oggetto cui pure tende. Di questa dialettica della rappresentazione, il quadro di Velázquez ci offre un’illustrazione esemplare, almeno secondo Foucault. Il quadro è innanzitutto un autoritratto e già questo allude ad una tensione rappresentativa: nel suo farsi autoritratto, il quadro sembra voler alludere a quel punto che è necessariamente invisibile — allo sguardo del pittore che lo organizza. E tuttavia, nel suo presentarsi come un oggetto tra gli altri, il pittore rinvia necessariamente alla sua soggettività che nel quadro non c’è, né può propriamente esservi. Ma è sullo specchio che le attenzioni di Foucault si focalizzano, ed anche se non pretendiamo di restituire per intero le argomentazioni ricche e sfuggenti di questo saggio, il loro nucleo è chiaro: per Foucault, lo specchio è uno sguardo che esce dal quadro per mostrarci ciò che sta al di là del quadro, nel nostro spazio. Ora, ciò che nello specchio si riflette e che si deve trovare proprio di fronte ad esso — la coppia reale — è a sua volta meta di due differenti sguardi che dal quadro le vengono rivolti: la osserva infatti il Velázquez pittore che la dipinge sulla tela, ma anche l’altro Velázquez che fa da spettatore poiché — scrive Foucault — non vi è dubbio che egli si volga a guardare il modello che il suo omonimo dipinge — il re e la regina. E tuttavia, in questa suo andare fuori da sé, l’immagine tace comunque ciò che cerca di dire: lo specchio non può mostrarci che un riflesso del modello cui il quadro assomiglia, ed il prezzo di questa parvenza è il silenzio su chi dovrebbe invece apparire nell’immagine riflessa: il pittore e lo spettatore, che devono scrutare la scena dipinta proprio dal punto che fronteggia lo specchio e che è invece occupato dalla famiglia reale. Alla scena dipinta e visibile fa così eco un punto reale e invisibile: il luogo che il soggetto e l’oggetto dell’immagine occupano e che lo specchio si rivela incapace di catturare Nel suo tentativo di andare di là da se stessa, l’immagine si scontra così ancora una volta con il limite costruttivo che la caratterizza.
Queste poche considerazioni sono forse sufficienti per rendere conto della ricchezza dell’interpretazione che Foucault ci suggerisce, — un’interpretazione che è meno lineare ma più ricca di quella che Searle doveva avanzare pochi anni dopo. Un punto tuttavia le accomuna: Searle e Foucault sono convinti che lo specchio rifletta un punto esterno allo spazio del quadro e che questo punto non soltanto ospiti la famiglia reale che il Velázquez dipinto a sua volta dipinge, ma sia anche il luogo in cui lo spettatore deve porsi (o deve immaginare di porsi) per cogliere la scena così come il pittore l’ha vista (o ha immaginato di averla vista).
Ora, quale sia questo luogo esterno al quadro è presto detto: vi è infatti un solo luogo che deve essere condiviso dallo spettatore e dal pittore, ed è il punto di vista definito dalla costruzione prospettica. Tanto per Foucault, quanto per Searle, la peculiarità costruttiva del quadro di Velázquez poggerebbe dunque su questo assunto: una costruzione prospettica centrale che pone il punto di proiezione del quadro di fronte allo specchio, che proprio per questo dovrebbe riflettere l’immagine del pittore che l’ha dipinta o dello spettatore che la guarda. Al suo posto, tuttavia, lo specchio restituisce l’immagine della famiglia reale che — concludono un po’ sbrigativamente Searle e Foucault — deve trovarsi anch’essa in quel luogo affollato che la costruzione prospettica indica e cui lo spettatore e il pittore non possono idealmente rinunciare, poiché solo per chi osservi da quel luogo è possibile scorgere nello specchio ciò che il dipinto ci mostra, — l’immagine riflessa della famiglia reale. L’oggetto e il soggetto del quadro si perderebbero così l’uno nell’altro, costretti a condividere un luogo la cui visibilità resterebbe comunque enigmatica.
 Di
fronte ad argomenti così affascinanti e ricchi di suggestioni come quelli di
Foucault e di Searle può sembrare perfino sgarbato prendere in mano squadra e
righello per vedere se le cose stiano davvero così come ci si dice. E tuttavia
sarebbe sbagliato non farlo, poiché il gioco di sguardi e di riflessi su cui siamo
chiamati a riflettere deve comunque essere percepibile, e può esserlo solo se
non si contravviene alla geometria che lo sorregge. Dobbiamo allora chiederci
se è davvero lecito sostenere che il punto di proiezione del quadro di Velázquez
sia posto di fronte allo specchio. Rispondere a questa domanda non è difficile,
poiché Velázquez ci offre più di un indizio per cogliere quale sia il punto di
fuga: le lampade sul soffitto, la linea che segna la sua intersezione con la
parete alla nostra destra, lo stipite superiore delle finestre, le cornici dei
quadri sui pilastri indicano tutti un unico punto — quella mano della figura incorniciata
dal vano della porta, cui Velázquez dà risalto sia in termini di luce, sia in
termini compositivi. Ma se questo è il punto di fuga, il punto di costruzione
di questa prospettiva eccentrica sarà
comunque di fronte ad esso, ed è qui — di fronte al vano della porta dipinta —
che dovrà idealmente porsi lo spettatore. E del resto come dubitarne, se tante
persone rivolgono il volto e lo sguardo verso un identico luogo che fronteggia evidentemente la figura del secondo Velázquez?
E se questo è il punto di vista che la costruzione prospettica ci invita
idealmente ad assumere, lo specchio — che ci apparirà come una superficie su
cui lo sguardo cade obliquamente — non potrà più mostrarci ciò che gli sta di
fronte: rifletterà qualcosa che si trova sulla sua destra (o se si preferisce:
alla nostra sinistra), come sa chiunque abbia giocato almeno un poco con gli
specchi. Rifletterà insomma la grande tela che Las Meninas ci mostra nella sua parte cieca, svelandoci così
l’arcano della sua figurazione: il quadro che Velázquez sta dipingendo (o ha
appena terminato di dipingere) raffigura la coppia reale. Ne segue che — secondo
la migliore tradizione metafisica — lo specchio ci mostra l’immagine di
un’immagine, e ciò è quanto dire che lo “sguardo” della riflessione non
abbandona affatto lo spazio figurativo del quadro. Queste considerazioni che
abbiamo proposto un poco alla buona hanno trovato una loro illustrazione esemplare
in un saggio del 1980 di Snyder e Cohen (Riflessioni
su Las Meninas: il paradosso perduto. Risposta critica), un saggio per
molti versi ammirevole e che dimostra in modo definitivo quale sia il punto
dello spettatore e quale il riflesso che per quel punto lo specchio
restituisce. La restituzione prospettica del Las Meninas che qui riproduco trae di lì la sua origine, ed è un
argomento sufficiente per mostrare l’insostenibilità delle tesi di Searle e
Foucault, — due tesi che non avrebbe senso cercare di difendere sottolineando
la differenza, per certi versi ovvia, tra la libertà dell’artista e la normatività
dell’ottica geometrica, poiché da un lato questa differenza è messa a tacere
proprio dalla sostanza dei loro argomenti, dall’altro perché Velázquez non avrebbe
mai spinto quell’ovvia distinzione sino al punto di scardinare la consistenza
ottica e geometrica dell’immagine. Velázquez, del resto, di specchi se ne
intendeva e se la Venere allo specchio
(1644-48) può guardarci ciò accade soltanto perché il suo autore conosce bene
le leggi della riflessione.
Di
fronte ad argomenti così affascinanti e ricchi di suggestioni come quelli di
Foucault e di Searle può sembrare perfino sgarbato prendere in mano squadra e
righello per vedere se le cose stiano davvero così come ci si dice. E tuttavia
sarebbe sbagliato non farlo, poiché il gioco di sguardi e di riflessi su cui siamo
chiamati a riflettere deve comunque essere percepibile, e può esserlo solo se
non si contravviene alla geometria che lo sorregge. Dobbiamo allora chiederci
se è davvero lecito sostenere che il punto di proiezione del quadro di Velázquez
sia posto di fronte allo specchio. Rispondere a questa domanda non è difficile,
poiché Velázquez ci offre più di un indizio per cogliere quale sia il punto di
fuga: le lampade sul soffitto, la linea che segna la sua intersezione con la
parete alla nostra destra, lo stipite superiore delle finestre, le cornici dei
quadri sui pilastri indicano tutti un unico punto — quella mano della figura incorniciata
dal vano della porta, cui Velázquez dà risalto sia in termini di luce, sia in
termini compositivi. Ma se questo è il punto di fuga, il punto di costruzione
di questa prospettiva eccentrica sarà
comunque di fronte ad esso, ed è qui — di fronte al vano della porta dipinta —
che dovrà idealmente porsi lo spettatore. E del resto come dubitarne, se tante
persone rivolgono il volto e lo sguardo verso un identico luogo che fronteggia evidentemente la figura del secondo Velázquez?
E se questo è il punto di vista che la costruzione prospettica ci invita
idealmente ad assumere, lo specchio — che ci apparirà come una superficie su
cui lo sguardo cade obliquamente — non potrà più mostrarci ciò che gli sta di
fronte: rifletterà qualcosa che si trova sulla sua destra (o se si preferisce:
alla nostra sinistra), come sa chiunque abbia giocato almeno un poco con gli
specchi. Rifletterà insomma la grande tela che Las Meninas ci mostra nella sua parte cieca, svelandoci così
l’arcano della sua figurazione: il quadro che Velázquez sta dipingendo (o ha
appena terminato di dipingere) raffigura la coppia reale. Ne segue che — secondo
la migliore tradizione metafisica — lo specchio ci mostra l’immagine di
un’immagine, e ciò è quanto dire che lo “sguardo” della riflessione non
abbandona affatto lo spazio figurativo del quadro. Queste considerazioni che
abbiamo proposto un poco alla buona hanno trovato una loro illustrazione esemplare
in un saggio del 1980 di Snyder e Cohen (Riflessioni
su Las Meninas: il paradosso perduto. Risposta critica), un saggio per
molti versi ammirevole e che dimostra in modo definitivo quale sia il punto
dello spettatore e quale il riflesso che per quel punto lo specchio
restituisce. La restituzione prospettica del Las Meninas che qui riproduco trae di lì la sua origine, ed è un
argomento sufficiente per mostrare l’insostenibilità delle tesi di Searle e
Foucault, — due tesi che non avrebbe senso cercare di difendere sottolineando
la differenza, per certi versi ovvia, tra la libertà dell’artista e la normatività
dell’ottica geometrica, poiché da un lato questa differenza è messa a tacere
proprio dalla sostanza dei loro argomenti, dall’altro perché Velázquez non avrebbe
mai spinto quell’ovvia distinzione sino al punto di scardinare la consistenza
ottica e geometrica dell’immagine. Velázquez, del resto, di specchi se ne
intendeva e se la Venere allo specchio
(1644-48) può guardarci ciò accade soltanto perché il suo autore conosce bene
le leggi della riflessione.
Alla pars destruens che ha segnato l’avvio delle nostre considerazioni vorrei ora far seguire una pars construens, e la prima mossa in questa direzione consiste nel cercare di comprendere meglio la funzione degli specchi dipinti, soffermandoci in primo luogo sulla relazione che lega lo spazio dell’immagine al luogo che ospita ciò che sullo specchio vediamo baluginare. Un’osservazione balza agli occhi: uno specchio è, in linea di principio, un dispositivo ottico che ci consente di vedere ciò che il nostro punto di vista sulla scena ci avrebbe vietato di scorgere. Ora, nella dimensione propriamente percettiva ciò che uno specchio ci mostra è ciò che potremmo vedere se solo modificassimo l’angolo della nostra visuale: lo specchio ci mostra ciò che è nascosto, ma che potrebbe diventare visibile se solo ci muovessimo un poco. Sul terreno figurativo le cose mutano: non possiamo infatti mutare il punto di vista su cui si costruisce l’immagine e ciò affida allo specchio una funzione sottilmente iconoclasta — lo specchio mostra ciò che non si può vedere, consentendo l’irruzione di una realtà nuova nello spazio irreale dell’immagine. Lo specchio è il luogo di un imprevisto che scardina almeno in parte le scelte compositive di chi ha fatto l’immagine e proiettando nel suo spazio qualcosa che non gli appartiene. Le forme di questa non appartenenza tuttavia sono varie, ed io credo che si possano distinguere almeno tre differenti forme:
a) La prima forma è caratterizzata dall’appartenenza
dell’oggetto che si riflette allo spazio figurativo. Riproponendo ancora una
volta l’antico tema del paragone tra le arti, Vasari osservava che alla scultura
che ci costringe a cogliere nel tempo il variare dei profili, la pittura può contrapporre
un sapiente gioco di specchi che sveli i lati nascosti delle cose in un unico
istante. Ora, che la prospetticità dell’immagine potesse essere effettivamente
percepita come una limitazione che si frappone ad un pieno godimento della
forma è un fatto che traspare, per esempio, nel San Sebastiano del Pollaiolo, che costringe gli artefici del
martirio a disporsi gli uni specularmente agli altri, in una danza di movimenti
che ha innanzitutto il compito di mostrare ciò che di volta in volta la prospettiva
ci nega. Qualcosa di simile accade in un quadro del Bellini, che raffigura una
ragazza che si guarda in un piccolo specchio, mentre alle sue spalle uno
specchio più grande ripete per noi ciò che di lei non potremmo altrimenti
vedere. Sarebbe tuttavia un errore credere che l’unica funzione dello specchio
consista, in questo caso, nel restituire la completezza della forma: in realtà
gli specchi possono mostrarci dettagli o aspetti che arricchiscono la
dimensione emotiva dell’immagine. Un volto che lo specchio restituisce ad una
persona che ci volge le spalle ha un’ovvia valenza espressiva e il gioco di
sguardi della Donna allo specchio di
Ter Borch (1650) lo mostra con chiarezza. E tuttavia, nell’uno e nell’altro
caso la riflessione è caratterizzata dal suo rimandare ad un oggetto che
appartiene allo spazio figurativo, anche se l’aspetto che di esso lo specchio
ci mostra non è visibile dal punto di vista che il pittore ha propriamente
scelto. Parleremo allora di una riflessione
interna in senso stretto.
b) È tuttavia possibile una diversa forma di rispecchiamento
che amplia lo spazio figurativo dell’immagine, poiché ci mostra qualcosa
che di fatto non si trova nel luogo che il pittore ha figurativamente racchiuso
nella cornice, ma che avrebbe tuttavia potuto in linea di principio
appartenervi se soltanto il pittore avesse ampliato l’angolo di visuale o
avesse mutato il suo punto di osservazione, arretrandolo. Guardiamo questo
quadro di Quentin Massys intitolato Il cambiavalute
e sua moglie (1514): un uomo e una donna di estrazione borghese sono
intenti a soppesare con infinita cura del denaro di cui debbono saggiare il
valore, e tanto lo sfondo che ritrae alcuni libri e gli strumenti del loro
mestiere, quanto l’attenzione che il pittore ha dedicato ad illustrare i dettagli
in cui si scandisce la prassi meticolosa del loro lavoro sembrano dare al
quadro una valenza eminentemente descrittiva: Massys ha voluto mostrarci un
mestiere e la meticolosità consapevole di chi lo esercita. Ad un piccolo
specchio convesso che può facilmente sfuggire alla nostra attenzione spetta
tuttavia il compito di aprire la descrizione ad un’imprevista eco narrativa: lo
specchio ci mostra infatti il volto di un uomo che ha sicuramente a che fare
con le operazioni del cambiavalute, ed una volta che questo dettaglio ci abbia
colpiti è difficile negare alla scena una diversa drammaticità. Ora che abbiamo
visto nello specchio disegnarsi quel volto, sospettiamo quale sia lo sfondo di
quel contare che si accompagna ad una così serena lettura dei testi sacri! E
tuttavia, per quanto significativa sia qui la cesura tra ciò che è raffigurato
al di qua e al di là della cornice e per quanto questa scansione in uno spazio primario e in uno spazio secondario sia necessaria per dare
all’immagine la complessità di significato che le spetta, resta egualmente vero
che l’intera scena avrebbe potuto cadere
sotto un unico sguardo. Abbiamo a che fare allora con una riflessione che è
sì esterna allo spazio fattualmente racchiuso
dalla cornice ma che non pretende per questo di infrangere ma solo di ampliare
lo spazio figurativo in quanto tale. Parleremo allora di una riflessione solo accidentalmente esterna, per indicare
insieme il fatto e la possibilità, l’essere esterno dell’oggetto rispecchiato
all’immagine, ma il suo potervi in linea di principio far parte.
|
|
|
c) Tra gli esempi che avremmo potuto scegliere per illustrare il concetto di riflessione accidentalmente esterna vi è un quadro che Velázquez conosceva bene e che, per così dire, si situa sul confine estremo della classe che abbiamo appena delineato — mi riferisco a Gli sposi Arnolfini (1434) di van Eyck. Il quadro ritrae una coppia di sposi nell’istante in cui si celebra il loro matrimonio; alle loro spalle, tuttavia, uno specchio convesso mostra il proscenio dell’immagine che la cornice esclude alla vista: nello specchio vediamo che davanti agli sposi vi sono i testimoni del matrimonio che, con la loro presenza, rendono effettivo il contratto. Fin qui tutto si adatta ancora alla nozione di riflessione accidentalmente esterna, ma poiché spesso si è sostenuto che nello specchio è lo stesso van Eyck che ci si mostra, non è difficile comprendere come qui ci si trovi in prossimità di una diversa forma di riflessione: basterebbe infatti porre tra le mani di quel riflesso un pennello perché l’ampliamento dello spazio figurativo implicasse una vera e propria frattura ontologica, poiché se lo specchio ci mostrasse chi ha dipinto l’immagine nell’atto di dipingerla alluderebbe necessariamente ad un luogo in linea di principio esterno allo spazio figurativo. A porre tra le mani di un’immagine speculare il pennello che la disegna è più volte Escher in alcuni suoi enigmatici e paradossali autoritratti allo specchio Prima di Escher, tuttavia, si era avventurato lungo questa strada il Parmigianino che, come dice Vasari, «per investigare le sottigliezze dell’arte, [...] guardandosi in uno specchio da barbieri, di que’ mezzotondi [...], si mise con grande arte a contraffare tutto quello che vedeva nello specchio, e particolarmente se stesso [...] e vi fece una mano che disegnava, un poco grande come mostrava lo specchio, tanto bella che pareva verissima». Una mano che disegna, scrive Vasari, e ciò è quanto dire che lo specchio allude esplicitamente ad un luogo che non può appartenere allo spazio figurativo, poiché ad occuparlo è l’artefice stesso dell’immagine o il suo spettatore. Parleremo in questo caso di una riflessione essenzialmente esterna: lo “sguardo” dello specchio allude infatti ad un oggetto che non può trovarsi nello spazio figurativo poiché per la sua stessa natura non vi appartiene.
A questa distinzione che concerne il luogo cui allude l’immagine speculare dobbiamo tuttavia affiancarne una seconda che ci invita invece a riflettere su una proprietà del rispecchiamento. Il rispecchiamento può essere una relazione riflessiva, quando l’oggetto che si riflette si trova esattamente di fronte alla superficie riflettente. Ma può essere anche una relazione riflessiva, se solo l’angolo di visuale si discosta dalla perpendicolare alla superficie riflettente. In questo caso se A si rispecchia in S per B, allora B si rispecchierà in S per A, rendendo così simmetrica la relazione di rispecchiamento. Ora, queste sono proprietà obiettive del rispecchiamento. Ci disponiamo invece su un nuovo terreno se osserviamo che l’immagine speculare non soltanto c’è, ma può essere effettivamente colta come immagine. In questo caso allo sguardo rivolto allo specchio fa eco lo sguardo che specularmente lo specchio restituisce: parliamo allora di reversibilità del rispecchiamento che ovviamente ha luogo solo quando al di qua dello specchio non vi sono oggetti ma persone. A partire di qui si può tentare di tracciare uno schema che dia forma alla nostra seconda classificazione
|
forme
del rispecchiamento |
||||||
|
reversibili |
non
reversibili |
|||||
|
attualmente |
potenzialmente |
|
||||
|
realmente |
immaginativamente |
realmente |
immaginativamente |
riflessive |
simmetriche |
|
|
|
unilateralmente transitive |
|||||
|
riflessive |
Simmetricamente transitive |
|||||
|
falso
riflessive |
transitive |
|||||
Sul lato della non reversibilità non vi è nulla di nuovo da dire: sono propriamente irreversibili le immagini speculari che hanno a che fare con oggetti inanimati. Sono invece reversibili quelle forme di rispecchiamento che hanno a che fare con un possibile spettatore, ed è per questo che si può distinguere se questo spettatore potenziale eserciti o non eserciti la sua funzione di osservatore. Diremo invece che la reversibilità è reale se nella funzione dello spettatore vi è una persona, mentre parleremo di reversibilità immaginativa quando almeno uno dei termini del rispecchiamento è un soggetto cui è concesso uno sguardo solo in un senso metaforico — come accade per esempio quando diciamo che a guardarci è una figura di un quadro o una statua. Di qui l’ultimo livello di distinzioni proposto. Parliamo di reversibilità riflessiva quando qualcuno si guarda allo specchio, di reversibilità transitiva quando qualcuno vede nello specchio il volto di qualcun altro che a sua volta lo guarda, e di falsi riflessivi nei casi in cui ha luogo una reversibilità transitiva, mascherata sotto le vesti della riflessività — come quando, in un gioco, fingiamo di guardarci allo specchio, mentre guardiamo di sottecchi qualcun altro che si accorge del nostro sguardo. Infine, parliamo di una funzione transitiva unilaterale quando vi è uno spettatore potenziale che si è distratto e che non raccoglie ciò che pure lo specchio gli porge — di qui la ragione per la quale questa voce si trova nello schema solo dalla parte della reversibilità potenziale. L’ultima osservazione vale solo per tacitare un possibile fraintendimento: abbiamo parlato di funzione transitiva del rispecchiamento e in questo caso ci siamo lasciati guidare non dalla nozione logica di transitività, ma dalla sua accezione grammaticale, — quella che ci consente di dire che un verbo è transitivo quando l’azione che esprime ci conduce ad un oggetto. Un rispecchiamento è transitivo, dunque, quando qualcuno, guardando lo specchio, vede qualcosa di diverso da sé e la transitività è simmetrica quando chi è visto nel rispecchiamento vede a sua volta l’immagine di chi lo guarda.
Qualche esempio può chiarire meglio le cose che abbiamo detto. Questo disegno di Escher (1) ci propone evidentemente un rispecchiamento simmetrico, ma non reversibile, laddove vi è reversibilità attuale, reale e riflessiva nel ritratto del filosofo che esercita davanti allo specchio l’esercizio dell’autocoscienza (2). Infine (3) abbiamo a che fare con una reversibilità attuale, reale, transitiva e falso riflessiva in questo quadro di van Aachen che ci presenta una donna che, fingendo di guardarsi allo specchio, rivolge a noi spettatori il suo sorriso.
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
È difficile dire se lo schema che vi ho proposto è completo e se tutte le voci hanno davvero un senso. Quello che abbiamo fatto basta tuttavia per i nostri scopi, e ci consente innanzitutto di osservare che questa classificazione deve essere intrecciata con quella che abbiamo precedentemente tracciato e che caratterizzava in modo specifico le immagini.
Che un simile intreccio sia possibile è appena il caso di dirlo anche se adattare alla dimensione figurativa lo schema che abbiamo tracciato per secondo implica una serie di problemi che nascono dal fatto che lo specchio in un quadro è uno specchio dipinto e non può mutare di scena al variare della mia prospettiva. Accade così che, quando abbiamo a che fare con un quadro, la reversibilità transitiva si leghi ad un rispecchiamento essenzialmente interno: ciò che vediamo sullo specchio è il volto di una figura che appartiene allo spazio figurativo ma che guadagna — in virtù del rispecchiamento — una relazione con lo spettatore. Nella Venere con lo specchio (1555) di Tiziano o di Velázquez le cose stanno proprio così: lo specchio ci mostra il viso di Venere, ma l’immagine dialoga con lo spettatore poiché lo specchio che ci mostra il sorriso della dea deve mostrare ai suoi occhi il nostro volto. Ma di questo andare al di là dello spazio figurativo lo specchio non può rendere conto, se non quando il rispecchiamento si fa riflessivo, come accade nell’Autoritratto del Parmigianino cui abbiamo dianzi fatto cenno.
Da questo lungo girovagare tra gli specchi e le loro funzioni possiamo trarre qualche strumento per chiederci quale sia la natura del rispecchiamento che Velázquez in Las Meninas pone sotto ai nostri occhi. Una prima risposta al quesito è immediata: si tratta di un rispecchiamento interno in senso stretto, poiché nello specchio non vediamo la vera famiglia reale, ma solo un’immagine dell’immagine — un riflesso del quadro di cui direttamente vediamo solo tela e cornice. Ma anche la nostra seconda classificazione ci permette di dire qualcosa: lo specchio che ci appare obliquamente quando lo osserviamo dal punto di costruzione dell’immagine ci mostra ciò che il grande quadro di cui vediamo solo la tela ritrae e così permette da un lato al nostro sguardo di porre l’immagine in quanto tale e, dall’altro, consente alla scena raffigurata di volgersi verso di noi e di invitarci a guardarla. Possiamo indicare allora un punto nel nostro schema: abbiamo a che fare con una forma immaginativamente reversibile di rispecchiamento, ed in modo particolare con una reversibilità simmetricamente transitiva, poiché lo sguardo che lo specchio conduce sino al quadro ci è restituito dal volgersi del quadro verso di noi che ha luogo in virtù del rispecchiamento.
Abbiamo indicato un punto in uno schema, ma per comprendere il senso di questa mossa è forse necessaria ad una breve digressione che, muovendo da immagine ad immagine, ci conduce ad un soggetto pittorico che può insegnarci qualcosa — il tema di Susanna e i vecchioni.
Di questo tema vorrei parlare richiamando innanzitutto un quadro del Tintoretto (1555): qui la scena biblica è narrata soltanto nel suo antefatto: Susanna si bagna nel giardino della sua casa e i vecchi la spiano, rubando un’intimità che loro non spetta. E tuttavia il trasformarsi di Susanna in uno spettacolo rubato e in una visione che la rende oggetto è già in qualche modo anticipato dal riflettersi del suo corpo nello specchio e, in parte, nella superficie oscura dell’acqua in cui si bagna. Allo sguardo dei vecchi corrisponde così lo “sguardo” dello specchio: entrambi esercitano la stessa funzione poiché, proprio come la pittura, trasformano un corpo vivo in un’immagine. Questo stesso ordine di considerazioni ci permette di intendere il pensiero che sorregge la struttura immaginativa di una diversa interpretazione di questo soggetto, la Susanna e i vecchi del Guercino che si trova al Prado. In questo quadro non vi sono, una volta tanto, specchi, ma vi è — come spesso accade in Guercino — un gioco sottile tra uno spettatore interno ed uno spettatore esterno all’immagine. Nel quadro del Prado vi è innanzitutto uno spettatore interno: è uno dei vecchi che contempla, non visto, il corpo di Susanna. Ma vi è anche un richiamo esplicito allo spettatore esterno: l’altro vecchio si rivolge proprio a noi che guardiamo il quadro, invitandoci a tacere, e in questa richiesta di complicità non è difficile scorgere l’invito a riflettere sul parallelismo che lega la vicenda di Susanna spiata dai vecchi al nostro assistere da spettatori all’opera della pittura. Susanna diviene spettacolo per lo sguardo indiscreto dei vecchi; ma anche la tela si fa quadro nel suo rivolgersi ad uno spettatore ideale: il pensiero che Guercino pone sotto i nostri occhi è dunque proprio qui, in questo sottile tramutarsi della natura di ciò che abbiamo di fronte in virtù dello sguardo che lo contempla.
Di qui, da questo nesso che stringe l’immagine in quanto tale allo spettatore che la guarda, dobbiamo muovere per tornare ancora una volta a Las Meninas, a questo quadro che può essere compreso davvero solo se si coglie la relazione che lega il suo raffigurare uno specchio al volgersi così manifesto dei suoi personaggi verso il luogo che lo spettatore ideale deve far proprio.
Affrontiamo innanzitutto quest’ultimo punto e chiediamoci che cosa il quadro raffiguri. La risposta potrebbe suonare così: vi è un pittore che dipinge un quadro, una bambina che si fa portare dell’acqua, un uomo e una donna che parlano, un signore che sta per abbandonare la stanza, salendo su per i gradini delle scale che si intravedono nel vano della porta.
Una risposta apparentemente accurata, ma in fondo inesatta, poiché ciò che di fatto essa descrive è una scena superata dagli eventi. Un attimo prima che si desse la visione cui il quadro dà voce le cose dovevano stare proprio così come le abbiamo appena descritte: dovevano proprio accadere quelle vicende molteplici e distinte che di norma si danno nella realtà. Ma un attimo dopo — l’attimo fissato dal quadro — tutto è cambiato, perché ora è giunto uno spettatore e con esso lo sguardo rispetto al quale la congerie molteplice degli eventi si organizza in una trama. Ora, proprio come il mansueto animale che troneggia in primo piano, anche le molte vicende in cui si scandisce il quadro debbono destarsi dal torpore che le avvolge per convenire in uno spettacolo unitario, ed è proprio di questo esser divenute parti di uno spettacolo e quindi di un nuovo quadro che danno testimonianza gli sguardi dei personaggi rivolti verso lo spettatore che è appena giunto. Così, se davvero si vuol dire che Las Meninas racconta qualcosa, si deve rammentare che l’evento particolarissimo cui in questa sua “istantanea” Velázquez dà voce è l’evento in cui la realtà si fa quadro. Lo sguardo dello spettatore diviene così una sorta di sguardo di Medusa che sospende la vita reale e la muta di segno, trasformandola in una scena teatrale, in uno spettacolo che si dispiega per noi. E d’altro canto, se lo sguardo dello spettatore raccoglie la scena e ne fa uno spettacolo è vero anche che il quadro si rivolge allo spettatore — guardandolo, come fanno le molte figure che si accalcano sul margine destro del quadro.
Questo stesso ordine di considerazioni deve guidare la nostra comprensione dello specchio che troneggia nel centro del quadro. Che vi sia un nesso tra la raffigurazione pittorica e l’immagine speculare è una constatazione tutt’altro che nuova: per Alberti, il mito di Narciso ci parla della pittura anche perché l’instabile mobilità del riflesso è, per così dire, una cifra dell’immaterialità dell’immagine. Ed anche in Velázquez le cose stanno così: nel suo incerto scintillio, lo specchio ci mostra il prendere forma dell’immagine, il suo manifestarsi nella sua eterea natura. La tela che, con la sua presenza di cosa materiale e opaca, copre una parte tanto ragguardevole della scena, svela così il suo aspetto immateriale soltanto nello specchio che ne riflette la dimensione puramente figurativa. Anche in questo caso, dunque, qualcosa si desta: la materia morta e cieca della tela si trasforma in un’immagine viva: dietro la pesantezza dell’essere, lo sguardo dello specchio svela un’apparenza luminosa ed eterea. La svela tuttavia, ed è questo un punto su cui riflettere, soltanto se lo specchio fa da tramite del nostro sguardo, se cioè nel suo riflettere conduce il nostro sguardo di spettatori dal luogo che dobbiamo idealmente assumere — il luogo che la costruzione prospettica ci assegna — alla tela che, nel suo divenire spettacolo per una soggettività, si anima della vita propria delle immagini. Ne segue che se anche lo specchio di Las Meninas riflette qualcosa che appartiene allo spazio figurativo, svolge egualmente una funzione transitiva poiché vincola la raffiguratività dell’immagine allo sguardo che la pone. Ed è una funzione transitiva simmetrica, poiché nello specchio si riflette per noi, nel suo volgersi verso di noi, la scena dipinta — la famiglia reale che ci guarda.
Così, al gesto del pittore che si ritrae per guardare ciò che ha dipinto fa eco lo sguardo che lo specchio ci permette di gettare sulla superficie della tela, ed in entrambi i casi lo sguardo dello spettatore determina il farsi avanti dell’immagine: alla percezione della cosa si sostituisce il vedere la raffigurazione. Ed è proprio di questo sostituirsi alla realtà della raffigurazione in virtù dello sguardo di chi la contempla che il quadro di Velázquez ci parla, ora suggellando in un riflesso l’immaterialità dell’immagine, ora riconoscendo nel volgersi dei suoi personaggi che è sufficiente che vi sia uno spettatore perché la realtà si metta in scena.
Dobbiamo ora tornare al nostro mestiere di filosofi per trarre dalle immagini qualche conclusione sulla natura delle immagini. Ora, Las Meninas è un quadro che ci invita a riflettere su molte cose, ma in primo luogo sul nesso che lega la raffigurazione al suo spettatore. Questo nesso, tuttavia, non è colto nella sua dimensione pragmatica, ma — lo abbiamo appena osservato — nel suo sfondo ontologico: Velázquez ci invita a pensare al fatto che ogni immagine è per uno spettatore.
Questo nesso è fenomenologicamente evidente. Una raffigurazione non è una cosa tra le altre e non è qualcosa che esista alla stessa stregua dei pigmenti e della tela di cui pure consta, poiché implica una partecipazione soggettiva ed una disponibilità peculiare senza le quali non soltanto non è colta, ma propriamente non è. Percepire una raffigurazione significa infatti saper vedere nei pigmenti e nel loro disporsi sulla tela una figura che riconosciamo, e questa figura vi è solo se ciò che funge da sostrato della visione (la tela variamente coperta da colori) si anima per la soggettività di un senso nuovo. Le immagini dipendono dalla soggettività dello spettatore; e tuttavia, la dipendenza dell’immagine dallo sguardo che la pone non toglie che alle immagini appartenga anche il loro esplicito rivolgersi allo spettatore: lo sguardo pone l’immagine e l’immagine lo interpella.
È intorno a questo nesso così ricco di implicazioni che la fantasia creatrice di Velázquez si muove, proiettando tuttavia il nucleo fenomenologico di questa tesi sullo sfondo di una poetica in cui non è difficile scorgere l’eco di una domanda che nel Seicento si fa ossessiva: la domanda che verte sul discrimine che separa la realtà dalla rappresentazione, la vita vera dal sogno. In questa luce, la necessaria inerenza della raffigurazione ad uno spettatore e il suo recitarsi per lui diviene lo spunto per mettere in movimento una molteplicità di immagini che sono caratteristiche di un’epoca che non rinuncia ad affiancare alle proprie certezze il tarlo di un dubbio scettico radicale: la tesi della necessaria inerenza dello spettatore all’immagine rifluisce così nel sospetto che alla vita basti essere osservata dalla giusta distanza per essere trasformata in un sogno coerente, in una scena teatrale o, se si vuole, in un affresco. Nell’Illusione teatrale di Corneille è sufficiente che la magia di Alicandro faccia apparire al padre come su un palcoscenico le gesta compiute dal figlio perché la sua vita assuma la forma di uno spettacolo, di una commedia in cui onori e drammi si succedono nell’unità di una trama; e così stanno le cose anche per Las Meninas: il gioco degli specchi e degli sguardi cui Velázquez dà vita ci rammenta quanto sottile sia il discrimine che separa la pienezza del vivere dall’acquisizione di quella distanza che la trasforma in un affresco[8].
Lezione nona
1. Le immagini, gli esperimenti
Nelle lezioni precedenti abbiamo cercato di far luce sul concetto di raffigurazione e siamo giunti a fissare alcuni punti che ritengo siano relativamente importanti. In particolar modo ci siamo soffermati su alcune caratteristiche peculiari delle raffigurazioni che vorrei qui rammentare:
1. Le raffigurazioni hanno carattere eminentemente visivo. Il carattere figurativo di un’immagine non implica un sistema di convenzioni e non rimanda ad un codice di carattere linguistico che definisca il valore dei segni pittorici. Le raffigurazioni non si leggono: si guardano, ed è per questo che non vi è un dizionario dei segni pittorici e che l’apprendere uno stile figurativo non ha nulla a che spartire con lo studio mnemonico cui siamo costretti quando cerchiamo di imparare i vocaboli di una lingua straniera.
2. Le raffigurazioni non sono segni e non hanno una funzione denotativa. Le immagini non stanno per qualcosa e non sono assimilabili nemmeno sotto questo riguardo ai nomi del nostro linguaggio. Un segno ha un senso perché vi una relazione di proiezione che ci consente di applicarlo ad un qualche oggetto — ad un numero, a una persona, a una cosa. Nel caso delle immagini le cose non stanno così: le immagini bastano a se stesse e per comprenderle non vi è bisogno di una relazione di proiezione che ci dica come applicarle alla realtà, poiché tutto ciò che le raffigurazioni chiedono e che sia possibile un riconoscimento percettivo che ci consenta di vedere ciò che esse ci mostrano.
3. Le immagini sono il luogo di un riconoscimento ed è a partire di qui che si può meglio comprendere sia la natura delle immagini sia il loro peculiare rapporto con la visione. Le raffigurazioni si vedono, ma il nostro vederle implica un riconoscimento. Ora, il riconoscimento percettivo ha un fondamento obiettivo: non possiamo vedere ciò che vogliamo e non è in linea di principio possibile imparare a vedere, se non forse nei primissimi mesi di vita quando nell’uomo si viene compiendo ciò che in altri animali sembra essere già dato alla nascita. Ma se non si può imparare a vedere si può invece imparare a rivolgere lo sguardo in una direzione determinata o a chiudere gli occhi su determinati aspetti di ciò che la scena pittorica ci porge. Le raffigurazioni si vedono, ma il vedere può legarsi ad una prassi che può essere appresa e il risultato cui infine conduce la percezione di immagine può in parte dipendere dal modo in cui abbiamo imparato ad interrogare visivamente una scena.
4. La percezione di un’immagine implica un riconoscimento sui generis, poiché ciò che in una raffigurazione si riconosce e diviene percettivamente presente per noi non è la cosa stessa, ma solo il suo aspetto fenomenico così come è reso sulla carta dalla scelta di un determinato schema intuitivo.
5. Le scene figurative hanno perciò carattere meramente fenomenico e il loro esserci è tutto racchiuso nel loro percipi. Il carattere puramente fenomenico di ciò che in un’immagine si raffigura si manifesta anche nel fatto che ciò che è presente percettivamente nell’immagine non nega ciò che la rende possibile — la tela e i pigmenti — proprio come, d’altro canto, la consapevolezza percettiva che di fronte a noi in realtà vi è una tela variamente colorata non chiede che venga rimossa la scena figurativa che lo sguardo ci propone. Ciò che è solo fenomenicamente presente non nega e non è negato da ciò cui l’esperienza attribuisce una presenza reale.
6. La percezione di immagine è un’esperienza complessa che si articola su due piani, connessi in un rapporto di fondazione unilaterale. Vi è innanzitutto la percezione ambientale che è percezione dello spazio reale in cui sono e che di fatto ospita una tela, variamente coperta da pigmenti. Su questa percezione, e da essa dipendente, si fonda una percezione di immagine — una percezione che non nega la percezione ambientale, ma la relega sullo sfondo, come l’orizzonte di senso che attribuisce a ciò cui siamo ora rivolti il carattere della mera fenomenicità.
7. Di qui deriva una duplice constatazione sulla natura delle immagini. La prima: dire di qualcosa che è un’immagine non significa affatto asserirne una proprietà reale. Non vi è infatti un criterio che ci permetta da un lato di asserire di un’immagine che è un’immagine e che, dall’altro, sia diverso dal suo mero apparirci così. La seconda tesi deriva dalla constatazione della natura intenzionale del carattere di immagine e ci invita a cogliere l’eco pragmatica che è racchiusa nella dimensione ontologica delle raffigurazioni: le raffigurazioni sono tali solo per uno spettatore.
8. Di questa natura complessiva delle immagini lo spazio figurativo ci offre un’eco intuitiva. Gli oggetti che lo spazio figurativo ospita non stringono relazioni spaziali obiettive con gli oggetti reali: alla natura meramente fenomenica delle scene raffigurate fa eco la radicale chiusura dello spazio figurativo, il suo respingere come insensato ogni tentativo di collocare ciò che in esso si manifesta rispetto ad un qualsiasi punto del mondo. Le immagini, tuttavia, non sono soltanto caratterizzate dalla chiusura rispetto al reale, ma implicano necessariamente uno spettatore, poiché la loro natura meramente fenomenica implica necessariamente un rimando ad una soggettività che percepisca e riconosca ciò che nell’immagine prende forma. Anche di questa caratteristica relazione che stringe l’essere delle immagini al loro percipi, lo spazio figurativo offre una realizzazione intuitiva: anche lo spazio figurativo è determinato infatti dall’avere una relazione spaziale sui generis con il luogo dello spettatore, ed è per questo che ha un senso dire che la scena raffigurata è qui davanti a me e che vi sono figure che mi sono vicine, mentre altre sono relegate in una lontananza incolmabile.
Di qui, da queste considerazioni di carattere generale, possiamo muovere per indicare, sia pure sommariamente, quale sia la natura delle immagini e, soprattutto, quale sia la loro posizione rispetto ai consueti oggetti del mondo, alle cose di cui abbiamo esperienza. Venire a capo del concetto di immagine significa anche questo: saper dire, seppure per sommi capi, che differenza vi sia tra una cosa e una raffigurazione e quale sia l’ordine in cui dobbiamo pensare le immagini e il mondo in cui siamo.
Ora, nelle ultime lezioni ci siamo di fatto imbattuti in una duplice differenza tra le cose e le raffigurazioni, — una differenza su cui è forse opportuno soffermarsi un poco. In primo luogo ci siamo imbattuti nella natura puramente fenomenica dello spazio figurativo e nella sua chiusura rispetto alla concatenazione degli eventi e delle esperienze. Ogni evento nel mondo rimanda ad altro ed è quello che è proprio nel gioco di questi rimandi: di qui da un lato la sua dipendenza dal corso reale degli eventi, ma anche, dall’altro, il suo porsi come qualcosa che si dà nell’esperienza ma che non è tutto racchiuso nell’esperienza che di fatto ne ho. Le proprietà reali di un oggetto non sono necessariamente quelle che di primo acchito ci appaiono, e la storia del progresso scientifico ci ha mostrato quanto diverso sia l’aspetto reale del mondo rispetto alla sua dimensione fenomenica. Non così stanno le cose per le raffigurazioni. Il mondo dell’immagine è tutto dato insieme all’immagine stessa ed è in questo simile all’universo narrativo di un romanzo, in cui non possono esservi in senso proprio né nuove scoperte né lacune, poiché il mondo narrato è posto dalla narrazione e racchiude in sé ed implica solo ciò che in sé la narrazione racchiude ed implica. In questa dipendenza dell’universo figurativo dal percipi che lo pone ci eravamo imbattuti poi, in secondo luogo, quando avevamo sottolineato che le immagini si rivolgono ad uno spettatore e sono nel suo manifestarsi ad esso. Anche questa è una caratteristica delle immagini che la distingue con chiarezza dagli oggetti del mondo che non soltanto non sono racchiusi nell’esperienza che li pone, ma non sono nemmeno caratterizzati dal loro porsi come oggetti che rimandino necessariamente ad una soggettività.
Su questo punto vorrei cercare di essere più chiaro. Quando dico che nel senso degli oggetti così come noi li esperiamo non vi è il loro necessario rimandare ad una soggettività esperiente non intendo prendere posizione sui temi maiuscoli del trascendentale: intendo soltanto affermare che quando parliamo di un albero, di una penna o di un sasso non siamo per questo costretti a pensare che vi sia qualcuno che li percepisca, laddove questa necessità sembra sussistere quando, per esempio, parliamo di un dolore o di una sensazione piacevole. Il dolore che provo c’è finché lo sento ed è per questo che Cartesio può dedurre dal cogito l’esistenza di una soggettività; dal punto di vista ontico, invece, una simile mossa gli è preclusa per ciò che concerne la res extensa, poiché dell’albero nella strada posso dire che c’è anche se non lo vedo affatto e il pensiero di una cosa che sussista anche al di là di una soggettività che ne abbia esperienza non è un pensiero contraddittorio, così come non è affatto privo di senso pensare ciò che tutti di fatto pensiamo — che vi è stato un mondo anche prima degli uomini e che vi sarà un mondo anche quando non ci saremo più. Non è contraddittorio, e questo significa: nel senso degli oggetti così come si costituiscono in un’esperienza soggettiva ed intersoggettiva non è affatto racchiuso il rimando ad una soggettività ed è per questo che si può senz’altro parlare di qualcosa senza dover parlare di qualcuno. Ora all’origine di questa caratterizzazione grammaticale che ci mostra quale sia il senso che attribuiamo alla nozione di oggetto, vi è ancora una volta un gioco linguistico che si radica direttamente sul terreno percettivo. La tastiera con cui scrivo è una cosa che vedo e che avverto sulla punta delle dita, — e questo mio vedere e questo mio toccare appartengono evidentemente alla dimensione soggettiva della mia esperienza. Non vi appartiene invece la tastiera poiché il senso che la mia percezione le attribuisce è del tutto indipendente da questo mio vederla e toccarla: proprio perché imparo che cosa sia un oggetto come la tastiera in una serie aperta di esperienze reali e possibili, apprendo anche l’indipendenza effettiva dell’oggetto da ogni mia singola esperienza. L’oggetto nella percezione si dà proprio così, come qualcosa di cui ho esperienza e che quindi non è né riconducibile ad una mia esperienza, né tale da implicare per sua natura un’esperienza qualsiasi.
Certo, per poter parlare di un oggetto debbo in qualche misura conoscerlo: l’esperienza è il luogo di accessibilità degli oggetti in generale e di ogni oggetto di cui parlo debbo avere quindi una conoscenza diretta o indiretta. Ora che ogni oggetto conosciuto racchiuda in sé il rimando ad una soggettività è ovvio, ma ciò non significa ancora che l’esser conosciuto sia una relazione in cui gli oggetti debbano necessariamente stare. Nulla negli oggetti chiede che siano necessariamente conosciuti, o almeno: noi usiamo così la parola «oggetto» e tolleriamo senz’altro, come un’espressione sensata, il discorrere di oggetti o addirittura di mondi sconosciuti. Ed un discorso analogo vale evidentemente anche per ogni constatazione di esistenza. Per poter sostenere che vi è un albero nel giardino debbo averlo visto (o fidarmi di qualcuno che l’ha visto), ma questo è il criterio che mi consente di affermarne l’esistenza, non un momento che sia implicato dall’esistenza stessa dell’oggetto. Il fatto che io veda che c’è un albero nel giardino mi dà una ragione per affermare che le cose stanno proprio così, ma ciò che mi autorizza a constatare l’esistenza di qualcosa non è per questo un momento che sia implicato in quanto tale dall’esistenza stessa di quell’oggetto. Ancora una volta: il fatto che vi sia la Luna in cielo posso accertarlo soltanto guardando lassù, ma che lassù vi sia la Luna non ha davvero nulla a che fare con il mio guardarla e nemmeno con il fatto che io affermi o abbia ragione di affermare che la Luna in cielo c’è, e da molto prima che il tempo fosse avvertito e misurato dagli uomini. O almeno: è questo il significato che attribuiamo all’esistenza degli oggetti.
Diversamente stanno le cose quando parliamo delle raffigurazioni: l’esserci di un’immagine non implica il rimando al percipi solo come un criterio che ci consente di affermarne l’esistenza, poiché una raffigurazione è qualcosa che è solo in virtù di un riconoscimento percettivo. Lo abbiamo già osservato. Dire di qualcosa che è un’immagine non significa asserirne una proprietà reale: vuol dire invece sostenere che in circostanze normali è possibile vedere e riconoscere in ciò che ci si presenta una scena particolare. È possibile riconoscerla: la scena che un quadro raffigura “c’è” solo all’interno dell’esperienza che ne abbiamo ed è per questo che non è possibile anche soltanto pensare che sia diversa da come la vediamo. Il drago che San Giorgio uccide nella pala Pesaro è verde, e se quel drago fosse reale la fisica potrebbe mostrarci che non è realmente di quel colore, poiché vi è un senso in cui si può affermare che il colore è solo un modo in cui gli organismi viventi reagiscono percettivamente alla proprietà reale che certi corpi hanno di riflettere solo in parte la luce che ricevono; un drago dipinto è invece in sé verde, poiché non ha davvero alcun senso chiedersi quale sia la proprietà reale di quel drago che determina il suo reagire così alla luce e il suo suscitare in un organismo animale di un certo tipo una determinata percezione visiva. Ma ciò è appunto quanto dire che laddove l’esserci delle cose non implica un rimando alla soggettività, l’esserci delle raffigurazioni poggia invece su un rapporto necessario con lo spettatore che le contempla.
Si potrebbe sostenere, a partire di qui, che le raffigurazioni hanno una sorta di destino metafisico poiché ci mostrano la dipendenza dell’accadere da quel punto sensibile che lo comprende: la soggettività. Nelle raffigurazioni si inscenerebbe così in modo esemplare la recita del trascendentale, quella recita che non si coglie più negli oggetti che hanno assunto una loro falsa autonomia. Lungi dall’essere interpretabili a partire dal modello platonico della mimesis, le immagini sarebbero allora il luogo privilegiato per comprendere la manifestazione del mondo, la sua verità. Non credo che questo cammino debba essere intrapreso e non credo che il senso che si può attribuire al discorso alto del trascendentale possa andare al di là di questo riconoscimento: della grammatica dei concetti si deve poter rendere conto senza abbandonare il terreno dell’esperienza — questo termine preso in un’accezione molto ampia e generale. Ma soprattutto ritengo che non si debba parlare delle raffigurazioni come se fossero il luogo di una manifestazione originaria dell’essere. La raffigurazione è un concetto secondario, poiché è il luogo di un riconoscimento ed implica la nostra esperienza delle cose: le immagini ci parlano solo perché in esse si fa avanti l’eco del mondo, le sue molte voci che tentiamo di ricomporre in una esemplare unità.
Di qui un tratto che caratterizza in profondità le immagini e che spesso ne determina la funzione. Nel mondo ci siamo trovati; alle immagini, invece, spetta un compito narrativo: le immagini debbono raccontare da capo la presenza delle cose perché solo così possiamo non soltanto trovarci nel mondo ma tentare di ritrovarci in esso. Le immagini rimettono in scena il mondo, ma il loro compito non è per questo mimetico, più di quanto non lo sia il lavoro del mito che racconta la genesi del cosmo e lo ricrea per permetterci di trovare un posto nel cosmo e di credere che ci sia stato assegnato. Un lavoro, dunque, in un certo senso creativo anche se la sua sensatezza è interamente vincolata alla dimensione della ripetizione: il mito crea di nuovo questo mondo e lo crea con i materiali e le vicende che al mondo appartengono, poiché solo se lavora con l’eco della realtà che a tutti da sempre è data può ottenere il risultato cui tende: trovare nel mondo il nostro mondo. Lo abbiamo dianzi osservato: nelle immagini ci impossessiamo delle cose del mondo, ce ne appropriamo. Da queste espressioni, tuttavia, è forse opportuno espungere la piega conoscitiva che sembra caratterizzarle. Le raffigurazioni, nella norma, non fanno conoscere nulla di nuovo e questo vero soprattutto per le immagini artistiche da cui non possiamo venire a sapere nulla, poiché non ci rivelano alcun evento particolare. Eppure le immagini hanno spesso molto da insegnarci: forse non nuovi fatti, ma talvolta un diverso stile di vita che si attagli al racconto del mondo che ci viene proposto. Ma ciò è quanto dire che ciò che le immagini ci insegnano si gioca non sul terreno della conoscenza ma sul piano di un’etica del vivere: le immagini ci raccontano con le voci del mondo ciò che è importante del mondo e ci invitano a ritrovarci in esso. Proprio perché stringono un legame essenziale con il concetto di ripetizione, le immagini possono porsi come il luogo in cui si realizza un esperimento: nell’eco del mondo che nell’immagine risuona si sperimenta visibilmente una familiarità nuova con le cose.
2. Il concetto di raffigurazione e i suoi confini
Nell’ora precedente ci siamo soffermati su considerazioni generali sulla natura delle raffigurazioni e abbiamo cercato di mostrare come le tesi che avevamo passo dopo passo sostenuto racchiudessero in sé una serie di conseguenze importanti per definire i contorni di una filosofia dell’immagine. Ora dobbiamo invece mostrare come le caratteristiche dell’immagine ci consentano di misurare lo spazio del concetto di raffigurazione o, se si preferisce, le condizioni che ci consentono di avvalerci di questo concetto. Certo, i concetti si usano in vario modo e non vi sono certo solo ragioni fenomenologiche che ci guidano nell’impiegare il concetto di raffigurazione. E tuttavia anche se, disponendoci in una diversa prospettiva, potremmo forse trovare qualche controesempio, credo che da un punto di vista descrittivo si possa sostenere che la condizione che ci consente di parlare di una raffigurazione sia l’irriducibilità del raffigurato al sostrato materiale che la ospita. Le immagini si danno quando siamo consapevoli di avere di fronte a noi una superficie — la tela, un muro, un foglio di carta — ma di fatto vediamo al di là di essa disegnarsi una scena che non le appartiene e che non saremmo affatto disposti a descrivere come se fosse una sua proprietà reale. Vedo di fronte a me una tela e vi riconosco una scena ben nota: vedo San Giorgio che uccide un drago. Ma ciò che vedo (San Giorgio che uccide il drago) non è una proprietà reale del sostrato, poiché in quella tela è reale solo il suo essere qui azzurra, qui verde, qui color argento — sempre che ci si conceda di chiudere un occhio sulle questioni relative al dibattito sulla realtà dei colori.
Queste considerazioni valgono anche per l’arte astratta: in un quadro di Kandinsky, per esempio, vediamo strane creature acquoree e, accanto ad esse, macchie di colore in cui sembra disegnarsi qualcosa, ma nell’uno e nell’altro caso ciò che vediamo non può essere descritto dicendo che vi è una tela che ha questi e questi altri colori, disposti in queste e queste altre forme. Ciò che vediamo non sono proprietà della tela e non appartengono alla sua superficie, ma si danno in uno spazio diverso — sopra o sotto di essa.
Potremmo esprimerci allora così: si dà un’immagine quando non vi è coincidenza tra la tela che vediamo e la forma che sopra o dietro la tela si scorge, e ciò è quanto dire che vi è uno spazio figurativo quando la scena dipinta non aderisce alla superficie materiale del sostrato, ma si dispone lungo l’asse della profondità, aprendosi un varco che la libera dallo spazio reale per disporla nello spazio dell’immagine. Ne segue che di uno spazio figurativo si può parlare solo quando l’immagine in quanto tale vive sullo sfondo della consapevolezza dell’esserci del sostrato che la rende materialmente possibile. L’abbiamo già osservato: si può parlare di una raffigurazione solo se il riconoscimento che dà vita all’immagine si accompagna alla consapevolezza della sua natura soltanto figurativa e ciò è possibile solo se la scena che nel disegno si mostra non nega la certezza della percezione ambientale e quindi anche il mio essere certo del fatto che là dove si mostrano uomini, città e campagne vi è in realtà soltanto una superficie materiale su cui sono stati disposti ad arte vari pigmenti.
Di qui, da questo duplice carattere dell’immagine, si deve muovere per indicare quali siano i confini esterni che circoscrivono lo spazio concettuale della raffigurazione: proprio perché il concetto di raffigurazione ha la sua condizione di applicabilità nella duplicità di piani in cui si scandisce la sua percezione, proprio per questo si può affermare che da un lato la raffigurazione si perde quando viene meno la consapevolezza percettiva del sostrato dell’immagine e la percezione si fa ingannevole e che, dall’altro, le immagini si chiudono quando il movimento in profondità dello spazio figurativo è interamente riassorbito dalla superficie della tela. Potremmo raffigurare così lo spazio che spetta al concetto di raffigurazione:
|
mera bidimensionalità |
Spazio del concetto di raffigurazione
|
mera tridimensionalità |
Questi sono appunto i confini esterni del concetto di raffigurazione, e quindi insieme il farsi avanti delle determinazioni fenomenologiche che ci impediscono di parlare di un’immagine. Ma se il concetto di raffigurazione ha confini esterni è tuttavia possibile individuare i suoi limiti interni, i luoghi in cui la raffigurazione stessa annuncia il suo prossimo venir meno: da una parte avremo allora il trompe l’oeil, dall’altra la tendenziale bidimensionalità dell’arte astratta, il suo porsi come un rifiuto radicale di riproporre lo spazio prospettico e la sua vocazione illusionistica. In mezzo, ordinate secondo la regola della profondità, le diverse forme della raffigurazione, il loro diverso modo di parlare allo spettatore e di proporgli un diverso spazio figurativo. Di qui la possibilità di complicare lo schema che abbiamo proposto, per consentirgli di esprimere — accanto ai confini esterni del concetto di raffigurazione — la sua interna dialettica, il suo essere animata da una polarità che ci consente di ordinare le diverse tipologie dell’immagine e il loro movimento. La profondità dello spazio figurativo assume così la funzione di scandire l’interno dinamismo dello spazio figurativo e si pone come una sorta di asta graduata che ci permette di assegnare un luogo alle differenti tipologie di immagine:

Sul significato complessivo di questo schema, ed in modo particolare sul rapporto che lega la profondità delle immagini alla loro tipologia e alla dimensione pragmatica del rapporto con lo spettatore, dovremo in seguito tornare. Ora dobbiamo invece soffermarci ancora un poco sulla questione concernente i limiti del concetto di raffigurazione, e per farlo vorrei cercare di osservare più da vicino che cosa accade alle immagini quando si approssimano ai confini che circoscrivono la loro possibilità. Le immagini possono chiudersi approssimandosi alla mera bidimensionalità, così come possono perdersi nel reale quando assumono la forma del trompe l’oeil, ma in entrambi i casi comprendere queste figure di confine significa avere ben presente il loro porsi come luoghi differenti di uno stesso processo — il processo di dissoluzione dell’immagine.
Che di qui si possa muovere per comprendere almeno in parte il senso che la negazione della profondità ha assunto nei movimenti artistici del secolo scorso non è difficile mostrarlo. Una parte significativa dell’arte novecentesca ha pronunciato un chiaro verdetto di condanna nei confronti della profondità dell’immagine, e il fastidio per la prospettiva come forma d’arte mimetica si è spesso legato ad una piega sottilmente iconoclasta: nella negazione della profondità, le poetiche novecentesche hanno voluto mettere in questione lo statuto delle immagini, il loro porsi come uno spettacolo da contemplare, come una visibile manifestazione di un mondo immaginato o di una realtà mirabile. La scena teatrale che si apriva nella profondità visibile della tela doveva chiudersi e l’immagine aderire sempre più chiaramente alla superficie, sin quasi a dissolversi.
Così stanno le cose in Mondrian. Nella sua teorizzazione del neoplasticismo, la negazione della dimensione figurativa si lega implicitamente al rifiuto della pienezza delle raffigurazioni, che debbono essere ripensate nella loro natura poiché non si può più chiedere loro di riproporci, seppure nel velo della finzione, l’aspetto visibile del nostro mondo e le forme della natura. Tutto questo deve essere messo da parte, e con esso l’immagine classica del quadro. Leviamo allora la cornice, per mettere innanzitutto da canto la sicurezza che lo spazio figurativo possa essere protetto dallo spazio reale e, in secondo luogo, per rinunciare alla consuetudine espressiva che ci assicura che là dove la cornice racchiude uno spazio, vi sia uno spettacolo peculiare e quasi l’irruzione di un diverso ordine di realtà nel nostro mondo.
Da queste attese occorre spogliarsi, perché l’immagine non deve farci vedere altro se non ciò che davvero vi è, e allora non dobbiamo soltanto liberarla dalla cornice, ma dobbiamo anche renderla sempre più evidentemente aderente al piano, poiché appunto nel quadro non dobbiamo vedere null’altro che il quadro. Lo spazio puramente fenomenico della raffigurazione deve chiudersi poiché ciò che dobbiamo vedere sulla tela non è una finzione ma il mondo così com’è — quel mondo retto dalla legge immobile della perpendicolarità cui si deve ricondurre l’idea stessa di ogni accadere, una volta che ci si sia liberati appunto dalla pretesa di trovare un senso umano nell’ordine delle cose e ci si sia liberati dalla capricciosità degli eventi così come ci appaiono quando li guardiamo partecipandovi.
Lo spazio dell’immagine deve chiudersi poiché non abbiamo nulla da mostrare se non ciò che c’è, e tuttavia basta osservare il senso di queste considerazioni per rendersi conto che nelle raffigurazioni deve comunque manifestarsi qualcosa che altrimenti non si manifesta — non l’essere nella sua apparenza, ma la sostanza delle cose, quell’essere vero che sta sotto alle apparenze e cui normalmente siamo ciechi. Così, per quanto l’immagine debba rinunciare alla sua profondità per farsi prossima al sostrato cui inerisce, resta egualmente vero che alle raffigurazioni si chiede di mostrare qualcosa che non è direttamente accessibile e che non coincide con la superficie della tela. Così, anche nelle opere così esemplarmente bidimensionali di Mondrian, si fa avanti una qualche profondità dell’immagine: le spetta infatti il compito di raffigurare ciò che sta sotto le cose — la loro permanente substantia — ed è questa la ragione che guida Mondrian a rendere visibile la trama ordinata del mondo secondo uno schema tendenzialmente eccentrico che ci invita a pensare che quel susseguirsi di verticali e di orizzontali continui al di sotto della scorza superficiale dei fenomeni e che l’immagine sia appunto il luogo di accessibilità di uno spazio più profondo — qualcosa come una moderna sinopia scoperta rimuovendo la superficie colorata di un intonaco o di un affresco.
Le considerazioni che abbiamo fatto valere per Mondrian, valgono anche — seppure in una diversa luce — anche per un artista come Paul Klee. Anche per Klee non si può certo chiedere alla pittura di ripetere il cammino della mimesi ed anche nel suo caso il rifiuto della prospettiva si accompagna ad una concezione creativa dell’arte pittorica: il compito della raffigurazione, così si legge nei suoi scritti, non è quello di ripetere il visibile, ma di dare forma a ciò che è possibile, alla radice invisibile delle cose. I quadri sono e debbono essere mondi possibili, ed è per questo che il pittore deve mettere da parte gli strumenti della mimesi e deve acconsentire a quella generale tendenza verso la superficie che caratterizza la pittura novecentesca: il suo compito non è quello di restituire una visibilità già data e di offrirci un nuovo spettacolo, ma consiste invece nel costruire sperimentalmente sulla tela la genesi delle forme, il loro vivo emergere.
E tuttavia anche per Klee il rifiuto della profondità dell’immagine si lega ad una ironica sfiducia nella possibilità di coniugare pienamente il dire e il mostrare e quindi, ancora una volta, al pensiero sottilmente iconoclastico dell’insufficienza delle immagini. In fondo, tutta la poetica di Klee sorge da una radicale insoddisfazione nei confronti delle forme, della loro presenza esibita e statica. La forma è diventata muta e il mondo una realtà in cui è difficile riconoscersi, se non ci si assume il compito di superare la staticità della sua forma in nome della sua possibile genesi, la visibilità piena e priva di un senso apparente nel movimento dell’invisibile verso il visibile — nella narrazione sensata del prendere forma.
In questa radicale sfiducia nella sensatezza della forma sono racchiuse molte cose, ed in particolare il rapporto che Klee stringe con la cultura e la sensibilità del romanticismo tedesco e con la sua distinzione tra forma e figurazione. Ma è implicita anche la dimensione esistenziale di cui si carica l’arte e quindi anche il compito del pittore. Se nel nostro esser gettati nel mondo siamo predestinati ad un’esistenza inautentica, ciò accade innanzitutto perché il mondo in cui viviamo è una realtà in cui i fenomeni — le forme, appunto — si susseguono senza che sia possibile scorgerne il senso apparente. Di forma in forma, il mondo diviene senza permetterci di vedere, sotto la scorza dei fenomeni, il senso del suo sviluppo. Ma ciò che non ci si mostra nello spettacolo del mondo deve essere ricreato dal pittore, che nel divenire proteiforme della realtà, deve sapersi raccapezzare, riconnettendo il dato alla genesi cui appartiene, la forma chiusa e statica alla processualità della figurazione. Proprio come noi, anche il pittore
è stato gettato in un mondo proteiforme [in eine vielgestaltige Welt gesetzt wurde], in cui bene o male gli tocca raccapezzarsi (P. Klee, Opere, Feltrinelli, Milano 1976, p. 81).
Di qui il compito del pittore cui si chiede di inaugurare una vera e propria svolta esistenziale che è resa ancor più necessaria dalla miseria dei tempi:
Oggigiorno vediamo attorno a noi forme esatte d’ogni tipo: nolens volens l’occhio ingurgita quadrati, triangoli, cerchi, elaborazioni d’ogni specie quali trame di fili di ferro su sbarre, cerchi su leve; cilindri, sfere, cupole, cubi più o meno elevati e combinati in una molteplicità di effetti. L’occhio ingurgita tali oggetti (ivi, p. 60).
Ma alla crisi del presente e alla sfiducia nella forma non si può rispondere soltanto opponendo alla visibilità vuota dell’ora il passato inattingibile delle origini; si deve anche pronunciare una rinuncia consapevole alla pienezza della forma e alla sua possibilità di dispiegarsi sensibilmente. Se vuole davvero essere raffigurazione di ciò che è soltanto possibile e quindi di ciò che non si è ancora interamente spogliato della sua originaria invisibilità, l’immagine deve accettare l’onere della contraddizione e farsi icona dell’invisibile. Può farlo, tuttavia, solo assumendo la forma di un’immagine che dilegua: solo così, nel loro porsi come raffigurazioni che si tolgono, i quadri di Klee possono rivelare la loro natura ossimorica di immagini che ci vogliono mostrare ciò che ancora non si vede.
Per venire a capo di queste considerazioni avremmo potuto seguire un cammino differente e mostrare come il movimento di negazione della profondità dell’immagine può assumere una piega iconoclastica non in ragione del suo porsi come una negazione della raffigurabilità della forma, ma come reificazione della sua visibilità. Ora, è proprio quest’ordine di considerazioni che è all’origine del dibattito antico sulle icone e che determina la possibilità di un uso idolatrico dell’immagine. L’immagine può rinunciare alla sua astratta fenomenicità e farsi idolo, ma perché ciò accada è necessario che l’atteggiamento rispetto all’immagine non sia più determinato dalla mera visibilità, ma sia guidato dalla percezione dalla materialità del sostrato che la ospita, — una materialità cui la prassi del culto deve attribuire ora un’importanza centrale.
Di qui si dovrebbe muovere per intendere le ragioni che vincolavano, e ancora vincolano, la pittura di icone al requisito della superficialità dell’immagine; e tuttavia, piuttosto che soffermarci su questo tema che pure ci consentirebbe di cogliere il chiudersi dello spazio figurativo sotto una diversa luce immaginativa, vorrei lasciare alle spalle l’indagine di questa polarità del concetto di raffigurazione per rivolgere l’attenzione alla polarità opposta, per soffermarci così sulla linea di confine che separa le rappresentazioni dall’inganno percettivo e che ci pone di fronte a quelle immagini peculiari che vanno sotto il nome di trompe l’oeil.
Che cosa sia un trompe l’oeil è presto detto: si tratta di quel tipo di immagini che da un lato tentano di cancellare con arte il lavoro dell’arte e che, dall’altro, propongono una scena che avanza, almeno per un attimo, la pretesa di spacciarsi per vera. La pretesa, appunto: normalmente le immagini non ci ingannano affatto, e tuttavia nel caso dei trompe l’oeil il pittore sembra aver fatto tutto il possibile per lasciarci giocare con la possibilità dell’errore. Che sia un’immagine, forse, lo sappiamo, ma il trompe l’oeil è comunque capace di sorprenderci e di presentare una scena che sembra appartenere al nostro mondo e che sorge senza lasciarci scorgere la materialità della tela che la ospita.
Se ci lasciamo guidare da questa definizione di trompe l’oeil è evidente che dovremo mettere da parte tutte quelle immagini in cui l’aspetto illusionistico si riduce alla delineazione di un oggetto, colto sullo sfondo di un’immagine che si pone invece apertamente come tale. Così, quando Crivelli dipinge una Madonna con bambino e, in un’altra occasione, una Santa Caterina e poi vi aggiunge ora su un corrimano di pietra, ora sul muro di una nicchia il disegno di una mosca che sembra tanto più reale quanto più chiaramente percepibile è l’ombra che apparentemente proietta su ciò su cui poggia, crea senz’altro opere con un aspetto illusionistico, ma non per questo dipinge trompe l’oeil, poiché nel suo complesso l’immagine è presente come tale di fronte ai nostri occhi. Diversamente stanno le cose quando abbiamo a che fare con le immagini di pittori come Gjisbrechts o di Jacopo de’ Barbari: qui è l’intera opera che cerca di spacciarsi per vera, ed allora abbiamo davvero a che fare con un trompe l’oeil.
Chiarito così quale sia il senso che vogliamo attribuire alla nozione di trompe l’oeil, vorrei provare a indicare, seppure sommariamente, quali siano le strategie che consentono ad un’immagine di assumere un carattere apertamente illusionistico. Sulla prima ci siamo già brevemente soffermati: una pittura in trompe l’oeil è caratterizzata, nella norma, dal tentativo di dissimulare con arte il lavoro del pittore che non può farsi strada nella nostra coscienza senza per questo togliere il carattere illusorio dell’immagine stessa. A questa prima regola generale se ne affianca una seconda: il pittore di trompe l’oeil deve cercare di dissimulare percettivamente la presenza del sostrato materiale dell’immagine, e per farlo non è sufficiente stendere con infinita pazienza il colore per non rendere più percepibile il lavoro del pennello e per coprire la trama della tela o la grana del legno o della parte intonacata. Due sono le vie che possono essere concretamente percorse per ottenere questo risultato. La prima consiste nell’ambientare l’immagine in un luogo che renda inavvertita la presenza del sostrato materiale su cui poggia. Così si può dipingere sul muro una nicchia e disporvi alcuni oggetti consueti oppure si può giocare con gli elementi dell’arredo e fingere sull’anta di uno scaffale che lo scaffale sia aperto e che siano quindi visibili i libri e gli strumenti di scienza che si attagliano al riposo di un principe amante delle scienze e delle arti — ed è questo che vediamo nelle tarsie dello studiolo di Federico da Montefeltro ad Urbino. La ragione dell’inganno è la stessa: il sostrato materiale dell’immagine si sottrae alla vista proprio perché l’immagine lo ripropone figurativamente in un contesto che ne giustifica altrimenti la presenza, e così su un muro si raffigura il muro e una nicchia, sulle pareti lignee di una libreria l’intarsio ligneo di uno scaffale aperto, e così di seguito. Gli esempi potrebbero essere moltiplicati: in un quadro di Jacopo de’ Barbari si mostra una pernice morta appesa su un fondale di legno, ed il legno dipinto deve perdersi come immagine nel suo continuare percettivamente il legno della madia su cui doveva apparirci. E ancora: un’Annunciazione di van Eyck ci presenta Maria e l’arcangelo Gabriele come se fossero due statue lignee che si sporgono da due tavole esse pure di legno. Ma altre soluzioni sono possibili, e tra queste è opportuno rammentare la scelta di dipingere su superfici improprie. Così, van der Vaart dipinge un violino come se fosse appeso su una porta — su una porta reale, la cui effettiva presenza sembra contagiare di sé l’immagine e negarle il suo status e la sua dipendenza da un sostrato materiale.
Ai trompe l’oeil che sorgono dallo sforzo di mascherare il sostrato dell’immagine integrandolo nell’ambiente si affiancano le tavole in trompe l’oeil che sono spesso caratterizzate dal presentarci proprio un quadro con tanto di cornice su cui sono tuttavia dipinti una tela che si stacca, o il retro dell’immagine stessa, in un gioco che tende a farci sembrare reale proprio l’apparenza materiale del quadro, il suo esserci come cosa fisicamente reale.
In un caso o nell’altro, tuttavia, l’arte si libera delle difese percettive nello stesso modo: costringendo il sostrato reale dell’immagine ad assumere una veste figurativa, in un gioco in cui la realtà presunta dell’immagine è guadagnata costringendo lo spazio figurativo a spingersi sino a raffigurare ciò che ci attenderemmo fungere da sostegno dell’immagine stessa.
Vi sono altre caratteristiche percettive dei trompe l’oeil su cui sarebbero interessante soffermarsi. Spesso i trompe l’oeil sono caratterizzati dal presentarci oggetti che hanno poco profondità e che si stagliano su una superficie verticale. La ragione è chiara: l’inganno è raggiunto quando si riesce a dare l’impressione dello sporgersi della cosa raffigurata rispetto ad un piano che la sorregge, e questo obiettivo si ottiene con minore fatica quando l’immagine non deve fingere spazi troppo grandi. Di qui anche l’importanza delle ombre che gli oggetti proiettano: l’ombra che la cosa proietta sul fondale ci costringe a vederla discosta da esso, rafforzando così il carattere illusorio dell’immagine. Infine, un ruolo importante nella percezione dei trompe l’oeil è giocato dalla sorpresa: un quadro in trompe l’oeil è tanto più persuasivo quanto più sa eludere lo sguardo attento dello spettatore e quanto meno si pone come uno spettacolo ma ci appare — come ogni altra cosa reale — nel suo semplice esserci. Si comprende così la natura consueta degli oggetti dipinti, e il loro essere disposti in un contesto privo di elementi narrativi: il trompe l’oeil ci presenta la realtà nella sua veste più dimessa e quotidiana, e può ingannarci soltanto se gli oggetti che offre al nostro sguardo ci parlano a bassa voce e chiedono per sé una posizione di sfondo. Proprio perché intende perpetrare un inganno, il trompe l’oeil rinuncia all’esemplarità dell’immagine e cerca di restituire gli oggetti mostrandoceli nella casualità del loro esserci, in quella consueta banalità che è propria del reale.
Queste, appunto, alcune delle proprietà che di norma caratterizzano la natura dei trompe l’oeil e che ne determinano l’aspetto fenomenico. Su questo tema si potrebbe soffermarsi molto più a lungo, e tuttavia vorrei invece invitarvi a cogliere ancora una volta come la specificità della posizione dei trompe l’oeil rispetto allo spazio figurativo nel suo complesso determini anche la peculiarità della sua funzione espressiva. Nel trompe l’oeil le immagini non si chiudono ma si perdono, e ciò significa che nel farsi sempre più prossima alla realtà l’immagine si sovrappone al reale, per essere poi svelata nel suo carattere illusorio. Accade di norma proprio così: il trompe l’oeil pretende di ingannarci e parte del nostro compito di spettatori consiste nel fare tutto ciò che è a nostra disposizione per lasciarci ingannare dalle apparenze e per giocare sul sottile discrimine che separa l’inganno dalla coscienza di immagine.
Ma ciò è quanto dire che un trompe l’oeil non è una raffigurazione tra le altre, ma è appunto soltanto un’immagine, poiché il suo senso si fa avanti insieme alla constatazione di un inganno svelato, e quindi anche del rifluire di una realtà apparente nello spazio figurativo che di fatto le compete. Di qui appunto l’uso che dei trompe l’oeil normalmente facciamo — un uso ludico, che è propriamente caratterizzato dal tentativo di indurre un comportamento reale il cui senso è sottratto dall’immediata constatazione del carattere soltanto illusorio degli oggetti o degli ambienti che l’avevano motivato. Così si può dipingere dell’uva come Zeusi, per divertirsi alle spalle di chi la crederà anche solo per un attimo vera, e tenterà di rubarne un acino (e nel caso dell’uva di Joseph Decker la tentazione è forte).
Ma in questo sottrarsi della realtà nell’immagine, che fa da controcanto al perdersi dell’immagine nel reale, è implicito un gioco che può assumere valenze più serie. Il trompe l’oeil non è soltanto un’immagine che vive nel trapasso ludico dalla realtà alla finzione: è anche una forma di immagine che mira a svuotare la realtà della sua pienezza e a mostrarne la vacuità e l’inconsistenza nella possibilità sempre aperta del suo svelarsi come una mera immagine, come un inganno che è facile svelare. Così, se nel suo spegnersi aderendo sempre più strettamente al sostrato materiale che la sorregge l’immagine assume una piega sottilmente iconoclastica, nel suo giocare con la realtà e con la possibilità del disinganno, l’immagine assume su di sé una funzione metafisica: ci invita a considerare l’essere sotto il segno della vanitas. Al sorriso caricaturale che risponde al gesto avventato di chi cerca di afferrare un oggetto fittizio o di chi cede alla promessa di uno spazio che si svelerà irreale fa eco il sorriso ironico dell’immagine che nel revocare a sé la presunta realtà delle cose ne mostra l’intrinseca debolezza. Le immagini sono soltanto immagini: questo è ciò che il trompe l’oeil pone infine sotto ai nostri occhi, quando l’illusione si mostra nella sua natura autentica. Ma il «soltanto» dell’immagine si fa strada nel reale, e la possibilità dell’inganno assume un senso nuovo: ci invita a riflettere sulla labilità del confine tra realtà ed apparenza e, quindi, sulle ragioni che ci spingono a dubitare innanzitutto sul piano etico della effettiva pienezza delle cose, del loro titolo a porsi come reali. Di qui appunto il farsi strada nei trompe l’oeil del tema della vanitas: la nicchia che ci presenta gli oggetti consueti, affianca ad essi le immagini classiche della precarietà del reale — ai libri e agli utensili si affiancano così la clessidra, la candela o talvolta il teschio. E ciò che accade nelle nicchie si ripete anche nei quadri che raffigurano quadri. Anche qui il tema della vanità si fa strada e la tela che il quadro ci presenta è spesso lacerata e strappata, in un gioco che è da un lato funzionale all’inganno percettivo, ma che è dall’altro chiaramente connesso con un intento di natura etica. Del resto, è forse per questo che i maestri della pittura illusionistica pongono nei frutti o nei pani dipinti qualche piccola imperfezione: la frutta segnata, il pane tagliato, la parete sbrecciata sono da un lato segni di una realtà usuale che c’è senza il diritto di esibirsi, ma sono anche dall’altro metafore della fragilità del reale, della sua incapacità di resistere al tempo e, insieme, della sua tendenza a sottrarsi alla nostra presa[9].
Lezione decima
1. La geometria duplice delle immagini
Le riflessioni che abbiamo dianzi proposto ci hanno mostrato ancora una volta come le immagini siano caratterizzate da una loro interna dualità: vi è immagine solo quando lo spazio figurativo ha una sua profondità e tuttavia non nega, nel suo apparire, la superficialità del sostrato cui appartiene.
Su questo punto ci eravamo già soffermati, ed avevamo osservato come la dualità della percezione di immagine non fosse riconducibile ad una mera coesistenza di piani ma assumesse la forma di una relazione interna tra due aspetti di un’identica percezione. In particolar modo avevamo osservato che il percepire un’immagine significa sempre percepire le determinatezze fenomeniche del sostrato materiale dell’immagine come se fossero caratteristiche interne alla raffigurazione, forme che traspaiono nella scena dipinta assumendo un significato figurativo. Così un’immagine non è soltanto fatta di pigmenti disposti su una tela, ma è anche sempre il risultato percettivo del trasparire dei pigmenti e del sostrato nella forma della scena raffigurata, determinandone il senso espressivo e percettivo. E se si deve riconoscere che quest’affermazione è tanto più vera quanto più l’immagine rinuncia al precetto del celare con arte l’arte, e se è ovvio che un quadro di van Gogh lascia trasparire la materialità dell’impasto cromatico assai più di quanto non accada in un quadro cinquecentesco, ciò non toglie che la scelta dei materiali faccia sempre parte, seppure in misura variabile, del risultato percettivo dell’immagine, della sua interna configurazione.
Su questo punto è opportuno insistere un poco, poiché ciò che qui ci si mostra ripropone in forma nuova una caratteristica del concetto di raffigurazione: il suo riproporci nella forma di un’interna polarità i confini che circoscrivono la sensatezza della sua applicazione. Il concetto di immagine ha confini esterni: l’immagine c’è soltanto quando è irriducibile alla configurazione materiale del sostrato ed in modo particolare il suo spazio non coincide con la superficie della tela. E tuttavia in ogni immagine è rinvenibile una polarità interna: ogni immagine, infatti è animata da una dialettica interna tra la geometria superficiale dell’immagine e la geometria profonda dello spazio figurativo, tra le forme che scandiscono superficialmente lo spazio invisibile della tela e le forme che si agitano nella visibilità dello spazio figurativo.
Questo è quanto intendo dire. Quando disegniamo qualcosa, la disegniamo su un sostrato materiale che ha una forma che è, come tale, caratterizzata da una sua interna struttura, e l’una e l’altra non sono senza relazione con lo spazio figurativo. Possiamo anzi spingerci in un passo in avanti ed osservare che le cornici hanno, tra le altre loro funzioni, anche questa: ad esse spetta il compito di racchiudere lo spazio figurativo e di farlo così coincidere con la forma che esse ritagliano nella superficie materiale della tela. Una cornice rotonda racchiude una tela rotonda, ma definisce anche la forma dello spazio figurativo, il suo essere circoscritto da un margine di accessibilità che coincide con l’apertura che la cornice ritaglia nello spazio reale. Ora, scegliere una cornice non significa solo scegliere la forma dello spazio figurativo, ma vuol dire anche scandirlo secondo una serie di regole, di possibilità che sono dettate dalla geometria superficiale dell’immagine. Si tratta di un tema complesso che è trattato con grande ricchezza di esempi e di osservazioni sottili in un libro di Charles Bouleau, intitolato La geometria segreta dei pittori. Qui vorrei limitarmi soltanto a qualche generalissimo esempio che ci consenta di comprendere il senso del problema — o almeno: il senso che questo problema ha all’interno delle nostre considerazioni. Pensiamo allora ad una cornice circolare e alla possibilità di inscrivere nel cerchio due quadrati, l’uno le cui diagonali siano i diametri che si allineano con l’orizzontale e con la verticale, l’altro che abbia invece i lati disposti lungo questi assi. Così:

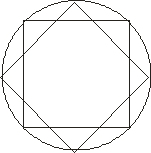
E ora se tracciassimo le diagonali dei quadrati e ponessimo in questo schema non la Madonna della seggiola ma la Sacra famiglia del Signorelli il nesso tra geometria superficiale e geometria profonda dell’immagine assume una sua esemplare chiarezza.
Potremmo naturalmente proporre molti altri esempi, abbandonando
le cornici rotonde e muovendo dapprima alla forma più classica della cornice:
le cornici rettangolari. È a questo proposito che Bouleau parla di armatura
del rettangolo e con essa intende quella suddivisione dello spazio
figurativo che deriva dalla partizione tracciata dalle diagonali. Le diagonali
si incontrano  e
segnano la metà dei lati, consentendo così una divisone dello spazio
dell’immagine in primo luogo. in due nuovi rettangoli, le cui diagonali si
incrociano individuando due punti che consentono una divisione in quattro del
rettangolo originario. Il gioco può essere iterato e la figura viene così ripartita
in parti: l’incrocio tra le diagonali dei mezzi con le diagonali dei quarti
consente una divisione per tre dei lati e di qui si può ottenere una divisione
per sei, secondo una regola essa pure iterabile. Ne nasce una geometria di linee
lungo cui disporre le figure, e contenerle. E ancora: il lato minore del rettangolo
può essere ribaltato sul lato maggiore, dando così vita a due quadrati che possono
sovrapporsi delineando a loro volta degli spazi e delle linee di tendenza. Nel
disegno di Giotto che ci mostra San Francesco di fronte al sultano la regola costitutiva
del disegna nasce proprio da qui — da questa geometria superficiale dell’immagine,
dal gioco che il ribaltamento prima e le diagonali poi disegnano sulla parete
affrescata.
e
segnano la metà dei lati, consentendo così una divisone dello spazio
dell’immagine in primo luogo. in due nuovi rettangoli, le cui diagonali si
incrociano individuando due punti che consentono una divisione in quattro del
rettangolo originario. Il gioco può essere iterato e la figura viene così ripartita
in parti: l’incrocio tra le diagonali dei mezzi con le diagonali dei quarti
consente una divisione per tre dei lati e di qui si può ottenere una divisione
per sei, secondo una regola essa pure iterabile. Ne nasce una geometria di linee
lungo cui disporre le figure, e contenerle. E ancora: il lato minore del rettangolo
può essere ribaltato sul lato maggiore, dando così vita a due quadrati che possono
sovrapporsi delineando a loro volta degli spazi e delle linee di tendenza. Nel
disegno di Giotto che ci mostra San Francesco di fronte al sultano la regola costitutiva
del disegna nasce proprio da qui — da questa geometria superficiale dell’immagine,
dal gioco che il ribaltamento prima e le diagonali poi disegnano sulla parete
affrescata.
Come ho detto gli esempi possono essere moltiplicati, e Bouleau ci mostra quale peso nella geometria dell’immagine abbiano avuto da un lato le speculazione sulla proporzione aurea (come nel caso della Deposizione della croce di Rogier van der Weyden) o, dall’altro, le armonie musicali che Alberti proietta sulla partizione degli spazi (e la Primavera del Botticelli ci offre una nuova possibile esemplificazione).
Non è possibile affrontare qui, nemmeno per sommi capi la storia di questo problema: chiederebbe una competenza che non ho e ci porterebbe comunque troppo lontano dalla dimensione filosofica delle nostre considerazioni. E di fatto ciò che questi problemi possono insegnarci può essere detto in breve: la geometria superficiale delle immagini può determinare lo spazio figurativo nelle sue partizioni e nella disposizione dei suoi oggetti — può, in altri termini, imbrigliarne la geometria profonda solo perché nello spazio figurativo si coglie, seppure in una nuova luce, la struttura formale interna alla tela, la rete delle relazioni geometriche che scandisce percettivamente il suo esserci. Il pittore che segue le diagonali della cornice e divide gli spazi sulla superficie piana del foglio usando righello e compasso crea insieme l’articolazione dello spazio profondo dell’immagine, che deve così apparirci come un’eco delle linee di forza tracciate sul piano. E ciò è quanto dire che nello spazio profondo dell’immagine deve farsi visibile anche la sua superficie, — geometria superficiale e geometria profonda debbono in qualche misura dividersi la scena percettiva poiché l’una trae senso dall’altra. Ciò è vero in ogni immagine, e tuttavia non è difficile rendersi conto che il nodo che stringe la geometria superficiale dell’immagine alla disposizione degli oggetti che animano lo spazio figurativo varia con il variare della profondità dell’immagine. Nel disegno di un mosaico bizantino la geometria della cornice si fa necessariamente assai prossima alla geometria dello spazio figurativo e la tensione tra le due geometrie si fa esigua. Diversamente stanno le cose quando lo spazio figurativo si fa profondo, poiché è proprio la profondità dell’immagine che apre la forbice tra ciò che struttura il piano materiale del foglio e la forma della disposizione degli oggetti nello spazio figurativo. Di qui la tensione tra questi due momenti e la drammaticità che la loro composizione può di volta in volta assumere. Anche in questo caso, dunque, la profondità dell’immagine si pone come una sorta di asta graduata che misura l’immagine e che ne definisce il carattere.
2. Il segno e il disegno
Alle considerazioni che abbiamo proposto sulla geometria delle immagini fa eco la dialettica tra segno e disegno, tra la forma del tratto e la sua funzione figurativa. Anche in questo caso le riflessioni sul confine esterno delle raffigurazioni hanno una loro eco sul piano figurativo e ci mostrano un’interna polarità. L’aspetto materiale del segno non appartiene allo spazio figurativo e, in un senso relativamente ovvio del termine, non vi appartiene nemmeno la sua forma obiettiva: allo spazio figurativo appartiene soltanto ciò che il segno disegna. Per dirla in breve: nello spazio figurativo non ci sono pennellate diritte o ricurve, — vi sono invece contorni diritti o ricurvi e profili di oggetti. E tuttavia, anche in questo caso alla nettezza delle distinzioni grammaticali deve far eco in seno all’immagine il linguaggio che conosce il più e il meno della polarità. Non vi è dubbio infatti che il segno nella sua forma si imponga come caratteristica del disegno e che traspaia quindi nello spazio figurativo.
Ma vi traspare secondo una misura mutevole che varia con il variare della profondità dell’immagine. Nella linea che traccia il volto in un’icona bizantina segno e disegno sono l’uno accanto all’altro poiché la funzione cui il tratto di pennello assolve non può essere facilmente disgiunta dalla forma che gli spetta: dobbiamo vedere nella linea diritta il profilo diritto del naso, nella curva dolce che il pennello disegna la curva elegante degli occhi, e così di seguito. Ma quanto più l’immagine si fa profonda, tanto più la cosa che vediamo animare lo spazio figurativo si discosta per la sua forma dalla forma obiettiva del segno. Eppure il segno lo vediamo come un aspetto caratteristico della scena dipinta e ciò rende più viva e dialettica la dualità interna all’immagine.
Quale sia questa dualità e quale la tensione che li connette
non è difficile dirlo: il disegno che ha profondità e in modo particolare il
disegno prospettico sorge come negazione dell’identità di segno e disegno e
come riconoscimento, d’altro canto, del loro necessario intreccio. Di qui la particolarità delle raffigurazioni prospettiche:
la prospettiva è una tecnica che ci costringe a cogliere il significante sulle
ceneri del significato, e non come un suo momento interno. Ai linguaggi che non
rinunciano a muoversi sulla superficie della tela e che ci propongono
un’immagine dell’oggetto ricca di momenti signitivi poiché il tratto che la
matita lascia nel circoscriverlo è comunque presente come un indice che
definisce la distanza della raffigurazione dal suo divenire illusoria, si
contrappone così la prospettiva come linguaggio della profondità che pone di
fronte agli occhi dello spettatore un disegno in cui sembra manifestarsi la
cosa stessa. Sul quadro prendono forma volti e corpi, ma non sembra quasi
possibile vedere insieme la linea che li delimita, alla cui presenza possiamo
pienamente accedere quando — distolto lo sguardo dalla cosa — lo rivolgiamo al
fenomeno che la manifesta, per cogliere la geometria nascosta delle linee, che
ci appaiono ora sullo sfondo di un cammino che conduce all’astrattezza del segno. Di fronte ad un quadro noi, come spettatori,
cerchiamo di renderci disponibili
all’illusione: lo sguardo si dirige verso il significato. Ma il significante è
comunque presente: seppure solo in trasparenza, la forma concreta del tratto si
fa strada e ci chiede di guardarla. Distesa sulla tela la forma prospetticamente
data assume il contorno dell’ombra — di ciò che si dispone sul velo che Alberti
suggeriva al pittore di tenere tra sé e la cosa ritratta.
È in questo contesto che è opportuno rammentare, seppur brevemente,
il fenomeno dell’anamorfosi. Che cosa sia l’anamorfosi è presto detto: parliamo
di anamorfosi tutte le volte in cui una scena dipinta o una sua parte ci appare
secondo un taglio prospettico tanto accentuato da renderla irriconoscibile. Un
quadro ha un suo punto di vista privilegiato: lo guardiamo ponendoci di fronte
ad esso. Ma il dipinto è stato costruito secondo una prospettiva fortemente eccentrica:
possiamo cogliere ciò che l’immagine raffigura solo assumendo una posizione
innaturale rispetto all’immagine. Di qui tuttavia, il segno si scioglie nel
disegno e l’immagine ricompare, — dopo averci costretto a faticare non poco.
L’anamorfosi è, appunto, una raffigurazione capricciosa: come ogni
disegno ci promette qualcosa, ma sembra poi volerci negare il suo contenuto, per vederci indaffarati al suo cospetto. E
tuttavia il risultato cui infine perveniamo non deve farci dimenticare lo
stupore del primo sguardo, poiché il senso dell’anamorfosi consiste proprio nel
rendere liberamente percorribile il cammino che dal segno conduce al disegno,
in una sorta di percorso interno al concetto di raffigurazione. Il percorso cui
l’anamorfosi costringe lo spettatore ripete la polarità interna all’immagine,
il suo distendersi tra la forma che appare e le forme che le consentono di
apparire. Questo è quanto l’anamorfosi ci mostra: il cammino che l’immagine può
percorrere tra il venir meno del segno e la piena autonomia del significante —
un’autonomia verso cui l’anamorfosi sembra condurci, senza tuttavia farcela toccare
con mano, poiché in quell’intrico di linee dobbiamo comunque cercare un volto,
un paesaggio, un racconto[10].
Lezione undicesima
1. Le immagini: un oggetto culturale
Le riflessioni che abbiamo svolto sin qui si sono silenziosamente attenute ad una semplificazione metodologica: volevamo riflettere sulla natura percettiva delle raffigurazioni e, proprio per questo, ci siamo tenuti lontani da ogni considerazione che chiamasse in causa le ragioni per le quali le immagini sono così importanti per noi. Ora, tuttavia, è giunto il momento di lasciar cadere questa finzione e di ricordarsi che le raffigurazioni non sono cose tra le altre ma oggetti che appartengono alla nostra cultura e che non è in generale possibile parlarne senza tenere conto delle diverse e molteplici forme in cui delle immagini ci avvaliamo.
Per noi uomini le immagini sono importanti e si intrecciano in molti e diversi modi con la nostra vita, sin da quando siamo piccoli. Ce lo ricorda Wittgenstein in un pensiero sottile che vorrei leggervi:
Devi pensare alla parte che le immagini del carattere dei dipinti (in opposizione ai disegni tecnici) hanno nella nostra vita e qui non c’è proprio nessuna uniformità. Da confrontare con: qualche volta si appendono proverbi ai muri. Ma non trattati di meccanica (il nostro rapporto con queste due cose) (Ricerche filosofiche, op. cit., XI, 87).
Perché i quadri si appendono alle pareti e non si appendono invece le dimostrazioni geometriche o gli enunciati di una qualche legge fisica? Forse questa domanda non ce la siamo mai posta, o forse abbiamo ritenuto di sapere già come rispondere: un dipinto è bello da guardare e cattura lo sguardo, mentre una formula o una dimostrazione può essere bella da comprendere, ma non sembra parlare direttamente allo sguardo. Non vi è dubbio che questo sia un motivo, ma non è l’unico e l’osservazione che abbiamo appena citato ci invita a pensare ancora: nessuno orna i muri della propria casa con l’equazione della retta, ma qualche volta su una parete si può scrivere in un cartiglio un detto famoso, un proverbio o una massima, e la ragione di questo gesto è chiara — un proverbio, come un ritratto di qualche illustre predecessore, può dissuaderci dal compiere azioni avventate o invitarci ad assumere un comportamento virtuoso, ed è per questo che ci sembra così ovvio appenderlo ad una parete e lasciare che da lì ci guarda e commenti le nostre azioni. Nei palazzi nobiliari si era soliti raccogliere in una stanza o in un corridoio i ritratti degli avi, e basta percorrere oggi quelle stanze e quei corridoi per comprendere come una simile galleria di volti dovesse rammentare agli ospiti quale fosse il comportamento da assumere e quale la soggezione che ci si attendeva da loro. Ma se un ritratto può incutere soggezione, un altro può invitarci a un ricordo carico di affetto, ed un terzo può semplicemente farci pensare. Le funzioni delle immagini sono molte, e molte e diverse sono le domande che ad esse rivolgiamo: si possono appendere immagini sacre davanti alla porta di casa per sentirsi protetti, si possono raccogliere le fotografie in un album per sorreggere il racconto che si farà sfogliandolo e si può tenere una fotografia della propria famiglia nell’ufficio per tracciare una continuità tra due differenti scenari della propria esistenza.
Ma perché soffermarsi su queste cose che tutti sappiamo? Per rammentare che siamo accomunati da un particolare atteggiamento rispetto alle immagini, — un atteggiamento che può cambiare e che si è scandito in varie forme nella storia della nostra cultura ma che è caratterizzato da una peculiare vicinanza alle immagini e dalla convinzione che abbiano molto da dirci. E non è ovvio che sia così, non è affatto necessario che di fronte ad un ritratto o a una fotografia si reagisca come noi reagiamo — guardandoli quasi come se fosse presente ciò che per loro mezzo si raffigura e come se fosse possibile che il volto ritratto a sua volta ci guardi minaccioso o sorridente dalla parete che lo ospita (ivi, XI, 93), in un gioco che ci sembra del tutto normale giocare. Ma questo gioco potrebbe un giorno sembrarci semplicemente ridicolo e potrebbe forse accadere che il divertimento che oggi ci procura ceda il passo alla noia e alla stanchezza:
Potremmo facilmente immaginare uomini che non hanno questo rapporto con le immagini. Uomini, per esempio, che provino una vera e propria repulsione per le fotografie perché un volto privo di colore e, e forse anche un volto in proporzioni ridotte, gli sembra inumano (ivi, XI, 90).
Per una cultura diversa dalla nostra le immagini potrebbero essere inguaribilmente mute. Per noi, invece, parlano e questa è la premessa su cui poggiano molti dei presupposti di senso che danno alle immagini la loro pienezza. Ma ciò è quanto dire che se vogliamo davvero comprendere il senso effettivo che attribuiamo ad una raffigurazione, dobbiamo rivolgere l’attenzione da un lato alla nostra forma di vita e, dall’altro, ai molti giochi linguistici che attribuiscono alle immagini un senso definito, disponendole nelle pieghe di una prassi che ci insegna come impiegarli.
Alle considerazioni fenomenologiche sulla natura delle immagini debbono connettersi così le riflessioni ermeneutiche sulla dinamica dei loro possibili usi, e ciò pone il problema di comprendere come e dove la varietà dei giochi linguistici possa far presa sulla determinatezza intuitiva delle raffigurazioni. Su questo punto ci siamo già più volte soffermati, quando in varie occasioni abbiamo osservato che le immagini sono strumenti, e che uno strumento può essere impiegato in vario modo e per scopi diversi anche se la varietà delle forme d’uso e degli obiettivi ha un limite che si radica nella natura dello strumento, nella sua forma. Così, possiamo attribuire funzioni molto diverse ad un’immagine, ma non possiamo dimenticare che una raffigurazione è un oggetto che ha una forma essenzialmente visiva e che possiamo usarla in vario modo, ma che il campo di variabilità delle sue forme di impiego è definito dal fatto che infine ogni immagine si usa così — guardandola. Da una parte la forma, dall’altra la funzione, e l’orizzonte delle funzioni ci riconduce alla dimensione della storia e delle forme di vita: le funzioni delle immagini si pongono sotto il segno dell’ermeneutica. Ma le immagini non hanno soltanto una funzione, e di fatto perché un’immagine possa ottemperare al suo scopo è necessario che abbia una forma che le consenta di essere usata proprio così. Ora, la forma di un’immagine ci riconduce prevalentemente al come del suo darsi percettivo: all’ermeneutica dell’immagine deve dunque affiancarsi la sua fenomenologia.
Certo, parlare di forma e di funzione di un’immagine non significa affermare che questi momenti sussistano l’uno accanto all’altro e che sia possibile coglierli nella loro separatezza. Un’immagine che non abbia una funzione non vi è, ed ogni funzione si intreccia con la forma dell’immagine, determinandone almeno in parte il senso e il modo di datità. E tuttavia, la constatazione ovvia che ci rammenta che forma e funzione non possono essere colti se non nel loro reciproco intreccio, non deve impedirci di distinguere questi due concetti, ma soprattutto di domandarci quale sia di volta in volta la relazione che li lega. Che non si possa separare una volta per tutte e sino in fondo la forma dalla funzione non è un argomento che ci consenta di non porre di volta in volta la questione della loro distinguibilità e del loro intreccio, proprio come non sarebbe una buona ragione per non bere la consapevolezza del fatto che prima o poi si avrà di nuovo sete.
Per chiarire un poco queste considerazioni è forse opportuno addentrarci a titolo esemplificativo sul terreno di un’analisi dei nessi tra forma e funzione delle raffigurazioni. Ora, un primo passo in questa direzione potrebbe consistere nel rammentare che questo nesso non ha carattere necessario, e che è possibile mutare la funzione di un’immagine senza alterarne necessariamente immediatamente la forma. Così, data un’immagine, è sempre possibile intenderla, per esempio, come un semplice contrassegno e quindi come una configurazione di simboli che trae il suo senso dall’istituzione di una relazione di proiezione rispetto ad un determinato stato di cose. Una fotografia di una persona può avere per noi la vita propria delle immagini: possiamo guardarla per ricordarci di una persona cara; ma possiamo anche utilizzarla come foto segnaletica se invece di farne la meta di un vedere esclusivamente rivolto all’oggetto che ci manifesta, la utilizziamo come un mezzo per individuare una persona persa nella folla. In questo caso la fotografia non vale per chi la guarda come meta di un riconoscimento, ma come fondamento di una relazione proiezione che conduce ad altro. Certo, anche se una relazione di proiezione può essere del tutto arbitraria, nel caso delle fotografie segnaletiche o delle carte geografiche il nesso proiettivo ha carattere intuitivo: l’immagine che funge da contrassegno è simile a ciò che denota ed è per questo che da un lato non abbiamo bisogno di spiegazioni per imparare ad usarla e, dall’altro, non sembra necessario adattare la forma della raffigurazione alla nuova funzione che le viene attribuita. Non è necessario, ma di norma accade: tra forma e funzione vi è un nesso che si manifesta anche nella natura delle fotografie segnaletiche — nella loro caratteristica inespressività. Le fotografie per la carta di identità si scelgono così: si cerca uno scatto che non fissi una qualche espressione particolare, ma restituisca il nostro volto nella piega anonima di un’astratta riconoscibilità. E la ragione è ovvia: ciò che in un contrassegno deve esserci è solo ciò che è utile per la sua funzione di rimando. Di altre cose non c’è bisogno: se deve servirci per riconoscere una persona nella folla e non deve valere per noi come un nuovo oggetto da guardare, la fotografia deve rinunciare a tutti quei tratti che non servono per sorreggerci nel compito dell’individuazione.
Di qui l’adattarsi della forma della fotografia alla funzione che le viene imposta e il farsi avanti di un genere che tende ad assumere proprio quelle caratteristiche che ci consiglierebbero di scartare quella fotografia se l’obiettivo fosse quello di ospitarla in un album.
Ad altre funzioni competono altre forme, e la storia delle arti figurative è, o almeno dovrebbe essere, anche la storia del nesso che lega le immagini al loro uso. Un’icona russa, un affresco rinascimentale, un ritratto barocco, un quadro storico ottocentesco non sono soltanto immagini che differiscono per forma, ma sono anche oggetti culturali che hanno funzioni diverse e che si inseriscono diversamente nelle nostre forme di vita. Per farlo debbono adattare la loro forma al loro uso, e basta soltanto pensare ad un tratto esteriore come la dimensione fisica dell’immagine per rendersene conto. Un affresco è grande perché vuole assumere una funzione pubblica: l’affresco è nella Chiesa o nelle stanze di un palazzo ed è fatto in modo tale da non poter abbandonare il luogo per il quale è stato pensato. Di qui, da queste stanze o dalle navate di questa chiesa, deve giungerci il messaggio di cui l’immagine è latrice. Ma un quadro può essere anche oggetto di una devozione privata: l’immagine può farsi piccola e chiedere di essere osservata da vicino, ed in questo caso la sua forma suggerisce l’intimità della ricezione e fa della percezione del dipinto un dialogo silenzioso tra ciò che è ritratto e lo spettatore. Del resto, una piccola raffigurazione può essere portata con sé e si può tenere tra le mani, ed in questo caso la sua stessa aderenza ad un sostrato materiale può assumere una valorizzazione immaginativa poiché può consentirci una serie di comportamenti che non sarebbero semplicemente possibili se l’immagine avesse natura impalpabile, e qui gli esempi potrebbero essere tratti tanto dalla devozione popolare, quanto dalla letteratura rosa che narra di innamorati che baciano e stringono al petto il ritratto dell’amata.
Si potrebbe insistere ancora sul terreno degli esempi, su cui del resto si dovrà in seguito tornare. E tuttavia, piuttosto che dilungarmi ancora su questo piano, vorrei invitarvi a riflettere in modo un poco più approfondito sul fatto che vi è un uso delle raffigurazioni che ha valenza immaginativa e che trova le condizioni più adatte per farsi avanti proprio in virtù della natura peculiare delle raffigurazioni. Che cosa intendo dire quando alludo ad un uso immaginativo è presto detto: ci avvaliamo immaginativamente di un oggetto quando lo trasciniamo in un comportamento ludico che strappa la cosa dalla sua appartenenza al mondo reale per farne il soggetto di una narrazione all’interno della quale valgono funzionalmente una serie di proposizioni e di credenze. Così stanno le cose nei giochi dei bambini: si inventa il canovaccio di un gioco e gli oggetti domestici assumono un significato nuovo — il divano è una nave e le poltrone sono isole da raggiungere a nuoto. Naturalmente vi è un vantaggio nel trascinare nel gioco oggetti reali, poiché l’immaginazione di ciascuno può farsi gioco comune se le è concesso di far presa su oggetti che siano disponibili per tutti e se la presenza corposa delle cose può sorreggere la prassi ludica e suggerirle una molteplicità di possibili sviluppi — e su questo punto vi invito senz’altro a leggere un bel libro di Walton intitolato Mimesis as Make-Believe. On the Foundations of Representational Arts (1990). Nel gioco, abbiamo detto, il divano è una nave e le poltrone sono isole, ma è evidente che del verbo «essere» dobbiamo fare qui un uso assai parco poiché nella prassi del gioco non modifichiamo la natura reale degli oggetti, ma li trasciniamo soltanto in una trama narrativa che ci invita a considerarli come se fossero vere proposizioni che vere non sono ma che debbono essere credute tali da chi accetta le regole del gioco. Queste regole sono solo in parte assunzioni che si fanno nel momento in cui si decide il gioco, e spesso nuove regole sorgono spontaneamente nel gioco e sono suggerite dalla forma degli oggetti e dalle possibilità che essi offrono alla prassi ludica; il loro dipendere dalla forma delle cose non toglie tuttavia il loro carattere immaginativo: chi gioca fa come se il divano fosse una nave e le poltrone isole ma non per questo crede davvero che le cose stiano così. La situazione ludica si sovrappone al mondo reale ma non lo nega, e ciò è possibile solo perché le “credenze” che la animano si rivolgono ad uno scenario che è interamente distinto dall’universo reale nel quale normalmente siamo. Ciò che è vero per il gioco è vero soltanto nel gioco che si dispiega quindi necessariamente ritagliandosi uno spazio autonomo i cui confini non separano un luogo dagli altri, ma uno scenario dell’esperienza — lo scenario immaginativo — dal mondo reale in cui ha luogo. Così, il bambino che, nella prassi ludica, trasforma gli oggetti che gli stanno accanto in navi, isole e pesci mostruosi non per questo pretende di coinvolgere nel proprio gioco la totalità delle cose che lo circondano o di porre lo spazio di gioco in cui si muove in una qualche relazione spaziale con quel mondo la cui certezza non è messa in discussione, ma è solo momentaneamente tacitata, come un peso di cui è opportuno ogni tanto liberarsi. La realtà del mondo con il suo spazio obiettivo e il suo tempo resta intatta, ma il gioco ci vieta di prestare ascolto al suo rumore o di rammentare la sua presenza senza assoggettarla alla regola del gioco, ad un’interpretazione ludica che le assegni un «come se» che si attagli alla finzione in cui ci siamo volontariamente immersi.
Così appunto stanno le cose quando ci disponiamo nel gioco linguistico dell’immaginazione. Ma se questa è la natura delle finzioni non è difficile comprendere perché le raffigurazioni siano, per così dire, predestinate ad un impiego immaginativo. Certo, vi sono raffigurazioni che, lungi dal porsi come fondamento di una messa in scena immaginativa, valgono per noi come testimonianza che un evento è davvero accaduto e che si è svolto così. È questo l’uso consueto che delle fotografie si fa su un giornale: la relazione causale che lega il soggetto dell’immagine alla sua origine empirica suggerisce una simile forma di impiego. Ma se ci limitiamo alle raffigurazioni in quanti tali, allora non è difficile mostrare come molte delle caratteristiche che competono alla loro forma possano insieme sorreggere un impiego immaginativo che sorge così come una naturale continuazione dell’esperienza cui le immagini ci chiamano.
Per tentare di giustificare una simile osservazione è necessario rammentare brevemente quali siano le caratteristiche che sono proprie degli oggetti dipinti e dello spazio figurativo. Ora, nelle nostre analisi ci eravamo innanzitutto soffermati su un punto: avevamo infatti osservato che ciò che vediamo dipinto su una tela o raffigurato in una fotografia non è, in senso proprio, un oggetto poiché ha una natura meramente fenomenica e non possiede una realtà che vada al di là del suo essere percepito. Gli oggetti dipinti non esistono in senso proprio e il loro porsi come oggetti fenomenici chiede che vi sia uno spettatore che li osservi e che sappia insieme riconoscere ciò che si raffigura. Riconoscere che ciò che vedo in un quadro esiste solo come uno spettacolo per chi l’osserva vuol dire anche rammentare che il porsi della scena figurativa non vale come una negazione della realtà della tela e dei pigmenti che rendono possibile la percezione dell’immagine; tutt’altro: il paesaggio dipinto che vedo di fronte a me non pretende di esistere e non mette in dubbio la solidità del muro che lo ospita. Del resto, alla realtà meramente fenomenica di ciò che l’immagine raffigura fa da riscontro la sua peculiare spazialità: lo spazio figurativo ha una sua propria chiusura e nulla di ciò che ospita può essere sensatamente posto in una relazione reale con le cose che occupano lo spazio obiettivo. In un quadro di Vermeer si vede una ragazza che sorride, seduta di fronte a un tavolo in una stanza, illuminata da una finestra con le ante discoste. La stanza dipinta è qui di fronte a noi che la osserviamo, ma non possiamo per questo dire che la stanza dipinta è nella stanza in cui siamo, proprio come del tavolo dipinto si può dire soltanto che è vicino alla finestra dipinta: chiedersi se sia vicino o lontano ad una qualche finestra reale è invece del tutto privo di senso, poiché vicina (o lontana) è la tela su cui quello spettacolo si dispiega. Per dirla in breve: gli oggetti raffigurati sono soltanto all’interno della raffigurazione e dello spazio figurativo cui appartengono, e se ci fossimo espressi così, ripetendo una formula di cui ci siamo appena avvalsi per chiarire la natura degli oggetti immaginativi, avremmo fin da principio colto qual è il nesso che rende così facile il trapasso dalla natura meramente intenzionale dell’universo figurativo alla dimensione propriamente immaginativa che caratterizza per esempio i giochi infantili o le finzioni proprie di un racconto o di un romanzo. Gli oggetti figurativi sono oggetti meramente fenomenici che si danno soltanto per uno spettatore, proprio come gli oggetti immaginativi sono ciò che si dà nella prassi ludica, — in una prassi che ritaglia uno spazio immaginativo nello spazio reale e vincola la natura e l’esistenza sui generis dei propri oggetti alla regola della narrazione entro cui si danno. Di qui, dunque, la vocazione immaginativa della figurazione, il suo tendenziale condurci dalla percezione alla narrazione fantastica, seguendo un cammino che sembra dettato dalle pieghe dell’etimologia che non riesce a separare le parole della dimensione immaginativa da un esplicito riferimento all’orizzonte figurativo.
Ora, cogliere la relazione che lega la natura dello spazio figurativo allo spazio immaginario della narrazione è importante perché ci mostra ancora una volta come la natura degli oggetti determini l’uso che ne facciamo. E tuttavia se questo nesso va sottolineato è anche per comprendere che cosa di nuovo accada quando ci disponiamo nei confronti delle immagini in un atteggiamento immaginativo. Le raffigurazioni sono oggetti visivi, ma se davvero prendono vita per noi è solo perché accettiamo di prendere parte al gioco che ci propongono. Guardare una raffigurazione e riconoscere ciò che ci presenta non significa ancora disporsi rispetto all’immagine in un atteggiamento che ci consenta di viverla pienamente, di sentirci motivati a comportarci rispetto ad essa come se fossimo presso la scena raffigurata. Per vedere in un ritratto un volto basta guardarlo; per sentirsi osservati dal suo sguardo o per avvertire la sua presenza nello spazio di risonanza dell’immagine è necessaria l’immaginazione. Su questo punto è forse opportuno soffermarsi un poco per dare alle nostre considerazioni la pienezza intuitiva degli esempi. Ad Arezzo Piero della Francesca ha dipinto un ciclo di affreschi che narra la storia della vera croce, e tra i molti riquadri in cui questo ciclo pittorico si scandisce uno è dedicato a raffigurare la morte di Adamo. Lo guardiamo: vi è un’immagine che ci presenta qualcosa: vediamo di fronte a noi un vecchio morente, circondato dall’affetto dei suoi familiari. Ma ciò che vediamo di fronte a noi può divenire parte di un gioco dell’immaginazione e possiamo sentirci chiamati ad assistere immaginativamente alla morte di un uomo, anzi alla morte del primo uomo che ha vissuto consapevolmente l’avvicinarsi della propria fine: Adamo. Qui, davanti a noi che guardiamo, si dispiega nell’esemplarità della prima volta il destino dell’uomo, ma insieme si mostra anche la possibilità del suo superamento — almeno se ci lasciamo persuadere dal messaggio che Piero della Francesca ci racconta nei suoi affreschi di Arezzo e cerchiamo di vedere nell’albero che nasce sulle spoglie di Adamo il legno di cui sarà fatta la croce da cui dipenderà la sua salvezza. Questa scena e le altre scene di cui il ciclo si compone le vediamo poiché sono dipinte e sono qui di fronte a noi, ma per dar loro vita dobbiamo condividere una presenza: dobbiamo accordarle il nostro qui e il nostro ora immaginativo, dobbiamo fare come se quella scena si recitasse di fronte ai nostri occhi e fosse possibile condividere le emozioni e i pensieri che la animano. Alla percezione della scena dipinta deve affiancarsi così la sua recitazione e noi, come spettatori, siamo invitati a condividere il mondo che ci si mostra e a credere immaginativamente a ciò che ci viene detto nella recita che si mette in scena tra i quattro legni della cornice. Qualcosa dunque muta ed è solo per questo che le immagini assumono per noi quella vicinanza che ce le rende tanto interessanti: le raffigurazioni si dispiegano nel loro senso se accettiamo di metterle in scena — nell’immaginazione E tuttavia perché ciò accada non dobbiamo fare altro che seguire il percorso che l’immagine nella sua struttura fenomenologica ci indica.
Questo percorso c’è noto: ci siamo già soffermati sulla natura paradigmatica dell’immagine, sul suo porsi come una ripetizione esemplare di una scena che c’è per noi proprio in quanto il nostro coglierla ha la forma di un riconoscimento. Ma ci siamo soffermati anche sul fatto che le immagini sono volte allo spettatore e, per così dire, gli chiedono di occupare uno posto determinato — quel posto a partire dal quale soltanto un’immagine si lascia percepire. Ma ciò che dal punto di vista dell’immagine è innanzitutto una condizione della sua percepibilità può assumere il senso di un invito per l’immaginazione: la raffigurazione sembra rivolgersi allo spettatore invitandolo ad un dialogo ed animando lo spazio di risonanza dell’immagine di una vitalità nuova. È in questo spazio che si dà il gioco con l’immagine, — un gioco che, come vedremo, è dettato ancora una vota dalla peculiarità delle forme della raffigurazione ed in modo particolare dalle diverse modalità del suo spazio figurativo.
E ciò che vale per lo spazio, vale anche per il tempo. Anche in questo caso la dimensione immaginativa si intreccia con la forma della raffigurazione, animandola di una sua interna temporalità. Avremo modo di tornare su questo tema nelle lezioni conclusive del corso. E tuttavia è forse possibile anticipare almeno un punto dei temi di cui dovremo discorrere per mettere da parte un possibile fraintendimento che sorge non appena riflettiamo sul fatto che non è vero che ciò che si raffigura in un quadro esista soltanto nello spazio figurativo che gli compete. Possiamo accettare il gioco cui un ritratto ci invita e comportarci come se avessimo di fronte a noi la persona che la fotografia ritrae, ma questo naturalmente non significa che la persona ritratta non esista al di là della cornice o che non siano possibili altre fotografie che lo ritraggano: quella persona c’è o c’è stata davvero da qualche parte del mondo, anche se noi guardandone il ritratto facciamo come se fosse qui con noi. E in questo non vi è davvero nessun paradosso: il fatto che immagini qualcosa non impedisce che quel qualcosa esista realmente. L’immaginazione non crea oggetti reali, ma non per questo li distrugge.
Ma ciò che è vero per un soggetto reale può essere vero anche per un soggetto meramente immaginario. Forse San Giorgio, con autentica soddisfazione del drago, non è mai esistito; eppure molti quadri ce ne parlano, e lo stesso accade per le vite di molti altri santi che forse non hanno consistenza storica, ma che pure esistono al di là della cornice, poiché li ritroviamo affresco dopo affresco in un ciclo narrativo o nel ripetersi di quel ciclo in sempre nuove chiese. Ed in questo caso ciò che dà consistenza e unità al personaggio dipinto al di là della sua appartenenza ad un singolo affresco è soltanto ed unicamente l’unità di una narrazione che dispone le immagini in una tradizione e in un racconto, che le scandisce come tappe di una temporalità immaginativa. Ciò che esiste al di là del dipinto è, in questo caso, soltanto l’unità di una narrazione, la scelta cum fundamento in re di raccogliere in un unico universo immaginativo i mondi che i singoli affreschi ci propongono, costruendo così una storia che si rende visibile nei suoi momenti esemplari e che gode della temporalità assoluta delle fiabe — del loro avere un inizio che non tollera un prima ed una fine che non rimanda ad un dopo. Così San Giorgio deve accontentarsi di una vita racchiusa tra la ricerca del drago, la sua uccisione e la liberazione della principessa e San Cristoforo di un unico momento di gloria esemplarmente inscritto nel suo nome: a questo uomo gigantesco è concesso soltanto di attendere di là da un fiume l’arrivo del bambin Gesù, traghettarlo sulle spalle all’altra sponda e poi scomparire in un felice anonimato.
E tuttavia, proprio il discorrere di queste narrazioni che tante volte sono state ripetute nella storia della nostra cultura figurativa ci invita a riflettere sul nesso che lega la narrazione alla tradizione e che consolida l’una nell’altra. È questo ciò che accade in quella forma dell’immaginazione narrativa che assume i contorni del mito e della religione e che non si accontenta di porre l’essere dei propri oggetti in una dimensione soltanto immaginativa, ma cerca per essi un’esistenza diversa — non l’esistenza reale, ma l’esistenza sublimata di ciò che deve essere e in cui si deve credere perché è sancita da un racconto che ha guadagnato una sua unicità poiché si è fatto norma nella tradizione. Di qui le forme cui le raffigurazioni religiose dovevano attenersi, di qui il loro ripetere sempre daccapo gli stessi volti e le stesse storie: solo così l’essere immaginativo del racconto poteva superare i confini della cornice e guadagnare la consistenza delle tradizioni. Nessuno può dire oggi quale fosse il volto di Cristo, sempre che si dia per scontato che sia davvero esistito qualcuno cui si possano attribuire le vicende che narra il Vangelo — poiché questo è il Cristo di cui una parte così considerevole della pittura occidentale ci parla. Forse il dio-uomo non è esistito, ma tutti noi abbiamo un’idea ben precisa del suo viso: quale sia il volto del Gesù dei Vangeli lo ha deciso una tradizione pittorica antica che ha ripetuto se stessa creando passo dopo passo l’illusione che quel continuo ripetere fosse l’eco di una voce autentica — di un’originaria manifestazione che giustifica e dà fondamento al gesto creativo del pittore, alla sua immaginazione di un volto. La pazienza infinita del pittore di icone che subordina il proprio desiderio creativo alla regola di un’imitazione pedissequa diviene così il fondamento di una favola antica: il volto di Cristo si sarebbe impresso originariamente in un velo, in una raffigurazione che si è fatta calco e che ha cancellato nella fisicità del contatto l’idealità e l’arbitrarietà del riferimento. La condizione fenomenologica che ci invita riconoscere un identico referente in una molteplicità di immagini — la somiglianza effettiva di quei volti dipinti — diviene così la regola che ci consente di stringere più immagini in un racconto e di ripetere questo racconto nell’unità di una tradizione.
2. Fenomenologia ed ermeneutica delle immagini
Le considerazioni che abbiamo proposto nella lezione precedente ci hanno permesso di fissare almeno un poco il senso che deve essere attribuito alla tesi secondo la quale le raffigurazioni vivono per noi quando divengono parte di una prassi immaginativa, e cioè quando ci dichiariamo disponibili a metterle in scena e a rappresentarle secondo il copione che esse stesse ci porgono. L’immaginazione ha bisogno di sostegni, e Walton ha giustamente sottolineato come le raffigurazioni siano capaci di coordinare le nostre fantasie, accomunandole e subordinandole ad una regola che è racchiusa nella raffigurazione stessa. Un quadro sa prendere per mano la nostra immaginazione e sa condurla dove vuole, consentendoci da una lato di fantasticare in modo vivido e coerente intorno ad un soggetto definito e, dall’altro, di avere chiaramente visibili di fronte agli occhi le regole del gioco che ci si propone di giocare e gli oggetti e le persone che popolano il mondo immaginativo in cui ci è concesso di penetrare.
Molte altre cose dovrebbero essere dette a questo proposito e insieme sarebbe forse opportuno soffermarsi un poco a commentare il libro di Walton, — un libro molto bello, da cui ho tratto più di uno spunto. Dobbiamo invece accontentarci delle cose dette e cercare di vedere più chiaramente nei problemi che sollevano, addentrandoci in un tema cui abbiamo già fatto cenno: il tema della spazialità dell’immagine. Si tratta di un tema importante per molte ragioni, e noi abbiamo innanzitutto sottolineato più volte come l’immagine sia volta allo spettatore e possa instaurare con lui un dialogo che ha una specifica connotazione spaziale. La vicenda raffigurata che osservo è qui, di fronte a me, e se deve essere possibile un coinvolgimento, allora deve esistere uno spazio di risonanza dell’immagine, un luogo che possa ospitare la dinamica delle relazioni tra chi osserva la scena e la scena che per lui si recita: se nel dipinto qualcuno deve guardarmi, additarmi ad un altro, parlarmi o invitarmi ad entrare nel quadro, ciò può accadere soltanto se vi è uno spazio comune tra me e la scena dipinta, se nella dimensione percettiva dell’immagine vi è una spazialità capace di sorreggere le deissi che dal quadro si rivolgono allo spettatore.
Su questo punto ci siamo già soffermati: ogni immagine ha uno spazio di risonanza che si attiva quando lo spettatore si lascia coinvolgere dal gioco e si rivolge attivamente alla scena dipinta, immaginando ciò che essa chiede che sia immaginato. Ora, il coinvolgimento dello spettatore dipende innanzitutto dalla sua consuetudine con le raffigurazioni e, in generale, dal posto che esse occupano nella sua esistenza e nella forma di vita che gli è propria.
Ma se l’atteggiamento complessivo rispetto alla dimensione figurativa ci riconduce al terreno della storia e delle scelte individuali e collettive, il modo in cui il nostro rapporto con le raffigurazioni effettivamente si realizza dipende invece soprattutto dalla forma fenomenologica dell’immagine, dal suo essere fatta in un modo che rende intuitivamente accessibile la dimensione del coinvolgimento o che, al contrario, congela nella loro separatezza i poli tra cui dovrebbe occorrere un dialogo. Ancora una volta, possiamo renderci conto di quest’ordine di considerazioni muovendo dal tema di cui discorriamo, poiché un’immagine sa rendere tanto più vivo e percorribile lo spazio di risonanza che le appartiene quanto più si fa esigua e difficilmente avvertibile la discontinuità percettiva tra la forma dello spazio figurativo che la caratterizza e la struttura fenomenologica dello spazio in cui lo spettatore si trova. L’immagine è volta verso lo spettatore e può protendersi verso di lui, ma il movimento dell’immagine verso chi la osserva è tanto più persuasivo, quanto minore è lo scarto tra la scena dipinta e la scena reale: solo in questo caso, infatti, l’immaginazione dialogica trova nella dimensione intuitiva della scena un suggerimento ed un sostegno.
Non vi è dubbio che interrogarsi sulla maggiore o minore continuità apparente tra lo spazio dell’immagine e lo spazio dello spettatore vuol dire riflettere sulle forme che la profondità dello spazio figurativo può assumere: un’immagine giocata su un’apparente bidimensionalità renderà più avvertibile lo scarto tra lo spazio figurativo e lo spazio dello spettatore, laddove una raffigurazione prospettica tenderà a rendere esiguo e quasi inavvertibile il discrimine che sussiste tra l’uno e l’altro spazio. Di qui l’importanza che deve essere attribuita alle tecniche di raffigurazione della profondità: ogni tecnica sceglie infatti una tra le possibili forme di raffigurazione e, correlativamente, è una delle voci che determinano l’atteggiamento soggettivo che lo spettatore è indotto ad assumere verso l’immagine. Come si debba guardare un quadro non lo si può dire una volta per tutte, poiché ogni epoca chiede allo spettatore un nuovo e diverso atteggiamento ricettivo, — poiché diverse e nuove sono le funzioni e le forme delle immagini di fronte alle quali lo spettatore è posto. E tuttavia, di fronte a questo giusto richiamo alla linguisticità dell’opera d’arte e al suo rispecchiarsi nei presupposti culturali e storici che debbono permeare l’atteggiamento di chi intende comprenderne il senso, occorre sottolineare come ogni atteggiamento ricettivo debba essere comunque fondato fenomenologicamente. A guidarci nell’assunzione di un atteggiamento ricettivo che non sia cieco di fronte alla specificità dell’opera non possono essere soltanto gli imperativi dell’ermeneutica: debbono essere anche le determinazioni materiali e contenutistiche del fenomeno che abbiamo sott’occhio, poiché solo a partire di qui è possibile tracciare una tipologia delle forme di raffigurazione e delle relazioni percettive che ciascun tipo di immagine innanzitutto stringe con la soggettività dello spettatore.
Parte Seconda
Lo spazio e il concetto di raffigurazione
Lezione dodicesima
1. «Scrivo uno quadrangolo di retti angoli»
In un passo del suo Della pittura (1436) Leon Battista Alberti si interroga sulla natura delle raffigurazioni, e per tracciare il cammino che i suoi pensieri debbono seguire immagina di descrivere passo dopo passo che cosa si debba fare quando ci si appresta a dipingere. La prima mossa ha un significato esemplare:
Qui solo, lassato l’altre cose, dirò quello fo io quando dipingo. Principio, dove io debbo dipingere scrivo uno quadrangolo di retti angoli quanto grande io voglio, el quale reputo essere una finestra aperta sul mondo per donde io miri quello che quivi sarà dipinto (L. B. Alberti, Della pittura, in Opere volgari, a cura di C. Grayson, Laterza, Bari, 1974, p. 36).
Si tratta di un incipit in cui molte cose sono racchiuse, e tra queste una definizione della natura delle immagini che è davvero caratteristica della cultura rinascimentale: un quadro è come una finestra che ci permetta di guardare un mondo che è tanto facilmente accessibile allo sguardo quanto lo è ciò che guardiamo, per il vano di una finestra.
Di questa metafora della pittura, così ricca di considerazioni fenomenologiche che si intrecciano ad elementi di poetica dobbiamo tuttavia disinteressarci, per rivolgere l’attenzione al gesto cui Alberti ci invita: se vogliamo dipingere qualcosa dobbiamo innanzitutto tracciare una cornice su un foglio per assegnare un luogo al mondo che l’arte renderà poi concretamente visibile. E ciò è quanto dire che se prendiamo alla lettera le parole che abbiamo citato, sembra lecito sostenere che uno spazio figurativo si dà non appena costruiamo il nostro «quadrangolo di retti angoli» e quindi rendiamo palese la nostra volontà di separare ciò che è interno da ciò che è esterno alla cornice.
Non vi è dubbio che una simile tesi possa lasciarci perplessi e che a rigore non sia affatto vero che per disegnare qualcosa sia necessario dapprima tracciare una cornice. Spesso quando disegniamo qualcosa ci accontentiamo di uno spazio vuoto sul foglio, e quest’osservazione così ovvia va ripetuta perché ci consente di rammentarci che non è affatto vero che ogni immagine abbia una cornice. Perché si dia uno spazio figurativo non è necessario «scrivere uno quadrangolo di retti angoli»: basta disegnare qualcosa e accettare che vi sia un confine seppur vago tra ciò che appartiene al foglio e ciò che invece appartiene al disegno. E tuttavia, fatte salve queste precisazioni, le riflessioni dell’Alberti possono comunque servirci, perché ci invitano a sottolineare una caratteristica essenziale dello spazio figurativo su cui ci siamo già soffermati, ma su cui dobbiamo ancora indugiare un poco: la sua chiusura. Lo spazio figurativo è chiuso, e questo significa che per lo spazio delle immagini non vale la regola che guida la nostra esperienza della spazialità — una regola che Kant formulava pressappoco così: vi è un unico spazio della nostra esperienza ed ogni sua parte concretamente data presuppone nel suo stesso senso la totalità dello spazio, il suo infinito estendersi. Ogni mia concreta esperienza dello spazio è limitata: ogni singola percezione è racchiusa nell’unità di un luogo o si estende sin dove giunge il mio limitato campo visivo. Ma la datità del limite è inessenziale alla determinazione del senso percettivo della spazialità, poiché la percezione dello spazio è una percezione aperta: fa parte della mia esperienza della spazialità il fatto che ogni singola intuizione spaziale si accompagni alla coscienza di un «e così via» che allude alla necessaria continuazione del luogo in un luogo più ampio, del limitato in ciò che lo racchiude, in un’iterazione infinita in cui si costituisce il senso vissuto della spazialità.
Ma se il concetto intuitivo di spazio rivela parte della sua grammatica nell’esperimento ludico delle scatole cinesi, lo spazio figurativo è invece caratterizzato dall’avere in linea di principio un limite che lo racchiude. Il limite dello spazio figurativo è il limite della visibilità: lo spazio dell’immagine è tutto racchiuso in ciò che l’immagine ci mostra, e non si dà qui una coscienza dell’«e così via» che apra la scena percettiva ad una sua necessaria continuazione, ad un’aperta iterazione dell’atto di andare oltre il limite. Lo spazio figurativo è dato una volta per tutte insieme alla raffigurazione che lo pone e proprio come ogni immagine basta a se stessa, così lo spazio che in esse si apre non ha nulla che lo costringa a spingersi al di là dei limiti che gli sono propri.
Che una simile affermazione sia almeno in parte vera è relativamente ovvio: se sono chiuso in casa e qualcuno mi chiede che cosa c’è al di fuori di quelle pareti potrei sensatamente rispondere che vi è una via tra le altre della città di Milano. Se però mi si chiedesse di dire che cosa accade nello spazio figurativo a pochi metri dalla cornice che lo racchiude non saprei davvero che cosa ribattere, perché a pochi metri dalla cornice lo spazio figurativo semplicemente non c’è e quindi, in linea di principio, non può accadervi nulla.
Tutto questo è ovvio, e tuttavia vi è almeno un senso in cui sembrerebbe legittimo sostenere che lo spazio figurativo continua anche al di là dei limiti della cornice. Se guardiamo un dipinto che ci mostra un paesaggio lontano vedremo scivolare le colline al di sotto della cornice e lo stesso accade quando l’immagine ci presenta una figura tagliata, che si fa visibile solo in parte al di qua della cornice e che sembra sporgersi da uno spazio invisibile nel regno della visibilità. Basta tenere sotto gli occhi immagini di questo tipo per trarre una conclusione diversa da quella cui siamo dianzi giunti: la cornice non sembra essere il limite che circoscrive lo spazio figurativo, ma solo l’apertura che ci consente di accedervi — un’apertura ora ampia, ora esigua, ma comunque mai tanto vasta da non nascondere ciò che pure vi è e potrebbe essere scorto. E se le cose stanno perché non cedere alle metafore dell’Alberti e perché non sostenere che un quadro è, in linea di principio, davvero simile ad una finestra che costringe lo sguardo entro un limite definito, ma che non per questo delimita lo spazio che al di là di essa si rende parzialmente visibile?
Si tratta di un’obiezione che coglie almeno in parte nel segno e su cui dovremo in seguito ritornare per coglierne sino in fondo il significato, ma ciò nonostante non credo che davvero ci costringa a rinunciare alla tesi che abbiamo appena sostenuto. Certo, una figura tagliata dalla cornice non si dà interamente allo sguardo e il fatto che per descriverla ci si esprima proprio così, dicendo che vi è una figura tagliata o che si sporge nella cornice, è un segno evidente che ciò che vediamo è appunto colto nel suo essere soltanto una parte, una frazione che appartiene ad un intero di cui si avverte la mancanza. Per quanto possa sembrare paradossale, non vediamo soltanto quello che c’è, ma vediamo anche che qualcosa manca: ciò che abbiamo sotto gli occhi non può essere descritto se non riconoscendo che il visibile si intreccia all’invisibile, e che entrambi determinano il senso di ciò che ci si manifesta.
In questo intreccio di visibile e di invisibile non si deve tuttavia cercare di scorgere un qualche mistero, ma solo una regola percettiva che conosciamo bene: anche se vediamo gli oggetti nella loro forma obiettiva, ciò che di essi si manifesta è sempre parziale e dipende tanto dal gioco degli aspetti, quanto dal loro nascondersi l’un l’altro, come accade quando qualcosa scivola dietro un’altra celandosi al nostro sguardo. Così, se avvertiamo che i limiti della cornice sono angusti non è perché lo spazio figurativo in quanto tale chieda di aprirsi ad uno spazio che non abbia limiti e che non sia per sua natura circoscritto, ma è solo perché ciò che nell’immagine si mostra è in sé un intreccio di visibile e di invisibile. L’incompletezza che avvertiamo in determinati aspetti dello spazio figurativo non parla in favore di una dipendenza dello spazio dell’immagine da uno spazio più ampio, ma ci rammenta che anche sul terreno figurativo il tacere è una forma del discorso. L’orizzonte di invisibilità che è presente nello spazio figurativo è interamente definito da ciò che nell’immagine si vede: solo perché l’immagine dice a chiare lettere che qualcosa è taciuto possiamo poi avvertire come una costrizione il limite che la cornice impone allo spazio della visibilità. Ma se l’incompletezza non è una caratteristica dello spazio figurativo ma un suo possibile contenuto, allora non vi è bisogno di uscire dall’immagine per intenderne il senso poiché la chiusura dello spazio figurativo può convivere con la constatazione che ciò che ci comunica è talvolta il senso della casualità o dell’incompletezza, come accade in certi quadri di Degas che sembrano volerci dire che ciò che osserviamo nell’immagine non è una scena che si reciti per noi, ma una casuale istantanea sul mondo.
Alla chiusura dell’immagine nella cornice fa eco l’incolmabilità della distanza che la separa dallo spettatore. Lo spazio figurativo è qui, di fronte a noi che osserviamo l’immagine, ma per quanto vicina ci appaia la scena dipinta, è evidente che non è possibile cancellare la distanza che ci separa da essa. Certo, possiamo avvicinarci ad un affresco o allontanarcene e ciò ci consente ora di vedere meglio un dettaglio che altrimenti non avremmo notato, ora di cogliere una più ricca veduta di insieme, — e non vi è dubbio che il nostro accostarci o discostarci dalla parete affrescata abbia un qualche significato spaziale. Quando mi avvicino ad un affresco in un palazzo o in una chiesa vado verso la scena dipinta e mi dispongo nel modo migliore per coglierla: per quanto sia utile ed importante distinguere tra lo spazio figurativo e lo spazio occupato dal sostrato materiale che lo ospita non si deve per questo dimenticare che vi sono molte ovvie interazioni tra questi due momenti.
E tuttavia, per quanto possa avvicinarmi alla parete affrescata e per quanto significativi siano gli intrecci cui alludevo, ciò non toglie che la scena dipinta cui siamo rivolti rimanga tanto distante da noi quanto è scritto nelle decisioni figurative di chi l’ha realizzata e che ogni nostro farci presso la superficie materiale che la ospita sia ininfluente sotto questo riguardo.
Possiamo avvicinarci quanto vogliamo alla tela di Friedrich che ritrae un monaco su una spiaggia nebbiosa: il mare e l’uomo che lo contempla resteranno egualmente lontani, poiché la lontananza è interamente determinata dal modo in cui la tela dipinta, dal fenomeno che in essa prende forma. Al contrario, possiamo allontanarci quanto vogliamo dalla Madonna del Parmigianino: la figura possente di san Zaccaria resterà comunque vicinissima allo spettatore, tanto vicino da occupare quasi il suo spazio al di sotto del margine della cornice. E non è un caso che le cose stiano così. L’essere a distanza della scena dipinta non è una proprietà reale e non ci parla di una relazione che appartenga allo spazio obiettivo: è invece una caratteristica puramente fenomenica e\d interna dello spazio figurativo. La distanza non è in questo caso un dato reale che si manifesti alla soggettività percipiente secondo forme che variano quanto più ci avviciniamo all’oggetto che in lontananza ci appare, ma è una mera datità fenomenica: la lontananza è tutta racchiusa nella scena figurativa, nel suo fenomeno. Ma ciò è quanto dire che l’essere a distanza dell’immagine è una forma in cui si manifesta la chiusura dell’immagine rispetto allo spazio reale. E se le scene raffigurate hanno una loro distanza che è determinata dalla natura delle immagini e se non vi è una prassi che ci consenta di ricondurre il lontano al vicino e il vicino al lontano, allora si può sostenere che lo spazio figurativo non è un luogo dello spazio reale ma ha una sua autonomia di principio: lo spazio che si apre nell’immagine è un altro spazio e non è possibile colmare la distanza che ci separa da esso.
Le considerazioni che abbiamo appena proposto ci permettono di dare un significato più preciso alla tesi della chiusura dello spazio figurativo. E tuttavia basta riflettere un poco su questa nozione per rendersi conto che alla chiusura dello spazio figurativo corrisponde la sua piena datità fenomenica. Lo spazio figurativo è pienamente fenomenico, e ciò significa che vi è piena coincidenza tra ciò che in esso è racchiuso e ciò che in esso è in linea di principio visibile. Lo spazio reale non si comporta così. Quando entro in una stanza vedo molte cose e insieme ho esperienza del loro essere solo in parte visibili: il tavolo è addossato alla parete, la porta è alle mie spalle, la sedia si intravede appena dietro al pilastro. E tuttavia ciò che è nascosto può farsi visibile, e in vario modo: posso volgere gli occhi, camminare e vedere i profili della stanza che prima mi erano negati e posso, se voglio, scostare il tavolo dalla parete per vedere la superficie del muro che era prima nascosta.
Ma è possibile un diverso cammino per mostrare l’irriducibilità dello spazio reale a ciò che ora ne vedo: potrei infatti spingermi sino a quei luoghi che ora scorgo in lontananza e scoprire in ciò che mi appariva remoto e indistinto un mondo. Ma potrei anche avvicinarmi sempre di più a ciò che ho di fronte, scoprendo che anche all’interno di ogni regione spaziale vale la regola dell’iterazione: ogni dettaglio racchiude nuovi dettagli che possono essere colti e che possiamo osservare. Lo spazio della nostra esperienza è continuo e possiamo sempre cercare di scorgere tra due punti per quanto vicini un punto che li separi e che ci era dapprima sfuggito. Il microscopio è uno strumento potente che ci fa vedere cose che non avremmo altrimenti potuto vedere, ma questo non toglie che la possibilità della visione microscopica sia interamente racchiusa nella grammatica del concetto intuitivo della spazialità.
Della spazialità reale, non dello spazio figurativo: su questo terreno non ha infatti alcun senso chiedersi che cosa si nasconda alla vista tra due luoghi apparentemente contigui, perché nello spazio figurativo vi è solo ciò che si manifesta. Certo, anche in questo caso si deve distinguere la presenza di qualcosa che non si manifesta dal manifestarsi della sua assenza. Nello spazio figurativo non vi è nulla che non si manifesti: lo spazio figurativo è pienamente fenomenico. Ma la pienezza fenomenica dello spazio figurativo non esclude affatto che si possa vedere il nascondersi di qualcosa o che si possa scorgere nella scena dipinta qualcosa che è tanto lontano da sfuggire alla nostra vista. In molti quadri di Mantegna le cose stanno proprio così: ciò che è lontano assume le forme di uno spazio abitato in cui si potrebbe scorgere sempre di nuovo qualcosa, se solo fosse possibile avvicinarsi e far sì che il lontano si dissolva nel lento incedere della vicinanza, nel cammino che ci costringe a scoprire che il lontano è infine il vicino del vicino. Ma perché ciò possa vedersi in un quadro, la forma fenomenologica dell’«e così via» deve porsi come un contenuto della raffigurazione, poiché di per sé lo spazio figurativo non rinuncia alla propria chiusura e non implica affatto un’aperta continuazione.
La chiusura e il principio della piena datità non sono una caratteristica che appartenga soltanto alle raffigurazioni. Così stanno le cose anche nell’universo narrativo. Una narrazione ha un inizio e una fine assoluti, e non ha senso chiedersi che cosa sia accaduto prima del «c’era una volta…» e dopo il felice matrimonio: tutto l’universo della favola è racchiuso tra questi limiti e non vi è nulla che possa oltrepassare questa cornice temporale. Non solo: il principio della chiusura fa valere la propria autorità anche in relazione al lettore. Quando pronunciamo la formula che apre lo spazio narrativo della favola, ci affidiamo ad una forma temporale che del passato ha soltanto la definitività del distacco: quando diciamo che c’era una volta un pezzo di legno vogliamo semplicemente dire da un lato che quel pezzo di legno ora non vi è anche se intendiamo narrarne la vicenda, e dall’altro che possiamo immaginare che la storia si dipani in un passato che non è più possibile definire e che trova il suo senso più pieno solo nel permetterci di declinare ogni eventuale domanda che cercasse di fissare un quando e, insieme, una relazione temporale con il nostro presente. Proprio come lo spazio figurativo, anche l’universo narrativo ha dunque una sua peculiare chiusura. Ma anche un suo principio di piena datità: nel mondo narrato vi è solo ciò che la favola pone e per quanto ci si possa affaticare ad interpretare un racconto, nulla di quello che verremo di volta in volta proponendo potrà proporsi come una nuova scoperta, ma solo come il risultato cui ha condotto un lungo cercare ciò che comunque era già dato. Nell’universo narrativo è già tutto esemplarmente presente, compreso il non detto, ed anche in questo caso tra il mondo narrato e il mondo reale vi è una differenza di principio che deve essere colta. Il tempo di cui nella vita abbiamo esperienza è denso: gli eventi si susseguono gli uni agli altri, ma appartiene al senso dell’esperienza la possibilità di chiedere che cosa sia accaduto tra gli uni e gli altri. Mi sono alzato dal letto in silenzio, mi sono fatto il caffè e poi ho cominciato a scrivere questa lezione, e se questo è un resoconto abbastanza fedele della mia domenica mattina è evidente che la scansione degli eventi avrebbe potuto essere più ricca poiché non vi è successione di fatti che ci impedisca di chiedere che cosa sia tra essi avvenuto. Una simile domanda sarebbe invece fuori luogo se ci immergessimo in un contesto narrativo. Ulisse trascorre un anno da Circe, ma ciò non significa che si possa davvero domandare che cosa accade dopo che i compagni furono restituiti alla loro forma umana, poiché di tutti quei giorni Omero ci dice soltanto questo: «e là tutti i giorni fino al compirsi di un anno / sedevamo, a goderci carni infinite e buon vino». Spazio per domande qui non ve n’è, e questo perché in linea di principio il tempo narrativo non lascia che ci si interroghi su ciò che può essere avvenuto tra un evento e l’altro. Nel tempo narrato non vi sono lacune ed è avvenuto soltanto ciò che si dice essere avvenuto, e se talvolta ci sembra lecito chiedere e non sappiamo accontentarci di ciò che ci viene raccontato è solo perché anche in questo caso tra le forme del dire vi è il tacere che ci induce a cercare ciò che nel tempo narrato è comunque già presente — come una mancanza.
2. Lo spazio figurativo, lo spazio reale
Su queste considerazioni era opportuno, credo, soffermarsi un poco. E tuttavia riconoscere la chiusura dello spazio figurativo e la sua alterità rispetto allo spazio reale non significa ancora avere risolto la trama complessa delle relazioni che l’immagine può stringere con lo spettatore. Anche in questo caso il rimando alla dimensione narrativa può insegnarci qualcosa. Un racconto ci parla di un universo chiuso in se stesso; alla chiusura come determinazione ontologica dell’universo narrativo può tuttavia far eco un’apertura di carattere pragmatico: il racconto può rivolgersi al lettore e chiamarlo in causa, cercando di assottigliare quanto è possibile la soglia che separa il mondo reale dall’universo narrativo. La vicenda del teatro novecentesco è, da questo punto di vista, esemplare: ad una narrazione tutta racchiusa nell’arco di scena, il teatro novecentesco contrappone una drammatizzazione che infrange di continuo la soglia che separa il pubblico dal palcoscenico, ed anche se questo non significa negare il diaframma che separa la realtà della finzione, non vi è dubbio che parte del senso dell’azione teatrale la sua funzione espressiva tragga dalla problematizzazione di questa cesura.
Anche nel caso delle immagini le cose stanno così. Anche su questo terreno sottolineare la radicale separatezza tra lo spazio figurativo e lo spazio reale non significa ancora aver risolto i problemi che si annidano in questa distinzione. Per rendersene conto è sufficiente rammentare che ogni immagine implica una persona che la guardi e che lo spettatore è necessariamente un punto di raccordo tra lo spazio dell’immagine e lo spazio in senso proprio. Si tratta di un’osservazione ovvia su cui, tuttavia, è opportuno soffermarsi per coglierne sino in fondo le conseguenze. Lo spazio in cui lo spettatore si muove è lo spazio reale della nostra esperienza, ed è qui che egli vede l’immagine e lo spazio figurativo che in essa si apre. L’immagine è appunto in un luogo tra gli altri, e non mi è possibile vedere una scena raffigurata senza vederla in un luogo che ha comunque una sua posizione nello spazio della mia esperienza, — in quello spazio che fa da sfondo alla prassi e in cui sono racchiuse le infinite cose del mondo. Lo spettatore, tuttavia, non è soltanto una cosa tra le altre nello spazio reale, ma è anche lo sguardo cui lo spazio figurativo si rivolge. Quando guardo un affresco lo vedo in un luogo che appartiene al mio mondo, e tuttavia (come abbiamo osservato) lo spazio figurativo mi si rivolge e instaura con me, in quanto spettatore, una relazione spaziale sui generis: la scena che vedo raffigurata è proprio di fronte a me, e la vicinanza del volto ritratto e la lontananza del paesaggio che fa da sfondo sono tali rispetto a me che li osservo e che colgo la mia posizione e il mio essere qui tanto rispetto all’immagine quanto rispetto all’ambiente reale nel quale mi muovo.
Di qui la posizione ambivalente dello spettatore, il suo porsi come un punto di raccordo tra la spazialità interna all’immagine e lo spazio reale che la racchiude ed in cui di fatto lo spettatore si trova. Questo raccordo è necessario perché la relazione spaziale che l’immagine in quanto tale ha con lo spettatore si dispiega necessariamente nello spazio di cui abbiamo da sempre esperienza e che si dà nella percezione ambientale. Nelle chiese un tempo si raffigurava nella cupola la figura di Cristo; e non a caso: il fedele doveva poterlo scorgere proprio lassù, e sentirsi osservato dall’alto. Ma che la cupola sia in alto e lo spettatore sia in basso è qualcosa di cui fa fede la nostra percezione ambientale, che per prima disegna le coordinate del nostro spazio, per offrire poi la trama su cui si intreccia il ricamo della spazialità delle immagini: se possiamo sentirci osservati da un’immagine e se è possibile che un gesto o un movimento nella scena dipinta alluda verso di noi, ciò accade soltanto perché il luogo in cui sono è comunque già definito dalla mia percezione così come è ben salda la coscienza dello spazio che mi separa dall’immagine e che è attraversato dalle dinamiche espressive cui accennavamo. Ma ciò è quanto dire che lo spazio che separa lo spettatore dalla scena raffigurata è il teatro in cui si compenetrano due differenti forme della spazialità, ciascuna delle quali gioca un suo specifico ruolo. Vi è innanzitutto la consueta percezione della spazialità: lo spazio tra lo spettatore e l’immagine si costituisce nella percezione ambientale ed è fenomenologicamente caratterizzato dalle regole che normalmente sorreggono il mio percepire uno spazio tridimensionale, che ha una sua profondità percepita ed una sua stabile configurazione. Sulla trama dello spazio esperito, tuttavia, lo spazio figurativo aggiunge la propria dinamica spaziale: il mio essere qui nello spazio reale si definisce anche in relazione ai vettori che ci legano allo spazio figurativo, ed è per questo che guardando un affresco come la Trinità del Masaccio posso davvero sentirmi il destinatario del movimento di offerta della croce e, al contempo, colui cui Maria si rivolge per invitarlo a salire verso la scena raffigurata. Ma se il mio essere qui non si definisce soltanto rispetto allo spazio reale in cui mi muovo, ma trae il suo senso anche dalla scena raffigurata, allora si può concludere che lo spazio che mi separa dall’immagine è per sua natura uno spazio peculiare che, come vedremo, ripropone in forma nuova la dualità delle immagini.
Vorrei parlare di questo spazio come dello spazio di risonanza dell’immagine per sottolineare come si tratti di uno spazio reale che è tuttavia pervaso dalle eco dello spazio figurativo che vi si manifesta e che in esso trova il proprio rapporto con lo spettatore. Ora, sostenere che lo spazio di risonanza dell’immagine è il luogo in cui si compongono due differenti nozioni di spazialità vuol dire di fatto interrogarsi sulla forma intuitiva che una simile composizione può assumere: le raffigurazioni sono oggetti che parlano agli occhi e l’unica forma in cui lo spazio esperito e lo spazio dell’immagine possono trovare un accordo è, di conseguenza, di natura intuitiva. Di qui la conclusione che credo possa essere tratta: l’eco dello spazio figurativo può riverberarsi nello spazio dello spettatore solo perché vi è una qualche continuità visiva, solo perché qualcosa li accomuna e ci consente di ritrovare l’uno nell’altro. E tuttavia, anche se ogni immagine ha un suo spazio di risonanza, la misura della continuità tra l’uno e l’altro spazio può variare e con essa il modo in cui lo spettatore entra in contatto con l’universo figurativo.
Che cosa ciò significhi è presto detto. Lo spazio in cui lo spettatore si trova può essere strutturato in molti modi e qui anche le determinazione architettonica può dire la sua; un punto, tuttavia, può essere fissato con relativa chiarezza: lo spazio percepito è comunque uno spazio che ha una sua forma che è caratterizzata tanto dalla struttura della profondità, quanto dalla dinamica degli aspetti e del loro comune rimandare all’unicità di un punto di vista, ad un luogo più o meno definito rispetto al quale lo spazio e l’obiettività delle forme si dispiegano secondo una determinata configurazione prospettica. Ne segue che la continuità tra lo spazio figurativo e lo spazio in cui lo spettatore si muove è tanto più viva quanto più l’immagine sa garantire la percezione della profondità, ancorandola ad un punto di vista — al luogo che lo spettatore deve assumere. Al contrario, quanto più l’immagine rinuncia alla profondità e alla dinamica dei punti di vista, tanto più sensibile si farà lo scarto che la separa dallo spazio dello spettatore. Un’immagine ancorata ai valori di superficie non propone uno spazio figurativo che sia percettivamente coerente con lo spazio dello spettatore e non instaura quindi una qualche continuità percettiva con il mondo dello spettatore: l’universo figurativo che l’immagine ci propone sottolinea così la sua alterità, la sua irriducibile autonomia.
Non è difficile scorgere in queste riflessioni l’eco di un discorso che è per noi almeno in parte già noto: nella maggiore o minore continuità dell’immagine con lo spazio che la ospita e nel nesso che questo problema ha con la dimensione dello spazio di risonanza dell’immagine si può infatti ritrovare ciò cui alludevamo quando avevamo osservato che la profondità nella raffigurazione è come un’asta graduata che ci permette di ordinare le diverse forme delle immagini all’interno dello spazio concettuale che loro compete.
A quelle considerazioni che erano rimaste così vaghe possiamo tentare di dare ora una veste più definita. Ogni immagine, abbiamo detto, ha un suo spazio di risonanza e questo spazio è ciò che le permette di instaurare un rapporto con lo spettatore. Lo spettatore osserva la scena dipinta e in questo senso è sempre in qualche modo legato all’immagine che gli sta di fronte; questo legame tuttavia varia a seconda della forma che concretamente assume lo spazio di risonanza come luogo della sintesi tra la spazialità dell’immagine e lo spazio reale. Potremmo forse esprimerci così: lo spazio di risonanza delle immagini ci dice in che modo lo spettatore si pone di fronte all’immagine, poiché in esso concretamente si esprime in una qualche forma la relazione spaziale che lega lo spettatore alla scena raffigurata. Ora, la forma di questa relazione varia con il variare della forma dello spazio figurativo; ne segue che dire che lo spettatore è di fronte all’immagine significa asserire cose diverse a seconda di come lo spazio figurativo si pone in relazione con lo spazio reale, continuandolo illusionisticamente o differenziandosene in modo più o meno marcato.
Di qui la conclusione che vogliamo trarre. Se si è invitati a porsi di fronte ad un’immagine in modi diversi a seconda della natura dello spazio figurativo, allora si può sostenere che la forma intuitiva che lo spazio di risonanza assume è una delle voci che determinano il rapporto pragmatico dello spettatore con l’immagine. Lo spazio di risonanza può essere caratterizzato dalla continuità, ed in questo caso l’essere di fronte all’immagine assume le forme del coinvolgimento dello spettatore che può guardare al mondo che di fronte ai suoi occhi si raffigura come se non fosse separato da un’evidente cesura dallo spazio reale nel quale si trova. Lo spettatore, in questo caso, è coinvolto poiché può non può non vedere la scena se non così: come un mondo il cui spazio sembra lambire il suo, disponendolo nel gioco che la tela predispone. Il coinvolgimento è dunque in senso etimologico, e solo in questo senso, una consapevole illusione. Ma anche se è uno spazio di risonanza è sempre presente e se vi è comunque un qualche coinvolgimento, la sintesi tra lo spazio figurativo e lo spazio reale può disporsi sotto il segno della discontinuità, ed in questo caso l’essere di fronte all’immagine si declina prevalentemente nella forma della separatezza tra il mondo reale e l’universo figurativo. Ora lo spazio figurativo si apre davanti ai nostri occhi e noi come spettatori non possiamo fare a meno di coglierlo in relazione al luogo che occupiamo; ma le parole della comunanza sono tacitate da quelle dell’alterità, e l’immagine ci colpisce soprattutto per la sua volontà di sottolineare il discrimine che la separa dal nostro mondo.
Il senso di queste espressioni alludono non deve essere frainteso: coinvolgimento e separatezza sono termini che, in questo contesto, alludono ad una distinzione di carattere descrittivo e ci parlano di fatto solo della continuità o della discontinuità che caratterizza il trapasso tra lo spazio figurativo e lo spazio reale[11]. Rammentarlo è importante se non si vogliono confondere i piani su cui le nostre considerazioni si muovono, e tuttavia se questa distinzione deve essere proposta è perché si può scorgere qui un fondamento fenomenologico dell’atteggiamento ermeneutico rispetto alle immagini.
Su questo punto è opportuno insistere. Certo, che lo spettatore si faccia “catturare” emotivamente dall’immagine dipende da molte cose e tra queste un posto importante spetta al comportamento ricettivo cui è stato educato. Le immagini si guardano in molti modi, e nella precedente lezione ho sostenuto che parte del significato che le raffigurazioni hanno per noi dipende dalla nostra capacità di metterle in scena e di raccontarle, — e il raccontare e l’inscenare sono giochi linguistici che vanno al di là del contenuto intuitivo delle immagini e alludono all’insieme delle forme di vita che sono proprie degli uomini. Possiamo anzi spingerci un passo più avanti ed osservare che data un’immagine, non è per questo ancora detto il modo in cui una cultura ne farà uso: se volessimo impegnarci in uno dei tanti possibili esercizi di antropologia immaginaria che sono così frequenti nelle pagine dei filosofi, potremmo senz’altro fantasticare di tribù che non possono guardare un’immagine, comunque essa sia fatta, senza lasciarsi catturare emotivamente e che non sanno osservare un dipinto senza cedere alla tentazione di fingere di avere proprio di fronte agli occhi ciò che l’immagine raffigura.
Ma potremmo anche immaginare una tribù meno incline ad assottigliare il diaframma che separa il mondo reale dall’universo figurativo, una tribù che nelle immagini, comunque esse siano, colga innanzitutto l’estraneità rispetto al nostro mondo, e si tratterebbe — in questo caso come nell’altro — di un’immaginazione coerente e legittima. E tuttavia, se ci dimentichiamo degli esperimenti mentali di un’antropologia filosofica che corre talvolta il rischio di semplificare troppo le cose, non è difficile scorgere che vi è comunque un nesso tra la forma dell’immagine e le regole del suo uso, e che non ogni immagine è adatta per essere usata come si vuole. Del resto, basta interrogarsi sulla ragione che spinge ogni cultura figurativa ed ogni diversa epoca storica a mutare la forma delle immagini, per rendersi conto che anche all’origine degli stili ricettivi si deve indicare un fondamento intuitivo. Se le immagini mutano di forma non è per noia: è perché si intende usarle in modo diverso
Queste sono evidentemente considerazioni di carattere generale, della cui effettiva percorribilità possiamo accertarci solo così: mostrando che è possibile avvalersene per raccogliere le idee sulla natura delle immagini. E tuttavia prima di immergerci sul terreno degli esempi e delle illustrazioni intuitive è necessario tracciare ancora qualche distinzione ed osservare che la possibilità delle immagini di coinvolgerci si intreccia, ma non coincide con il loro porsi in una disposizione dialogica con lo spettatore. Le immagini possono coinvolgere lo spettatore, invitandolo a guardare allo spazio raffigurato come se fosse davvero di fronte ai suoi occhi; per invitarlo ad un dialogo tuttavia il coinvolgimento non basta: è necessario che qualcosa nell’immagine assuma una funzione perlocutoria e si rivolga allo spettatore, interpellandolo. Certo, la possibilità che un’immagine si rivolga allo spettatore e abbia quindi una valenza transitiva dipende dalla sua capacità di reggere intuitivamente il peso della deissi: qualcosa dallo spazio dell’immagine deve sapersi rivolgere verso il luogo dello spettatore e questo è tanto più facile quanto più marcata è la continuità degli spazi che si compongono nel luogo di risonanza dell’immagine. Ma se uno sguardo o un gesto coglie più facilmente nel segno quando ci si rivolge da un quadro prospettico, ciò non toglie che sia da un lato possibile una raffigurazione coinvolgente priva di momenti perlocutori e che sia, dall’altro, possibile rinvenirli in immagini prive di una spazialità persuasiva. Dobbiamo così distinguere in modo esplicito il momento del coinvolgimento dal carattere dialogico delle immagini, e ciò è quanto dire che nel raccogliere i nostri esempi possiamo farci guidare da una matrice che distingua almeno quattro possibilità, articolate su due differenti coppie di valori: da un lato infatti le immagini possono essere ordinate rispetto alla continuità che le lega allo spazio reale, ed avremo in questo caso le due modalità del coinvolgimento e della separatezza dell’immagine, dall’altro è possibile invece chiamare in causa la dimensione transitiva dell’immagine, la sua capacità di interpellare lo spettatore, ed in questo caso avremo l’oscillare dell’immagine tra il suo asserire di fronte allo spettatore qualcosa o il suo esplicito rivolgersi ad esso in un dialogo. Così:
|
|
Separatezza (A) |
Coinvolgimento (B) |
|
Intransitiva (C) |
1 (C-A) |
2 (C-B) |
|
Transitiva (D) |
3 (D-A) |
4 (D-B) |
Ma appunto sul significato di queste distinzioni debbono poter parlare gli esempi.
Lezione tredicesima
1. Un possibile ordinamento
Nella lezione precedente abbiamo cercato di mostrare come la forma dello spazio figurativo ci consentisse di delineare il fondamento fenomenologico degli atteggiamenti ricettivi rispetto alle immagini, e questa tesi ci ha condotto a tracciare in forma schematica le direttrici lungo le quali fissare le diverse forme dello spazio figurativo che hanno una loro eco nell’atteggiamento che assumiamo rispetto alle scene raffigurate.
Ora, per cercare di far luce sullo schema proposto vorrei in primo luogo, riflettere un poco sulle condizioni cui è vincolata la forma percettiva del coinvolgimento. Queste condizioni ci sono già note, almeno nelle loro caratteristiche generali: vi è coinvolgimento quando lo spazio pittorico sembra continuare percettivamente lo spazio reale dello spettatore, e ciò è possibile quando, in linea di principio, la scena dipinta sa rendere percettivamente persuasiva la dimensione della profondità e sa ancorarla al punto di vista dello spettatore.
Basta leggere queste considerazioni di carattere generale per rendersi conto come il movimento verso un’immagine coinvolgente coincida con il cammino che dalle tecniche più elementari per rendere la profondità dello spazio conduce sino alla prospettiva in senso stretto, — a quella tecnica figurativa che per tutto il Rinascimento vale come una promessa che assicura il pittore della scientificità e insieme della grandezza della sua prassi. Ora, parlare di tecniche figurative per rendere la profondità sembra alludere ad un orizzonte puramente culturale, e di fatto vi è stato chi — e proprio discorrendo della prospettiva rinascimentale — ha avvertito il bisogno di affermare che uno spazio percettivo non vi è, e che vi sono soltanto le molte diverse convenzioni che rispondono alla sensibilità di una cultura e di un’epoca storica. All’origine di questa tesi vi è un saggio di Erwin Panofsky che nel 1925 pubblica La prospettiva come forma simbolica in cui si sostiene il carattere convenzionale e storico della prospettiva. E tuttavia, piuttosto che entrare nel vivo di un dibattito che ci condurrebbe a ripetere cose che abbiamo già detto, vorrei limitarmi ad osservare che ogni tecnica figurativa racchiude in sé osservazione ed esperimento, e lega in un unico nodo la capacità di cogliere alcune strutture dell’esperienza e di elaborarle in una tecnica che possa essere facilmente impiegata ed appresa. Lo abbiamo già osservato: ogni prassi pittorica si avvale di schemi che debbono garantire da un lato un riconoscimento percettivo, ma debbono sapersi piegare dall’altro ad una prassi che può essere appresa e che è tutt’altro che facile insegnare, anche se il risultato cui conduce ci sembra così naturale. Anche se gli oggetti della nostra quotidiana esperienza sono ben chiari nella loro forma di fronte ai nostri occhi, non si impara a disegnare soltanto guardando più attentamente le cose, ma sempre anche ascoltando i consigli di chi ha già appreso una tecnica e ci guida nell’applicarla. I pittori nelle botteghe si tramandavano le regole di un sapere codificato, che doveva essere appreso ora con la ripetizione e l’esercizio, ora affiancando al lavoro della mano la comprensione teorica. Per disegnare le mani o i tratti del viso bisogna ottemperare a molti precetti del mestiere, e vi sono diverse regole che ci insegnano a disporre i lineamenti in un volto secondo le giuste proporzioni e a salvarle anche quando il volto ci appare reclinato o colto in una prospettiva particolare. Queste regole vanno insegnate o pazientemente scoperte, e questo è vero anche per gli schemi intuitivi che ci guidano nel rendere la profondità. Lo spazio profondo si può rendere visibile in molti modi, e vi sono differenti metodi di cui possiamo avvalerci per creare nello spazio figurativo una qualche profondità, che a sua volta dipenderà nel modo della sua manifestazione dalle scelte figurative di cui ci si avvale. Ora, ogni schema intuitivo per rendere la profondità comporta l’apprendimento di una tecnica: lo spazio si fa profondo se disegnando obbediamo ad un insieme di precetti di volta in volta diversi. Ma questo non significa affatto che gli schemi intuitivi abbiano natura convenzionale: per stipulare una convenzione non vi è bisogno dei precetti del mestiere, ma solo di un testo su cui trovarsi d’accordo. Di una tecnica vi è invece bisogno quando si vuole ottenere un risultato che deve poter essere apprezzato al di là del nostro convenirne: le tecniche racchiudono in sé un saper fare, e se di un saper fare vi è bisogno è solo perché non ci basta decidere che l’immagine sia profonda, ma vogliamo vederlo al di là di ogni eventuale stipulazione. E questo vero per qualsiasi tecnica che cerchi di rendere visibile nello spazio figurativo la dimensione della profondità, per le tecniche elaborate che chiedono l’ausilio della riflessione geometrica, così come per le tecniche più semplici che si affidano ad una qualche regola dell’esperienza per poi elevarla ad unico criterio metodico. Così, invece di sostenere la convenzionalità della prospettiva o di contrapporre a questa tesi l’assunto della sua naturalità, vorrei invitarvi ad osservare che vi sono molte diverse forme per rendere lo spazio profondo e che tutte hanno un loro fundamentum in re: tutte consentono di vedere nell’immagine l’aprirsi in profondità dello spazio, anche se ciascuna a suo modo e in una differente misura. E tutte sorgono da un intreccio di osservazione e di riflessione — anche se nel caso della prospettiva questo intreccio è più complesso che in molti altri casi.
Rivolgiamo allora lo sguardo agli schemi intuitivi della profondità[12]. Tra questi il più semplice è forse quello che ci costringe a dare profondità all’immagine avvalendosi della regola percettiva del nascondimento e della sovrapposizione. Così stanno le cose in molti quadri di Klee, e in generale la regola della sovrapposizione è lo strumento privilegiato per rendere la profondità dello spazio figurativo nell’arte dell’antico Egitto. Ciò che è parzialmente nascosto è dietro, ciò che nasconde è davanti, ed in questo gioco di sovrapposizioni lo spazio guadagna una sua profondità senza per questo rinunciare all’aderenza ai valori di superficie e senza dimenticarsi così di sottolineare l’alterità dello spazio figurativo dallo spazio reale dello spettatore.
Un secondo modo per rendere la profondità dello spazio figurativo ci riconduce invece alla regola delle oblique, la cui massima suona così: disegna dapprima la vista frontale delle cose e poi disponi obliquamente le visioni laterali, e otterrai l’apparenza di uno spazio che si inerpica nella dimensione della profondità. Questa regola ha un suo ovvio fondamento percettivo: se nel mare scorgiamo il profilo di una nave, la vediamo tanto più lontana da noi quanto più ci appare alta nel mare. E ciò è quanto dire: sono più lontani da noi i luoghi che più si approssimano alla linea dell’orizzonte, — al luogo prospettico verso cui all’infinito convergono tutte le direttrici che abbiano un qualche indice di profondità. Lo schema intuitivo delle oblique poggia su questo fatto fenomenologico elementare: una linea che sale verso l’orizzonte è una linea che segue il cammino della lontananza. Si tratta di una constatazione elementare che può tuttavia assumere le forme di una tecnica relativamente elaborata. Alla disposizione casuale delle oblique che caratterizza il disegno di un bambino, si può sostituire la regola che ci invita dapprima a disporle orientandole nel medesimo verso e poi a tracciarle le une parallele alle altre, come accade in tanta parte della pittura cinese. Ma è possibile anche imparare a orientarle rispetto all’orizzonte prospettico che fa così il suo ingresso nello spazio figurativo. Vi saranno allora le oblique che accompagnano il movimento di salita verso l’orizzonte e oblique che dai tetti nel cielo scendono verso il basso, allontanandosi verso il confine dello spazio visibile. Una regola questa che troviamo già negli affreschi di Giotto a Santa Croce, ma che deve essere rammentata perché insieme alla linea dell’orizzonte cui quel salire e quello scendere alludono compare l’idea di uno spazio che si orienta verso lo spettatore poiché ne rivela implicitamente l’altezza.
E tuttavia perché di un coinvolgimento si possa a pieno titolo parlare la convergenza delle oblique verso l’orizzonte non basta, e questo anche se avvalendoci di questa tecnica sappiamo già creare una viva percezione della profondità e siamo in grado di fissare, seppur vagamente, l’altezza del punto di vista. Dalle immagini si può pretendere di più, ed in modo particolare si può pretendere che sappiano dirci un tratto fondamentale della profondità come categoria percettiva: il suo essere per qualcuno. La profondità percepita ha una sua peculiare caratteristica fenomenologica e non è una dimensione tra le altre: è piuttosto la veste soggettiva che la nostra esperienza dello spazio concede ad una delle sue tre dimensioni. Larghezza ed altezza sono dimensioni che si raccordano alla legge terrestre del filo a piombo: se lo spazio si orienta nell’esperienza quotidiana lungo gli assi delle verticali e delle verticali è perché gli oggetti pesano e rivelano la perpendicolare al suolo. Ora, della pretesa che vi sia davvero un alto e un basso lo scienziato dovrà in seguito liberarsi, e tuttavia altezza e larghezza non rimandano in se stesse al mio esserci; la profondità, invece, sorge come relazione spaziale che si determina soltanto in relazione al luogo in cui sono. Dire che lo spazio è profondo significa rammentare l’incedere della lontananza, il passo con cui lo spazio sprofonda allontanandosi da me. Dal punto di vista fenomenologico, il terzo asse cartesiano ha una sua peculiarità ineliminabile, poiché è nel modo del darsi della lontananza che lo spazio si incentra nel luogo da cui lo si osserva, facendo del «qui» un punto gravido di senso. Ora, anche di questo punto si vuole parlare nell’immagine, ma non si può certo mostrarlo: il «qui» è un luogo che non si vede. Ma che si avverte, ed anche l’immagine può farlo avvertire allo spettatore, orientando lo spazio figurativo verso un punto che sta innanzi ad esso.
Ma se la scena dipinta deve ricordarci del significato “esistenziale” della profondità, alla regola delle oblique parallele deve sostituirsi la regola della convergenza delle ortogonali. Non si tratta di una regola priva di un fondamento intuitivo, e vi sono infinite esperienze che ci mostrano la convergenza delle linee di profondità, il loro tendere verso un punto. Se osserviamo un porticato, ricorda Lucrezio, lo vediamo chiudersi nel vertice oscuro di un cono, e i cigli di una strada che corra diritta verso l’orizzonte non sono soltanto obliqui nel loro sprofondare in lontananza ma convergono sino a chiudersi in un punto infinitamente lontano. Si tratta di un’esperienza comune, di cui tuttavia si può rendere conto e Leonardo ci invita a riflettere sul fenomeno della convergenza con un disegno che ci pone idealmente al centro di due linee che corrono parallele, per mostrare poi come i raggi di luce che ci consentano di vederle formino rispetto alla perpendicolare un angolo che si fa sempre più acuto quanto più ci allontaniamo dall’osservatore. Dalle forme quotidiane dell’esperienza siamo rapidamente passati ad una schematizzazione che contiene in sé il nucleo di una riflessione geometrica.
E tuttavia, prima che questi ragionamenti prendessero forma, i precetti dell’arte avevano già raggiunto la meta, e basta guardare la Predella della maestà di Duccio da Buoninsegna per rendersene conto. Qui, e ancor più chiaramente, nell’Annunciazione o nella Presentazione al tempio di Ambrogio Lorenzetti la scena raffigurata ci parla del luogo che dobbiamo assumere come spettatori, e in questo nuovo significato spaziale di cui l’immagine si appropria si può iniziare a scorgere ciò che intendevamo quando parlavamo della natura coinvolgente delle immagini. Il coinvolgimento nasce di qui: di fronte alla Presentazione al tempio dobbiamo disporci secondo una regola che non è dettata soltanto dal generale volgersi dell’immagine allo spettatore, ma dalla peculiarità della scena raffigurata che si orienta percettivamente rispetto allo spettatore e gli appare così come dovrebbe in linea di principio apparirgli uno spazio reale che si dispiegasse di fronte ai sui occhi. Certo, la diversità qualitativa tra la spazio pittorico e lo spazio reale è facilmente avvertibile, e gli elementi di continuità si intrecciano agli elementi di discontinuità, in un gioco che determina la specificità di queste immagini. E tuttavia un primo passo è compiuto.
Sarebbe tuttavia un errore credere che il cammino verso un’immagine coinvolgente si fermi a questi primi tentativi di raffigurazione prospettica. Certo, le ortogonali al piano convergono in unico punto, ma lo spazio nel suo complesso non corrisponde ancora ad una regola unitaria. E ancora: le linee convergono, ma dove bisogna farle convergere? In un punto esatto, in un luogo circoscritto, in più punti allineati? — tutte queste sono domande cui la pittura del tardo medioevo cerca di dare una risposta, saggiando diverse possibili soluzioni. Una risposta, tuttavia, doveva imporsi, ed anche in questo caso osservazione e coscienza riflessiva dovevano stringersi in unico nodo. Se osservo una scena dal basso ho un orizzonte basso, se mi alzo l’orizzonte sale con me: la linea dell’orizzonte si accorda evidentemente al mio punto di vista. Basta tuttavia riflettere un poco per trasformare quest’intuizione vaga in una considerazione più esatta: ora ci piazziamo tra le rotaie e osserviamo come il mio sguardo allontanandosi tende a rendere sempre meno ampio l’angolo che forma con la linea di terra. Si tratta, ancora una volta, di una progressione che, all’infinito, tende ad un limite che è raggiunto quando la linea visuale si fa parallela al terreno. Il punto in cui visivamente le rotaie si incontrano è il non-luogo verso cui addita una linea visuale che corre ormai parallela alla linea di terra e che è quindi tanto alta quanto lo è il nostro punto di vista.
Si tratta di considerazioni geometriche relativamente ovvie che non chiedono necessariamente di essere comprese sullo sfondo della geometria proiettiva e delle sue regole ma che tuttavia si dispongono già nell’alveo delle riflessioni che dovevano condurre all’origine della prospettiva artificiale. In un certo senso, del resto, le linee generali del discorso prospettico sono già racchiuse in questo nostro ragionare intuitivo sulla convergenza fenomenica, in quella geometria intuitiva fondata su «una più grassa Minerva» cui Alberti invita il ragionamento del pittore. Possiamo così prendere alla lettera le critiche di Delaunay o di Paul Klee che vedevano nella prospettiva l’ossessione delle rotaie e del succedersi delle traversine e muovere da questa esperienza esemplare per ricavare il criterio costruttivo che ci consenta di disegnare lo spazio prospettico nella sua interezza. Si tratta del resto di un criterio di estrema semplicità. Tracciamo le rotaie e fissiamo nel centro della tela il loro convergere e poi segniamo l’incedere cadenzato delle traversine che si allontanano dallo spettatore, e con questa duplice mossa abbiamo disegnato il piano di base. Ora, la regola per scorciare il piano di terra può essere ripetuta, in un’iterazione che ci consente di dar vita allo spazio profondo, che sorge così come una ripetizione dell’identico rispetto al centro ottico dell’immagine, al luogo verso cui convergono tutte le linee di profondità:

Di qui poi, una volta costruita la gabbia prospettica del quadro, si può muovere per mostrare come il punto di fuga verso cui si dirigono le linee della profondità non deve necessariamente trovarsi al centro del quadro. Normalmente guardiamo un dipinto disponendoci di fronte al suo centro; la costruzione prospettica può tuttavia chiederci di mutare quest’abitudine ricettiva e può costringerci ad accordare il luogo in cui siamo all’eccentricità dello sguardo rispetto al quale la scena dipinta è stata costruita. Non solo il quadro, ma anche la scena raffigurata ha un suo centro prospettico che ci invita a disporci in una posizione determinata: la scena può corrispondere ad una vista dall’alto o dal basso, ad uno scorcio o ad una visione frontale e in ciascuno di questi casi lo spettatore è in linea di principio chiamato a far proprio un punto di vista. La raffigurazione si fa così coinvolgente poiché chiede allo spettatore di assumere un punto di vista particolare rispetto alla scena dipinta, proiettando le forme dello spazio figurativo nello spazio di risonanza dell’immagine.
In queste ultime considerazioni, l’analisi sulle tecniche della profondità ha ceduto almeno in parte il passo al problema che ora più ci sta a cuore: il problema del coinvolgimento dello spettatore. E tuttavia perché si possa davvero affrontare questo tema nella sua forma più evidente dobbiamo rivolgere propriamente lo sguardo alla costruzione prospettica dello spazio figurativo e al suo farsi avanti nella cultura pittorica del Rinascimento italiano. Vi è nella genesi di questa tecnica mirabile un fascino che è difficile non avvertire. La prospettiva è in sé un capitolo di una geometria nuova, ma il suo luogo di origine si muove su un diverso scenario: le riflessioni sui testi classici dell’ottica, il ragionare geometrico sulle proprietà dei triangoli che la convergenza delle ortogonali traccia sul foglio e, soprattutto, il sapere del pittore che cerca un metodo sicuro per realizzare un progetto preciso — fare del quadro una finestra aperta sul mondo, un diaframma sottile su cui segnare il contorno visibile delle cose, proprio così come appaiono. Un’idea, questa, ben chiara nella mente di più di una generazione di pittori che non riescono a non pensare al quadro se non come al luogo in cui si restituisce una visione delle cose che avrebbe potuto essere nostra se solo ci fossimo trovati di fronte alla finestra che su quegli eventi si apre. Il quadro prospettico deve restituirci una presenza seppure irreale, e può farlo solo se sa aprire nello spazio esperito del presente lo spazio figurato del possibile. Ma ciò significa appunto che l’immagine si fa prospettica quando sa raffigurare la profondità della scena dipinta e il suo orientamento raccordandoli esplicitamente al luogo dello spettatore. La specificità della prospettiva è appunto questa: il metodo prospettico costruisce l’immagine definendo con esattezza il punto di vista dello spettatore e la sua distanza dall’immagine, raccordando l’uno all’altro lo spazio figurativo e lo spazio dello spettatore.
La storia della prospettiva tra Quattrocento e Cinquecento è scandita dal desiderio pratico del pittore di trovare la via più semplice per definire il passo della lontananza e per raccordarlo al luogo dello spettatore, e così al «metodo migliore» dell’Alberti si affianca il metodo ottimo del Gaurico e del Viator o quella regola «più di ogni altra commoda» che il Vignola ci racconta nel suo trattato. Nella storia di questi metodi non possiamo qui immergerci, e per avere un’idea di quale sia in generale il fondamento del metodo prospettico rimando all’appendice che chiude questa dispensa e alle illustrazioni che sono disponibili nella pagina didattica del corso. Del resto il nostro obiettivo è più limitato: ciò che intendiamo mostrare è il nesso che lega la prospettiva come tecnica di raffigurazione della spazialità alla possibilità del coinvolgimento, — una possibilità che risulta con chiarezza dalle cose che abbiamo detto sin qui, ma che vorremmo ora provare a saggiare con qualche esempio.
2. Esempi
Le nostre brevi considerazioni esemplificative possono
prendere le mosse di qui, — da questo quadro di Andrea Mantegna che rappresenta
San Marco. Si tratta di un quadro che ha una ben chiara struttura spaziale: una
nicchia, che esibisce dichiaratamente il sapere prospettico del suo  autore,
racchiude uno spazio oscuro che ospita il corpo e il volto dell’evangelista. Ma
se il corpo e il capo di Marco sono protetti nello spazio della nicchia, il
braccio destro che sorregge il capo in un gesto che rammenta il segno della
benedizione greca sporge dallo spazio che sembra assegnato all’immagine, spingendosi
al di là del davanzale di pietra verso di noi. Sulla pietra poggia una mela che
ci invita forse a qualche complessa riflessione simbolica, ma soprattutto
poggia il vangelo che sui apre verso di noi e che sembra gravitare sul nostro
spazio di spettatori. E poiché del vangelo si tratta e non di un libro
qualunque, non è difficile intendere la dialettica degli spazio su cui Mantegna
ci invita a riflettere. Vi è uno spazio dell’immagine: lo spazio sacro che
l’evangelista occupa e che è ben disegnato dalla nicchia che lo incornicia. Ma
vi è anche lo spazio profano dello spettatore verso cui tuttavia l’immagine si
rivolge, in un movimento di continuità che è ben sottolineato dall’affacciasi
del vangelo dall’uno all’altro spazio. Del vangelo appunto: del libro che Marco
ha scritto e che nelle sue intenzioni altro non è che il luogo in cui la parola
divina si fa leggibile per l’uomo. Di qui il senso del quadro e, insieme, la
forma espressiva che lo spazio di risonanza dell’immagine assume: nel suo
disporsi come il luogo in cui la dialettica degli spazi si compone in un’unità
nuova, lo spazio di risonanza dell’immagine doveva divenire il luogo in cui per
la cultura rinascimentale poteva trovare una mediazione e un raccordo la dualità
tra lo spazio profano e reale della vita e lo spazio sacro della religione.
autore,
racchiude uno spazio oscuro che ospita il corpo e il volto dell’evangelista. Ma
se il corpo e il capo di Marco sono protetti nello spazio della nicchia, il
braccio destro che sorregge il capo in un gesto che rammenta il segno della
benedizione greca sporge dallo spazio che sembra assegnato all’immagine, spingendosi
al di là del davanzale di pietra verso di noi. Sulla pietra poggia una mela che
ci invita forse a qualche complessa riflessione simbolica, ma soprattutto
poggia il vangelo che sui apre verso di noi e che sembra gravitare sul nostro
spazio di spettatori. E poiché del vangelo si tratta e non di un libro
qualunque, non è difficile intendere la dialettica degli spazio su cui Mantegna
ci invita a riflettere. Vi è uno spazio dell’immagine: lo spazio sacro che
l’evangelista occupa e che è ben disegnato dalla nicchia che lo incornicia. Ma
vi è anche lo spazio profano dello spettatore verso cui tuttavia l’immagine si
rivolge, in un movimento di continuità che è ben sottolineato dall’affacciasi
del vangelo dall’uno all’altro spazio. Del vangelo appunto: del libro che Marco
ha scritto e che nelle sue intenzioni altro non è che il luogo in cui la parola
divina si fa leggibile per l’uomo. Di qui il senso del quadro e, insieme, la
forma espressiva che lo spazio di risonanza dell’immagine assume: nel suo
disporsi come il luogo in cui la dialettica degli spazi si compone in un’unità
nuova, lo spazio di risonanza dell’immagine doveva divenire il luogo in cui per
la cultura rinascimentale poteva trovare una mediazione e un raccordo la dualità
tra lo spazio profano e reale della vita e lo spazio sacro della religione.
Il San Marco del Mantegna è un esempio tra i molti
possibili, e le considerazioni che abbiamo appena enunciato potrebbero essere
senza molte correzioni riproposte per intendere il senso di molti altri suoi dipinti,
e tra questi la Presentazione al tempio. Mantegna non si lascia
influenzare dalle annotazioni psico logiche
di Giotto e di Duccio da Buoninsegna, che ritraggono la scena illuminandola con
il gesto spaurito del bimbo che tende le braccia alla madre; tutt’altro: come
Bellini, racchiude il bambino in un viluppo di fasce che lo rendono
inespressivo e che, tacitata la psicologia dei gesti e degli affetti, ci
costringono a pensare al mistero terribile di quel bambino nato per morire. E anche
qui la continuità visiva degli spazi ci rende necessariamente partecipi di quel
dono: Maria che affida il suo bambino al sacerdote del tempio deve
necessariamente sporgersi nel nostro universo reale, abbandonando lo spazio
sacro dell’immagine — poiché è per noi e per il nostro mondo che quel dono si
fa necessario. E ciò che vero per il Mantegna, vale per molti altri pittori che
proiettano la scena consueta nella pittura di icone della Vergine della tenerezza
sullo sfondo di una dialettica tra gli spazi che ormai conosciamo. Così accade
in questa Madonna con bambino del Crivelli, che separa lo spazio
dell’immagine dallo spazio dello spettatore dipingendo tra l’uno e l’altro un
muretto, su cui Maria sembra deporre Gesù che si pone così visibilmente come la
forma di mediazione tra l’universo sacro e quello profano, tra dio e l’uomo —
una scelta iconografica molto diffusa e che nel Crivelli ritroviamo in molte
altre raffigurazioni di questo stesso tema (nella Madonna con bambino di
Bergamo, di Verona, di Washington, di New York) che variano più per la
simbologia degli oggetti che arricchiscono la scena che per la strutturazione
spaziale che ne determina il senso.
logiche
di Giotto e di Duccio da Buoninsegna, che ritraggono la scena illuminandola con
il gesto spaurito del bimbo che tende le braccia alla madre; tutt’altro: come
Bellini, racchiude il bambino in un viluppo di fasce che lo rendono
inespressivo e che, tacitata la psicologia dei gesti e degli affetti, ci
costringono a pensare al mistero terribile di quel bambino nato per morire. E anche
qui la continuità visiva degli spazi ci rende necessariamente partecipi di quel
dono: Maria che affida il suo bambino al sacerdote del tempio deve
necessariamente sporgersi nel nostro universo reale, abbandonando lo spazio
sacro dell’immagine — poiché è per noi e per il nostro mondo che quel dono si
fa necessario. E ciò che vero per il Mantegna, vale per molti altri pittori che
proiettano la scena consueta nella pittura di icone della Vergine della tenerezza
sullo sfondo di una dialettica tra gli spazi che ormai conosciamo. Così accade
in questa Madonna con bambino del Crivelli, che separa lo spazio
dell’immagine dallo spazio dello spettatore dipingendo tra l’uno e l’altro un
muretto, su cui Maria sembra deporre Gesù che si pone così visibilmente come la
forma di mediazione tra l’universo sacro e quello profano, tra dio e l’uomo —
una scelta iconografica molto diffusa e che nel Crivelli ritroviamo in molte
altre raffigurazioni di questo stesso tema (nella Madonna con bambino di
Bergamo, di Verona, di Washington, di New York) che variano più per la
simbologia degli oggetti che arricchiscono la scena che per la strutturazione
spaziale che ne determina il senso.

 Nella rilettura
dell’iconografia bizantina che matura in età rinascimentale la dialettica tra
spazio sacro e spazio profano gioca un ruolo centrale, e per rendersene conto è
opportuno volgere lo sguardo ad un’icona particolare: l’icona dell’imago
pietatis. Su questa strana raffigurazione Belting e Panofsky hanno scritto
pagine molto importanti; per noi, tuttavia, è sufficiente osservare che questa
strana immagine, che non ha un carattere narrativo, allude al mistero
eucaristico, — un’interpretazione, quest’ultima, che sembra essere confermata
dal fatto che il corpo di Cristo ci appare talvolta in un calice ed è comunque
esibito come l’ostia nel gesto della consacrazione. Ora, il significato di
fondo di quest’icona permane anche quando Bellini sente il bisogno di rivisitarla
e riproporla in una serie di quadri famosi. Qualcosa tuttavia muta:
all’immagine del Cristo nel sepolcro si affiancano Maria e Giovanni e la valenza
simbolica della scena si arricchisce di un motivo nuovo, poiché ora lo spazio sacro
dell’immagine si lega allo spazio dello spettatore secondo una dialettica che
ci è ormai nota. Un muro segna il diaframma
tra i due spazi che tuttavia la costruzione prospettica lega, e questo gioco
di continuità e di separatezza è ripetuto dalla posizione di Cristo, — dal
suo porsi da un lato nello spazio sacro e, dall’altro, nel suo lasciar
cadere la mano nello spazio profano dello spettatore. All’ostensione del corpo
di Cristo si affianca così la consapevolezza visiva che quel sacrificio ha
nello spettatore il suo destinatario. Il sacrificio che si consuma nello spazio
dell’immagine ha la sua ragion d’essere nel nostro mondo, e questa
constatazione che è così strettamente connessa con il senso stesso del mistero
eucaristico cerca di assumere una piega apertamente visiva in questi dipinti
del Bellini.
Nella rilettura
dell’iconografia bizantina che matura in età rinascimentale la dialettica tra
spazio sacro e spazio profano gioca un ruolo centrale, e per rendersene conto è
opportuno volgere lo sguardo ad un’icona particolare: l’icona dell’imago
pietatis. Su questa strana raffigurazione Belting e Panofsky hanno scritto
pagine molto importanti; per noi, tuttavia, è sufficiente osservare che questa
strana immagine, che non ha un carattere narrativo, allude al mistero
eucaristico, — un’interpretazione, quest’ultima, che sembra essere confermata
dal fatto che il corpo di Cristo ci appare talvolta in un calice ed è comunque
esibito come l’ostia nel gesto della consacrazione. Ora, il significato di
fondo di quest’icona permane anche quando Bellini sente il bisogno di rivisitarla
e riproporla in una serie di quadri famosi. Qualcosa tuttavia muta:
all’immagine del Cristo nel sepolcro si affiancano Maria e Giovanni e la valenza
simbolica della scena si arricchisce di un motivo nuovo, poiché ora lo spazio sacro
dell’immagine si lega allo spazio dello spettatore secondo una dialettica che
ci è ormai nota. Un muro segna il diaframma
tra i due spazi che tuttavia la costruzione prospettica lega, e questo gioco
di continuità e di separatezza è ripetuto dalla posizione di Cristo, — dal
suo porsi da un lato nello spazio sacro e, dall’altro, nel suo lasciar
cadere la mano nello spazio profano dello spettatore. All’ostensione del corpo
di Cristo si affianca così la consapevolezza visiva che quel sacrificio ha
nello spettatore il suo destinatario. Il sacrificio che si consuma nello spazio
dell’immagine ha la sua ragion d’essere nel nostro mondo, e questa
constatazione che è così strettamente connessa con il senso stesso del mistero
eucaristico cerca di assumere una piega apertamente visiva in questi dipinti
del Bellini.
 La
dialettica tra lo spazio sacro e lo spazio profano si manifesta con chiarezza
in molti quadri di Raffaello, e John Shearman ha mostrato in un suo splendido
libro (Arte e spettatore nel Rinascimento italiano, 1992) come questa
dialettica attribuisca un senso peculiare a opere come La deposizione:
qui, nel contesto di un’opera che è per altri versi determinata da una serie di
riferimenti classici (e tra questi il richiamo al trasporto funebre di
Meleagro), si fa avanti una nuova piega immaginativa, poiché Raffaello orienta
il movimento di deposizione del corpo dio Cristo dallo spazio dell’immagine verso
il nostro spazio di spettatori, secondo un’inclinazione di senso che non può
più sfuggirci. Anche qui Raffaello doveva fare scuola, e il motivo ispiratore
di questa deposizione — il movimento del corpo di Gesù dallo spazio di
narrazione della vicenda sacra allo spazio profano dello spettatore — trova una
sua eco e lo ritroviamo nella Deposizione del Pontormo e del Caravaggio,
dove alla dinamica del sorreggere si lega il gioco diretto degli sguardi.
La
dialettica tra lo spazio sacro e lo spazio profano si manifesta con chiarezza
in molti quadri di Raffaello, e John Shearman ha mostrato in un suo splendido
libro (Arte e spettatore nel Rinascimento italiano, 1992) come questa
dialettica attribuisca un senso peculiare a opere come La deposizione:
qui, nel contesto di un’opera che è per altri versi determinata da una serie di
riferimenti classici (e tra questi il richiamo al trasporto funebre di
Meleagro), si fa avanti una nuova piega immaginativa, poiché Raffaello orienta
il movimento di deposizione del corpo dio Cristo dallo spazio dell’immagine verso
il nostro spazio di spettatori, secondo un’inclinazione di senso che non può
più sfuggirci. Anche qui Raffaello doveva fare scuola, e il motivo ispiratore
di questa deposizione — il movimento del corpo di Gesù dallo spazio di
narrazione della vicenda sacra allo spazio profano dello spettatore — trova una
sua eco e lo ritroviamo nella Deposizione del Pontormo e del Caravaggio,
dove alla dinamica del sorreggere si lega il gioco diretto degli sguardi.
Potremmo soffermarci a lungo su questi ed altri esempi. E
tuttavia, piuttosto che moltiplicare gli esempi, vorrei richiamare l’attenzione
su un’opera che è all’origine della pittura prospettica e che racchiude in sé
con un’acutezza impareggiabile i temi di cui stiamo qui discorrendo: la Trinità
del Masaccio. Vi è chi ha voluto cogliere in quest’opera una concessione alle
lusinghe dell’arte prospettica e nella volontà illusionistica che pervade
questo affresco un’ingenuità da cui Masaccio avrebbe dovuto tenersi lontano. Ma
si tratta di un giudizio affrettato che muove dal presupposto che l’illusionismo
pittorico non possa avere una finzione espressiva e sia in fondo necessariamente
un gioco da cui l’arte dovrebbe tenersi lontana. E invece la dimensione
illusionistica fa necessariamente parte del processo di ricezione di
quest’opera. Masaccio vi dedica molta attenzione: il punto costruttivo
dell’impianto prospettico è posto infatti in maniera tale che lo spettatore —
che si muove all’interno dello spazio architettonico della Chiesa — sia
costretto ad approssimarvisi per poter vedere sempre meglio la scena dipinta.
Ora l’illusione prospettica si traduce nella disponibilità dello spettatore a
«cedere» ad una particolare sensazione spaziale: alla sensazio ne
di continuità che sembra legare lo
spazio reale allo spazio figurativo. E ciò è quanto dire che chi osserva
l’affresco può volontariamente illudersi di avere di fronte a sé una cappella,
uno spazio sacro che racchiude una scena sacra: solidamente poggiato sull’Arca
dell’alleanza, vi è infatti Dio padre che sorregge il Figlio morto sulla croce.
La continuità che la prospettiva suggerisce tra lo spazio figurativo e lo spazio
di risonanza dell’opera è accentuata dalle scelte figurative su cui ci siamo
dianzi soffermati. In primo luogo, l’affresco raffigura una cornice — la volta
a botte della cappella e i suoi pilastri — che circoscrive lo spazio sacro
della figurazione, ma propone anche alcune figure — i donatori, l’altare, il
sarcofago con lo scheletro, la «cornice» stessa — che da questa si sporgono,
facilitando così il trapasso dallo spazio figurativo allo spazio dello
spettatore. Ma vi è anche, in secondo luogo, una duplice deissi: Maria, ai
piedi della croce, rivolge lo sguardo
verso lo spettatore e, insieme, gli addita con un gesto della mano il sacrificio
del figlio. La sensazione di continuità sembra essere confermata anche a
livello tematico: all’interno e all’esterno della cappella la morte sembra
imporsi come il tema comune su cui meditare. Alla morte del dio uomo fa da
contrappunto la morte umana che occupa con la sua presenza lo spazio di risonanza
del quadro e ne determina l’alone emotivo.
ne
di continuità che sembra legare lo
spazio reale allo spazio figurativo. E ciò è quanto dire che chi osserva
l’affresco può volontariamente illudersi di avere di fronte a sé una cappella,
uno spazio sacro che racchiude una scena sacra: solidamente poggiato sull’Arca
dell’alleanza, vi è infatti Dio padre che sorregge il Figlio morto sulla croce.
La continuità che la prospettiva suggerisce tra lo spazio figurativo e lo spazio
di risonanza dell’opera è accentuata dalle scelte figurative su cui ci siamo
dianzi soffermati. In primo luogo, l’affresco raffigura una cornice — la volta
a botte della cappella e i suoi pilastri — che circoscrive lo spazio sacro
della figurazione, ma propone anche alcune figure — i donatori, l’altare, il
sarcofago con lo scheletro, la «cornice» stessa — che da questa si sporgono,
facilitando così il trapasso dallo spazio figurativo allo spazio dello
spettatore. Ma vi è anche, in secondo luogo, una duplice deissi: Maria, ai
piedi della croce, rivolge lo sguardo
verso lo spettatore e, insieme, gli addita con un gesto della mano il sacrificio
del figlio. La sensazione di continuità sembra essere confermata anche a
livello tematico: all’interno e all’esterno della cappella la morte sembra
imporsi come il tema comune su cui meditare. Alla morte del dio uomo fa da
contrappunto la morte umana che occupa con la sua presenza lo spazio di risonanza
del quadro e ne determina l’alone emotivo.
Al momento della continuità si affianca tuttavia il riconoscimento della discretezza. L’illusione è, in qualche misura, trattenuta: il rigorismo prospettico che caratterizza l’esecuzione della volta a botte si placa nella definizione delle figure sacre che non sono affatto viste, come invece dovrebbero, di sotto in su, ma ci appaiono in un’imperturbabile frontalità. Non solo: la stessa decisione di adottare un punto di vista dal basso tende a creare uno stacco tra ciò che è dentro e ciò che è fuori dalla cornice: lo spazio reale «continua» nello spazio figurativo, cui tuttavia non sembra possibile accedere. Del resto, la connessione tematica cui avevamo dianzi alluso è solo parziale: la morte nello spazio sacro è inscritta nel messaggio religioso che ne determina la funzione salvifica, mentre la morte che appare nello spazio dello spettatore si manifesta nella concretezza opprimente dello scheletro e nella massima cupa che ne sottolinea la presenza nei toni proverbiali della vanitas — «io già fui quel che voi siete, quel che io son, voi lo sarete». Tra i due spazi vi è dunque una comunanza che non cancella le differenze — un fatto questo che è già tutto racchiuso nel gesto così contenuto di Maria, nel suo renderci partecipi di una scena di cui pure non possiamo fare parte.
Di qui, da questa dialettica della continuità e della discretezza, si deve muovere per comprendere ciò che Masaccio intendeva dirci. Guardiamo nuovamente la scena che si raffigura all’interno della cappella dipinta: Masaccio ci mostra il Cristo crocifisso, ma non si limita a raffigurare, come di consueto, Maria e Giovanni ai piedi della croce, ma pone al suo culmine la figura del Padre, che sorregge il corpo del Figlio, volgendolo verso di noi, che di quel sacrificio siamo i destinatari. In questo gesto vi è tuttavia qualcosa di più del solo sorreggere: il Padre ci mostra il corpo di Cristo e le sue braccia sono volte verso di noi, per offrirci il sacrificio da cui, per il cristiano, dipende la nostra salvezza. Al gesto reale del Padre fa eco il gesto simbolico del Figlio, poiché il gesto di abbraccio è comunque parte della valenza retorica dell’immagine della crocifissione. Verso un identico nucleo di senso converge del resto anche il richiamo biblico contenuto nell’affresco del Masaccio, perché se si può affermare — come è stato autorevolmente sostenuto — che la croce poggia sull’Arca dell’alleanza, su cui Mosè celebra il sacrificio che cementa il patto tra dio e il suo popolo (Esodo, 24-26), allora sembra plausibile sostenere che nel gesto del Padre non vi è soltanto l’ostensione del corpo del Figlio, ma vi è un porgere in cui si esprime il senso stesso del sacramento dell’eucarestia. Dalla vecchia alleanza sorge la nuova (Matteo 26, 26-8), e il sacramento della comunione è appunto questo: ciò che permette di intendere la morte in una luce nuova e di rinsaldare a partire di qui un nuovo patto tra l’uomo e dio. Solo se si tiene bene a mente lo sfondo della morte e risurrezione di Cristo e della sua riproposizione nel sacramento eucaristico, la morte che campeggia nello spazio umano può essere intesa nel suo significato autenticamente cristiano — quel significato su cui Masaccio intende farci riflettere. Di qui la necessità di distinguere, ma insieme di connettere gli spazi in cui si articola la nostra esperienza della Trinità del Masaccio. Quegli spazi debbono essere distinti: lo spazio sacro non può perdersi nello spazio profano, perché è irriducibile ad esso. Ma debbono appunto essere messi in comunione: solo se è possibile istituire un rapporto di continuità tra un piano e l’altro della narrazione il senso cui Masaccio allude può di fatto dispiegarsi intuitivamente. Solo se lo spettatore può concretamente percepire l’unità che lega il suo spazio allo spazio figurativo, la dimensione terrena della morte può stemperarsi nella speranza di salvezza che si annuncia nel sacrificio di Cristo e nella sua ripetizione eucaristica. Ed è questo appunto che la prospettiva permette: lungi dall’essere solo il mezzo per creare un piacevole inganno, la strutturazione prospettica che mette capo alla sensazione di continuità che lega lo spazio di risonanza dell’opera (lo spazio umano) allo spazio figurativo (lo spazio dove si svolge il sacrificio di Cristo) si configura così come il sostrato sintattico che permette al genio di Masaccio di dare forma intuitiva al nucleo più ricco della fede cristiana.
Da questi temi così alti dobbiamo tuttavia prendere commiato, per tornare alle nostre considerazioni fenomenologiche che ci invitano a riflettere su un tema in cui ci siamo più volte imbattuti nei nostri esempi — il tema dei fondamenti intuitivi ed immaginativi del coinvolgimento[13].
Lezione quattordicesima
1. Il coinvolgimento: le sue forme spaziali
Nella lezione precedente ci eravamo soffermati su alcuni esempi tratti dalla pittura rinascimentale e al di là delle differenze che di volta in volta avevamo sottolineato, ci era sembrato possibile scorgere un tratto che accomunava le opere di cui abbiamo discusso: il loro aprirsi allo spettatore per suggerire un nesso tra lo spazio dell’immagine e lo spazio della sua ricezione. In modo particolare, nei dipinti di cui abbiamo discusso la relazione tra lo spazio figurativo e lo spazio di risonanza dell’immagine si è venuta determinando come un mezzo per dare forma intuitiva ad una relazione carica di suggestioni metafisiche: la relazione tra il divino e l’umano, tra lo spazio sacro e lo spazio profano. Di qui anche la natura del soggetto di molte delle opere su cui ci siamo soffermati: la possibilità di intendere la dinamica del coinvolgimento percettivo come un veicolo immaginativo per dare forma alla differenza e alla relazione tra divino ed umano doveva facilmente condurci in prossimità del nucleo ultimo del cristianesimo — il suo porsi come religione del dio uomo, del Cristo che muore per gli uomini, varcando così lo spazio divino per calcare la scena dello spazio umano e, insieme, per suggerire la necessità di un suo superamento. Il mistero del cristianesimo che si celebra nel rito della comunione poteva trovare così una sua raffigurazione esemplare sulla soglia che divide lo spazio dell’immagine dallo spazio della sua risonanza.
Non vi è dubbio che nella storia della pittura occidentale
questa lettura della relazione percettiva del coinvolgimento occupi un posto
centrale. Sarebbe tuttavia illegittimo confondere un modo di vivere
immaginativamente la soglia che separa e unisce lo spazio figurativo allo
spazio reale in cui lo spettatore si trova con la dialettica percettiva che
rende concretamente possibile una simile lettura. Anche se non è facile
tracciare una volta per tutte i confini che le separano, è sempre necessario
tentare di distinguere le analisi fenomenologiche dalle questioni di poetica, e
questo vale anche se la nostra capacità di tracciare le prime si nutre di ciò
che la varietà delle seconde ci mostra come loro condizione invariante. Così, è
importante sottolineare che la relazione di coinvolgimento che ci connette allo
spazio figurativo può assumere altri significati e non è affatto vincolata
alla lettura che il Rinascimento ha dato di temi e di soggetti che in parte le
derivano dalla pittura di icone bizantina. L’apertura della soglia del quadro
non parla necessariamente della relazione tra il divino e l’umano e non deve
pronunciarsi necessariamente sul mistero eucaristico; molte altre letture sono
possibili: può per esempio porsi anche come un mezzo per dare forma intuitiva
al rapporto tra la realtà e l’illusione, tra la vita e il sogno. Si tratta di
un tema che abbiamo in parte già toccato quando abbiamo discusso della valenza
ironica del trompe l’oeil e del suo rapporto con il tema della vanitas,
ma che sarebbe possibile arricchire sia richiamando alla mente alcune delle
considerazioni e degli esempi discussi a proposito di Las Meninas di
Velázquez, sia ricordandoci di molte opere di Magritte, in cui l’istanza
surrealistica si esprime ancora una volta assumendo le forme della pittura
prospettica. E non a caso: se si deve suggerire il pensiero che la realtà sia
pervasa dal sogno e che la logica delle cose non sia meno assurda dei giochi
dell’immaginazione, allora è necessario istituire comunque un raccordo tra lo
spazio dell’immagine e lo spazio di risonanza, tra ciò che è dentro la tela e
ciò che racchiude la tela. La condizione umana di cui ci parla Magritte in
fondo è proprio questa: quella di scoprire che il mondo reale non è meno
assurdo e privo di una sua logica seria del mondo onirico dell’immaginazione.
Ma è possibile anche  lasciare
da parte le preoccupazioni della metafisica e vedere nella forma del coinvolgimento
un mezzo per sancire la possibilità di penetrare nello spazio dell’interiorità.
Una tenda scostata lascia intravedere una stanza e nella stanza una ragazza
legge una lettera: è un quadro di Vermeer che qui gioca con la soglia
dell’immagine per mostrare la dialettica della comprensione. Possiamo penetrare
nello spazio dell’altro, senza tuttavia giungere davvero sino alla radice ultima
della sua intimità: proprio come non possiamo andare al di là del gioco delle espressioni
per vivere ciò che l’altro vive, così posiamo leggere la lettera che ci è
celata solo nell’intensità dello sguardo della ragazza che la legge.
lasciare
da parte le preoccupazioni della metafisica e vedere nella forma del coinvolgimento
un mezzo per sancire la possibilità di penetrare nello spazio dell’interiorità.
Una tenda scostata lascia intravedere una stanza e nella stanza una ragazza
legge una lettera: è un quadro di Vermeer che qui gioca con la soglia
dell’immagine per mostrare la dialettica della comprensione. Possiamo penetrare
nello spazio dell’altro, senza tuttavia giungere davvero sino alla radice ultima
della sua intimità: proprio come non possiamo andare al di là del gioco delle espressioni
per vivere ciò che l’altro vive, così posiamo leggere la lettera che ci è
celata solo nell’intensità dello sguardo della ragazza che la legge.
Del resto, il rimando alla pluralità delle forme del
coinvolgimento deve a sua volta intrecciarsi con la constatazione che vi sono
molte diverse forme percettive in cui si può parlare di un coinvolgimento, — un
fatto questo che ci riconduce alla dinamica dei punti di vista. Il coinvolgimento
indica una continuità percettiva con la scena raffigurata ed una simile continuità
è già raggiunta quando la regola di costruzione dello spazio dell’immagine è
coerente con la regola fenomenologica che determina la scena percettiva per un
punto dello spazio. Ma alla continuità della scena visiva può legarsi la
discontinuità della prassi e della dinamica degli interessi e per rendersene
conto è sufficiente rammentare le linee di fondo di una fenomenologia del punto
di vista. Il primo passo in questa direzione consiste nel rammentarsi del fatto
che l’io si situa anche e soprattutto nel
rapporto con le cose che gli appaiono fenomenicamente: la determinazione
del punto di vista chiede che lo
spazio non sia vuoto e che vi sia un ancoraggio reale dello sguardo, un oggetto
che ne sia la meta. La presenza di oggetti, tuttavia, è una condizione necessaria
perché si possa parlare di un punto di vista, non una condizione sufficiente:
due punti (l’io e la cosa) bastano per individuare una retta, non per un angolo
— e quest’osservazione sembra negare la sensatezza del concetto di cui discorriamo.
Venire a capo di questa difficoltà significa comprendere che
l’io non è un punto nello spazio, ma è sempre rivolto in una qualche direzione, determinando così il suo
orientamento, ma anche quello delle cose che gli appaiono. Noi siamo
innanzitutto un corpo, e il corpo è una cosa che ha un verso, ed è proprio il nostro avere una direzione normale di
movimento che si accorda con la disposizione frontale degli occhi che fa sì che
abbia un senso dire che siamo orientati nello spazio e che rende in ultima istanza
inadeguato ogni tentativo di schematizzare la situazione dell’io segnando un punto su un foglio di carta.
Dall’asimmetria del nostro corpo possiamo tuttavia muovere al suo essere
orientato nello spazio solo quando chiamiamo in causa la componente soggettiva:
l’io è un corpo che agisce e che esperisce, e l’agire e l’esperire delineano
nello spazio una molteplicità di direzioni, di frecce che dall’io si dipartono,
indicando il luogo verso cui è attualmente orientato. In altri termini: perché
sia lecito parlare di un orientamento spaziale non basta che il corpo sia volto verso un punto dello spazio — è
necessario che l’io vi si rivolga
esplicitamente, rendendolo meta del proprio osservare. A partire di qui il
cammino che ci separa dalla nozione di punto di vista può essere facilmente
colmato. Se ha senso parlare di un punto di vista solo quando ciò che è
percepito è anche la meta cui siamo
propriamente rivolti, allora possiamo distinguere due differenti situazioni
fenomenologiche: la meta verso cui siamo rivolti può infatti trovarsi in una
direzione che coincide o che non coincide con quella verso cui siamo
di fatto volti. Nel primo caso abbiamo la frontalità,
nel secondo la visione di scorcio; da
un lato vi è un sovrapporsi delle frecce dell’orientamento reale e
dell’orientamento cognitivo della soggettività, dall’altro l’aprirsi di un
angolo — l’angolo di visuale — che momentaneamente
le separa. E tuttavia, poiché la direzione verso cui siamo volti non è un mero
fatto ma dipende essenzialmente dalla presenza di un interesse dominante che motiva il nostro avere assunto e non aver
mutato la posizione del nostro corpo e quindi il suo orientamento nello spazio,
ne segue che il senso pieno delle nostre considerazioni può essere inteso solo
se si osserva che, laddove il punto di vista frontale è espressione della stabilità dell’orientamento soggettivo e
della coincidenza tra ciò verso cui
l’io ora si rivolge e ciò che da tempo aveva motivato il suo volgersi, la
visione angolata implica invece una vera e propria divaricazione della soggettività, il suo opporre l’interesse momentaneo
che la muove alle ragioni che tuttora motivano il suo mantenere un determinato
orientamento corporeo. Alla dimensione statica
della frontalità si contrappone così la dinamicità
del punto di vista angolato, il suo interrompere il corso dominante della
nostra esperienza e il suo porsi come uno scarto dalla norma della frontalità
che deve essere sanato, rinunciando o cedendo all’interesse da cui siamo
momentaneamente distratti.
Lo scorcio come uno scarto dalla norma della frontalità: su questa definizione è opportuno soffermarsi un poco. Nella visione frontale l’oggetto assume un ruolo centrale e pretende dall’io uno sguardo che renda ragione della stabile obiettività del suo esserci. Di contro, le cose viste di scorcio sembrano sottrarsi alla soggettività che le sorprende nel luogo in cui sono: nella visione di scorcio più che l’oggetto sembra esprimersi la casualità del suo incontro percettivo con il soggetto. Potremmo forse esprimerci così: nella visione frontale, l’io si colloca nel posto che è richiesto dalla situazione oggettiva nel suo complesso e osserva ciò che deve osservare, mentre nella visione di scorcio il soggetto è, in qualche modo, fuori luogo e si sente escluso dalla scena percettiva che pure sceglie di vedere. Ne segue che lo scorcio è davvero uno scarto dalla norma: lo scorcio ci costringe infatti a prendere atto di un’anormalità, a puntare la nostra attenzione sull’io e sul suo luogo, che passa inosservato quando l’io si trova là dove deve trovarsi — di fronte alle cose. Di qui il carattere di oggettività che spetta alla visione frontale, il suo porsi come uno sguardo che sembra cancellare la consapevolezza del punto di vista e della sua relatività e che è, proprio per questo, tendenzialmente impersonale. Di contro, lo scorcio racchiude in sé un elemento di arbitrarietà soggettiva e quindi anche di instabilità: l’io è appunto fuori dal luogo che gli spetta e ciò crea una tensione rispetto al posto che dovrebbe far suo.
Di qui, da queste considerazioni di fenomenologia della percezione, si dovrebbe muovere per definire le differenti forme di coinvolgimento che si legano alla dinamica dei punti di vista. La visione frontale è una visione che attesta la congruenza tra l’essere volto e l’essere rivolto della soggettività percipiente: la scena figurativa sembra, proprio per questo, coinvolgere lo spettatore come testimone di un evento al cui cospetto è chiamato e che si recita in sua presenza. Così non è un caso se Lo sposalizio della Vergine di Raffaello si impone allo sguardo secondo la legge di una frontalità esasperata: di quelle nozze siamo appunto i testimoni e nel nostro essere rivolti alla scena che Raffaello ci mostra non vi è davvero nessuna casualità.
Ma sono possibili anche differenti forme di coinvolgimento.
Lo scorcio non ci pone come testimoni di una scena che si recita per noi, ma è
piuttosto espressione di un distacco
che si fa strada al di là della continuità percettiva che lega lo spazio
figurativo allo spazio di risonanza dell’immagine. Sui significati concreti che
questo distacco assume per la soggettività, le considerazioni fenomenologiche
debbono necessariamente legarsi a considerazioni che sono dapprima di natura
empirica, poi di natura antropologica e storico-culturale. Così, il senso di
distacco che è implicito nella visione dall’alto riceverà una prima
determinazione di senso dal rimando alla nostra originaria esperienza del mondo
della vita: verso l’alto, e cioè là dove hanno il loro luogo naturale le cose leggere ed eteree, che per essere raggiunte
chiedono al nostro corpo pesante uno sforzo considerevole. Ma anche
l’esperienza del nostro corpo incide necessariamente sul senso e sul valore
immaginativo di ciò che è in alto e sul suo rapporto verso il basso. In alto vi
è ciò che ha importanza capitale e
che non può certo essere paragonato alle vicende pedestri di tutti i giorni; ma vi è anche l’ambito di ciò che è
spirituale, di ciò che contrasta con le bassezze dell’esistenza. E tuttavia
perché, vista dalle altezze incommensurabili dei cieli, la terra possa farci
sorridere «per il suo vil sembiante» e ci appaia infine come «l’aiuola che ci
fa tanto feroci» (Par. xxii, v.
151) è necessario che il distacco che
caratterizza fenomenologicamente la visione dall’alto si trasformi in un vero e
proprio commiato; è necessario, in
altri termini, che l’alto e il basso siano investiti da una valorizzazione
immaginativa che si carica delle certezze della fede e che dispone i significati
impliciti nei materiali dell’esperienza in un contesto culturale più ampio,
in un orizzonte di valori e di pensieri che li arricchiscono di nuovi sensi e
di nuove valenze. Ed uno stesso discorso vale per le raffigurazioni. Quando
Caspar David Friedrich dipinge la Grande riserva, la dipinge — come
abbiamo visto — scegliendo un punto di vista dall’alto, ed in questa scelta è
evidente il desiderio di coinvolgere lo spettatore nella forma del distacco. E
tuttavia, perché il distacco assuma la forma di uno sguardo che prende commiato
dal mondo sono necessari altri pensieri — è necessario quel sentimento
cupamente religioso del vivere che attraversa le opere di Friedrich e che si
esprime nel suo esasperato simbolismo e nella fantasia creatrice che dà forma alle
sue visioni.
La polarità dei valori immaginativi del sopra e del sotto si
manifesta, seppure in forma speculare, anche nell’analisi del punto di vista
dal basso. Anche qui abbiamo a che fare innanzitutto con il determinarsi della
modalità del distacco: il basso si rapporta all’alto come a una meta che chiede
di essere raggiunta e che propone un cammino che si inerpica in forma ora più,
ora meno ripida e che si rivela quindi ora impraticabile, ora invece
percorribile. E va da sé che il significato morale che si lega immaginativamente
al cammino verso l’alto si fonda su di un complesso intreccio in cui si
annodano considerazioni di ordine culturale, esperienze che chiamano in causa
la corporeità e fondamenti fenomenologici della percezione.
Infine, allo sguardo dall’alto e dal basso si deve aggiungere
lo scorcio laterale, che può ovviamente combinarsi con i punti di vista che
abbiamo discusso e che pure si lega ad un insieme di valori immaginativi su cui
le indagini fenomenologiche possono fare luce. Così, se ci rammentiamo di ciò
che abbiamo appena sostenuto, ci sembreranno più chiare le considerazioni di
Heinrich Wöllflin secondo cui la pittura barocca scopre, insieme al fascino
dello scorcio, il senso di una visione in cui tutto ci parla del soggettività,
del suo precario esserci e della casualità della scena che si impone al suo
sguardo. La casualità dell’immagine, la sua eccentricità rispetto al soggetto
che la sorprende possono poi divenire metafora della fuggevolezza del tempo, e
forse non è un caso che la visione di scorcio sia tipica dell’impressionismo e
che si leghi al proposito di non dipingere le cose nella loro stabile
oggettività, ma di ricreare sulla tela l’attimo dell’incontro percettivo tra il
soggetto e l’oggetto, l’istante accidentale in cui la visione ha luogo. E tuttavia,
piuttosto che addentrarci ulteriormente in questo terreno, vorremmo osservare
come, anche in questo caso, la possibilità di dare un senso pieno a parole come
casualità, fuggevolezza, precarietà ci costringa ad abbandonare
il terreno delle analisi fenomenologiche, per chiamare in causa la dimensione
dell’espressività e per comprendere in che modo i materiali dell’esperienza si
facciano veicolo di una significatività storicamente determinata.
2. Il coinvolgimento: i veicoli dell’immaginazione
Dobbiamo ora tornare sugli esempi su cui ci siamo soffermati per mostrare un momento che li unifica e che merita di essere discusso: sia che si tratti del San Marco di Mantegna, della Deposizione del Pontormo o della Trinità del Masaccio, in tutti questi casi il nesso tra lo spazio figurativo e lo spazio di risonanza dell’immagine non è soltanto garantito nella sua possibilità dalla continuità che percettivamente si istituisce tra l’uno e l’altro spazio, ma è insieme posto e rafforzato da elementi interni alla scena figurativi, volti ad indebolire il diaframma che separa l’immagine dal mondo reale. Ora ciò può avvenire in molti modi, e cercare di raggiungere una qualche completezza su questo terreno chiede una competenza che io non ho e che comunque ci condurrebbe ad abbandonare il terreno propriamente filosofico. Vorrei dunque limitarmi solo a qualche vago cenno, cui è difficile rinunciare se vogliamo davvero comprendere il senso delle considerazioni che abbiamo proposto.
Osserveremo allora che un primo modo per indebolire il diaframma che separa lo spazio figurativo dallo spazio dello spettatore consiste nella raffigurazione di un movimento disposto lungo l’asse della profondità. Così stanno le cose nella Deposizione del Pontormo o di Raffaello: il corpo di Gesù viene trasportato a fatica dallo spazio profondo verso lo spazio dello spettatore e la percezione visiva del movimento tende ad aprire immaginativamente un varco nel diaframma dell’immagine e a renderne percorribile la soglia. E ciò naturalmente può avvenire in due direzioni: possiamo sentirci meta di un tendere che dal quadro si orienta verso lo spettatore o essere invece coinvolti in un movimento che ci trascina verso lo spazio dell’immagine — ed è questo ciò che per esempio accade in un quadro come La zattera della Medusa di Géricault.
Al movimento interno all’immagine che suggerisce la percorribilità dello spazio e insieme ottunde la consapevolezza dell’incolmabilità della distanza che ci separa dalla scena dipinta si affianca la raffigurazione di elementi che rendano visivamente percorribile la soglia che separa l’immagine dallo spazio reale. Si tratta di una tecnica che si trova di frequente nel trompe l’oeil: qualcosa sembra sporgere dallo spazio dell’immagine, creando così l’illusione della percorribilità della cesura che lo separa dl mondo reale. Molte delle immagini che abbiamo visto nella scorsa lezione si avvalgono di questo sostegno visivo dell’immaginazione: nel San Marco del Mantegna il vangelo sporge dalla nicchia del santo, e al suo porsi come una mediazione tra l’uomo e dio fa eco il suo sporgersi dallo spazio figurativo verso il nostro spazio di spettatori, aprendo così un varco che sembra visivamente prometterci la possibilità di uno scambio tra lo spazio sacro e lo spazio profano. Un discorso analogo vale per la Pietà di Bellini o per la Madonna con bambino del Crivelli che aprono un varco tra lo spazio sacro e lo spazio profano dipingendo dapprima un muro per dividerli e poi lasciando che una mano o un braccio lo oltrepassi.
Anche nel caso del Bellini o del Crivelli, la soglia dello spazio figurativo è resa percorribile dall’artificio dello sporto; e tuttavia, in queste immagini vi è di più: vi è, infatti, uno sporgersi che è insieme una negazione della cornice — di quel muro che sembra racchiudere in sé lo spazio dell’immagine. Ora, il gesto pittorico che crea una cornice dipinta e ne fa un momento interno allo spettacolo che il quadro ci propone recupera al contenuto espressivo dell'opera una (o più di una) delle diverse funzioni che alla cornice come oggetto reale spettano nel contesto della ricezione di un quadro. E tra le funzioni della cornice, ve n’è una che riveste un’importanza centrale, specialmente all’interno del contesto teorico in cui ora ci muoviamo: la cornice è infatti un mezzo che sorregge la percezione nel suo tracciare il confine che distingue lo spazio ambientale dallo spazio figurativo. Di qui la prima funzione di una cornice dipinta: può sottolineare come parte dell’immagine abbia soltanto natura figurativa, proponendoci tuttavia ciò che si trova al di qua della cornice dipinta come se fosse reale o comunque capace di transitare dall’uno all’altro spazio, superando lo scarto ontologico cui la cornice allude. Per questa funzione della cornice dipinta e violata non è difficile trovare esempi. Ce ne offre molti Bellini, ma uno particolarmente felice lo troviamo in un quadro di frate Filippo Lippi: la sua Madonna con bambino custodita agli Uffizi può sottolineare con forza il dono che Gesù fa di sé proprio perché la cornice che sembra dapprima rinchiuderlo nello spazio figurativo è soltanto dipinta — oltrepassarla significa così, per l’immaginazione visiva, assistere al movimento di Gesù verso lo spettatore. Ma la cornice comunque permane e da un lato ci consente di trasformare la natura in paesaggio e di porla a quella distanza che sola consente una sua valorizzazione espressiva ed una sua autonoma sensatezza, dall’altra ci ricorda l’irriducibilità dello spazio sacro allo spazio profano.
Di qui la seconda funzione cui una cornice dipinta può assolvere. La cornice insiste sulla dualità degli spazi di cui segna i confini; dipingere cornici nella cornice vorrà dire allora intervenire in questa dualità, articolando in una molteplicità di livelli lo scarto tra realtà e finzione. Potremmo forse esprimerci così: la cornice o le cornici dipinte scandiscono nell'unità di un percorso il salto ontologico cui l'immaginazione pittorica ci invita.
Quale sia poi il significato concreto che questo percorso assume è solo il gioco linguistico storicamente determinato della ricezione pittorica a definirlo. Nella pittura rinascimentale questo cammino assume una forma definita: segna le tappe di un itinerario che va dallo spazio profano dello spettatore allo spazio sacro dell'immagine. Proprio come nelle antiche chiese lo spazio del culto era protetto da uno spazio intermedio — il nartece in cui erano confinati i catecumeni — o da un portale incastonato di immagini — l'iconostasi delle chiese ortodosse — così in molti quadri una cornice dipinta crea un itinerario possibile che dallo spazio sacro conduce allo spazio profano dello spettatore, attraverso un cammino che conduce da ciò che la cornice dipinta racchiude a ciò che al di là di essa è racchiuso dalla cornice reale. Così stanno le cose nella Trinità di Masaccio: qui il movimento di salita verso la croce è scandito dal disegno in trompe l’oeil del sepolcro di Adamo, dalle figure esterne alla cornice architettonica dei donatori, dal dipinto di Maria che sta sulla soglia della cappella dipinta e, infine, dalla meta cui tutto questo conduce — dalla figura del Padre e del Figlio racchiusi nello spazio architettonico della volta. Ma gli esempi potrebbero essere moltiplicati, e la forma iconografica della Sacra conversazione è spesso caratterizzata da un gioco di recinzione e di incorniciamento degli spazi che allude al movimento digradante che da dio giunge all’uomo attraverso la mediazione dei santi e della chiesa.
La violazione della cornice ci riconduce ad una forma di coinvolgimento che è innanzitutto caratterizzato da un movimento che va dall’immagine allo spettatore: è dalla scena dipinta che si propaga il movimento che deve raggiungere lo spettatore e sollecitarlo ad un ascolto. Ma non è sempre così: il coinvolgimento può assumere la forma di un movimento che va dallo spettatore all’immagine, come un suo penetrare nello spazio figurativo. Ed anche in questo caso l’immaginazione trova un sostegno concreto in ciò che la percezione le porge. Così, l’aprirsi di una tenda o di un velo a scoprire una scena tende a sostenere un movimento che va dallo spettatore allo spazio figurativo e non viceversa. Una tenda scostata è, per l’immaginazione, una tenda che qualcuno ha appena scostato, e nello spazio che si apre lo sguardo penetra, per cogliere ciò che accade in un’altra stanza, in uno spazio che non è il nostro ma che pure è contiguo. Certo, il velo può aprirsi anche per i personaggi della scena dipinta e la Madonna Sistina di Raffaello è un possibile esempio di questa reciprocità; nella norma, tuttavia, a scostare il velo dall’immagine è la mano dello spettatore che può così assistere a una scena privata — e la pittura olandese da Vermeer a Rembrandt ci offre molti possibili esempi.
Uno stesso vettore immaginativo caratterizza nella norma anche la raffigurazione di una porta in funzione di cornice. Da una porta dipinta si può entrare ed uscire, e Las meninas di Velázquez ci mostra il vano di una porta da cui un servitore sta per uscire, abbandonando così lo spazio dell’immagine per perdersi definitivamente. Ma da una porta in funzione di cornice sembra soltanto possibile entrare: la porta aperta spalanca la possibilità di accedere ad uno spazio che l’immagine mostra. Ed anche in questo caso gli esempi ci riconducono alla pittura olandese e alla sua narrazione intima e dimessa.
Su questo tema molte altre cose andrebbero dette, ma sarebbe
necessaria una competenza che non ho. Resta tuttavia una riflessione da cui non
possiamo esimerci. Il senso delle considerazioni che abbiamo proposto ci invita
infatti ad osservare come l’immaginazione non sia priva di un’interna legalità,
di ragioni che ci consentono, se non di anticiparne le mosse che restano imprevedibili
nella loro aperta infinità, almeno di comprenderle e di coglierle nell’unità di
un percorso. Vi sono appunto percorsi dell’immaginazione, e questo
proprio perché l’immaginazione mette in movimento le cose e attribuisce loro un
senso: qualcosa ci è dato percettivamente, ma l’immaginazione non si
ferma al dato, ma lo dispone in una rete di rimandi possibili, orientandolo
in una direzione determinata e attribuendogli una peculiare piega
immaginativa. Giovanni Piana lo spiega bene muovendo da un esempio felice:
Pensiamo alla situazione del discendere in una cantina. Può darsi il caso che nel discendere si provi un lieve senso di inquietudine. Un certo disagio: anzi, forse, soltanto passando dinanzi alla porta che conduce ad essa. Se dovessimo in qualche modo spiegare le ragioni di questo disagio, parleremo forse dell’oscurità della cantina; delle sue pareti umide e viscide, del fatto che essa si trova sottoterra e di altre cose ancora. Ma che ragioni possono essere queste? Di una cosa possiamo elencare le proprietà, ma esse non possono fare altro che circoscriverla attraverso le determinazioni di cui consiste e che possono essere constatate. La cantina è oscura. E con questo? Ammettiamo allora che l’immaginazione deve svolgere qui un qualche ruolo. Ma sarebbe evidentemente un errore presentare le cose come se passando davanti alla porta della cantina ci immergessimo in strane fantasticherie. In realtà non accade nulla di tutto questo. La differenza del punto di vista che ora abbiamo adottato e che ci. consente di mettere in rilievo un altro aspetto della tematica dell’immaginazione appare qui dal fatto che, se con «immaginare» intendiamo, come in precedenza un’effettiva produzione di scene immaginative, allora sarebbe giusto dire che, nel caso in questione, non stiamo immaginando nulla. Perciò vogliamo parlare piuttosto di una piega immaginativa che la situazione percettiva assume in quanto essa è compenetrata di immaginazione. Se poi andiamo alla ricerca delle ragioni di quel disagio e ci richiamiamo anzitutto all’oscurità, sappiamo benissimo che non si tratta di rilevare un dato di fatto da cui possa derivare qualcosa. L’oscurità pura e semplice non spiega nulla. In questo modo vorremmo piuttosto accennare ad un senso da cui la cosa è tutta permeata ed in cui essa tende a dissolversi. Quella porta si apre sull’oscuro – conduce in esso. Perciò non si tratta di una proprietà che fissa la cosa nella sua determinatezza: l’oscurità è qui una determinazione instabile, un’«idea» che «ci viene in mente» e sulla quale si addensano in modo indeterminato altre «idee». Ci sono dunque «associazioni»: ma ciò non significa che vi siano idee concatenate l’una all’altra e la mia mente non faccia altro che passare da questa a quella. Parliamo anzitutto dell’oscurità: ma in realtà ci riferiamo ad essa come ad una sorta di indice di direzione immaginativa. L’immaginazione si innesta su questo punto, ma non propone, a partire di qui, altri contenuti, spostandosi da un punto ad un altro punto. Essa invece imprime alla cosa una tendenza al movimento, si impossessa di essa per proiettarla sul piano di un dinamismo latente. In questo modo viene imboccata la via che conduce all’immagine: la cosa si trova ora avvolta da un orizzonte indeterminato di sensi fantasmagorici, viene risucchiata in una prospettiva immaginativa nella quale tende a perdere stabilità e consistenza. Essa comincia a muoversi, secondo un movimento che fa tutt’uno con l’azione delle sintesi, con il peso di altre idee che si fanno sentire nella forma di un richiamo allusivo. In breve potremmo dire: alla cosa viene apposto un indice di direzione sintetica dell’immaginazione: ed essa assume così il carattere di valore immaginativo (G. Piana, Elementi di una dottrina dell’esperienza, (1979), ora in Spazio filosofico, indirizzo internet: http://filosofia.dipafilo.unimi.it/~piana/elementi/e-idx-01.htm ).
Nell’immaginazione gli oggetti diventano mobili e insieme soggetti di una narrazione, se pur minimale, che li mette in scena e attribuisce loro un agire indeterminato che sorge dalla loro natura ma che non è affatto riducibile ad essa. Una porta scostata diviene una porta che è stata aperta e che ci propone un cammino, una strada conduce ad una meta e chiede di essere seguita, il sole alto nel cielo ci scruta, e tuttavia l’essere aperto della porta, la percorribilità della strada, l’essere in alto del cielo non sono che fatti ed acquistano un significato e un valore immaginativo solo quando l’eco dei pensieri che ad essi si lega si fa avanti sulla scena della soggettività e guida e sorregge la prassi di un gioco che può prenderci talvolta la mano: da questi fatti l’immaginazione trae il suo racconto e l’essere stabile delle cose assume un movimento ed un valore immaginativo.
Ora, in questa implicita vocazione narrativa l’immaginazione rivela il suo carattere ludico e quindi anche la sua dipendenza dalle inclinazioni della soggettività: l’immaginazione gioca con le cose e le connette in un orizzonte nuovo e in un contesto che è comunque animato e determinato dagli interessi e dalle preoccupazioni di chi di fatto gioca. Su questo punto ci siamo soffermati più volte: quale sia il significato dello sguardo dall’alto o della frontalità, del velo che si scosta o della dialettica tra gli spazi dell’immagine non può essere detto una volta per tutte, poiché questo significato varia con il variare della sintesi immaginative che si fanno di volta in volta valere e che dipendono in larga misura anche dalla soggettività, dalle sue forme di vita, dalle sue esigenze. E tuttavia, parlare di sintesi immaginative vuol dire anche, necessariamente, tenere conto della dimensione contenutistica degli oggetti che possono essere investiti di un senso immaginativo solo perché qualcosa nella loro natura sorregge il rimando che l’immaginazione intesse con altri oggetti o con possibili usi. Certo, la scala che conduce in cantina non assume un valore inquietante perché, vedendola, io ripeta tra me e me una concatenazione di idee che passo dopo passo mi conduca dall’idea di oscurità all’idea dell’essere sotto terra e da questo pensiero al pensiero della tomba e della morte; queste idee non debbono essere necessariamente pensate, poiché vivono come un’eco soffusa in quella percezione immaginosa: forse la porta della cantina ci basta guardarla per avvertire un disagio e forse il disagio non si fa manifesto se non nella circospezione con cui ci assicuriamo passo dopo passo dei gradini. E tuttavia se qualcuno ci chiedesse perché quel disagio o per quale motivo per noi tutti, così credo, la scala della cantina non sale affatto, ma scende — almeno per l’immaginazione — dovremmo riproporre proprio quella concatenazione di pensieri che non sono affatto pensati, ma che fanno egualmente da sfondo e da cassa di risonanza alla nostra percezione di un oggetto tra gli altri — la scala un po’ buia che va verso le fondamenta della casa dove è stata scavata la cantina, ma che altrettanto ragionevolmente conduce dall’oscurità del basso verso l’alto. Ma ciò significa ancora una volta ripetere che l’immaginazione e le sue valorizzazioni sintetiche non sono riducibili a fatti, ma sorgono da fatti giocando con essi e scegliendo in essi gli aspetti che ci consentono il gioco: così
dopo che si è sottolineata l’irriducibilità della funzione
valorizzante dell’immaginazione è importante notare che essa poggia anzitutto
su associazioni. Una pietra è effettivamente solida, dura, pesante. La
pioggia viene proprio dal cielo, bagna la terra e senza di essa i semi non
germinano. Il cielo è effettivamente alto, altissimo addirittura, e luminoso.
Di qui, da fatti, si traggono immagini (ivi)
Di qui l’importanza di un’analisi di ciò che consente all’immaginazione di mettersi in moto, dei fatti e delle strutture percettive da cui prende le mosse[14].
Lezione quindicesima
1. Dal coinvolgimento alla separatezza: l’icona
Abbiamo cercato sin qui di far luce sulla natura del
coinvolgimento percettivo e sul nesso che lega la forma delle immagini coinvolgenti
alle valorizzazioni immaginative e all’atteggiamentoche allo spettatore si
chiede di assumere. L’immagine coinvolgente non è solo un’immagine che, per
esempio, può consentirci di mettere in relazione lo spazio sacro allo spazio
profano: è anche una forma di raffigurazione che viene vissuta in un certo modo
e che, proprio perché non chiede di essere intesa sottolineandone l’alterità,
può essere guardata in un certo modo ed utilizzata per certi fini. Così, per riprendere
un esempio che abbiamo già fatto, quando Bellini dipinge la Pietà che è
custodita a Brera, riprende senz’altro un tema che è caratteristico della
tradizione iconica bizantina, ma lo pone sullo sfondo di un paesaggio reale
rischiarato dalla luce tenue di un tardo pomeriggio di primavera. Lo sfondo dorato
scompare e con esso la durezza lignea dell’icona e si apre invece uno spazio prospettico
— una differenza percettiva che allude ad un significato nuovo e ad un
differente comportamento ricettivo: lo spettatore è chiamato ad assistere
a ciò che un tempo è accaduto e a meditare sulla passione di Gesù e sul mistero
eucaristico senza distogliere lo sguardo dalla scena così come il pittore di
fatto la mostra. L’immagine ha cambiato senso e, insieme, funzione: il
suo compito non consiste più nell’indicare la via di una meditazione che distoglie
lo sguardo per immergersi in una riflessione che si involve in se stessa, ma
nel consentire un pensiero che cresce sull’immagine e se ne nutre. Ciò che
vediamo mutata è la forma dell’immagine, ma la forma è la possibilità della
funzione, ed è proprio per questo che ogni nuova concezione dell’immagine
non può limitarsi a suggerire un nuovo atteggiamento ermeneutico, ma deve cercare
la forma figurativa che lo renda concretamente possibile.
Di tutto questo abbiamo appunto già parlato, e tuttavia se vogliamo davvero saggiare la validità delle tesi che abbiamo sostenuto dobbiamo lasciare da parte le immagini coinvolgenti, per occuparci invece di quelle raffigurazioni che si pongono sotto il segno della separatezza. Di qui la scelta di rivolgere la nostra attenzione a una nuova tipologia di immagini, a quelle raffigurazioni che rinunciano ad una resa illusionistica della spazialità per aderire invece al piano che le ospita. Disponiamo così ancora una volta l’asta graduata della profondità nello spazio del concetto di immagine per ordinarne le differenti tipologie, ma questa volta ci orientiamo verso quelle immagini che aderiscono ai valori di superficie e che, proprio per questo, non consentono allo sguardo dello spettatore di penetrare con continuità nell’immagine, che appare così nella sua separatezza e nell’alterità della regola cui è subordinata la costruzione del suo spazio figurativo. Certo, si tratta di una separatezza che ha gradi e di un’alterità che è pervasa di elementi che accomunano lo spazio figurativo allo spazio reale: qualsiasi immagine si fonda su un riconoscimento percettivo e si avvale di ciò che l’esperienza ci insegna. Ciò non toglie, tuttavia, che abbia senso parlare di una famiglia di immagini in cui si fa più chiaramente avvertibile il momento dell’alterità, ed è di queste immagini caratterizzate dall’aderenza ai valori di superficie che dobbiamo discutere.
Ora, all’interno di questa famiglia di immagini vorremmo
scegliere di soffermarci su una forma figurativa la cui storia si intreccia
strettamente con la definizione della sua funzione: vorremmo cioè parlare delle
icone, anche se vorremmo parlarne da filosofi che si interessano alla
teoria delle immagini e non da storici dell’arte. Questa precisazione è
necessaria: l’icona è una forma pittorica molto particolare, che ha una sua
storia millenaria ed una sua vasta area di diffusione che abbraccia dapprima
l’impero d’Oriente e l’Italia per poi radicarsi nell’area di influenza della
Chiesa ortodossa. E se l’icona è per sua natura espressione di una volontà artistica
che non intende venire a patti con la storia e con le novità che essa arreca, è
altrettanto vero che lo storico non può non scorgere ciò che comunque accade
nella pittura sacra dell’Oriente europeo e deve quindi sforzarsi di periodizzare
e di riconnettere al suo mutevole contesto un’arte che è solo apparentemente
immobile. Non solo: se nel mondo ortodosso l’icona giunge sino alle soglie del
XIX secolo senza subire modificazioni che ne intacchino la sostanza, in
Occidente invece — ed in particolar modo in Italia — l’icona viene sottoposta a
partire dal XII-XIII secolo ad una reinterpretazione radicale, e alla storia di
questa vicenda Belting ha dedicato pagine di grande interesse teorico in un
libro intitolato Bild und Kult. Eine Geschichte der Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, Beck, München 1993.
Si tratta di temi e di problemi di grande interesse, ma — è bene ripeterlo — non spetta a noi discuterne: noi vogliamo invece interrogarci sulla natura delle immagini e per farlo dobbiamo discorrere dell’icona in generale, o più precisamente: delle ragioni che motivano la forma di queste tavole lignee, che sono innanzitutto caratterizzate da un’aderenza evidente ai valori di superficie, che hanno di solito piccole dimensioni, un soggetto invariabilmente religioso e che si legano comunque al culto e, spesso, alla devozione privata.
Affrontare questo compito significa in primo luogo rivolgere l’attenzione ad un aspetto che è caratteristico dell’icona: il suo tratto stilizzato. Si tratta di una stilizzazione particolare: quando osserviamo un ritratto dipinto in un’icona, di primo acchito non abbiamo l’impressione di avere a che fare con un disegno appena abbozzato, né con una raffigurazione che rinunci ad una resa convincente dei tratti somatici, e tuttavia a quest’impressione si lega fin da principio la certezza di avere a che fare con un processo di natura astraente che fissa la molteplicità delle forme di un viso in un insieme di stilemi che si sommano gli uni agli altri per dar vita ad un volto che sembra in linea di principio sottratto alle accidentalità del tempo e alle casualità che trasformano l’immagine dell’uomo in quella di un individuo, segnato dal tempo e dallo spazio. Il taglio degli occhi, la piega e l’attaccatura del naso, la forma degli zigomi, l’ovale del volto, la bocca piccola e chiusa si ripetono identici in ogni nuova icona che può in linea di principio pretendere di raffigurare degli individui concreti — Gesù, Maria, il Battista, Maddalena, i santi — solo in virtù di un processo additivo in cui il volto acquista caratteri peculiari (la barba nelle sue varie fogge, i capelli con le loro acconciature, i veli delle vesti con i loro colori, ecc.) differenziandosi così da altri volti. Le differenze individuali, le diverse età, ed anche in parte il maschile e il femminile ci appaiono così come forme appena accennate, come risultati che si ottengono aggiungendo un tratto dopo l’altro, in un processo in cui le differenze qualitative sono ricondotte ad un metro quantitativo.
Quali sono le ragioni di questa forma di stilizzazione che cancella le pieghe dell’individualità? Nelle pagine di molti autori — e per esempio in Trubeckoj (Contemplazione del colore, La Casa di Matriona, Milano 1988) o in Zibawi (Icone. Senso e storia, Jaca Book, Milano 1993) — vi è una risposta immediata: l’umanità delle icone è un’umanità santificata, che si è liberata dai ceppi dell’individualità terrena e si è riconosciuta nella sua forma originaria. L’icona ritrova nei volti degli uomini il volto di Adamo, e nel volto di Adamo prima del peccato scorge il volto divino, di cui il primo uomo era compiuta immagine. Così, si deve concludere che è colpa nostra se il genere si è frastagliato nelle specificità individuali: tra le tante ricadute di quell’originaria caduta vi è infatti l’individualità del volto, il suo avere assunto i tratti casuali che gli sono propri contravvenendo alla purezza logica dell’universale.
Non credo che questa lettura possa essere semplicemente rifiutata, e tuttavia prima di avventurarci sul terreno di ciò che le icone raffigurano è opportuno soffermarsi sugli stilemi di cui l’icona si compone per trovare qui un primo indizio che renda plausibile un uso linguistico che accomuna la lingua greca a quella russa e che non può non destare un qualche interessato stupore: in queste due lingue (e forse è così anche per altre lingue slave) l’atto del dipingere l’icona è ricondotto al gesto dello scrivere un testo. Le icone, dunque, si scrivono, e se il pittore e il calligrafo possono essere compresi sotto un identico nome ciò sembra accadere innanzitutto per questo: perché il lavoro dell’uno e dell’altro consiste nel tracciare su un foglio o su una tavola lignea un insieme di stilemi, di tratti ben definiti e stilizzati. Credo che le cose stiano davvero così, e tuttavia nelle pieghe di questo strano uso linguistico si cela un altro suggerimento cui vorrei dare ascolto. La scrittura non si fonda soltanto su tratti semplificati, ma su una vera e propria codificazione del segno. Scrivere significa vincolare il tracciato della penna ad una regola codificata che non si può abbandonare, pena il venir meno di ciò che fa di un tratto una lettera scritta. Ora, di questa necessaria dipendenza da una tradizione l’icona è una manifestazione esemplare. Dipingere un’icona significa davvero, in un certo senso, scriverla, poiché il pittore non deve dimostrare l’originalità di una scelta figurativa, né cercare un volto nuovo o una nuova disposizione delle figure che intende ritrarre: deve invece seguire un cammino che è segnato dalla tradizione, che fissa il calco della forma cui ci si deve attenere.
Queste considerazioni si manifestano nell’aderenza del pittore di icone ad un insieme di schemi figurativi prestabiliti, di stilemi pronti per l’uso. Certo, la pittura si fonda sull’utilizzo di schemi figurativi e anche il pittore rinascimentale o barocco si avvale di un repertorio di forme apprese dalla tradizione, di stilemi che sorreggono il pittore anche quando si cimenta con la copia dal vero. Gombrich l’ha mostrato con chiarezza: dipingere non significa seguire con la mano il contorno di ciò che l’occhio vede, ma vuol dire sempre applicare le regole di trasposizione pittorica dei fenomeni, gli schemi che sono stati appresi e che la prassi pittorica perfezione ed adatta ai compiti che si debbono di volta in volta fronteggiare.
Così, prima di dipingere ciò che intende raffigurare
l’apprendista dovrà esercitarsi nel disegno e ripetere molte volte e in molte
diverse fogge il contorno delle mani, dell’ovale di un volto, dei suoi lineamenti,
e se poi dovrà dipingere un soggetto si rammenterà di come gli altri lo hanno
affrontato. Se vuole dipingere il trasporto di un corpo morto, il pittore
rinascimentale deve rammentarsi dell’Alberti e di quel bassorilievo di Meleagro
che «in sé pare in ogni suo membro ben morto» (De pictura, II, 37), e questo
anche se a cimentarsi nell’impresa non è un pittore qualsiasi ma Raffaello o il
Signorelli.
Ma non è difficile scorgere che nel caso dell’icona l’aderenza allo schema figurativo si spinge ben più avanti ed assume davvero la forma di una regola rigida che si frappone come un veto posto alla varietà delle forme. I volti degli uomini sono molti, ma vi è sostanzialmente un unico taglio degli occhi, o almeno così pare.
L’aderenza alle regole della tradizione figurativa si mostra del resto con eguale chiarezza sul terreno dei soggetti. Ancora una volta: anche nella pittura rinascimentale i soggetti sono, in fondo, ben pochi. E tuttavia il precetto di raccontare storie ben note si lega al riconoscimento della necessità dell’inventio, della libera variazione e reinterpretazione della scena. Nel caso dell’icona, invece, non è il soltanto il soggetto ad essere prescritto dalla tradizione: anche la disposizione e l’espressività delle figure sono vincolate sino ai dettagli apparentemente più insignificanti. Così nell’iconografia della Vergine — questo tema ripetuto infinite volte per un arco di tempo di più di un millennio — l’icona ci mostra alcuni pochi modelli, che si differenziano gli uni dagli altri per alcuni gesti ben definiti (cfr. G. Gharib, Le icone mariane. Storia e culto, Città nuova, Roma 1987). Ecco, se vuoi dipingere Maria devi dipingerla così, con un mantello spesso ornato da tre piccole stelle perché Maria è aeiparthenos (sempre vergine), con l’aureola perché è panaghia (interamente santa), con il bambino in braccio, perché il Concilio di Efeso (431) ha sancito che Maria è davvero theotokos (madre di dio), anche se poi è lecito rappresentarla secondo alcune varianti che hanno comunque un significato ed una forma definita: è possibile dipingerla allora come regina in trono (Brephocratousa Basilissa), come theotokos consapevole della divinità del figlio benedicente (Brephocratousa Odigitria) o come madre che accetta soffrendo il destino del figlio, che stringe a sé con tenerezza (Brephocratousa Eleousa).
|
|
|
|
|
Brephocratousa
Basilissa |
Brephocratousa
Odigitria |
Brephocratousa Eleousa |
Certo, ogni genere lascia aperto un (esiguo) margine di libertà e vi sono altre tipi iconografici che non abbiamo nominato (l’avvocata e l’allattante, la Madonna della deesi e della dormizione, ecc.), ma nella sostanza le cose stanno così, ed è per questo che il pittore di icone rammenta davvero il copista medioevale che con infinita pazienza si sforza di restituire in una bella forma sensibile un testo che esiste già e che non deve essere in alcun modo alterato. Del resto che il pittore di icone si pensi come un copista non è un fatto che sia racchiuso soltanto nelle pieghe del linguaggio, ma che traspare anche nella prassi consueta di non firmare i propri lavori — quelle immagini di cui il pittore è artefice, ma non può dirsi creatore, perché come si legge nella preghiera del pittore che un monaco del monte Athos — Dioniso da Furnà — scrive in un suo manuale di pittura (Ermeneutica della pittura (1733), Napoli 1971) è dio che deve guidare le mani di chi dipinge il volto di Gesù, di Maria e dei santi.
È alla luce di queste considerazioni che deve essere intesa la ricca aneddotica sulle prime icone. L’icona di Maria non è nata per caso, da un gesto creativo qualsiasi: è Luca, l’evangelista, che l’ha per primo ritratta, fissando una volta per tutte il suo volto. E non si tratta certo di un qualsiasi testimone oculare: Luca è appunto un evangelista e la sua mano, che sa farsi guidare dal dettato divino nello scrivere i vangeli, deve farsi altrettanto obbediente nel dipingere. Quanto all’icona di Cristo, la sua origine è ancora più libera dalla fantasia del pittore: il modello cui ogni altra icona deve richiamarsi è un’immagine non è stata fatta dalla mano dell’uomo (acheropita), ma che Gesù stesso ha creato, ponendo sul suo volto un velo, per dare al re Abgar quel ritratto che egli chiedeva e che il suo pittore non sapeva tracciare.
|
|
|
|
Guercino, San Luca
dipinge Maria |
L’immagine di Gesù sul velo
(XII secolo) |
Di qui il nesso che lega la stilizzazione dell’icona ad un insieme di scelte figurative sancite dalla tradizione. Se il tratto figurativo deve semplificarsi e fissarsi in uno stilema codificato dalla tradizione è perché solo così la raffigurazione può resistere al movimento della storia e può ripetere in forme sempre eguali l’icona originaria da cui deriva, — quell’icona del cui senso non si può dubitare, poiché la sua forma visibile deve apparirci come il frutto di un evento miracoloso, di un gesto attraverso cui si attua una vera e propria epifania del divino. Ciò che l’icona, stilizzandosi, ripete non è dunque soltanto una tradizione figurativa, ma è l’evento originario che la fonda e che insieme permette ad una tavola di legno di essere immagine del divino. Tutte le icone aspirano dunque, e per la loro stessa forma, ad essere acheiropoietai: la mano dell’uomo deve dipingere l’icona obbedendo a una regola il cui primo obiettivo è nascondere nell’impersonalità del passato la persona del pittore.
Le considerazioni che abbiamo raccolto sin qui non sono sufficienti per comprendere il significato della stilizzazione nell’icona, e per rendersene conto basta riflettere ancora un poco sul racconto, così ricco di implicazioni filosofiche, dell’origine delle immagini sacre. Nella favola di Abgar è racchiuso un suggerimento su cui riflettere: se Gesù deve porre sul suo volto il velo per imprimervi il contorno della sua forma sensibile è perché — racconta Evagrio nella sua Storia ecclesiastica (VII secolo) — Hannan, il pittore che cerca di ritrarlo, non riesce a fissare lo sguardo sul suo modello a causa, leggiamo, «della gloria ineffabile del suo volto». Si tratta di una metafora anche troppo nota: l’uomo è una creatura sensibile e non può soffermarsi in una contemplazione diretta di ciò che è divino. Può invece volgere il proprio sguardo su ciò che ne è immagine, sulle tracce sensibili che lasciano tralucere, ma insieme velano, il volto di dio. Le tracce, appunto: ciò che sul velo si imprime è soltanto il contorno di un volto, la sua immagine stilizzata. Nella leggenda che racconta l’origine della prima icona è dunque racchiuso, nelle pieghe di un’allegoria neoplatonica, un precetto pittorico che trae le sue ragioni profonde da una concezione metafisica del sensibile: il volto di Gesù devi dipingerlo così, restituendo soltanto la traccia dei suoi lineamenti, poiché nel visibile si può scorgere soltanto un’eco di quell’invisibile che non possiamo altrimenti afferrare. Anche di qui si deve muovere per comprendere il nesso che lega la stilizzazione al significato dell’icona. L’icona ha un soggetto religioso: è la raffigurazione visibile dell’invisibile. Ma può esserlo solo se rinuncia ad uno stile figurativo di stampo naturalistico: l’icona può assolvere alla sua funzione solo se ciò che in essa si mostra non soddisfa pienamente lo sguardo, ma si pone come la spia di un percorso che deve essere compiuto e che ci conduce al di là di ciò che propriamente si raffigura. Nell’immagine si deve cogliere allora il suo essere segno e traccia, e ciò è possibile soltanto in virtù di un processo di stilizzazione che ostacoli, per così dire, il movimento figurativo che va dal segno al raffigurato e ci costringa a vedere l’uno nell’altro. La tenuità e la stilizzata valenza figurativa dell’icona, che le impediscono ogni pretesa illusionistica e indeboliscono il suo rimando alla realtà raffigurata, si pongono così come una spia della funzione metafisica dell’immagine, che altro non è se non un tramite visibile dell’invisibile.
Su questo punto si deve insistere. Ogni immagine è caratterizzata da un “movimento” che si radica nella sua natura: le immagini sono segni che si animano di un significato, superfici colorate che traspaiono come il residuo di un movimento che ci conduce verso la scena che in esse si raffigura — nella tela vediamo dipinti un volto, una natura morta, un paesaggio. Ora, questo movimento non è mai in senso proprio interamente compiuto, poiché dell’immagine in quanto tale vi è coscienza solo quando vi è ancora la consapevolezza percettiva del sostrato materiale della figurazione. E tuttavia la constatazione della necessaria incompiutezza del processo figurativo si affianca al riconoscimento che il modo in cui il movimento figurativo si compie varia con il variare della forma dell’immagine: vi sono infatti stili figurativi che tendono a fermare quel movimento ben prima che giunga alla meta, altri che invece lo arrestano quando è ormai giunto ad aver consumato nell’apparenza dell’oggetto dipinto quasi ogni traccia che ci parli del suo essere soltanto il frutto della prassi pittorica. Detto altrimenti: vi sono tecniche di disegno che lasciano vedere ben chiari i segni di cui la raffigurazione consta, mentre ve ne sono altre che tendono a nascondere il lavoro del pittore, per lasciar scorgere soltanto ciò che grazie alla sua opera si raffigura. La pittura rinascimentale appartiene sicuramente a questa seconda categoria, mentre dovremmo porre sotto l’egida della prima ogni tecnica figurativa in cui il momento della stilizzazione gioca un ruolo essenziale.
Che questo sia il caso dell’icona l’abbiamo già detto. Ma l’icona non è soltanto una forma d’arte in cui la stilizzazione gioca un ruolo centrale; è anche un’immagine accentuatamente bidimensionale, e non vi è dubbio che tra i momenti che determinano il movimento dell’immagine un ruolo particolare spetti proprio alle tecniche che determinano la profondità dello spazio figurativo. Un disegno è innanzitutto questo: una superficie che si anima di una dimensione nuova, di una profondità che vi è soltanto per lo sguardo che la coglie. Ora quanto più viva è l’illusione della profondità, quanto maggiore è la tendenza dell’immagine a nascondere il significante nel significato: compito della prospettiva — scriveva Lomazzo — è «far sembrare le pareti per niente», trasformando la presenza massiccia del muro o della tela che ospitano il dipinto in una finestra aperta da cui osservare lo spettacolo che la fantasia del pittore ci porge. Sulla natura apertamente non prospettica delle icone la critica d’arte si è spesso soffermata, e si è talvolta sostenuto che le icone non soltanto non obbediscono alla regola della convergenza delle rette che si addentrano nello spazio profondo, ma sono anzi espressione di una concezione della spazialità diametralmente opposta, poiché caratterizzata dal principio generale della divergenza delle ortogonali al piano. Nelle icone la prospettiva rinascimentale non avrebbe cittadinanza, ma al suo posto lo spettatore troverebbe l’obbedienza ad una regola geometrica nuova: la regola della prospettiva rovesciata. Allo spazio prospettico che si restringe nel suo lento incedere verso l’orizzonte farebbe così eco nell’icona un diverso movimento della spazialità, che al suo spingersi verso sempre nuove lontananze affiancherebbe una tendenza diametralmente opposta — la tendenza che risospinge lo spazio raffigurato verso lo spettatore che lo osserva. Sendler la descrive così, nel suo libro altrimenti così utile e chiaro sulle icone:
il principio della prospettiva inversa è semplice. Le linee di questa prospettiva non si incontrano in un punto di fuga situato dietro il quadro, ma in un punto situato davanti ad esso. In realtà non si può parlare di un sistema con un solo punto di fuga situato nello spettatore, perché nelle icone vi è raramente un solo punto di convergenza e sovente ogni oggetto rappresentato ha una sua propria prospettiva. Analogamente non si trova la scala delle altezze che, nella prospettiva lineare, ha per funzione di rappresentare l’estensione dello spazio. Sovente gli oggetti non sono posti in ordine di distanza e di dimensioni, ma sono giustapposti secondo un principio di composizione e secondo il significato di tali oggetti nella scena rappresentata. Pertanto non vi è profondità all’interno della rappresentazione: lo spazio è ridotto, si estende verso lo spettatore. In tal modo le linee di forza sono invertite: vengono avanti dall’interno dell’immagine verso lo spettatore. In tal senso l’icona è il contrario di una pittura del Rinascimento: non è una finestra attraverso la quale lo spirito umano deve penetrare nel mondo rappresentato, ma è un luogo di presenza. In essa il mondo rappresentato irradia verso colui che si apre a riceverlo. Nella prospettiva inversa è attivo lo spazio, non colui che guarda (E. Sendler, L’icona, immagine dell’invisibile, San Paolo, Cinisello Balsamo 1985, p. 120).
Su quest’ipotesi — che sembra essere confusa quel tanto che basta e vaga quel tanto che serve per rendere vano ogni tentativo di comprenderla davvero — non vogliamo qui soffermarci, e vorremmo limitarci ad osservare che ben più che di una spazialità costruita secondo una qualche prospettiva è opportuno parlare, in questo caso, di una spazialità stilizzata che si apre nell’immagine solo quel tanto che basta per ospitare la scena che deve essere raffigurata. Nell’icona uno spazio prospettico — diritto o rovesciato che sia — non vi è poiché lo spazio dell’immagine non si costruisce rispetto ad un punto o ad un luogo esterno ad essa e non tende a porsi in un rapporto di continuità con l’ambiente in cui lo spettatore si muove. Tutt’altro: ciò che caratterizza lo spazio dell’icona è il suo porsi come uno spazio chiuso in se stesso, che non intende in alcun modo assumere una valenza illusionistica e che non soltanto può per questo permettersi la massima libertà compositiva, ma deve anche rinunciare ad ogni tentativo di negare l’alterità dell’immagine, il suo porsi come un oggetto che appare insieme ai limiti dello spazio figurativo che ospita.
Di qui l’importanza che in molti saggi sull’icona si attribuisce alla natura dei materiali di cui l’icona consta. Così nel libro di Sendler ci imbattiamo inaspettatamente in un lungo capitolo che ci racconta come scegliere legni e colle per costruire un’icona poiché, leggiamo, nessun particolare può essere trascurato se si vuole che la cornice ospiti un’immagine visibile dell’invisibile. E allora dobbiamo davvero soffermarci sui pregi della quercia, del platano, della palma e del faggio, sui rischi del cipresso e dell’abete ed anche sulle procedure che rendono il loro legno adatto all’icona, anche se oggi (e lo si deve riconoscere con una punta di amarezza) non si disdegna nemmeno il compensato o il panforte. E ciò che in queste pagine assume la forma di una descrizione attenta a riscoprire nella perizia dell’artigiano e nello scrupoloso rispetto della tradizione la sacralità di un compito, si mostra invece nel suo sfondo teorico nel saggio di Florenskij sulle icone. Qui, messo da parte il fascino per le tecniche antiche che per qualche misteriosa ragione sembrano ammantate di una saggezza che si nega alle tecniche d’oggi, la riflessione sul legno dell’icona prende la forma di una «metafisica della superficie della rappresentazione» (Le porte regali (1922), a cura di E. Zolla, Adelphi, Milano 1993, p. 112). Nelle pagine di Florenskij questo titolo così impegnativo non trova uno svolgimento adeguato. Una tesi tuttavia emerge con relativa chiarezza: l’icona deve essere dipinta su legno perché non deve apparirci come uno spettacolo etereo, come una manifestazione fenomenica che si dispieghi agli occhi della soggettività. Alla legnosità dell’icona che lascia trasparire la durezza del sostrato su cui poggia fa così da contrappunto la diafana inconsistenza della pittura su tela, — quella tela che doveva ospitare la pittura prospettica, poiché la sua elasticità e la sua leggerezza rispondono alle esigenze di un’arte che vuole trasformare il quadro in una finestra aperta sul mondo sensibile (ivi, pp. 113-4).
Sui risvolti metafisici ed etici che Florenskij ritiene di poter scorgere nell’arte rinascimentale non intendiamo qui soffermarci. La ragione che ci spinge verso queste pagine è un’altra: ciò su cui Florenskij richiama la nostra attenzione è infatti il trasparire del sostrato ligneo nell’icona. Sappiamo già quale sia il motivo di questa necessaria trasparenza: solo se l’icona non cede ad una vocazione illusionistica e non compie sino in fondo il movimento che lega il raffigurante al raffigurato può mantenere aperto il cammino che la conduce dal visibile all’invisibile. Proprio come la stilizzazione ci avverte che ciò che nell’icona si raffigura non è che la traccia di una realtà sovrasensibile, così la presenza percettiva del legno che ospita l’immagine sacra impedisce allo sguardo di appagarsi in ciò che si raffigura, per volgerlo oltre l’immagine. L’icona
evoca un archetipo, desta nella coscienza una visione spirituale: per chi ha contemplato nitidamente e coscientemente questa visione, questa nuova secondaria visione per mezzo dell’icona è anch’essa nitida e cosciente (ivi, p. 69).
Ma se l’icona è un raffigurare che non si ferma in ciò che pure raffigura e se può porsi come una visione sensibile che fa da veicolo per una nuova visione di natura spirituale, ciò accade soltanto perché la forma percettiva dell’icona è quella di una raffigurazione che non accetta di rinunciare alla sua valenza di manifestazione incompiuta. L’icona, nota ancora Florenskij,
è sempre o più grande di se stessa, quando è una visione celeste, o è meno di se stessa, se essa non apre a una coscienza il mondo soprannaturale, e non si può chiamare altro che una tavola dipinta (ivi, p. 61)
— un’osservazione che deve essere condivisa, ma che può esserlo solo se si rammenta che la possibilità dell’icona di essere più di un’immagine riposa nella sua dimensione fenomenologica che la espone al rischio di essere soltanto una tavola dipinta. La natura dell’icona è dunque sospesa tra queste due possibilità: può divenire la via che pretende di condurci dal visibile all’invisibile così come può al contrario assumere i panni di una greve materializzazione del soggetto immateriale che in essa si raffigura — una dualità, questa, che doveva giocare un ruolo peculiare nella storia dell’icona.
Possiamo ora per un attimo tirare i remi in barca e se volgiamo lo sguardo al percorso che abbiamo insieme compiuto non è difficile rendersi conto di come, passo dopo passo, l’analisi della forma intuitiva dell’icona sia sfociata in una riflessione di carattere teorico sul suo significato e sulla sua funzione. Che questo fosse l’esito verso cui tendevano le nostre considerazioni l’avevamo già detto: per noi, riflettere sulle icone significava saggiare la natura del rapporto che lega la forma alla funzione dell’immagine ed eravamo quindi sin da principio orientati a percorrere questo cammino. E tuttavia far luce su questo rapporto non significa solo mostrare come il discorso sulla forma di un’immagine tenda a confluire in un’analisi del suo significato e della sua funzione, ma vuol dire anche osservare come da una considerazione puramente fenomenologico-formale non si possa affatto muovere per determinare quali siano le funzioni che una determinata epoca attribuisce alle immagini che produce. La forma, avevamo osservato, è la possibilità della funzione, ma non la determina univocamente, proprio come la forma di un utensile non ci costringe ancora ad usarlo in un unico modo: un cacciavite è fatto per avvitare e svitare le viti, ma posso usarlo anche come uno scalpello o come una leva.
Di qui la necessità di riprendere il discorso da dove l’abbiamo interrotto, muovendo tuttavia da un orizzonte più vasto: l’orizzonte della soggettività storica e della cultura cui appartiene.
2. La dimensione pragmatica dell’alterità dell’icona
Le nostre riflessioni sulla forma fenomenologica dell’icona ci hanno condotto ad una tesi che potremmo formulare così: per la sua stessa forma, l’icona è un’immagine il cui movimento si arresta prima di giungere alla meta e che, proprio per questo, può fungere da veicolo di una nuova dimensione rappresentativa che nel visibile lasci scorgere l’invisibile. L’icona è un’immagine in cui si raffigura la parvenza sensibile dell’invisibile, e se così ci esprimiamo è perché in questa forma paradossale (l’icona come immagine di un’immagine!) traspare l’eco di un problema che doveva assumere un peso crescente negli anni in cui più viva si fece la discussione teorica sull’icona — gli anni che precedono e seguono la vicenda iconoclastica.
Sullo sfondo della crisi iconoclastica vi sono certo una molteplicità di problemi di ordine storico e politico (l’iconoclasmo fu fortemente voluto dal potere imperiale, come uno strumento per ridimensionare l’autonomia ed il potere della chiesa), e tuttavia di questo complesso intreccio di ragioni possiamo qui tacere, per rivolgere la nostra attenzione soltanto alla dimensione pittorica e religiosa dell’icona. Ed un primo fatto balza agli occhi: sorto da una religione che è comunque caratterizzata dal divieto di circoscrivere, raffigurandolo, un dio che è per sua natura nascosto e che non può essere ricondotto neppure per un istante alla misura del visibile (anche sul monte Oreb Mosè può vedere dio solo nel suo essere avvolto in una nube di fuoco e di denso fumo), il cristianesimo dei primi secoli manifesterà un sostanziale rifiuto delle immagini. E non a caso: per la sensibilità religiosa del cristiano delle origini, affinatasi nel contrasto con la dimensione apertamente visibile del culto pagano, le immagini e comunque la commistione tra arte e fede sembravano appartenere ai retaggi di una cultura da cui si voleva prendere apertamente commiato. L’atteggiamento di rifiuto per una sensibilità religiosa ritenuta troppo incline all’idolatria doveva dunque giustificare il sospetto nei confronti delle arti figurative, cui non si riconosceva altro compito se non quello di narrare visivamente le vicende del vangelo; la negazione della funzione cultuale delle arti si affiancava così al riconoscimento di una loro funzione didattica: in un mondo in cui l’analfabetismo era la norma, la religione del libro doveva necessariamente accettare il sussidio dell’immagine.
E tuttavia per questo varco così esiguo, le arti figurative dovevano ritagliarsi uno spazio nella cultura cristiana, e basta volgere lo sguardo al mondo bizantino del VI secolo per rendersi conto che le immagini sacre giocano ormai un ruolo tutt’altro che secondario. E al peso crescente fa eco il bisogno di attribuire all’immagine una funzione nuova:
Lentamente […] l’immagine religiosa bizantina sarebbe divenuta un mezzo per manifestare l’incarnazione non semplicemente come fatto storico passato, ma come presenza viva ed eterna. Il ruolo dell’immagine smise di essere puramente didattico e si pose sulla via per divenire sacramentale come il sacrificio dell’eucarestia nella messa (E. Kitzinger, Il culto delle immagini. L’arte bizantina dal cristianesimo all’origine dell’iconoclastia (1976), La Nuova Italia, Firenze 1992, p. 93).
Nasce così l’icona e, insieme ad essa, il bisogno di giustificare un’arte che non vuol più avere una funzione soltanto didattica. L’icona non si accontenta di commuovere lo spettatore, non vuole porre di fronte ai suoi occhi quei tormenti e quelle passioni religiose che la pagina scritta non può rendere con eguale immediatezza. La sua funzione è un’altra: l’icona ha una funzione quasi sacramentale e vuole essere il tramite sensibile del divino. Giustificare l’icona voleva dire allora comprendere che cosa le permettesse di essere l’immagine visibile dell’invisibile.
Per la religione cristiana questo cammino è in parte già aperto: l’ebraismo non può raffigurare dio, poiché il padre cela ancora la sua sembianza ma, scrive Giovanni Damasceno, il cristiano crede in una religione in cui dio si è fatto uomo ed è divenuto visibile. Ciò che per l’antico testamento è peccato può cessare di esserlo per la religione del vangelo:
in realtà, se noi facessimo immagini del Dio invisibile, noi veramente cadremmo in peccato, poiché non è possibile che venga raffigurato ciò che non ha corpo, non ha figura, non può essere visto e non può essere circoscritto. Ed ancora: se noi costruissimo immagini di uomini e poi le considerassimo dei e ad esse prestassimo culto come a dei, allora veramente noi commetteremmo empietà. Però noi non facciamo nulla di tutto questo. Infatti se Dio si è incarnato e per la carne è stato visto sulla terra, e se a causa della sua indicibile bontà egli ha conversato con gli uomini e ha preso la natura, la consistenza e il colore della carne, allora noi non sbagliamo nel fare la sua immagine. Noi desideriamo di vedere la sua figura, come dice l’Apostolo divinamente ispirato: Noi ora lo vediamo come in uno specchio e in un enigma. E l’immagine è uno specchio ed un enigma che sono consonanti con la grossezza del nostro corpo: infatti la nostra mente, pur sforzandosi molto, non può uscire dalle cose corporee (Giovanni Damasceno, Difesa delle immagini sacre, Città nuova editrice, Roma 1997, p. 95).
In queste considerazioni sono racchiuse molte cose. È racchiusa la tesi secondo la quale il cristianesimo, che è la religione di un dio che si è fatto vicino agli uomini, non deve seguire l’ebraismo nella sua condanna delle immagini. Ma è racchiusa anche una vera e propria filosofia dell’immagine che ha un suo indubbio sapore neoplatonico: se il Figlio si è fatto uomo è perché vi era bisogno di un’icona divina, di una sua manifestazione che rendesse comprensibile il cammino che dall’unità indivisa del senso conduce sino al mondo e alle sue intricate vicende. Ma ciò è quanto dire che Gesù è la prima vera icona del Padre (ivi, pp. 38, 126), e nel processo di emanazione che dall’Uno invisibile ci conduce ai molti visibili la catena dell’essere può rinsaldarsi solo perché ogni anello è a sua volta immagine di ciò che lo precede e lo supera.
Ma se il divino deve accettare di ripetere in varie fogge la sua eco sensibile ciò accade perché noi uomini — lo sosteneva Dionigi l’Areopagita — «non possiamo contemplare le cose incorporee senza forme a noi proporzionate» (ivi, p. 128). E ciò è quanto dire che immagine e sensibilità debbono essere strette in un unico nodo e che debbono essere colte sullo sfondo di un’interpretazione trascendente che da un lato le carica di una funzione anagogica, dall’altro le priva in linea di principio di ogni autonomia, trasformandole in un’instabile cifra dell’invisibile. La sensibilità diviene così immagine e l’immagine la forma sensibile di qualcosa che è per sua essenza nascosto ai sensi:
Ogni immagine è rivelatrice e dimostratrice di ciò che è nascosto. Io dico qualcosa come questo: poiché l’anima è rivestita dal corpo, l’uomo non ha una conoscenza pura dell’invisibile; e poiché egli è limitato dallo spazio e dal tempo […] l’immagine fu escogitata a guida della conoscenza, per manifestazione e divulgazione delle cose nascoste (ivi, p. 125).
Di qui la ragione che legittima l’icona. Nel suo dipingere l’immagine sacra, il pittore ripete la vicenda metafisica del senso, il suo lento dipanarsi per immagini che ha origine dall’immagine prima di dio: da Gesù, il dio uomo. Così, nota Kitzinger,
proprio come, in virtù dell’ordine gerarchico dell’universo, vi è un momento ascensionale dalla sfera inferiore e sensibile verso quella superiore e intelligibile e da ultimo verso Dio, così, a sua volta, Dio si riflette secondo la legge dell’armonia universale e in graduale andamento discendente negli ordini inferiori e da ultimo anche negli oggetti materiali che rappresentano il nostro ambiente fisico. È proprio in virtù della loro capacità di configurarsi come immagini riflesse che tali oggetti possono essere definiti come eikones (Kitzinger, op. cit., p. 88).
Ma se la nozione di immagine ci appare sullo sfondo di una metafisica che interpreta il sensibile come icona, diviene comprensibile la ragione per la quale le leggende che narrano la genesi miracolosa delle immagini dal loro modello acquistano un significato più ricco e non ci appaiono più soltanto come segni della credulità popolare. La credenza ingenua e superstiziosa nelle immagini acheiropoietai può infatti nutrirsi del cibo etereo della metafisica neoplatonica: nei racconti che narrano l’improvviso disegnarsi del volto di Gesù o di Maria sui muri delle chiese o sul velo di Abgar traspare infatti in forma drammatica l’idea metafisica dell’immagine come emanazione dell’Uno e la funzione religiosa dell’icona come espressione di un’incarnazione perpetua, come forma che riproduce — seppure ad un livello più basso — il farsi visibile del Verbo.
A partire di qui, le nostre considerazioni secondo le quali l’icona è l’immagine di un’immagine non possono più stupirci: il nuovo significato che le icone assumono nel mondo bizantino a partire dal VI secolo si può comprendere solo se non lo si disgiunge dallo sforzo teorico di giustificare l’immagine sacra alla luce di una metafisica di stampo neoplatonico. Nei suoi apologeti, l’icona non trova infatti solo una voce pronta a tacitare le accuse di idolatria, ma anche una chiara delineazione dei compiti e della funzione delle immagini sacre. Come scrive, ancora una volta, Kitzinger:
Per la prima volta, l’artista cristiano ottiene dall’apologeta la dispensa dalla necessità di giustificare la propria opera, educando e ammaestrando lo spettatore, ovvero chiamando in causa direttamente le sue emozioni. L’immagine non deve narrare un evento o trasmettere un messaggio, né l’artista deve avere come obiettivo primario quello di suscitare nello spettatore un particolare stato d’animo, come timore o reverenza, devozione o compassione. L’artista, anzi, è incaricato del compito di creare un’immagine atemporale e distaccata, in contatto con il cielo piuttosto che con l’umanità, un’immagine in grado di rispecchiare come attraverso un riflesso diretto il suo divino e santo archetipo e, inoltre, di servire come veicolo di forze divine, come ricettacolo della divina sostanza. (ivi, p. 104).
Ma se la funzione dell’icona è racchiusa nel suo porsi come immagine visibile dell’invisibile, come manifestazione sensibile che deve condurre verso una meta trascendente, qual è l’atteggiamento che lo spettatore deve assumere di fronte all’immagine? Per potersi realizzare, la funzione anagogica dell’icona deve fare affidamento su un peculiare atteggiamento ricettivo dello spettatore: dalla funzione dell’immagine dobbiamo muovere così verso la sua pragmatica.
Nella riflessione sulle icone il problema di una definizione dell’atteggiamento dello spettatore gioca un ruolo tutt’altro che secondario. E non a caso: l’icona è una forma d’arte sacra che pretende di svolgere una funzione nel culto e ciò significa che lo spettatore deve sapersi rapportare ad essa con un atteggiamento ben definito. Non dobbiamo stupirci allora se la definizione del rapporto tra il fedele e l’immagine sacra è di fatto una delle prime preoccupazioni che animano il Concilio che chiude una delle stagioni più drammatica della storia dell’immagine nel mondo europeo: il secondo Concilio di Nicea (787). Convocato negli anni che seguono la prima grande crisi iconoclastica (730-785) per confutare le tesi del Sinodo di Hieria (754) e per definire dogmaticamente i canoni di una pragmatica dell’immagine, il secondo Concilio niceno si prefigge innanzitutto il compito di distinguere l’atteggiamento idolatrico dalla giusta venerazione delle immagini sacre.
Per tracciare il sottile discrimine che separa questi due atteggiamenti di ricezione dell’icona è necessaria almeno una cosa: che vi sia una piena consapevolezza dello scarto che sussiste tra l’immagine e il suo modello. Non è un caso allora se le pagine degli atti del Concilio ospitano ripetutamente osservazioni di questo tenore:
Altro è l’icona, altro il suo modello, e nessun uomo assennato cerca in alcun modo nell’icona le proprietà del modello. Nell’icona, infatti, il ragionamento corretto non riconosce altro se non il fatto che essa ha in comune con ciò di cui è l’icona il nome e non la sostanza (Vedere l’invisibile, Nicea e lo statuto dell’immagine, a cura di L. Russo, Aesthetica, Palermo 1997, p. 85)
E ancora:
i Cristiani hanno ricevuto il precetto di dipingere l’icona di Gesù secondo la natura secondo cui si rese visibile, non secondo quella per cui era invisibile: quest’ultima infatti non era circoscrivibile, giacché Dio “non l’ha mai visto nessuno”, come abbiamo sentito dal Vangelo. Dal momento che Cristo viene dipinto nella sua natura umana, è ovvio che, come la realtà ha mostrato, i Cristiani professano che l’icona visibile ha in comune con l’archetipo solo il nome e non l’essenza (ivi, p. 82).
Di fronte a queste affermazioni si può rimanere un poco perplessi: che bisogno c’è — ci chiediamo — di osservare che un’immagine non può afferrare nella sua interezza l’essenza di una persona ma solo il suo aspetto sensibile? Non è forse ovvio che in un ritratto ciò che può essere dipinto è l’aspetto di una persona così come si manifesta sensibilmente e non già quei pensieri che non traspaiano nei tratti del suo viso? E tuttavia è sufficiente riflettere un poco per comprendere che di quest’ovvietà si deve parlare per mettersi al riparo dalle accuse di idolatria che avevano sorretto e motivato la crisi iconoclastica. Così, nel sottolineare che l’icona rappresenta solo l’aspetto sensibile di ciò che raffigura, i teorici di Nicea intendevano liberare le immagini sacre dal viluppo delle questioni concernenti la duplice natura del Cristo: chi dipinge un’icona di Gesù non si macchia inconsapevolmente delle colpe di Ario (come aveva sostenuto invece il Sinodo di Hieria) poiché non pretende di ridurre la duplice natura del Figlio alla sua dimensione soltanto sensibile, ma si limita a raffigurare ciò che può essere raffigurato — l’aspetto sensibile del figlio di dio. Così si legge nelle pagine del Concilio:
Noi sappiamo che Cristo è di due nature, e di due nature in modo indivisibile, la divina cioè e l’umana; e dunque una incircoscritta ed una circoscritta si vedono in un unico Cristo. E l’icona è simile al prototipo non nella sostanza ma soltanto nel nome e nella disposizione delle membra che vengono dipinte. Infatti, neanche qualcuno che dipinge l’icona di un uomo cerca poi nell’icona un animo, sebbene sia incomparabile la differenza tra l’anima umana e la divina natura […] E nessuno mai che sia dotato di senno al vedere l’icona di un uomo ha pensato che, attraverso l’arte del pittore, l’uomo è separato dalla sua anima (ivi, p. 77).
E tuttavia quanto più i teorici di Nicea riconducono la raffigurazione alla sua dimensione sensibile e, per così dire, “raffreddano” il rapporto che lega l’icona al sovrasensibile di cui è mediatamente espressione, tanto più si fa avanti l’esigenza di rinsaldare quel nesso alla luce di una filosofia di stampo neoplatonico. Certo, un’icona raffigura Gesù solo perché i colori e le forme ne ricordano il corpo sensibile, che fa così da tramite tra l’immagine e il modello colto nella sua interezza. Ma quando poi si tratta di formulare quale sia il rapporto tra il corpo di Gesù e la sua natura divina il linguaggio neoplatonico delle immagini si apre un nuovo varco e nel sensibile deve poter trasparire l’invisibile da cui ha origine:
il nome di Cristo indica due nature, una visibile, l’altra invisibile; così lo stesso Cristo, visibile agli uomini attraverso il velo, cioè attraverso la sua carne, rese manifesta la natura divina — anche se questa rimaneva nascosta — attraverso segni (ivi, p. 131).
Nell’immagine sensibile alberga dunque un significato spirituale, proprio come nel corpo del Cristo si manifesta, seppure per segni e come dietro a un velo, la divinità. E se persino la duplice natura di Cristo può apparirci sullo sfondo di una concezione che nel visibile coglie la cifra dell’invisibile, diviene allora comprensibile come sia possibile ritorcere contro chi le aveva pronunciate le accuse di eresia e si possa davvero sostenere che in realtà chi disprezza le immagini sacre è incapace di pensare davvero la duplice natura del Cristo e in fondo crede che il suo essersi fatto uomo sia solo un’apparenza (ivi, pp. 53, 107).
In questo desiderio di condannare le teorie iconoclastiche con gli stessi argomenti che esse avevano fatto valere contro le icone non vi è tuttavia soltanto quella sottile perfidia che così spesso accompagna le dispute sui più alti problemi: vi è anche la volontà di difendere una concezione più positiva della sensibilità e delle sue molteplici forme. «Coloro che non accolsero le icone furono non battezzati» (ivi, 53) — scrive Tarasio, e in queste parole non si deve cogliere soltanto la tesi in sé ovvia secondo la quale la religione ebraica non accetta le immagini, ma si deve scorgere anche il segno di una convinzione più impegnativa: per Tarasio, riconoscere la validità dell’icona fa tutt’uno con la possibilità di sanare la frattura sancita dal peccato originale — quella scissione tra senso e sensibilità che coincide con il peccato di Adamo e che comporta la distinzione tra la sensatezza e il mondo della sensibilità. Lungi dall’accettare una teoria dell’immagine che distingue con troppa nettezza il senso dal sensibile, l’iconologia niceana tende a vincolare l’immagine alla santificazione del corpo e del sensibile cui alludono l’incarnazione del Cristo e il sacramento dl battesimo.
Di qui, da queste considerazioni di carattere generale, si può comprendere quale sia l’atteggiamento che il Concilio di Nicea ritiene si debba assumere di fronte alle immagini. Ciò che in primo luogo deve essere implicitamente negata è la liceità di un atteggiamento puramente contemplativo. Le icone raffigurano soggetti religiosi e spesso ci costringono a riflettere sulla sofferenza e la morte: di fronte a simili immagini non si può non commuoversi, e così da un argomentare che si tesse di citazioni e di racconti apprendiamo che di fronte all’immagine che raffigura la preparazione del sacrificio di Isacco bisogna piangere, proprio come fece Gregorio di Nissa (ivi, p. 33) e che non possiamo trattenerci dal venerare e baciare l’immagine di Maria che tiene in braccio Gesù (ivi, p. 143). E tuttavia non è soltanto alla dimensione emotiva dello spettatore che occorre rivolgere l’attenzione: nel suo tentativo di delineare una precettistica cui vincolare l’atteggiamento dello spettatore, il Concilio di Nicea si è innanzitutto preoccupato di tracciare un chiaro discrimine tra l’adorazione dell’immagine, che è comportamento idolatrico e quindi censurabile, e la venerazione dell’icona che è invece un atto dovuto. Così riconoscere che l’icona è un oggetto di culto significa porre fin da principio norme e divieti: di fonte all’icona non puoi adorarla, ma devi venerarla — la alethiné latreía deve cedere il passo alla thimetiké proskynesis. Ma in che cosa può mai consistere questa differenza che, vale la pena di ricordarlo, fu tracciata in modo cruento negli anni nel duplice scontro tra iconofili e iconoclasti?
Rispondere significa rammentare la struttura dell’immagine, per cercare poi di rendere esplicito ciò che gli atti del Concilio lasciano implicito. Osserveremo allora che l’atto dell’adorare non tollera mediazioni: si può adorare dio, non ciò che ha creato, anche se nella creazione traspare la sapienza del creatore. L’adorazione conosce soltanto un complemento oggetto assoluto: si adora qualcosa soltanto in virtù di ciò che essa è in sé e per sé. Ma ciò è quanto dire: non è in linea di principio possibile adorare un’icona in quanto tale poiché l’icona è per sua natura una cifra dell’invisibile. Si può invece, peccando, adorare il legno e i colori di cui l’icona consiste. Diversamente stanno le cose nel caso della thimetiké proskynesis: la venerazione ci appare infatti come un comportamento che si rivolge ad un oggetto solo in virtù del suo rimandare ad altro. Si venera dunque solo ciò che per la sua stessa natura implica una struttura relazionale. E ciò è quanto dire: si può venerare un’icona proprio perché è un’immagine, perché per sua natura sa condurci di là da se stessa, verso ciò che in essa si raffigura. La venerazione — diceva San Basilio — passa dall’icona al suo modello, ed in questa tesi che ricompare più volte come una verità inoppugnabile negli atti del Concilio è racchiuso il tentativo di Nicea di ricondurre ad una regola la pragmatica dell’immagine sacra. Di fronte all’icona devi atteggiarti così: devi guardarle come si guarda un segno che rimanda ad altro, poiché solo se non dimentichi che l’icona è il segno visibile di un invisibile puoi tracciare il discrimine che separa la dovuta venerazione dell’immagine da un atteggiamento di stampo idolatrico. E ciò è quanto dire che lo spettatore non deve limitarsi a guardare lo spettacolo che nell’icona si raffigura, ma deve saper riconoscere in ciò che si mostra il segno o l’eco di una verità trascendente:
L’icona — scrive Florenskij — evoca un archetipo, cioè desta nella coscienza una visione spirituale: per chi ha contemplato nitidamente e coscientemente questa visione, questa nuova secondaria visione per mezzo dell’icona è anch’essa nitida e cosciente (Le porte regali, op. cit., p. 69).
L’icona ci presenta un volto visibile affinché «la nostra mente sia rapita verso l’invisibile divinità» (Vedere l’invisibile, op. cit., p. 18): lo sguardo rivolto all’icona è allora espressione di un movimento che non si appaga nell’immagine, ma che deve andare di là da essa, rinunciando così alla natura sensibile.
Nelle Enneadi, Plotino dedica una breve riflessione alla figura dello spettatore di un quadro, e lo fa — come di consueto nelle sue pagine — commentando con la sapienza del filosofo un racconto che appartiene alla storia della cultura e che gli appare ormai come un mito su cui riflettere: il mito di Narciso. Di questa bella favola, e per lo stesso motivo, ci parla anche Leon Battista Alberti; nella favola di Ovidio gli pare infatti di poter scorgere la definizione dello spettatore ideale di un quadro: quello spettatore è proprio Narciso, «l’inventore della pittura» (Alberti) che, anche quando è divenuto consapevole dell’inganno che si spalanca di fronte ai suoi occhi, non rinuncia per questo a penetrare nell’immagine e a disporsi sul terreno di una finzione consapevole. Per Alberti, il compito dello spettatore è, in un certo senso, tutto qui: deve, come Narciso, rinunciare a distogliere lo sguardo dall’immagine, e deve così dar vita ad una consapevole illusione che stringa in un nodo dialetticamente complesso il mondo della vita e il mondo della pittura, lo spazio reale dello spettatore e lo spazio, apparente, della scena raffigurata. Ma in Plotino la favola è mutata di segno. Ciò che il mito descrive è ancora una volta un paradigma dello spettatore, ma si tratta ora di uno spettatore che ha smarrito la via e che non sa più rispondere al quadro obbedendo alle regole che esso prescrive. Nella storia di Narciso si deve leggere ora l’errore di uno spettatore distratto che si lascia catturare dalla dimensione sensibile dell’immagine e, proprio per questo, smarrisce il senso di ciò che vede. Narciso è preda della bellezza, ma la bellezza è soltanto nel movimento che dal sensibile ci conduce al di là del sensibile: il destino di Narciso, il suo ostinato insistere sulla dimensione del sensibile, deve apparirci così come il frutto di una colpa, di un atteggiamento falso rispetto all’immagine.
E tuttavia, riflettere sull’atteggiamento che lo spettatore deve assumere significa richiamare nuovamente l’attenzione sulla forma dell’immagine, sulla sua configurazione spaziale. Se davvero Narciso deve distogliere lo sguardo dal sensibile, anche l’immagine deve rivelarne l’insufficienza: lungi dal porsi come uno specchio levigato che sappia restituire nella forma di una compiuta e persuasiva finzione lo spettacolo del mondo, l’icona è un’immagine che da un lato rifiuta ogni valenza illusoria nel segnare apertamente il discrimine che separa lo spazio reale dallo spazio figurativo e che, dall’altro, nella manifesta stilizzazione delle sue forme sembra denunciare la radicale insufficienza della sensibilità rispetto al tema di cui vuole pure essere manifestazione. Così, se dovessimo esprimere in una sintesi estrema la differenza tra l’immagine rinascimentale e l’icona — quella differenza che per ciò che concerne lo spettatore ci si è mostrata nella diversa lettura del mito di Narciso — potremmo forse soffermarci sul ruolo che il velo gioca nell’aneddotica bizantina e nei teorici rinascimentali. Per Alberti il velo è innanzitutto metafora di una trasparenza: sul velo sottile che il pittore frappone tra sé e le cose traspaiono le forme belle del mondo che possono essere così fissate con un rigore che ha nel fenomeno ottico della proiezione il suo ultimo garante. Ma se sul velo di Alberti si staglia un’immagine che non è fatta dalla mano dell’uomo ma dalla geometria esatta della luce, sul velo di Abgar l’immagine acheropita del volto di Gesù si imprime come una traccia che è di fatto la velata espressione di una realtà trascendente. Al velo come metafora della trasparenza corrisponde così il velo come ricettacolo su cui si imprime il segno visibile dell’invisibile.
Possiamo ora finalmente concludere, concedendoci alcune brevi
considerazioni di riepilogo. Il nostro cammino intorno alle icone ha preso
innanzitutto le mosse da una riflessione sulla forma intuitiva
dell’icona: volevamo mostrare infatti come l’icona avesse una forma che non è
affatto casuale rispetto al significato religioso e culturale di cui è
espressione. Così, da un’analisi volta a far luce sulla forma intuitiva
dell’icona ci siamo lentamente indirizzati verso una riflessione sulla sua
funzione: in effetti, comprendere il significato di un’opera d’arte figurativa
significa sempre anche intenderla alla luce dell’orizzonte storico cui essa
appartiene, poiché solo così è possibile cogliere quali siano le domande
che lo spettatore si pone e quali le risposte (siano esse di ordine
estetico, culturale, religioso, sociale o politico) che egli cerca nell’immagine.
Ma anche dalla riflessione sulla funzione delle icone siamo stati risospinti
verso una nuova meta e abbiamo dovuto soffermarci seppur brevemente su sul
terreno di una pragmatica dell’immagine: ci siamo così improvvisamente
trovati immersi negli atti di una disputa antica che è insieme anche
espressione del tentativo di definire in forma dogmatica quale sia il giusto
atteggiamento che lo spettatore deve assumere di fronte all’icona. Di questa
breve digressione che ci ha costretto a camminare su un terreno che non è il
nostro — il terreno intricato delle riflessioni teologiche sulla natura di Cristo
— vi era bisogno: rileggere gli atti del Concilio di Nicea vuol dire anche
mostrare come il significato delle immagini non sia tutto racchiuso nelle immagini
stesse, ma ci costringa ad abbandonarle, sia pure soltanto momentaneamente,
per cogliere quella rete di rimandi che sola sa farle parlare. Per esprimerci
nella forma di una massima generale: nessuna immagine ha il significato che
ha se non all’interno del gioco linguistico che prescrive le regole del suo concreto
utilizzo.
E tuttavia a questa tesi, la tesi ermeneutica, si deve affiancare una massima di natura fenomenologica che potremmo formulare così: nessuna interpretazione di un’immagine può dirsi legittima se non ha fondamento in un’intuizione concreta e se non può assumere la forma di un processo di articolazione della dimensione intuitiva dell’immagine. Ne segue che riflettere sulla pragmatica e sulla funzione d’uso dell’immagine non significa soltanto andare al di là dell’immagine, ma vuole dire anche mostrare come l’atteggiamento che lo spettatore assume rispetto all’immagine e i compiti che le attribuisce siano resi concretamente possibili dalla forma fenomenologica che la caratterizza.
Lezione sedicesima
1. La transitività dell’immagine come relazione iconica
Nelle precedenti lezioni abbiamo cercato di far luce sulla possibilità dell’immagine di farsi coinvolgente e abbiamo insieme mostrato quali fossero le forme e i significati che le raffigurazioni possono assumere a seconda della relazione che stringono con lo spazio dello spettatore. Su questo tema non vorrei ritornare, se non per tacitare un possibile equivoco: le raffigurazioni, tutte le raffigurazioni, hanno uno spazio di risonanza e vi è sempre una relazione tra lo spazio figurativo e lo spazio dello spettatore. Ne segue che parlare di una raffigurazione coinvolgente o di una raffigurazione che ci tiene a distanza non significa affermare o negare l’esserci di uno spazio di risonanza dell’immagine, ma solo descrivere la forma che di volta in volta lo caratterizza. Su questo punto è importante non lasciarsi fuorviare perché se lo spazio di risonanza si fa più avvertibile e vivo in determinate immagini, ciò non significa che esso coincida con il fenomeno del coinvolgimento di cui è invece la condizione di possibilità: un’immagine può essere coinvolgente o escludente solo perché nella grammatica che la caratterizza è comunque già implicita una relazione spaziale con lo spettatore.
Uno stesso ordine di considerazioni deve essere fatto valere ora che ci accingiamo a discutere della natura transitiva o intransitiva dell’immagine, del suo rimandare o non rimandare allo spettatore come ad un momento che è implicato dal significato dell’immagine, dalla sua dimensione semantica.
Vi è, come sappiamo, un senso in cui ogni raffigurazione potrebbe essere detta transitiva: ogni immagine dipende infatti nel suo stesso esserci dalla presenza di uno spettatore e ciò è quanto dire che rimanda di là da essa e allude ad una soggettività che la colga. Questa dipendenza di carattere ontologico non deve tuttavia essere confusa con la dipendenza di cui intendiamo parlare anche se ne costituisce l’ovvio presupposto. Ogni immagine rimanda ad uno spettatore che in quanto tale la pone, ma proprio per questo è importante domandarsi se la sua presenza è o non è implicata dal contenuto dell’immagine e quindi da ciò che nello spazio figurativo prende forma. Dobbiamo in altri termini chiederci se la relazione tra lo spettatore e l’immagine sia soltanto implicata dalla sua struttura ontologica o appartenga invece alla sua struttura di senso, per tentare poi di precisare, in quest’ultimo caso, quale sia la forma che questa relazione concretamente assume. Ora venire a capo di questi interrogativi significa chiamare in causa ancora una volta lo spazio di risonanza dell’immagine: la relazione spaziale che lega lo spazio figurativo al luogo dello spettatore può infatti sorreggere una rete di rapporti intersoggettivi più o meno complessi, ed è per questo che una riflessione sulla spazialità delle immagini deve necessariamente tenere conto della situazione dialogica che talvolta appartiene alle immagini.
Su questo punto è tuttavia necessario soffermarsi un poco e questo significa innanzitutto chiarire quel “talvolta” di cui ci siamo appena avvalsi. Che vi siano immagini che nel loro contenuto non implicano alcuna transitività e che siano quindi del tutto autosufficienti dal punto di vista contenutistico è difficile negarlo. Pensiamo per esempio ad un paesaggio di Constable o ad uno dei tanti dipinti di fiori di Jan Brueghel: qui non sembra esservi nulla che ci costringa ad andare al di là dello spettacolo che si mostra ai nostri occhi e lo spettatore non è interpellato dal quadro, che propone una veduta senza per questo imporla o chiederci di guardarla. Nel dipinto si vede qualcosa — una scena di genere, un paesaggio, un canestro di fiori — ma non vi è una voce che dall’interno del quadro si levi e ci chieda di osservare la scena o che si rivolga a noi in un qualche senso del termine: lo spettatore non è interpellato da ciò che nel quadro è dipinto e quindi non vi è nulla che lo costringa a sentirsi come se fosse il «tu» di un «io» che dal quadro gli parla.
Questo non significa, naturalmente, che lo spettatore del quadro sia passivo, che non debba far nulla di fronte all’immagine e che non possa assumersi l’onere di dar vita alla scena, attribuendole una presenza fantastica. Di fronte ad un paesaggio di Constable potrei forse sentirmi pervaso da quel sentimento di serena malinconia che si prova di fronte allo spettacolo di una natura silenziosa e composta, e se poi mi chiedessi da dove sorge il senso vivo di questa presenza dovrei evidentemente rammentarmi del fatto che lo sguardo che ha per meta un quadro può spesso legarsi all’immaginazione e al gioco cui essa sottopone ciò che le si porge. E tuttavia lo sguardo che coglie l’immagine di quelle campagne e di quei prati non è coinvolto in un dialogo: il vedere è appunto un impersonale «si vede» che si limita ad accertare uno spettacolo o a fantasticarvi. Potremmo forse esprimerci così: vi sono quadri che consegnano allo spettatore un mondo visibile, senza tuttavia rivolgerglisi in un qualche modo. Così, se dovessimo descrivere ciò che il quadro mostra, potremmo enunciare una sorta di proposizione esistenziale che asserisce che di fronte a noi vi sono (seppure solo in effige) prati, colline, corsi d’acqua e bestie al pascolo e che questo spettacolo è reso accessibile per lo spettatore, anche se nulla di ciò che ci si mostra si rivolge a noi, in un dialogo.
Non tutti i quadri, tuttavia, sono fatti così. Non sempre un quadro si pone come meta di un vedere che si limita a raccogliere impersonalmente ciò che è raffigurato e non è certo vero che si possa sempre descrivere ciò che un dipinto ci mostra semplicemente enunciando una proposizione che dice che vi sono queste e queste cose, seppure soltanto dipinte. Tutt’altro: talvolta le immagini si rapportano esplicitamente allo spettatore, poiché al loro interno qualcuno rivolge un gesto o uno sguardo in direzione di chi le osserva. Basta che questo accada, perché molte cose mutino. Muta in primo luogo lo spazio di risonanza perché ora le relazioni spaziali che univano lo spettatore allo spazio figurativo assumono una valenza dialogica: la raffigurazione non si limita a chiedermi di osservarla da un luogo più o meno definito, ma lo indica assegnandomi insieme a un posto nello spazio un ruolo dialogico — se sono di fronte all’immagine è anche perché qualcuno nell’immagine mi si rivolge e mi chiede di dispormi sotto la categoria pragmatica del «tu».
In un saggio del 1828 Wilhelm von Humboldt aveva sostenuto che i pronomi personali derivano dagli avverbi di luogo, ed anche se questa tesi non regge al confronto con i fatti è tuttavia indicativa di una relazione importante che non poteva sfuggire ad un filosofo intento a ritrovare nel linguaggio la vicenda trascendentale della costituzione del mondo: lo spazio è una trama di relazioni e il suo organizzarsi rispetto al luogo in cui sono — al mio «qui» — non rende meno avvertibile il fatto che, proprio in quanto sono il «tu» di qualcuno, sono anche sempre la meta di una deissi che ha origine in un diverso «qui» — nel luogo occupato da chi mi parla e mi si rivolge, nelle forme e nei modi che sono determinati dalla sua collocazione spaziale. Di questo fatto il nostro linguaggio reca tracce evidenti. Nello spazio ci orientiamo attraverso una famiglia di parole che hanno lo spessore di una relazione dialogica. Qui dove io sono, là dove tu sei, questo che mi è vicino, codesto che ti è vicino, quello che ci è lontano, e alla famiglia dei pronomi e degli avverbi si può senz’altro affiancare la classe dei verbi che pure orientano il senso delle azioni di cui ci parlano sulla mappa delle relazioni dialogiche: si viene verso il qui che ti appartiene e si va verso un là che non è nostro, — ed è evidente che se una differenza vi è, questa non concerne il modo dell’azione ma l’orientamento nel contesto della situazione dialogica.
Questo ordine di considerazioni vale anche per lo spazio di risonanza dell’immagine che, proprio in quanto può assumere una valenza dialogica, può plasmarsi secondo una rete di rapporti che costringono lo spettatore a misurare il suo essere qui con il luogo di un altro — in questo caso, con il luogo fittizio che è occupato dal gesto di chi dallo spazio figurativo gli si rivolge. Così, il mosaico del Cristo pantocratore che dall’alto della cupola di Santa Prassede a Roma si rivolge verso il basso, guardando e benedicendo con la mano sollevata il fedele che transita laggiù, in basso, nella navata non può non costringerci a ridefinire il nostro luogo di spettatori: ora non siamo più semplicemente e soltanto in quel punto dello spazio in cui la scena dipinta si rende accessibile, ma siamo anche nel luogo che si definisce come la meta di un gesto comunicativo: per quanto sia strano a dirsi, il gesto e lo sguardo che dalla cupola il Cristo pantocratore rivolge verso lo spettatore ci consentono di sentirci non soltanto qui, ma anche — e insieme — quaggiù e di pensarci non soltanto come un io che vede un’immagine e che è ad essa percettivamente presente, ma anche come un tu cui si chiede di accogliere ciò che la raffigurazione promette.
L’orientarsi della scena dipinta verso lo spettatore e il suo interpellarlo, chiedendogli di reagire alla visione che si apre davanti ai suoi occhi non ha tuttavia soltanto un’eco spaziale, ma ci invita anche a disporre l’immagine in un contesto performativo che ci costringe a descrivere la scena dipinta non solo dicendo che cosa in essa si vede ma anche quale sia la dimensione pragmatica in cui quel vedere si inscrive e quale la prassi comunicativa che di qui ha origine. Così, per ripetere il nostro esempio, il mosaico del Cristo pantocratore non può essere descritto semplicemente dicendo che vi si vede l’immagine di Gesù benedicente: dobbiamo anche dire che Gesù benedice noi e che l’immagine ci si rivolge, che ci interpella e che ci invita a sentirci benevolmente protetti dal suo sguardo.
Non vi è dubbio che, a partire di qui, si colga con relativa chiarezza come la transitività dell’immagine si dia ad uno sguardo che non rinuncia alla dimensione immaginativa. Per poterci sentire osservati, protetti e giudicati da una raffigurazione non basta uno sguardo attento: è necessario assumere verso le immagini un atteggiamento ludico che attribuisca loro una viva presenza. Ora, un simile atteggiamento è sorretto dalla forma e dai contenuti della percezione, ma chiama anche in causa anche la capacità di illudersi e di stare al gioco. Così uno sguardo che cade dall’alto può valere per tutti come uno sguardo che ci scruta perché dall’alto si vedono davvero molte cose e perché tutti abbiamo un tempo visto un poco più in alto di noi le persone che di noi si prendevano cura. Ma per riuscire a sentirsi osservati e giudicati dal mosaico di un Cristo pantocratore non basta avere avuto un’infanzia; è necessaria anche l’immaginazione religiosa ed è per questo che è interessante leggere un documento che John Shearman riporta in un suo bellissimo libro intitolato Arte e spettatore nel Rinascimento italiano (1992). Si tratta di un testo che Nikolaos Mesarites scrive subito prima dell’occupazione latina di Costantinopoli nel 1204. Il tema è il Cristo pantocratore della cupola dei Santi Apostoli che doveva apparire così agli occhi di uno spettatore lontano da noi ormai otto secoli:
«La cupola mostra l’immagine dipinta di Cristo Dio Uomo, che si sporge e guarda fuori come dal bordo del cielo, nel punto del bordo da cui comincia la curva della cupola, guardando in basso verso il pavimento della chiesa e verso tutto ciò che sta in essa […] Quindi si può vederLo, per usare le parole del Cantico, guardare dalla finestra, , sporgersi fino all’ombelico dalla grata in cima alla cupola come un amante fervente e veemente. Il Suo sguardo è garbato e pieno di dolcezza, non si posa mai né a sinistra né a destra, ma è volto verso tutto quanto in una volta e al tempo stesso verso ciascuna singola persona». Questo testo — osserva Shearman — conferma la lettura del disco del Pantocratore come immagine del cielo vero entro la cupola e ci induce a leggere il Cristo dipinto non come un’astrazione distante e statica, ma come un’epifania, una presenza numinosa che appare allo spettatore (J. Shearman, Arte e spettatore nel Rinascimento italiano (1992), Jaca Book, Milano, 1995, p. 158).
Ora, proprio questo riferimento a un’immagine che non si dispone sul piano del coinvolgimento (anche se si avvale dell’artificio visivo della finestra e quindi di un mezzo che instaura una qualche relazione tra lo spazio dell’immagine e lo spazio dello spettatore), ci consente di definire seppure per sommi capi la relazione che lega la dialogicità dell’immagine alla presenza o all’assenza di un coinvolgimento percettivo. Un punto può essere sostenuto con relativa chiarezza: perché un’immagine possa stringere una relazione dialogica con lo spettatore non è necessario che sia caratterizzata da una spazialità prospettica o quasi prospettica, così come sarebbe del tutto illecito sostenere che ogni immagine costruita prospetticamente sia di per se stessa caratterizzata da una sua dialogicità. Il Cristo benedicente delle cupole non è costruito prospetticamente ma è dialogico, la Città ideale di Urbino è prospettica ma non è dialogica: ricondurre l’una all’altra le voci della nostra matrice sarebbe quindi del tutto illegittimo. E tuttavia ciò non significa che la dimensione transitiva e dialogica dell’immagine sia priva di un nesso con la dimensione del coinvolgimento, e la ragione è ovvia: perché l’immagine si faccia transitiva è necessario da un lato indebolire lo iato che separa lo spazio figurativo dallo spazio reale e, dall’altro, costruire la spazialità dell’immagine in modo che sappia sostenere intuitivamente la possibilità della deissi. In fondo un’immagine può interpellarci solo se dallo spazio figurativo può indirizzarsi verso di noi un gesto, un movimento o uno sguardo che ci costringa a reagire e a sentirci chiamati in causa.
Come di consueto, vorrei tentare di articolare un poco queste considerazioni disponendomi sul terreno di un’indagine fenomenologica. E su questo terreno la prima distinzione che deve essere tracciata ci riconduce alla possibilità che lo spettatore sia chiamato in causa dall’immagine come attore o come giudice della scena raffigurata: ad una transitività iconica si deve contrapporre così una transitività metaiconica.
Rivolgiamo innanzitutto l’attenzione alla prima possibilità, e cioè alla possibilità che chi guarda un quadro sia coinvolto come un attore nella scena dipinta. In un quadro di Velázquez intitolato La mulatta si vede una ragazza che con un gesto maldestro fa precipitare fuori dal quadro un pentolino, che lo spettatore è chiamato a raccogliere prima che cada per terra: a coinvolgerci è dunque, in questo caso, un’azione che dobbiamo continuare, assumendo così il ruolo di attori di una scena che ha inizio nello spazio figurativo. Credo che siano possibili molti altri esempi, e che La deposizione del Pontormo di cui abbiamo avuto dianzi occasione di discorrere sia costruita in modo tale da invitarci ad assumere il compito di continuare la fatica della deposizione. E tuttavia, piuttosto che seguire il filo che questi esempi ci porgono, vorrei richiamare l’attenzione sulla forma di coinvolgimento dialogico che ha maggiormente attratto l’interesse dei pittori e cui Alfred Neumeyer ha dedicato un libro molto bello, intitolato Der Blick aus dem Bild (1964). All’origine di questo libro c’è un’idea semplice: se vi è un segnale visivo evidente della presenza di un nesso dialogico questo è lo sguardo, poiché ci basta un’occhiata anche rapida per capire se qualcuno ci sta guardando e per fargli a sua volta comprendere che ci siamo accorti della sua presenza. Quando si parla con qualcuno lo si guarda negli occhi, e talvolta lo sguardo può essere l’unico mezzo che definisce chi sia il vero destinatario di un discorso formalmente rivolto a tutti, ma che è propriamente rivolto soltanto a colui che guardiamo negli occhi. Del resto già in quest’espressione — guardare negli occhi — è implicito il rimando alla soggettività dello sguardo e al porsi degli occhi come una via di accesso che ci consente di penetrare nello spessore delle persone, nel loro essere qualcosa di più che un oggetto che si consegna nella sua superficie. Guardare qualcuno negli occhi significa penetrare nell’interiorità di chi osserviamo per fare emergere un poco della sua vita nascosta ed è per questo che la fantasia del mito ha potuto immaginare l’idea di uno sguardo assoluto che sa sradicare la vita nascosta perdendola interamente — l’idea dello sguardo di Medusa che è capace di trasformare in una pietra buia chi la osserva.
Ora, di questo mezzo così ricco di suggestioni psicologiche la pittura può di fatto avvalersi per dare alle sue immagini una dimensione transitiva e dialogica, e il libro di Neumeyer cui accennavo traccia una storia molto ricca di questa forma espressiva. Io vorrei tuttavia limitarmi a sottolineare alcuni punti, per segnare alcune distinzioni che mi sembrano importanti per il nostro problema:
1. Vi sono innanzitutto le immagini che cercano uno spettatore, poiché gli si rivolgono con un gesto o, più frequentemente, con lo sguardo. È questo appunto il caso del Cristo pantocratore che dall’alto delle cupole guarda verso il basso e osserva e giudica. Nel disco della cupola di Panaghia Theotokos a Cipro si legge «Colui che vede tutto da questo alto posto, vede tutti coloro che entrano qui. Mortali, abbiate timore del Giudice» (Shearman, op. cit., p. 160), e di questa iscrizione così eloquente ci si può avvalere per cercare di dare un contorno più preciso a questa prima forma di transitività dell’immagine. Un punto deve essere subito messo in luce: in queste parole lo sguardo divino è innanzitutto presente come un fardello di cui deve farsi carico chiunque passi sotto la cupola o lungo la navata che ad essa conduce. E ciò è quanto dire: il movimento di transitività dell’immagine ha il suo centro propulsivo non nello spettatore, ma nell’immagine stessa — è da lei che lo sguardo si origina. Potremmo forse esprimerci così: nel caso del Cristo pantocratore lo spettatore deve assumere i panni dialogici della seconda persona, perché l’immagine gli si rivolge non nella forma di una risposta, ma di una richiesta. Di fronte a quest’immagine, lo spettatore è chiamato ad alzare lo sguardo solo per abbassarlo subito dopo e per sentirsi ora sua volta guardato. Il compito dello spettatore consiste così, paradossalmente, nel rinunciare al proprio ruolo per accettare di disporsi in una relazione essenzialmente asimmetrica: il senso dell’immagine del Cristo pantocratore comincia a vivere in tutta la sua pienezza quando lo spettatore si fa fedele ed abbassa lo sguardo per lasciarsi guardare. Del resto, nulla nel volto impassibile di Gesù lascia pensare che il suo guardare si leghi alla consapevolezza dell’essere a sua volta guardato; tutt’altro: noi siamo presenti allo sguardo di dio, ma dio non è presente al nostro e non può essere toccato dai nostri sguardi. La transitività dell’immagine assume così una forma tendenzialmente monologica: un dialogo degli sguardi non vi è, perché la fissità imperturbabile del volto di Cristo e la sua posizione che tutto domina ci costringono a pensarci più come oggetti che come soggetti del vedere. La dialettica del reciproco riconoscimento è interrotta, e non a caso: possiamo sentirci guardati e compresi da dio, ma non possiamo pensare che il nostro sguardo possa scrutarlo o sorprenderlo.
Alla peculiarità di questa relazione tra l’immagine e lo spettatore fa da contrappunto la vivacità della consapevolezza percettiva di essere scrutati e seguiti dallo sguardo che dall’immagine ci raggiunge. Possiamo così imbatterci in una vera e propria valorizzazione metafisica di un fenomeno percettivo che ha la sua radice nella resistenza delle immagini alla deformazione prospettica. Ci siamo tutti imbattuti in questo fatto di cui già Plinio narra nella sua storia della pittura: vi sono ritratti che sembrano seguirci con lo sguardo, anche se noi ci spostiamo lasciando sulla nostra destra ciò che prima era sulla nostra sinistra. Si tratta di un gioco ben noto che di fatto ci parla dei limiti computazionali della nostra visione: lo sguardo tiene conto dell’incapacità dello spazio figurativo di articolarsi in aspetti, ma non può proprio per questo non volgere verso di sé ciò che nell’immagine si orienta prospetticamente verso uno spettatore frontale. Ciò che appare rivolto allo spettatore deve continuare ad apparire così, a dispetto del nostro muoverci di fronte alla tela. Di qui il gioco misto a stupore che tante volte ci ha costretto a camminare su e giù per un corridoio, sotto la presa di uno sguardo dipinto che non ci abbandona.
Un gioco infantile che, tuttavia, ha per Cusano una serietà che chiama a pensare e a riflettere sul prospettivismo che nella luce straniata di una riflessione teologica deve apparire come la forma stessa della finitudine e come il segno sensibile dell’egoismo umano, del suo essere eticamente e metafisicamente contratto in una posizione finita da cui solo dio può liberarsi:
Avvicinati, ora, fratello che contempli, alla icona di Dio e prima mettiti a oriente, poi a mezzogiorno e da ultimo a occidente. Poiché la vista dell’icona ti guarda allo stesso modo dappertutto e non ti abbandona dovunque tu vada, sarà in te stimolata la speculazione e sarai spinto a dire: «Signore, in questa tua immagine intuisco ora con un’esperienza sensibile la tua provvidenza. Se non abbandoni me, che sono il più spregevole fra tutti, non abbandonerai certo mai nessuno. Tu assisti tutti e ognuno, come a tutti questi e a ognuno è presente l’essere senza il quale non possono essere» (La visione di Dio, in N. Cusano, Opere filosofiche, a cura di G. Federici Vescovini, UTET, Torino 1972, p. 548).
Così, in questo errore di sistema del nostro programma visivo Cusano coglie il segno della perfezione divina: la vista che nell’uomo è contratta e finitamente vincolata alla decisione della prospettiva si eleva in dio ben al di sopra di queste bassezze, e se ne libera astraendo da ogni contrazione: solo per questo l’icona di dio può guardare tutti e ciascuno, e può seguirci con gli occhi senza per questo trascurare di lasciare cadere il suo sguardo su chiunque la osservi.
2. Le considerazioni che abbiamo appena proposto ci hanno consentito di dare un senso definito ad una prima forma di transitività dell’immagine — ad una forma instabile, poiché la possibilità del sentirsi guardati senza a nostra volta guardare è sospesa su un sentimento che fa tutt’uno con il divaricarsi della soggettività, con il suo cedere alla consapevolezza di uno sguardo e, insieme, il suo distogliersi da esso. E tuttavia, a queste immagini che si fermano sulla soglia della dialogicità si possono contrapporre le raffigurazioni in cui il dialogo prende effettivamente corpo e lo spazio di risonanza è attraversato da una relazione percorribile nei due sensi: l’immagine ci coinvolge in un dialogo che ha domande e risposte e che struttura lo spazio figurativo e lo spazio dello spettatore a partire dalla situazione dialogica che si viene determinando. Ora non vi è più soltanto uno sguardo che dalla tela cerca lo spettatore, ma vi è insieme il manifestarsi del fatto che quello sguardo scopre qualcuno — che ci vede, nel mostro essere ora presenti di fronte all’immagine.
Così stanno per esempio le cose nel caso del Las Meninas di Velázquez, ma anche nel caso della Madonna sistina di Raffaello, — un quadro che ci presenta il tema che anima l’icona della brephocratousa eleusa nella forma drammatica di una presa d’atto che avviene nel gioco reciproco degli sguardi. Vorrei lasciare agli esempi che vi ho mostrato il compito di arricchire il senso di questa forma di transitività che accomuna i giochi maliziosi con gli specchi alle riflessioni implicite nel genere dell’autoritratto. E tuttavia almeno due considerazioni di carattere generale debbono essere senz’altro proposte. La prima ci riconduce al modo in cui la soggettività dello spettatore si pone. Ora non vi è più semplicemente uno sguardo che cerca lo spettatore e che l’osserva senza stupirsene: vi è invece la manifestazione evidente del fatto che nell’immagine qualcuno si è reso conto di noi e ci guarda. Ma ciò è quanto dire che l’immagine risponde alla nostra presenza, e che il nostro esserci non è soltanto gravato dallo sguardo che dall’immagine ci scruta, ma è riconosciuto dalla tela stessa: lo spettatore cessa così di essere soltanto il «tu» cui un monologo si rivolge per assumere nello scambio dialogico la dualità di ruoli che gli compete. E ciò è appunto quanto dire che la transitività dell’immagine assume una piena valenza dialogica e che lo spazio di risonanza diviene percorribile in entrambe le direzioni.
Vi è tuttavia una seconda considerazione che deve essere avanzata e che ci riconduce a quanto avevamo osservato discorrendo di un quadro di Velázquez che sembra invitarci a prendere prima che cada la pentola che una serva distratta ha lasciato cadere verso di noi: quanto più l’immagine ci coinvolge in un’azione o si fa dialogica, tanto più diviene legittimo proiettare il nostro presente di spettatori sulla trama in sé atemporale dell’immagine. La scena dipinta accade così sotto i nostri occhi e il «c’era una volta…» assume la forma di una narrazione al presente. Molti sono gli esempi possibili, ma vorrei ancora una volta rammentare Las Meninas di Velázquez: tra i significati di questo quadro così complesso c’è anche, io credo, una dialettica temporale che ha luogo tra l’istantaneità del gesto del volgersi che accomuna le figure sulla destra del quadro e la fissità atemporale della vicenda così come apparentemente la pittura la consegna alla tela. Apparentemente, appunto, poiché ciò che nella si ferma vive soltanto quando lo spettatore l’osserva, prestandole il suo ora che passa.
2. La transitività metaiconica
Nell’ora precedente ci siamo soffermati sulle forme di transitività che rimandavano un coinvolgimento dello spettatore nella vicenda narrata dall’immagine: il Cristo pantocratore si rivolge nel benedire o nello scrutare ai fedeli che dal basso l’osservano e l’azione che l’immagine narra è tutta racchiusa nel movimento che rende l’immagine transitiva. Così stanno evidentemente le cose anche nel caso della Venere di Velázquez o negli autoritratti di Rembrandt: qui il nesso che rende l’immagine transitiva fa evidentemente parte del contenuto della raffigurazione e non si rivolge all’immagine chiamandola in causa dall’esterno.
Ma non sempre le cose stanno così, ed è di fatto possibile che il rimando dialogico non sia interno all’azione narrata o al nucleo espositivo dell’icona stessa, ma sia ad essa esterno e ci inviti a prendere posizione su ciò che l’immagine ci mostra. Si potrebbe forse rendere conto di questa differente forma di transitività seguendo il cammino che Giovanni Bellini sembra percorrere nella sua rilettura dell’icona antica dell’imago pietatis[15]. Da quell’icona Bellini non vuole separarsi, ma sente il bisogno di ripensarla in una chiave drammatica che ci consenta di ripensare il dogma teologico che vi si esprime alla luce di una drammaticità tutta umana. Quell’immagine raffigura il mistero del cristianesimo ma deve anche dire nel linguaggio umano delle passioni il dramma che vi si narra. Così, nella Pietà di Brera il corpo di Gesù è affiancato dal pianto diverso di Maria e di Giovanni, l’uno rivolto al passato l’altro al futuro. Questi due dolori debbono insegnare allo spettatore come debba osservare la scena ed il cartiglio che Bellini pone illusionisticamente al di qua dello spazio pittorico funge da commento metaiconico sull’immagine: in un latino difficile [Haec fere quum gemitus turgentia lumina promant / Bellini poterat flere Joannis opus (Come questi occhi gonfi di pianto emettono quasi gemiti così poteva quasi piangere l’opera di Giovanni Bellini)] ci invita a cogliere quest’immagine come se fosse un lamento e quindi ad accordare il nostro contegno di spettatori ad una narrazione che è insieme un lamento funebre. Ma ciò che nella Pietà di Brera è affidato ad un cartiglio, assume in seguito una forma diversa: la forma di un personaggio esterno all’azione e al cuore del dramma che si rivolge verso di noi per invitarci ad accordare la nostra passione di spettatori sulla sua. E lungo questa via l’immagine si fa transitiva, ma la transitività di cui qui parliamo non rimanda ad un dialogo tra la scena dipinta e lo spettatore, ma assume la forma di una richiesta nuova: allo spettatore la tela chiede ora di assumere un determinato atteggiamento ricettivo, di farsi non attore ma giudice compassionevole della scena narrata. È come se Bellini si rivolgesse allo spettatore e, ponendosi sul suo stesso terreno, commentasse l’immagine dicendoci: «E se non piangi adesso, di che pianger suoli?»
Questa funzione di commento metaiconico rivolta allo spettatore è chiaramente menzionata da Leon Battista Alberti che nel suo Della Pittura scriveva:
e piacemi sia nella storia chi ammonisca e insegni a noi quello che ivi si facci, o chiami con la mano a vedere, o con viso cruccioso o con gli occhi turbati minacci che niuno verso loro vada, o dimostri qualche pericolo o cosa ivi maravigliosa, o te inviti a piagnere con loro insieme o a ridere (Della Pittura, II, 42).
Di questa figura che, nel quadro, tende ad assolvere il compito dello spettatore e a indirizzarlo verso una giusta comprensione dell’opera si è molto discusso[16]. Io vorrei tuttavia limitarmi ad osservare la sua funzione rispetto al problema della transitività dell’immagine. Ciò che vediamo è un personaggio che assume su di sé una funzione di mediazione che è chiaramente indicata dal suo duplice alludere: da una parte addita all’immagine, dall’altra si rivolge allo spettatore. In questo senso, appunto, l’immagine si fa transitiva: la figura albertiana mette in relazione il quadro con lo spettatore e gli suggerisce un determinato modo di reagire all’immagine e al suo senso. Ma appunto: ciò che caratterizza la figura albertiana è il suo rivolgersi all’immagine come a un tutto, assumendo quindi esplicitamente una funzione metaiconica. Di qui da un lato la vaghezza del gesto con cui il personaggio che si rivolge allo spettatore allude alla scena dipinta, dall’altro la ragione che lo spinge ai margini della scena.
Una ragion che non è difficile comprendere: proprio perché la figura albertiana intende rivolgersi allo spettatore per invitarlo ad assumere una posizione definita sull’immagine come un tutto, proprio per questo deve necessariamente porsi sul margine della raffigurazione, poiché solo se si pone sulla linea di confine dello spazio figurativo può effettivamente indicare la scena come un tutto e porsi come un operatore di nominalizzazione della scena pittorica. Posta al di qua del terreno propriamente figurativo, la figura albertiana può raccogliere nell’unità di un nome il contenuto proposizionale dell’immagine e richiamare l’attenzione dello spettatore su ciò che da essa è stato raccolto. Non è un caso allora se essa è di casa soprattutto nell’arte con un contenuto narrativo: il suo senso e la sua funzione rimandano infatti ad un’immagine che abbia un contenuto proposizionale — ma sul senso di questa affermazione dovremo tornare in seguito[17].
Parte terza
Il tempo e il concetto di raffigurazione
Lezione diciasettesima
1. Il tempo delle immagini
Nella seconda parte del corso ci siamo soffermati sul concetto di spazio figurativo e sulle ragioni che ci consentono di ritrovare nella sua forma la natura del concetto di immagine, e ora che questo compito è stato condotto a termine almeno nelle sue linee generali come resistere alla tentazione di obbedire ad un modello antico e interrogarsi sulla funzione che il tempo gioca nel concetto di raffigurazione?
Basta tuttavia formulare una simile questione perché una prima risposta si faccia avanti: un disegno è per sua natura il frutto di una prassi in cui il movimento si solidifica in un tratto immobile che non ci permette più di riconoscere il divenire che ad esso ha condotto. Un disegno si fa nel tempo e chiede che si aggiunga tratto a tratto; una raffigurazione, tuttavia, una volta che sia terminata, non può racchiudere una successione senza per questo vincolarla alla legge della coesistenza e quindi alla regola di una spazialità senza tempo. In un dipinto possiamo riprodurre molte cose ma non una serie di eventi che si susseguano, e ciò è quanto dire che in senso proprio non è possibile una raffigurazione della temporalità che, per sua natura, implica una successione ordinata.
Ora, negare alle raffigurazioni la possibilità di racchiudere in sé una successione temporale sembra voler dire, tra le altre cose, che non è in linea di principio possibile che una raffigurazione ci narri qualcosa, — questo termine preso in un senso molto ampio e generalissimo.
La ragione di una simile conclusione è relativamente ovvia. Certo, di per se stessa una successione ordinata non è ancora una narrazione e non basta che vi siano due o più eventi che si susseguano perché si possa parlare di un racconto. Il Sole tutte le mattine sorge e tramonta mutando ad ogni nuovo giorno la sua posizione nel cielo, secondo una regola che non conosce eccezioni. E tuttavia la successione ordinata delle posizioni del Sole non racconta nulla, anche se il primo racconto del tempo è forse già racchiuso nel tentativo di contare i giorni e di dare loro un nome per poter dire così il loro succedersi.
Il sorgere e il tramontare del Sole di per sé non bastano: perché vi sia una narrazione del tempo è necessario che vi sia qualcuno che ne prenda atto e che si preoccupi di delineare un calendario e, insieme ad esso, la forma umana del trascorrere del tempo. Ma se è necessario che alla successione ordinata degli eventi si affianchi la presenza di un soggetto che raccolga in unità quell’ordinato succedersi e se questo rimando soggettivo è implicato dal concetto di narrazione che racchiude in sé la coscienza di quell’ordinamento, ciò non toglie che l’esserci di una successione di eventi è comunque la condizione su cui poggia la possibilità del narrare[18]. Di qui la tesi cui avevamo alluso: se le immagini non possono ospitare una successione temporale, non possono nemmeno essere il luogo di una narrazione. E se così stanno le cose, le raffigurazioni debbono apparirci come il luogo in cui si celebra un eterno presente, un presente senza tempo.
Un presente senza tempo: su questo punto è necessario soffermarsi un poco. Se guardiamo ciò che un dipinto ci mostra, vedremo raffigurati uomini, paesaggi, contrade, e se qualcuno ci chiedesse poi di descrivere ciò che vediamo, useremmo probabilmente il tempo presente e diremmo che di fronte a noi vi sono queste persone, questi paesaggi e queste città. E tuttavia, per quanto ci appaia ragionevole esprimerci così, troveremmo comunque privo di senso ogni tentativo di definire il quando del mondo pittorico che abbiamo sotto gli occhi. Dobbiamo cioè ricordarci ancora una volta di San Giorgio e il drago e del duello che li vede impegnati nella predella di un quadro di Bellini, a Pesaro. Questo duello lo vediamo e c’è per noi, anche se solo nelle forme del dipinto; ciò non toglie tuttavia che non avrebbe davvero alcun senso sostenere che quel duello ha luogo proprio ora, alle 17.45 del 16 aprile 2003; quel duello ci è presente, ma non è presente affatto. Ma non appartiene per questo al passato. Certo, si potrebbe sostenere che forse vi è stato davvero un San Giorgio e forse anche un drago disposto a farsi uccidere a maggior gloria dei cavalieri cristiani, e se così stessero le cose avrebbe senso dire che, guardando quel quadro, ci ricordiamo di un evento passato. Un quadro si può usare proprio così: possiamo considerare ciò che ci mostra come un degno modo per celebrare un evento che crediamo sia un tempo avvenuto. E tuttavia il ripetersi di quell’evento che ora si inscena — ciò che nella tela vediamo — non occupa un posto nell’unico tempo del mondo e il suo esserci non è né prima, né dopo un qualsiasi evento che appartenga alla storia degli uomini. Possiamo allora trarre una conclusione che ci è nota: ciò che l’immagine ci presenta non ha una qualche relazione obiettiva con il mondo, e non ha quindi alcun senso cercare di stringere una relazione temporale obiettiva tra ciò che vedo in un disegno e ciò che accade di là da esso. Il mondo figurativo è acontestuale, e la acontestualità rispetto allo spazio in cui ci siamo dianzi imbattuti ha un suo analogon temporale: il mondo delle immagini non ha un suo luogo temporale che ci consenta di collocarlo rispetto alla retta del tempo e di fissare una volte per tutte un quando al c’era una volta della raffigurazione. Il presente delle immagini è e resta soltanto un presente, e non coincide affatto con quell’istante del tempo obiettivo cui di volta in volta attribuiamo questo nome.
Queste considerazioni non dovrebbero più di tanto stupirci, ed anzi il nesso che esse istituiscono con la forma peculiare della spazialità delle immagini può indicarci quale sia la ragione per cui, nonostante tutto, diciamo che la scena raffigurata è presente, — un’espressione quest’ultima che non sembra affatto giustificata dalle tesi che abbiamo sin qui proposto, poiché per poter essere detta presente una scena deve istituire comunque una relazione con il qui temporale della soggettività, con il suo esserci ora.
Ricordiamoci brevemente di come stessero le cose sul piano della spazialità: dopo aver sostenuto che le cose che appartengono allo spazio figurativo non stringono relazioni obiettive con gli oggetti del nostro mondo avevamo tuttavia osservato che la scena raffigurata stringe con lo spettatore una relazione spaziale sui generis e, proprio per questo, guadagna una sua localizzazione meramente fenomenica: ciò che un dipinto ci mostra ci appare proprio qui, di fronte a noi, ad una certa distanza e secondo una certa particolare angolazione. Qualcosa di simile accade anche per il tempo. La scena dipinta non ha un posto nel tempo obiettivo, ma riceve egualmente dallo spettatore una localizzazione temporale: proprio perché ci appare non soltanto qui ma ora, ciò che nell’immagine prende forma assume per noi il carattere fenomenico della presenza.
Alla somiglianza si deve affiancare la differenza. L’immagine ha una sua forma spaziale, e vi è quindi una relazione di maggiore o minore continuità tra lo spazio dello spettatore e lo spazio figurativo. Per il tempo le cose non stanno così: l’immagine non ha una temporalità autonoma, ma la riceve da chi, osservandola, le dà un presente che dura nel tempo.
Possiamo allora formulare una prima conclusione di carattere generale: ciò che nell’immagine si raffigura deriva la propria temporalità dalla presenza del percipi — dal tempo dello spettatore che guarda l’immagine e che lascia correre lo sguardo sulla scena, indugiando ora più, ora meno sulle parti che la compongono. Ne segue che la scena raffigurata guadagna una durata e una temporalità nel processo di ricezione dell’immagine: che San Giorgio uccida il drago è un evento che si mette in scena proprio ora e che ha un inizio e una fine, anche se questo rimando alla posizione temporale non può essere disgiunto dalla dimensione puramente fenomenica che lo caratterizza. Su questo punto dobbiamo anzi essere un poco più precisi, ed osservare che quando asseriamo che la scena dipinta in un quadro si fa presente allo spettatore non intendiamo affatto asserire che tutto ciò che in essa si dispiega sia posto come presente. La presenza dell’immagine per lo spettatore che la guarda non decide ancora nulla sull’eco temporale che deriva da un suo possibile impiego, proprio come il mio ricordarmi ora di un evento passato è sì testimonianza del fatto che ora rivivo ciò che un tempo è accaduto, ma non per questo mi costringe a negare che ciò di cui mi rammento deve essere posto in un luogo che non coincide affatto con il mio presente. Così, una vecchia fotografia in un album di famiglia può assumere la forma intuitiva di un ricordo: ciò che vediamo è declinato al passato proprio come al passato appartenevano le persone che vi sono ritratte. Ma l’indice del passato che la memoria o una voce esterna o il contenuto stesso dell’immagine attribuisce all’oggetto raffigurato, non ne cancella per questo la presenza: è proprio ora che il ritratto di quel volto si fa manifesto e che l’immagine vive, aprendo nel presente una scena che è rivolta al passato e che ci consente di ricordarlo. Proprio come un ricordo, la raffigurazione si rappresenta ora, mettendo tuttavia in scena qualcosa che ci parla di un tempo ormai definitivamente trascorso. E ciò che vale per il passato vale anche per il futuro: ora guardo la pianta di una casa, e comincio a fantasticare su come potrebbe cambiare spostando ora questo tramezzo, ora aprendo una porta, e se ho imparato a riconoscere nell’essenzialità del disegno tecnico la forma visiva di un futuro abitare, vedrò manifestarsi ora ciò che sarà o che potrebbe essere. Il palcoscenico dell’immagine si apre su una scena che ci consente di vedere ciò che avrà il suo luogo temporale nel futuro. Che poi il mondo che l’immagine mette in scena, possa essere a sua volta declinato al presente è appena il caso di dirlo: possiamo usare un’immagine proprio così — per mostrare come stanno le cose. Dalla mia finestra si vede questo — e ti mostro un disegno o una fotografia, e ciò che vedi vale più di molte parole.
Di qui appunto la tesi che abbiamo dianzi sostenuto: l’immagine ha un suo campo di presenza che deriva dal rapportarsi della raffigurazione alla soggettività percipiente, dal suo esserci per un soggetto. Se dunque si può dire che ora si inscena per noi l’evento che un dipinto ci mostra e se si può affermare che ciò che vediamo dura nel campo di presenza che è definito dal nostro percepirlo, ciò accade non in virtù di una proprietà intrinseca, dell’immagine, ma solo in relazione all’io dello spettatore — e questo al di là di ogni considerazione che ci consenta di avvalerci del contenuto dell’immagine per ricordarci di un evento reale o per riferirci ad una realtà presente o che abbiamo ragione di attendere.
Da questa prima tesi possiamo tuttavia muovere per cercare di cogliere come sia possibile attribuire alle immagini una temporalità più ricca. E non è difficile comprendere quale sia il cammino che si deve seguire: riconoscere che le raffigurazioni hanno un campo di presenza che ne circoscrive la durata vuol dire anche gettare una luce diversa sul problema della possibilità di impiegare le immagini in funzione narrativa. Il narrare implica una successione e, in senso etimologico, un racconto, e le raffigurazioni sono in sé prive di un interno succedersi di eventi; e tuttavia il percepirle dura e può essere scandito nella forma di una successione: il campo di presenza che l’immagine deve alla temporalità dello spettatore potrebbe assumere così la forma di un decorso temporale scandito secondo la regola del prima e del poi, — secondo la forma sensibile della narrazione.
Si tratta di un’osservazione su cui riflettere, e tuttavia il fatto che la ricezione di un’immagine sia un processo che dura non è ancora una buona ragione per sostenere che il campo di presenza debba articolarsi nella forma della temporalità narrativa. Posso guardare a lungo un ritratto e cogliere le caratteristiche di un volto, ma ciò non significa che l’immagine sia narrativa: il volto è presente allo sguardo ma i suoi lineamenti non si dispiegano nella forma del prima e del poi. Qui non vi è intreccio perché non vi è fabula: la ricezione non parla di una temporalità nell’oggetto raffigurato e il suo perdurare si perde come un tratto soltanto soggettivo. Ma ciò è quanto dire che il guardare si fa racconto solo se qualcosa nel contenuto dell’immagine sa guidarci nel disporre la scena in un orizzonte temporale.
Il rimando alla dimensione letteraria della narrazione può forse aiutarci a chiarire le idee. In un racconto, si può distinguere tra fabula e intreccio: la fabula è la successione ordinata degli eventi narrati, colti nelle loro connessioni causali e motivazionali e nella loro intrinseca determinazione temporale. Così, nel caso di Ulisse la fabula che l’Odissea narra consiste innanzitutto nella partenza da Troia, nelle avventure del viaggio, nell’anno trascorso da Circe, nella discesa agli inferi, nei sette anni trascorsi nell’isola Ogigia e, infine, nel viaggio che lo conduce all’isola dei Feaci e di qui a Itaca. Ma l’intreccio è ben diverso: dei sette anni trascorsi con Calipso Omero non parla se non per dire che vi sono stati, e tutta la storia di Ulisse è narrata intrecciando il presente al ricordo, in un ordinamento degli eventi che è insieme una libera espansione o compressione della loro durata temporale.
Ora, anche nel caso delle immagini si deve distinguere la fabula dall’intreccio. L’intreccio è dettato dall’articolarsi del processo ricettivo secondo la regola del prima e del poi: talvolta, nel tentativo di comprendere un’immagine, siamo invitati a ricomporla in unità, articolando il suo campo di presenza in una successione di scene, che rapportano gli uni agli altri i momenti di cui l’immagine consta attribuendo loro uno spessore temporale ed una diversa collocazione cronologica. Dall’intreccio sorge così una fabula, che nasce dal tentativo di ricostruire nell’unità di un senso l’universo figurativo che l’immagine ci propone. Ma ciò è quanto dire che una raffigurazione assume forma narrativa solo se qualcosa nel suo contenuto da un lato ci vieta di comprendere il senso della scena raffigurata rinchiudendolo nell’unità di un presente atomico, dall’altro ci consente di scandire il suo processo di ricezione nella forma di una successione ordinata. Solo nel nesso di questa duplice condizione il perdurare della presenza dell’immagine può assumere la forma di uno sviluppo narrativo. Di qui l’ipotesi che vogliamo sostenere: le immagini hanno una piega narrativa quando qualcosa nel loro contenuto di senso ci costringe, e insieme ci consente, di dare alla loro percezione la forma di un processo scandito nel tempo, di un intreccio che viene disegnando una fabula.
Basta formulare questa ipotesi perché si facciano nuovamente avanti le obiezioni che abbiamo formulato nelle considerazioni introduttive di questa lezione: la regola delle immagini è la coesistenza, e lo spazio di possibilità delle raffigurazioni sembra chiudersi al di qua della successione temporale e della sua forma di ordinamento dei fenomeni. Se, dunque, il decorso percettivo che ha per oggetto le immagini può fungere da schema sensibile della narrazione solo se qualcosa nell’universo figurativo ci invita a pensare la durata nella forma di un racconto, allora sembrerebbe davvero necessario sostenere che per una narrazione nelle immagini non vi è spazio — una conclusione, questa, che sembra essere tanto coerente con la tesi della non raffigurabilità delle successioni, quanto in contrasto con il compito narrativo che alle immagini è stato assegnato per secoli.
Ora, un primo modo per venire a capo di questa contraddizione sembra condurci verso una riformulazione dell’ipotesi che abbiamo appena proposto. Se le immagini non sanno racchiudere in sé uno spessore temporale e se nel loro contenuto non vi è appiglio per quella fabula che l’intreccio dovrebbe dipanare, allora la forma narrativa deve trovare soltanto nella soggettività il suo fondamento: un’immagine con un contenuto narrativo sarebbe allora soltanto un’immagine che usiamo per dare un volto e uno sfondo ai personaggi di un racconto che dobbiamo comunque narrare a parole. E se le cose stanno così dovremo sostenere che il momento narrativo non appartiene all’immagine e che, in senso proprio, non è raffigurato: l’immagine è statica e se narra qualcosa è solo perché la soggettività se ne avvale come di una tessera nel mosaico di una prassi — la prassi della narrazione — che non dipende da ciò che nell’immagine si mostra.
Si tratta di un’obiezione che ci invita a riflettere e che innanzitutto richiama la nostra attenzione su un fatto importante: qualunque conclusione si voglia trarre rispetto all’ipotesi che abbiamo formulato, si deve comunque riconoscere che la possibilità di cogliere in un’immagine un racconto presuppone che ci sia in primo luogo ben chiara la forma generale della narrazione, il gioco linguistico del raccontare[19]. Possiamo forse spingerci un passo più avanti ed osservare che perché un quadro acquisti un suo spessore temporale non è soltanto necessario che lo spettatore conosca la grammatica della narrazione, ma è anche opportuno che conosca già il contenuto della storia narrata e che ripeta a parole il racconto che gli occhi debbono cercare di seguire sulla tela. La nostra tradizione pittorica è ricca di quadri narrativi, ma la nostra facilità nel cogliere un racconto in una qualche scena dipinta dipende anche dal fatto che sappiamo già che cosa probabilmente ci verrà narrato: la mitologia greca, la Bibbia e i Vangeli fanno parte di questo patrimonio comune di racconti che ci aiuta a scoprire nella staticità delle immagini la fabula nascosta. Tuttavia, se il conoscere già la trama della storia è importante, ciò accade perché l’immagine si fa narrativa soltanto quando lo sguardo fa da sostegno alle parole che narrano ciò che il dipinto ci mostra. E se le cose stanno così, se prima vi è la storia raccontata a parole e solo poi vi sono le immagini che guadagnano una lettura narrativa perché possono essere inserite nel dispositivo di una narrazione verbale, perché non sostenere che le raffigurazioni di per sé non narrano nulla? Del resto, se ci si pone in questa prospettiva, è difficile negare un peso teorico ad un’esperienza che, credo, sia capitata a tutti: guardiamo un quadro e vediamo soltanto un istante privo di storia, ma poi leggiamo il titolo e siamo costretti a ritornare sui nostri passi perché quelle poche parole ci costringono a proiettare sul dipinto una dimensione temporale che non sospettavamo. Di qui, ancora una volta, la conclusione che sembra necessario trarre: le immagini non raccontano, anche se possono essere usate in un racconto, così come si usano le pedine in un gioco di società — per segnare intuitivamente il posto che i giocatori occupano nel corso del gioco.
Come reagire a queste obiezioni che mirano a svincolare la narratività delle immagini dal loro contenuto? Così, io credo: riconoscendo che se le raffigurazioni raccontano qualcosa è davvero soltanto perché la grammatica della narrazione ci è già nota e accettando senz’altro che la capacità delle immagini di raccontare dipende anche, e forse soprattutto, dalla parola che suggerisce allo spettatore il criterio per leggerle. E tuttavia, anche se è almeno in parte vero che un’immagine racconta soltanto per chi già conosce la storia narrata, vorrei comunque sostenere che non ogni immagine si attaglia altrettanto bene ad una lettura narrativa. Una natura morta non sembra narrare nulla: ci mostra soltanto degli oggetti variamente disposti — dei frutti, dei fiori, una candela accesa. E quando guardiamo un mazzo di fiori dipinti o un paesaggio non facciamo domande e non consultiamo la guida: guardiamo e basta, anche se talvolta siamo chiamati a riflettere sul significato allegorico cui quel dipinto può alludere. Ben diversamente stanno le cose quando osserviamo la Profanazione dell’ostia di Paolo Uccello: forse non conosciamo quella storia inquietante che così tristemente si discosta dalla gentilezza dei tratti pittorici, ma ci basta guardare il primo riquadro di quella predella per sentire il bisogno di chiedere quale sia la vicenda narrata. Ma ciò è appunto quanto dire che non tutte le immagini sembrano spontaneamente piegarsi ad una lettura narrativa e che la nostra capacità di inserire l’immagine nella trama di un racconto dipende da ciò che l’immagine sa farci vedere. Certo, le parole possono in linea di principio indicarci come si deve guardare un’immagine, ma sanno farlo solo se qualcosa nell’immagine ci consente di ritrovarle, e ciò che vale per il titolo di un affresco, vale anche per la nostra conoscenza di una qualche trama narrativa: non basta avere in mente una storia e leggere da qualche parte che di essa il quadro tratta per riuscire a vedere inscenato quel racconto, e ciò è quanto dire che anche la narrazione deve avere un sostegno intuitivo, un fondamento sensibile che ci consenta di disporre nel tempo ciò che sembra soltanto coesistere nello spazio.
Vorrei ancora una volta affidare ad un esempio il senso di queste considerazioni. Tutti noi conosciamo bene la favola antica della volpe e della vigna, ma non basta dipingere un grappolo d’uva e una volpe seduta lì accanto perché quella narrazione si dipani sotto i nostri occhi: tutto il nostro sapere e le nostre letture di Esopo non bastano per consentirci di vedere in quel disegno le ragioni che spingono la volpe a ripetersi che quell’uva in fondo non è ancora matura. Un conto è vedere l’uva e la volpe, un conto è vedere che la volpe non riesce a raggiungere l’uva — questo è il punto. Perché l’immagine sappia narrarci qualcosa dobbiamo vedere non soltanto degli oggetti, ma un evento, ed un evento è un fatto che si può descrivere soltanto attraverso una proposizione e che si dispone su un arco temporale.
Possiamo tracciare così una distinzione che ha il suo luogo di origine nelle Ricerche logiche husserliane: diciamo allora che da una parte vi è un vedere che ha un contenuto nominale e che si riferisce in quanto tale ad un oggetto — vedo appunto la volpe e l’uva — dall’altra un vedere che ha per oggetto uno stato di cose e che ha quindi un contenuto proposizionale, cui allude linguisticamente la forma «che» — vedo che la volpe non riesce a raggiungere l’uva. Dire che non tutte le immagini sono altrettanto adatte per fungere in uno schema narrativo vorrà dire allora sostenere che non tutte le immagini hanno forma proposizionale ed in particolare che non tutte le immagini hanno la forma di una proposizione che descrive l’accadere di uno stato di cose e il suo dipanarsi nel tempo. Alle raffigurazioni che pongono sotto i nostri occhi uno o più oggetti si debbono contrapporre le raffigurazioni che ci parlano dell’accadere di uno stato di cose; e solo le seconde e non le prime hanno in sé la molteplicità adeguata per sorreggere una lettura narrativa.
Le considerazioni che abbiamo appena proposto sembrano consentirci di rendere un po’ meno vaga la tesi secondo la quale non tutte le immagini si attagliano ad una lettura narrativa e sembra insieme confermare la plausibilità dell’ipotesi secondo la quale non ogni immagine si attaglia altrettanto bene ad una lettura narrativa.
Il problema, tuttavia, è più complesso, e sotto un velo di apparente chiarezza si nascondono ancora molte difficoltà. Per sorreggere un’interpretazione narrativa un’immagine deve invitarci ad un vedere proposizionale; è tuttavia sufficiente riflettere sulla natura di questa distinzione per far sorgere nuovi problemi, poiché non è affatto chiaro se la distinzione che abbiamo proposto appartenga alla dimensione percettiva in quanto tale o se si debba invece ricondurla alla dinamica dei giochi linguistici entro cui la percezione può avere luogo. Credo che vi siano buone ragioni per sostenere che questa distinzione ha un radicamento percettivo e che per illustrarla sia di fatto opportuno fare affidamento a situazioni esemplificative differenti, a scene percettive contenutisticamente diverse. Così per illustrare che cosa intendo con vedere nominale ti indicherò un qualche oggetto: un libro, una sedia, un tavolo e ti chiederò di guardarlo. Per illustrare invece che cosa sia un vedere proposizionale ti proporrò esempi diversi, tratti in modo particolare dalla famiglia degli eventi. Quando qualcosa all’improvviso muta è difficile non descrivere ciò che abbiamo di fronte agli occhi se non disponendoci nelle forme di un vedere proposizionale: attraversiamo un incrocio e vediamo che un’auto ci taglia la strada oppure guardiamo dalla finestra e vediamo che un merlo spicca il volo, e queste scene non sapremmo descriverle diversamente, senza far forza al contenuto descrittivo di ciò che naturalmente si impone alla percezione. Tutto questo sembra plausibile ed ovvio, e tuttavia se abbandoniamo il terreno di queste spiegazioni alla buona (che possono comunque insegnarci qualcosa) e se ci interroghiamo sul contesto entro cui quegli esempi si mostrano adeguati al compito che sono chiamati ad assolvere, ci si mostra che la distinzione che abbiamo proposto non è una distinzione soltanto percettiva ma chiama in causa anche la dinamica delle motivazioni che danno alla percezione un senso determinato. Il modo in cui descrivo una percezione non è tutto racchiuso nella percezione stessa e non mi sembra possibile fare un solo esempio che non possa essere inteso diversamente, non appena lo si pone sullo sfondo di un differente contesto di ragioni. Ne segue che parlare di un vedere proposizionale vuol dire anche chiamare in causa il contesto della percezione e le motivazioni che la sorreggono: nessuna scena percettiva ha infatti, in sé stessa, forma proposizionale e non avrebbe comunque senso puntare il dito in una direzione determinata e pretendere che chiunque veda così come noi sosteniamo di vedere. Così, può senz’altro accadere che ti inviti a guardare dalla mia finestra perché voglio che tu veda il mio terrazzo e che tu dopo un rapido sguardo mi dica: «vedo che non hai bagnato le piante». Può accadere così come potrebbe accadere tutt’altro, perché una stessa scena percettiva può essere descritta in molti modi e non basta additarla per avere con ciò deciso se ci mostra un oggetto, uno stato di cose o un evento. Se poi fissiamo la scena all’identità di un presente e ci disponiamo sul piano delle immagini, la dipendenza dal contesto si fa ancora più manifesta. Torniamo al quadro che raffigura un mazzo di fiori e che c’era a ragione sembrato come un possibile esempio per illustrare un’immagine che, nella norma, non chiede una lettura narrativa, e immaginiamo ora di lasciare cadere lo sguardo sul cartiglio che reca il titolo che il pittore ha scelto per il suo dipinto — un titolo che ci invita a cogliere ciò che vediamo sullo sfondo di un divenire: ora guardiamo meglio quel quadro e vediamo che alcuni fiori sono già caduti, mentre altri stanno sfiorendo, ed anche se uno storico dell’arte non parlerebbe ancora di un quadro che appartenga al genere narrativo, è un fatto che ciò che questo dipinto ci porge è il racconto di una vicenda che si dipana nel tempo e che di qui riceve il suo significato allegorico.
Credevamo di aver corroborato la nostra ipotesi e ci sembra invece di averla indebolita. Certo, non tutte le immagini sono suscettibili di una lettura narrativa e questo perché non tutte le immagini alludono ad un contesto che ci inviti a leggerle proposizionalmente. Ma se ciò che abbiamo appena osservato è vero, la diversa predisposizione delle immagini ad una lettura narrativa non dipenderebbe dal loro contenuto, ma dal contesto entro cui sono inserite. Non è un caso allora che le immagini abbiano così spesso affidato la loro capacità di narrare alla forma del ciclo pittorico. Perché un’immagine racconti qualcosa abbiamo bisogno di circondarla di parole che ci dicano come guardarla e che ci insegnino ad usarla come vogliamo; ma se le immagini sono molte e si susseguono le une alle altre secondo una regola determinata le parole diventano meno importanti ed abbiamo così l’illusione che la scena pittorica sappia davvero andare al di là dei limiti che caratterizzano la sua natura. Ci addentriamo in una chiesa e il nostro incedere è accompagnato da un susseguirsi di affreschi, che il ripetersi di una stessa cornice distingue e insieme lega. Nel primo riquadro vediamo un angelo e la Vergine l’uno di fronte all’altra e poiché abbiamo letto che il ciclo narra la vita del Cristo sappiamo subito di che cosa si tratta: quell’affresco racconta l’episodio dell’annunciazione. Di qui l’interpretazione degli affreschi segue con facilità: ogni nuova immagine viene infatti investita dalle attese che le precedenti hanno suscitato e il vedere assume naturalmente una piega proposizionale, poiché da ogni nuovo riquadro ci attendiamo che ci narri qualcosa e questo non in virtù della sua peculiare forma pittorica ma solo in ragione della sua appartenenza ad un ciclo narrativo. Abbiamo parlato di naturalezza, e tuttavia l’apparente naturalità dell’interpretazione narrativa delle immagini è soltanto l’esito cui conduce un invito sommesso, che è dapprima formulato a parole, ma che poi si traduce quadro dopo quadro in un’abitudine percettiva. La naturalezza è solo il risultato della ripetizione e non può dunque essere presa come un argomento per ancorare la narratività e lo spessore temporale delle immagini ad una qualche determinazione contenutistica che loro competa. E se la narratività delle immagini deriva dal contesto linguistico di un racconto che deve essere presupposto e che si insinua nella successione delle raffigurazioni, interpretandola narrativamente, allora sembra essere lecito sostenere che non vi è davvero bisogno di alcun sostegno intuitivo perché il nostro lento incedere di fronte alle stazioni del ciclo scandisca il tempo di un racconto: la narrazione non ha bisogno di altro se non del nostro desiderio di usare così ciò che scena dopo scena un ciclo ci mostra. Potremmo allora riformulare l’ipotesi da cui abbiamo preso le mosse in una forma più debole: perché il tempo di ricezione dell’immagine possa assumere le forme di una narrazione è sufficiente che ci si dica qual è la storia su cui il pittore intendeva intrattenerci e che sia possibile ritrovare i personaggi e i luoghi di quel narrare. Tutto il resto compete allo spettatore che deve dare alle scene che osserva tutto ciò che va al di là della natura statica delle immagini: la regola del prima e del poi ed il modo in cui è possibile applicarla alla scena dipinta.
Siamo giunti così a dare all’obiezione convenzionalistica che ci accompagna sin dai primi passi delle nostre riflessioni sulla temporalità delle immagini una forma più definita, ma proprio per questo diviene possibile mostrare che cosa la renda poco plausibile: il suo rescindere il nesso che lega la narratività delle immagini dalla loro natura sensibile. Il punto mi sembra essere questo: ricondurre la dimensione narrativa al di là del contenuto dell’immagine e sostenere che non vi è nulla nell’universo figurativo che possa motivare una lettura narrativa significa infatti sostenere che il racconto si aggiunge all’immagine come un commento esterno che non la scalfisce e che la trama temporale che alla narrazione compete non è cosa che si possa vedere e seguire con gli occhi. In altri termini: se l’immagine non racchiude in sé né successione né tempo e se la lettura narrativa non chiede che qualcosa nell’immagine sostenga la sua scansione temporale allora è legittimo sostenere che tra il racconto a parole che ci ripetiamo quando guardiamo un quadro e la scena dipinta vi è una relativa estraneità, poiché l’immagine non può fare altro che dare un volto ai personaggi e uno sfondo alle loro azioni. Quanto all’agire stesso di cui la narrazione ci parla, si deve rinunciare in linea di principio a raffigurarlo: non si può fare altro che ripetercelo, silenziosamente, mentre guardiamo il quadro.
 Una tesi chiara, ma che
non sembra rendere ragione del fatto che qualcosa muta sul terreno percettivo
quando qualcuno ci dice che un’immagine racconta qualcosa. Ecco, ora guardiamo Il
pagamento del Tributo che Masaccio ha dipinto nella Cappella Brancacci e,
non conoscendo quella strana storia, lasciamo correre lo sguardo sull’affresco,
secondo un ordine che è dettato dall’interesse percettivo del momento. Ma poi
qualcuno racconta la storia: viene imposto il pagamento di un tributo, e Gesù
che vuole segnare la distanza che lo separa da queste vicende terrene ordina
a Pietro di cercare il danaro nel luogo in cui meno ci si aspetterebbe di trovarlo
— nella bocca di un pesce — e di consegnarlo all’esattore. L’affresco è ancora
lo stesso e nulla muta nelle sue forme e nei suoi colori, ma ora che questa
storia c’è nota lo sguardo corre sulla tela seguendo un cammino prestabilito e
ricco di un nuovo senso. Ora la percezione muta e ci mostra un gesto che
domina su tutti gli altri: è il duplice ordine che Gesù impartisce a
Pietro. Di qui l’azione trae il suo senso, ed è per questo che Masaccio dipinge
quel duplice gesto di comando nel centro del quadro, relegando sullo sfondo la
pesca magica di Pietro e su un primo piano che sfugge alla vista il presente inessenziale
che ospita il pagamento del tributo e che trae il suo senso solo dall’essere la
risposta che segue al comando divino. Ciò che ora accade o che è appena
avvenuto è tutto racchiuso in quel gesto, e la logica temporale della narrazione
— il suo procedere da un passato che racchiude in sé ciò che comunque
avverrà — determina la disposizione delle figure nello spazio e insieme il
nostro dipanare l’immagine secondo le forme di un trascorrere dello sguardo che
è insieme eco di una temporalità narrativa. Ma se le cose stanno così, la
narrazione non accompagna l’immagine come se fosse una voce che non si lega al
suo contenuto, ma la compenetra e si pone come un invito a dare forma nuova
alla scena che si dipana di fronte ai nostri occhi.
Una tesi chiara, ma che
non sembra rendere ragione del fatto che qualcosa muta sul terreno percettivo
quando qualcuno ci dice che un’immagine racconta qualcosa. Ecco, ora guardiamo Il
pagamento del Tributo che Masaccio ha dipinto nella Cappella Brancacci e,
non conoscendo quella strana storia, lasciamo correre lo sguardo sull’affresco,
secondo un ordine che è dettato dall’interesse percettivo del momento. Ma poi
qualcuno racconta la storia: viene imposto il pagamento di un tributo, e Gesù
che vuole segnare la distanza che lo separa da queste vicende terrene ordina
a Pietro di cercare il danaro nel luogo in cui meno ci si aspetterebbe di trovarlo
— nella bocca di un pesce — e di consegnarlo all’esattore. L’affresco è ancora
lo stesso e nulla muta nelle sue forme e nei suoi colori, ma ora che questa
storia c’è nota lo sguardo corre sulla tela seguendo un cammino prestabilito e
ricco di un nuovo senso. Ora la percezione muta e ci mostra un gesto che
domina su tutti gli altri: è il duplice ordine che Gesù impartisce a
Pietro. Di qui l’azione trae il suo senso, ed è per questo che Masaccio dipinge
quel duplice gesto di comando nel centro del quadro, relegando sullo sfondo la
pesca magica di Pietro e su un primo piano che sfugge alla vista il presente inessenziale
che ospita il pagamento del tributo e che trae il suo senso solo dall’essere la
risposta che segue al comando divino. Ciò che ora accade o che è appena
avvenuto è tutto racchiuso in quel gesto, e la logica temporale della narrazione
— il suo procedere da un passato che racchiude in sé ciò che comunque
avverrà — determina la disposizione delle figure nello spazio e insieme il
nostro dipanare l’immagine secondo le forme di un trascorrere dello sguardo che
è insieme eco di una temporalità narrativa. Ma se le cose stanno così, la
narrazione non accompagna l’immagine come se fosse una voce che non si lega al
suo contenuto, ma la compenetra e si pone come un invito a dare forma nuova
alla scena che si dipana di fronte ai nostri occhi.
Del resto è solo se ci poniamo in questa prospettiva che ci invita a considerare la narrazione come un momento che si riverbera nella dimensione intuitiva dell’immagine che diviene possibile rendere conto della maggiore o minore capacità delle raffigurazioni di rendere visibile una storia. Perché il punto è ancora una volta questo: le immagini parlano agli occhi, e se talvolta comprendere il loro senso vuol dire anche immergersi nelle regole di un gioco linguistico, ciò non toglie che sia ragionevole attendersi che qualcosa nel contenuto dell’immagine sorregga quel gioco e lo renda facilmente percorribile. Possiamo tornare così, dopo un lungo cammino, alla nostra ipotesi, cui dobbiamo dare ora una forma più definita e chiara.
2. Un problema antico: il Laocoonte di Lessing
All’origine delle considerazioni che abbiamo appena proposto vi era un obiettivo ben preciso: volevamo raccogliere qualche riflessione che ci consentisse di rendere un poco più plausibile la tesi secondo la quale alle raffigurazioni non è preclusa la possibilità di parlarci in qualche modo del tempo e del suo divenire. Si tratta di una tesi che è stata più volte messa in questione, e in modo particolare Lessing ha ritenuto opportuno scrivere un saggio per convincere pittori e scultori a rinunciare alla tentazione del racconto.
Questo saggio è il Laocoonte, pubblicato nel 1766 a Berlino. Si tratta di un libro bello e importante, in cui si intrecciano in vario modo molti dei temi e dei problemi di un secolo, e se il nostro compito fosse quello di soffermarci sull’estetica settecentesca dovremmo osservare come in queste poche pagine, Lessing sappia proporre una risposta meditata e tutt’altro che superficiale a molte delle domande che attraversano il dibattito sulle arti: la riflessione sul gruppo marmoreo del Laocoonte diviene così l’occasione per pronunciarsi sulla questione degli antichi e dei moderni, sul concetto di imitazione e sulle sue diverse forme, ma anche sul rapporto tra ragione e sentimento, sulla natura del bello, sull’allegoria, sui rapporti tra parola ed immagine, sulla distinzione tra segni naturali e artificiali, e così via. Su tutti questi temi Lessing ha davvero qualcosa da dirci, e non vi è dubbio che per cogliere tutta la ricchezza delle sue considerazioni dovremmo assumere le vesti dello storico e collocare passo dopo passo ciò che Lessing afferma sullo sfondo di ciò che altri autori hanno detto, poiché solo se si comprendono le alternative possibili le tesi di Lessing assumono tutta la loro significatività.
Dovremmo, ma non lo faremo; ed anche se sono consapevole che questa è una rinuncia (e chi vuole avere un’idea di quante cose perdiamo può leggere ciò che Elio Franzini ha scritto nella sua Estetica del Settecento, Il Mulino, Bologna, 2003), vi invito a leggere queste pagine lessinghiane senza preoccuparci troppo di contestualizzarle, per cogliere invece ciò che possono insegnarci rispetto al problema che ci sta a cuore. E se ci poniamo in questa prospettiva è importante osservare che, per Lessing, vi è un’unità profonda, un legame che ci si svela non appena riflettiamo sul fine verso cui tendono e sul modo in cui ci consentono di raggiungerlo. Ora, lo scopo cui mirano la poesia e le arti figurative è racchiuso nell’idea del bello, e la bellezza è un valore che noi deriviamo dalla natura ma che risponde ad una regola che ha carattere generale e che ci consente di non declinare al plurale ciò che ci piace in un paesaggio, in un dipinto, in un poema. La bellezza è una sola, anche se può assumere forse diversi volti. All’identità dello scopo fa eco del resto l’eguaglianza del cammino percorso per giungervi: la poesia e le arti figurative raggiungono il bello, muovendosi sul terreno dell’illusione. L’una e l’altra «rappresentano oggetti assenti come se fossero presenti» (G. E. Lessing, Laocoonte, a cura di M. Cometa, Aesthetica, Palermo, 1991, p. 23) e sono quindi forme entro cui si realizza una riproposizione immaginativa della realtà, — una sua creazione coerente con il dettato soggettivo ed oggettivo della bellezza.
E tuttavia, riconoscere che la poesia e le arti figurative
sono legate da un nodo profondo non significa, per Lessing, sostenere che debbano
procedere sullo stesso terreno e che si possa davvero sposare il paradigma
rinascimentale dello ut pictura poesis. Tutt’altro: da questo precetto
della poetica rinascimentale che «ha prodotto in poesia la mania delle
descrizioni e in pittura l’allegorismo» (ivi,
p. 24) è necessario prendere le distanze, e per farlo Lessing ci invita a seguirlo
sul terreno di un’indagine che ha per tema un’opera d’arte  che,
riscoperta per caso nel 1506, doveva porsi come un esempio da imitare per la
cultura neoclassica: la raffigurazione marmorea del Laocoonte.
che,
riscoperta per caso nel 1506, doveva porsi come un esempio da imitare per la
cultura neoclassica: la raffigurazione marmorea del Laocoonte.
Della storia tragica di questo sacerdote, sbranato con i figli dai serpenti marini che Atena manda perché si compia al più presto il fato di Troia, aveva parlato anche Virgilio nella sua Eneide, e Winckelmann aveva notato che tra la descrizione poetica e la raffigurazione marmorea vi è una differenza importante: per Virgilio, Laocoonte alza grida terribili che giungono al cielo, come un toro ferito che sia sfuggito al colpo finale della scure [«clamores simul horrendos ad sidera tollit / qualis mugitus, fugit cum saucius aram / taurus et incertam excussit cervice securim» (Eneide, II, vv. 201-204)], mentre né lui né i figli sembrano urlare nel gruppo scultoreo di cui discorriamo. Una differenza importante che, per Winckelmann, è innanzitutto espressione di una diversa temperie culturale. La statuaria greca, ma non la poesia latina, è animata da una nobile semplicità e una quieta grandezza:
Come la profondità del mare che resta sempre in quiete, per quanto la superficie infuri, l’espressione nelle figure dei greci manifesta, in tutte le passioni, un’anima grande e composta. Quest’anima, nonostante le più atroci sofferenze, si palesa nel volto di Laocoonte e non solo nel volto. Il dolore che traspare in tutti i muscoli e tendini del corpo e che da solo, senza badare al viso e alle altre parti, quasi crediamo di sentire noi stessi al cospetto del ventre convulsamente contratto, questo dolore, dico, non si esprime affatto con segni di furore nel volto e nella posizione. Egli non leva nessun orribile grido come canta Virgilio del suo Laocoonte: l’apertura della bocca non lo consentirebbe; è piuttosto un sospiro angosciato e represso, come lo descrive il Sadoleto. Il dolore del corpo e la grandezza dell’anima sono distribuiti con eguale intensità, e quasi bilanciati nella struttura della statua. Laocoonte soffre, ma soffre come il Filottete di Sofocle: la sua miseria ci tocca l’anima; ma noi desidereremmo saperla sopportare come la sopporta questo grande (ivi, p. 25).
Una descrizione bella nella sua immagine iniziale, ma in fondo infelice, almeno in questo suo richiamare alla mente il Filottete di Sofocle che si lamenta e urla, proprio così come in molte opere della grecità urlano e si lamentano gli eroi e persino gli dei feriti. Nell’Iliade leggiamo che Ares ferito urla come se diecimila guerrieri urlassero insieme, e le grida di Ercole morente sono strazianti: se ne deve concludere, per Lessing, che ciò che per noi raffinati europei è divenuta una colpa — la manifestazione visibile delle emozioni — era per i greci una legittima manifestazione vitale. Così, almeno per Lessing, dobbiamo davvero accomiatarci da quest’immagine così composta della grecità e riconoscere che non può essere questa la ragione per la quale lo scultore del Laocoonte non ha fissato nel marmo le gesta del grido:
se è vero che il gridare quando si prova dolore può benissimo conciliarsi — e specialmente per i Greci — con la grandezza d’animo, allora il dare espressione ad un animo simile non può essere la ragione per la quale lo scultore non ha voluto imitare nel marmo questo gridare; deve esserci dunque un’altra ragione che lo induce a scostarsi dal suo rivale, il poeta, il quale esprime deliberatamente quelle urla (ivi, p. 28).
Il motivo di questa rinuncia deve essere cercato, per Lessing, nella specificità delle arti figurative e quindi nella peculiarità dei vincoli cui debbono ottemperare per potersi porre come arti del bello. La scultura e la pittura debbono creare l’illusione della bellezza, ma possono farlo soltanto riproducendo corpi belli, linee armoniche, forme composte. Ora, la sofferenza fisica e l’angoscia sono passioni che deformano il volto e che atteggiano il corpo secondo forme che non ne lasciano trasparire la bellezza. Di qui la ragione della tragica compostezza del Laocoonte: lo scultore
mirava alla somma bellezza, accettando i condizionamenti del dolore fisico, questo, in tutta la sua violenza deturpante, non si lasciava conciliare con quella. Egli lo dovette perciò mitigare; dovette ridurre le grida in sospiri; non perché il gridare tradisse un’anima volgare, ma perché stravolge il volto in modo disgustoso. Perché si immagini di spalancare la bocca a Laocoonte, e si giudichi. Lo si faccia gridare e si osservi. Era una figura che suscitava compassione perché esprimeva insieme bellezza e dolore; adesso è divenuta solo una brutta, ripugnante figura dalla quale volentieri si volge lo sguardo, perché la vista del dolore suscita dispiacere senza che nel contempo la bellezza dell’oggetto sofferente riesca a tramutare questo dispiacere nel dolce sentimento della compassione (ivi, p. 31).
Così, non è un caso se i pittori e gli scultori antichi non hanno mai rappresentato le Furie (ivi, p. 30) e se in generale la statuaria greca non rappresenta corpi deformi e lineamenti stravolti dalle passioni: se l’obiettivo delle arti figurative consiste nel rendere visibile il bello, ogni immagine che non si attaglia a questa regola dovrà essere senz’altro messa da parte.
Nel caso della poesia le cose sembrano differenti, e l’episodio di Tersite ne è una riprova: Omero non sembra turbato dal corpo deforme di questo soldato e anzi ritiene che l’insistere nella descrizione della sua bruttezza sia un prezzo che è opportuno pagare se si vogliono poter toccare le corde del ridicolo. E ciò che è vero nel caso delle pagine omeriche in cui si parla di Tersite, vale per molti altri passi poetici: Stazio descrive Venere come una Furia, Sofocle parla delle piaghe immonde di Filottete e, come sappiamo, Virgilio non si lascia trattenere dal descrivere le grida di Laocoonte. La poesia sembra, in altri termini, più libera della pittura e della scultura e nulla le vieta di seguire quelle strade che sono invece precluse alla scultura o alla pittura. La ragione di questa libertà, tuttavia, sembra riposare sul minore peso che la bellezza visibile gioca nelle pagine poetiche. La poesia è l’arte più comprensiva e dispone di bellezze che la pittura e la scultura non possono raggiungere: nulla di strano, dunque, se la poesia può creare l’illusione della bellezza senza per questo doversi necessariamente attenere soltanto alla sua dimensione fenomenica. Scrive Lessing:
Senza ricercare qui in che misura il poeta può riuscire a rappresentare la bellezza fisica, è tuttavia indiscutibile che, essendo aperto alla sua imitazione l’intero sconfinato regno della perfezione, l’involucro sensibile, sotto il quale la perfezione diviene bellezza, può essere solo uno dei mezzi minori tramite i quali può suscitare interesse per i suoi personaggi. Spesso egli trascura completamente questo mezzo, certo com’è che, una volta che il suo eroe si è guadagnato la nostra benevolenza, le sue qualità più nobili ci tengono così occupati che non pensiamo affatto alla sua figura fisica […]. Quando il Laocoonte di Virgilio grida, a chi viene in mente che per gridare occorre spalancare la bocca e che questa bocca spalancata è brutta? Basta che «clamores horrendos ad sidera tollit» sia un tratto sublime per l’udito, e sia quel che sia per la vista […]. Il Laocoonte grida, ma questo Laocoonte è appunto quello che conosciamo già ed amiamo come il più provveduto dei patrioti e il padre più amorevole. Non riconduciamo le grida al suo carattere, ma semplicemente alla sua insopportabile pena. Solo questa udiamo nelle sue grida; e il poeta solo attraverso queste grida poteva rendercelo sensibile. Chi dunque può ancora biasimarlo? Chi piuttosto non è costretto a riconoscere che se l’artista fece bene a non far gridare il suo Laocoonte, il poeta ha fatto altrettanto bene a farlo gridare? (ivi, pp. 34-35).
Sulla diversità delle forme di rappresentazione della poesia e delle arti figurative Lessing ci invita poi a riflettere attraverso un confronto che sorge da un’ipotesi storica, di cui oggi conosciamo al falsità. Quale sia il punto è presto detto: Lessing non sa che il Laocoonte è un gruppo marmoreo che risale al ii-i secolo a. C. e per questo prende seriamente in esame l’ipotesi che lo scultore abbia avuto sott’occhio la descrizione che Virgilio propone. Un’ipotesi falsa, ma interessante, poiché permette a Lessing di leggere le differenze tra la vicenda così come la narra Virgilio e così come la si è scolpita nel marmo come se fossero tutte motivate dalla specificità delle arti. Così Lessing può invitarci ad osservare che per l’immaginazione che sorge dalla lettura è lecito far avvolgere il collo e le membra due volte dalle spire dei serpenti, ma che questa descrizione non può essere seguita da chi intende raffigurare visivamente la scena, poiché il fascino visivo della scena chiede che si veda il corpo di Laocoonte, lo sforzo dei suoi muscoli, la tensione delle braccia e delle mani. Uno stesso criterio di visibilità costringe lo scultore a rappresentare nudi Laocoonte e i figli, laddove il poeta può, più verosimilmente, pensarli vestiti. Di qui la conclusione che Lessing ci propone: lo scultore si lascia guidare dalla descrizione che di questa vicenda così drammatica ci viene proposta dall’Eneide, ma deve poi necessariamente correggerla quando il poeta si discosta dalle esigenze della visibilità e segue le strade che gli sono proprie. Non sempre ciò che è bello per il poeta è bello anche per lo scultore, e questa constatazione di carattere generale deve valere come un segno della diversa ricchezza tematica che caratterizza la scultura e la poesia. La scultura e la pittura parlano agli occhi: il terreno che loro compete è interamente circoscritto dalla sfera della visibilità. La poesia, invece, è libera da queste restrizioni e può muoversi liberamente su differenti terreni. Nessuno può costringere il poeta a parlare soltanto per gli occhi.
Il senso di queste considerazioni è di per sé sufficiente per giustificare il sottotitolo che Lessing dà alla sua opera: Laocoonte, ovvero dei confini della pittura e della poesia. E tuttavia Lessing non si ferma a questa constatazione e ci invita di fatto a riflettere su quelle opere letterarie che sono, per così dire, pronte a saldare il loro debito con la dimensione intuitiva del vedere. Che simili opere vi siano è indubbio: talvolta, quando leggiamo un poema o un romanzo, siamo colpiti dalla capacità dell’autore di costruire sotto i nostri occhi la scena narrata e parte del fascino della lettura deriva dalla vivacità del quadro che dinnanzi a noi ha preso forma. E se di quadri poetici è lecito parlare, perché non dire che vi sono poeti e narratori che hanno un vivo senso pittorico e perché non sostenere che, in questo caso, pittura e scultura possano davvero aderire alla pagina scritta? Si tratta di una tesi apparentemente plausibile su cui Lessing ci invita a riflettere, guidandoci nella lettura delle pagine del conte di Caylus che, in un libro un tempo famoso (Tableaux tirés de l’Iliade, de l’Odyssée d’Homere et de l’Eneide de Vergile, avec des observations generales sur le Costume, Paris, 1757), si era chiesto che cosa mai avrebbe potuto essere la storia della nostra pittura se i pittori avessero tratto la loro ispirazione non già dalle pagine intuitivamente scarne dei Vangeli e della Bibbia, ma da un poeta visivo come Omero.
Questa pensiero curioso doveva assumere la forma seria di un progetto erudito, e Caylus ci invita a seguirlo nel discutibile progetto di costruire a parole molti dei quadri che non sono stati dipinti, ma che Omero aveva già delineato nella vividezza delle sue immagini. La parola sostituisce così il pennello e il quadro poetico trova con apparente facilità la via per divenire propriamente visibile — per trasformarsi un quadro fatto di tela e pigmenti. Una tesi curiosa, appunto, su cui pesa, per Lessing, un’incomprensione di fondo: Caylus crede che là dove il poeta ha saputo animare le sue descrizioni di elementi visivi, si annidino ottimi soggetti per le arti figurative. Ma così non è, almeno per Lessing, ed è in questa luce che debbono essere lette le pagine che egli dedica ai quadri che Caylus suggerisce di dipingere ad un qualche obbediente pittore. Alcuni di questi quadri potrebbero essere davvero felici — e tra questi Lessing rammenta il dipinto del banchetto degli dei[20]; altri sembrano invece difficilmente realizzabili e resterebbero comunque al di sotto della bellezza della narrazione poetica — ed è questo il caso della descrizione della pestilenza, causata dalle ire del dio Apollo[21]; in entrambi i casi, tuttavia, la corrispondenza con il testo poetico viene meno: la scena del banchetto è poeticamente ben poca cosa, anche se ne può derivare un bel quadro, laddove la scena della pestilenza è poeticamente felice, anche non si traduce facilmente in un’immagine. In un caso il poeta è privo dei colori e delle luci che rendono bello un quadro, nell’altro è il pittore a lamentare la staticità delle sue immagini, il loro essere priva di quella vita che, per Lessing, percorre le parole e i versi del poeta, ma non la tela e i pigmenti del pittore. E se così stanno le cose, Caylus sbaglia, e con lui sbagliano coloro che credono di poter ricondurre la pittura alla poesia, laddove quest’ultima si fa ricca di quadri e si accosta alle esigenze dell’intuizione:
vi sono vicende che si possono dipingere e vicende che non
si possono dipingere e lo storico può
narrare quelle che meglio potrebbero dipingersi in modo non pittorico, così
come il poeta può rappresentare le meno dipingibili nel modo più pittorico. Ci
si lascia sedurre dall’ambiguità della parola, se si considera la cosa
altrimenti. Un quadro poetico non è necessariamente una cosa che si può
trasformare in un dipinto materiale; piuttosto ogni tratto, ogni combinazione
di tratti diversi tramite i quali il poeta ci rende così sensibile un oggetto
che ne prendiamo conoscenza più distintamente delle sue stesse parole, si
chiama “pittorico”, si chiama “quadro”, poiché ci avvicina a quel grado di illusione
di cui sono particolarmente capaci i quadri materiali (ivi, p. 69).
E se questa conclusione è vera, se il grado di illusorietà di una poesia non coincide con la sua riconducibilità ad un dipinto materiale, è necessario chiedersi che cosa fa sì che una scena poetica intuitivamente ricca come la pestilenza causata dal dio Apollo non possa diventare un bel quadro e, correlativamente, che cosa rende poco interessanti per il poeta scene vivide e ricche di dettagli preziosi come un banchetto di divinità pagane? Il nodo della questione è qui, e Lessing ritiene di avere una risposta a questa domanda: la pittura e la scultura sono arti che nascono per rendere visibile una scena statica, ma sono inadatte là dove la bellezza e la ricchezza intuitiva sorgono dal dipanarsi dell’azione. La pittura non ha tempo ed è condannata alla staticità del presente; la poesia non ha spazio, e costruisce tutto nella temporalità del discorso: di qui la loro radicale differenza. Ma anche il diverso senso che spetta all’illusione. Il pittore illude ponendo sotto i nostri occhi una scena nella sua statica visibilità; il poeta invece racconta, e affida alle parole che si susseguono nel tempo il compito di guidare l’immaginazione lungo un cammino mobile e vario. Siamo giunti così alla tesi principale del Laocoonte, cui Lessing sente di dover dare forma argomentativa:
Io argomento come segue: se è vero che la pittura adopera per le sue imitazioni mezzi o segni completamente diversi da quelli della poesia; ovvero quella adopera figure e colori nello spazio, mentre questa suoni articolati nel tempo; e se i segni debbono avere un rapporto adeguato con il designato, allora i segni ordinati l’uno accanto all’altro possono a loro volta avere soltanto oggetti esistenti l’uno accanto all’altro, o le cui parti esistono l’una accanto all’altra, mentre segni che si susseguono possono esprimere oggetti che si susseguono o parti che si susseguono. Oggetti che esistono l’uno accanto all’altro o le cui parti esistono l’una accanto all’altra si chiamano corpi. Di conseguenza sono i corpi con le loro qualità visibili i veri oggetti della pittura. Oggetti che si susseguono l’un l’altro, o le cui parti si susseguono, si chiamano in generale azioni. Di conseguenza le azioni sono i veri oggetti della poesia (ivi, p. 70).
Si tratta di una tesi che va, almeno in parte, precisata, poiché è almeno dubbio che il linguaggio scritto (i cui segni coesistono) raffiguri oggetti diversi da quello parlato o che, in generale, una proposizione non possa asserire nulla di coesistente solo perché pronunciamo e comprendiamo le parole nel tempo. Un senso, tuttavia, queste considerazioni l’hanno: se la poesia si avvale di parole e se le parole si susseguono nel tempo, la comprensione non assumerà la forma di un dipinto in cui tutto è compresente, ma sarà scandita nel tempo, in un processo in cui il nuovo si sostituisce al vecchio rubandogli la scena. Per questo la descrizione è, in quanto tale, impoetica: perché la parola ottiene lentamente, e sempre di nuovo smarrisce, ciò che insieme si consegna ad un unico rapidissimo sguardo. Ma se le descrizioni sono impoetiche, le azioni non sono pittoriche, ed è per questo che si deve sostenere che la pittura e la scultura sono arti che hanno come loro oggetto la bellezza dei corpi e non la narrazione di una fabula.
Certo, la poesia e le arti figurative sono vicini tolleranti e possono quindi permettere piccole intrusioni di campo. Il poeta può descrivere, ma per Lessing è importante sottolineare che le descrizioni poetiche assumono spesso una forma narrativa ed affidano il loro successo ad una prassi che è volta a leggere nella bellezza la grazia, nella coesistenza statica il divenire. Così, della descrizione di Alcina che Ariosto propone nell’Orlando furioso, Lessing salva quei versi in cui la bellezza si fa grazia mettendosi in movimento: gli occhi di Alcina non sono belli perché sono neri e lucenti, ma perché sono «pietosi a riguardar / a mover parchi». Quanto poi allo scudo di Achille, per Lessing
Omero non dipinge lo scudo come qualcosa di perfettamente compiuto, ma come qualcosa in divenire. Egli dunque si è avvalso anche qui del lodato artificio di trasformare gli elementi coesistenti del suo oggetto in elementi consecutivi, creando in tal modo dalla noiosa pittura di un corpo il vivido quadro di un’azione. Non vediamo lo scudo ma il divino artefice che lo forgia (ivi, p. 82).
Qualcosa di simile vale anche per la pittura, cui non si può del tutto negare il diritto a sporgersi seppure di poco al di là della fissità dell’istante. Così come la poesia allude ai corpi e alla loro ordinata coesistenza spaziale disponendoli nel medium dell’azione, così la pittura può parlarci delle azioni, mostrandoci i corpi e disponendoli in modo tale da costringerci ad immaginare uno sviluppo. I corpi sono nello spazio, ma appartengono alla catena temporale delle cause:
tutti i corpi non esistono solo nello spazio, ma anche nel tempo. Essi perdurano, e possono apparire in ogni momento della loro durata, e in combinazioni differenti. Ognuna di queste apparizioni e combinazioni momentanee è il frutto di una precedente e può essere la causa di una successiva, ed è perciò, per così dire, il centro dell’azione. Di conseguenza la pittura può anche imitare le azioni, ma solo allusivamente, tramite i corpi (ivi, p. 71).
Di qui l’aprirsi di una via per la pittura narrativa. Una raffigurazione può narrare perché può scegliere di rappresentare i corpi, fissandoli in un istante che non basti a se stesso, ma che ci costringa ad immaginare uno sviluppo possibile. Gli eventi sono connessi causalmente e dipendono gli uni dagli altri: il compito del pittore che voglia narrare consisterà allora nel fissare l’immagine in un istante essenzialmente transitivo, in un momento che ci costringa a percorrere la catena causale nell’una e nell’altra direzione, proiettando così la dinamica temporale delle attese sulla scena presente, nella sua staticità:
la pittura, nelle sue composizioni coesistenti, può utilizzare solo un singolo momento dell’azione e deve perciò scegliere il più pregnante, sulla base del quale soltanto si rende più comprensibile ciò che lo precede e ciò che lo segue (ivi, p. 71).
Lessing non si sofferma a lungo sulla natura di questo momento pregnante, ma un tratto sembra essere comunque certo: un momento è pregnante se è tale da lasciare libero corso alla fantasia, se — in altri termini — non basta a se stesso, ma ci costringe a spingerci oltre. Compito del pittore è dunque quello di scegliere momenti che non riassumano in sé l’unità del decorso di un’azione ma vi alludano, costringendo lo spettatore all’onere di uno sviluppo immaginativo. Scrive Lessing:
È fecondo soltanto quel momento che lascia libero gioco all’immaginazione. Quanto più guardiamo, tanto più dobbiamo poter immaginare. E quanto più immaginiamo, tanto più dobbiamo credere di vedere. Nell’intero decorso di un affetto, tuttavia, non vi è nessun momento che goda di meno di questa capacità del suo acme. Al di sopra di esso non vi è nulla e mostrare allo sguardo il punto estremo di uno sviluppo significa tarpare le ali alla fantasia. Così, poiché la fantasia non può più spingersi oltre l’impressione sensibile, la si costringe ad occuparsi di immagini più deboli che precedono la sensazione, di quelle immagini al di là delle quali la fantasia teme la pienezza sensibile dell’espressione che funge loro da limite. Quando Laocoonte sospira, l’immaginazione può sentirlo gridare; se invece grida, essa non può fare un passo in avanti o indietro rispetto a questa rappresentazione, senza per questo vederlo in una situazione più sopportabile e quindi meno interessante. Lo sente gemere, oppure lo considera già morto (ivi, p. 33).
Il momento fecondo è dunque quel momento che mette in moto l’immaginazione e che costringe lo sguardo a considerarsi come parte di un decorso. Ciò che vediamo di per sé non basta, e lo sguardo deve legarsi all’immaginazione e continuare un processo di sviluppo che non è ancora giunto alla meta. Del resto, nota Lessing, in questo percorso l’immagine può sostenerci in qualche modo — creando un qualche sfasamento temporale. Un’immagine raffigura un presente, ma è comunque possibile ampliare l’istante raffigurato trasformandolo in uno sviluppo e disponendo le figure secondo la regola di un divenire. La coesistenza trapassa così in una successione, seppure immaginativa:
non voglio ricordare a questo proposito che nei grandi quadri narrativi il momento singolo è quasi sempre un po’ ampliato, e che forse non vi è neppure un solo quadro ricco di personaggi in cui ogni figura abbia perfettamente il movimento e la posizione che dovrebbe avere nel momento dell’azione principale; l’una l’ha un po’ antecedente, l’altra un po’ posticipata. (ivi, p. 80).
Si tratta di un’osservazione interessante e ricca di possibili sviluppi, su cui tuttavia Lessing non si sofferma. E non a caso: di fatto, ciò che a Lessing interessa non è tanto mostrare la possibilità della narrazione nelle immagini, quanto la differenza tra poesia ed arti figurative. Così, invece di invitarci a riflettere ulteriormente sulle ragioni che legittimano una simile prassi e che le consentono un successo sul terreno espressivo, Lessing si sofferma sul paragone tra poesia e pittura, per tracciare più nettamente il discrimine che gli interessa. Così alle riflessioni sulla falsa coesistenza delle figure in un’immagine Lessing affianca la prassi del poeta che descrive cercando di fingere la coesistenza anche là dove a rigore vi è successione.
A partire di qui si dovrebbe muovere per tentare di definire non soltanto le ragioni storiche che spingono Lessing a rifiutare il detto oraziano dello ut pictura poesis, ma anche le linee generali della poetica che di qui prende forma — una poetica orientata in chiave neoclassica. A noi tuttavia non spetta questo compito e possiamo fermarci qui, per cercare nella prossima lezione di dare ascolto alle osservazioni di Lessing sulle possibilità narrative delle immagini.
Lezione diciottesima
1. La narrazione e il presente esteso
Dopo la nostra breve digressione sul Laocoonte e sui rapporti tra scultura e poesia, possiamo tornare al nostro problema. E con un risultato nuovo: per quanto Lessing voglia invitarci ad abbandonare il sentiero tracciato dalla pittura rinascimentale, un passo nella sua opera ci invita a riflettere sul fatto che la raffigurazione di una scena può spingere l’immaginazione al di là del dato, integrando ciò che è propriamente percepito con ciò che è lecito attendersi.
Si tratta di un’affermazione importante che vorrei cercare di rendere un po’ più precisa, liberandola dalla vaghezza che la caratterizza e che può essere tollerata solo finché ci si muove nel contesto problematico del Laocoonte. Ora, il problema di cui Lessing ci parla quando osserva che vi sono momenti fecondi ci riconduce, in primo luogo, ad una caratteristica strutturale della percezione: ciò che ora vedo ha un senso determinato solo perché si colloca in un orizzonte temporale in cui ogni nuova fase appare da un canto come continuazione di ciò che è appena stato e, dall’altro, come il fondamento di un insieme di attese che saranno confermate o deluse da ciò che accadrà. Ma ciò è quanto dire che il futuro è anticipato dal presente che è, in questo senso, necessariamente un momento fecondo, poiché racchiude in sé un rimando a ciò che accadrà.
Di questa struttura temporale che accompagna ogni nostra esperienza possiamo cercare di rendere conto muovendo dalla percezione di un evento — una goccia di inchiostro che cade nell’acqua e lentamente si dissolve per divenire poi impercettibile. Basta riflettere su questo piccolo accadimento per rendersi conto che il processo percettivo si dipana necessariamente in una direzione e che il senso che spetta ad ogni sua singola fase è dato dal suo essere la continuazione della fase precedente e dal suo porsi come il termine medio che conduce a ciò che presto accadrà. Ciò che percepiamo ha un ordine di decorso che si scandisce nel divenire dei fenomeni e ciò è quanto dire che un qualunque istante P(n) della scena che ci sta sotto gli occhi ha il senso che gli spetta solo perché si pone da un lato come antecedente di P(n+1) e, dall’altro, come successore di P(n-1), come successore del successore di P(n-2), e così di seguito. Potremmo allora esprimerci così: il senso percettivo del punto P(n) non dipende soltanto dal suo occupare l’ennesimo posto in una successione, ma dall’insieme di relazioni temporali che fa sì che l’istante presente P(n) si comprenda per ciò che è nel suo correlarsi a P(n-1) come al suo antecedente, a P(n-2) come all’antecedente del suo antecedente, a P(n+1) come al suo successore, e così via. Il senso di ogni singolo “ora” si ricava così dalla prospettiva che lo lega al suo futuro più prossimo e al suo passato recente, che debbono apparirci secondo una regola di modificazione che è determinata da ciò che è attualmente presente. Il significato esperito dell’istante di tempo che viviamo trae così la sua forma dalla relazione che lo lega ad altri istanti, — agli istanti passati e futuri, colti secondo l’indice di modificazione temporale che li lega alla prospettiva del presente.
Ora, vi è uno strumento matematico molto semplice per esprimere un punto in relazione ad un duplice ordine di variazione: gli assi cartesiani. E degli assi cartesiani Husserl si avvale per costruire il suo primo diagramma temporale:
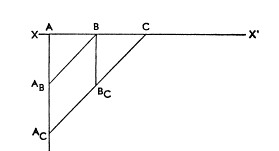
Si tratta di un diagramma che Husserl elabora tra il 1904 e il 1905 e che ci appare fin da principio come una complicazione della raffigurazione classica del tempo come una retta. Quell’immagine non è falsa ma non basta, e allora sotto l’asse delle ascisse dobbiamo tracciare l’asse delle ordinate, per creare uno spazio che restituisca al concetto di tempo la molteplicità della sua natura relazionale. Nel manoscritto da cui questo primo diagramma è tratto, Husserl ci invita a leggere così lo schema che ci propone:
XX’ sia la linea del tempo obiettivo. In essa solo un punto per volta è reale; lo sprofondare nel passato lo indichiamo attraverso ordinate in quanto riportiamo l’intervallo di tempo che A ha percorso sull’ordinata tracciata in A. Allora le linee diagonali ci danno un’immagine dei contenuti del campo temporale originario. Ogni linea diagonale contiene i gradi temporali del contenuto per il punto finale. In essa tutti i punti sono ovviamente simultanei (E. Husserl, Lezioni per la fenomenologia della coscienza interna del tempo, a cura di A. Marini, Angeli, Milano, 1981, p. 243).
Il senso di queste osservazioni è chiaro. Husserl traccia dapprima la retta del tempo obiettivo, su cui dispone gli eventi obiettivi nel tempo — per es., la successione di tre suoni A, B e C che durano per un certo intervallo di tempo A∩C. Ma questa rappresentazione, lo abbiamo dianzi osservato, è insoddisfacente se si vuole raffigurare il senso temporale della successione A∩C. Perché questo senso si faccia avanti è necessario raffigurare anche la relazione che ogni singolo istante di tempo obiettivo intrattiene con gli istanti di tempo trascorsi, e ciò significa innanzitutto rammentare che la prospettiva che lega l’istante (A) al presente muta ad ogni nuovo “ora”, e muta quindi anche il modo in cui (A) si dà alla coscienza. La mia esperienza del divenire passato di (A) non è dunque null’altro che questa: il mio cogliere il modificarsi della relazione che lega l’istante (A) al presente, il movimento continuo che dalla relazione di coincidenza — (A) coincide con il punto ora — ci conduce alla relazione di antecedente, di antecedente dell’antecedente, e così via, in un’iterazione idealmente aperta, ma che conduce infine allo sprofondare di (A) oltre la soglia della dimenticanza[22].
Di qui le ragioni che spingono Husserl a complicare il suo diagramma. La retta del tempo obiettivo deve divenire così l’asse delle ascisse su cui costruire per (A) l’asse delle ordinate, e su questo asse raffiguriamo tutti i valori di ordinata di uno stesso valore di x. Ora, se puntiamo il compasso nell’origine e riportiamo sull’asse delle y i punti che scandiscono l’intervallo temporale A∩C, avremo sull’asse delle y tutte le modificazioni di relazione temporale che uno stesso istante (A) — sprofondando nel passato — intrattiene con un sempre nuovo presente. Avremo così (AB) nell’istante presente (B), (AC) in (C), (AN) in (N), e così di seguito. E ciò che è vero per (A,) (B) o (C), vale anche per tutti i punti intermedi, con cui ogni singolo istante di tempo intrattiene una relazione temporale.
Possiamo allora concludere che se congiungiamo un punto qualunque del tempo obiettivo — (C), per es. — con la C-esima modificazione di luogo temporale che (A) subisce nel suo sprofondare nel passato, allora avremo una diagonale AC-C che ospita, per ogni istante temporale obiettivo racchiuso nell’intervallo A∩C, la modificazione temporale che gli corrisponde in C e che gli spetta in ragione della sua distanza rispetto al nuovo presente. Husserl parla a questo proposito di gradi temporali di un contenuto, del campo temporale per un punto dato o, negli scritti più tardi, del continuo di fase di un punto “ora”, ma il senso è comunque chiaro: la diagonale raccoglie l’orizzonte temporale del presente, disponendo il punto “ora” sullo sfondo temporale che gli appartiene — sullo sfondo degli istanti di tempo appena trascorsi, così come ci appaiono in virtù dell’indice di modificazione temporale che attesta la loro distanza dal presente. Avere esperienza del tempo vuol dire allora, per Husserl, esperire l’istante presente sullo sfondo degli istanti appena decorsi e degli istanti che stanno per farsi avanti, e ciò è quanto dire che la percezione del presente deve apparirci legata alla ritenzione del tempo appena trascorso e alla protenzione degli istanti che stanno per realizzarsi.
Nelle Lezioni sulla
coscienza interna del tempo questo schema è leggermente modificato:
![]()
A P E
A’ P’ ![]()


![]()
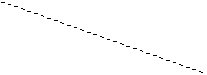
A’’
![]()
linea dell’oblio
Su questo nuovo schema dobbiamo soffermarci un poco, e non soltanto perché ripropone in una forma più nota (e forse più perspicua) ciò che Husserl ha da dirci sul tempo, ma anche perché vi è un tratto che ci consente di orientare le nostre riflessioni in una direzione propizia, — ed alludo alla scelta husserliana di vincolare il diagramma all’illustrazione di un evento che occupa l’intervallo di tempo A∩P. Si tratta di un evento trascorso: (P) è ormai passato ed è solo ritenzionalmente presente nella forma (P’) come sfondo temporale del punto “ora” — il punto (E). Se poi ci disponiamo in una prospettiva soltanto formale, non vi è dubbio che il punto (E) dipenda nel suo senso temporale dal suo correlarsi con gli istanti di tempo che ne costituiscono l’orizzonte: vivere un istante di tempo attribuendogli il senso del presente vuol dire cogliere il punto nel quale ci si trova come successore di ciò che è appena stato e come antecedente dell’attimo che tra poco calcherà la scena temporale. Dal punto di vista formale, dunque, il tempo è infinito, e non ha alcun senso parlare di punti che segnino un confine nel suo dipanarsi continuo: anche in questo caso, dunque, l’immagine del tempo come una retta ha qualcosa da insegnarci.
Le cose mutano quando alla dimensione formale affianchiamo la dimensione contenutistica, e lo schema husserliano sembra evidentemente alludere a questa possibilità. Ora rivolgiamo l’attenzione ad un evento qualsiasi: una goccia d’acqua si stacca dal rubinetto e cade, e questo sgradevole evento occupa l’intervallo di tempo A∩P. Altri eventi simili seguiranno, ma ciò non toglie che il cadere di questa goccia abbia comunque un inizio e una fine nel tempo, e che proprio per questo si possa dire che, dopo che (P) è trascorso e ha varcato le soglie della presenza per farsi passato, si è chiusa una parentesi temporale: qualcosa è terminato, e il nuovo presente — che per essenza appartiene alla continuità formale del tempo — si pone come un nuovo inizio, come l’apertura di una vicenda nuova che non chiede necessariamente di essere contenutisticamente legata a ciò che è stato. Il tempo è continuo, ma nella nostra esperienza la discontinuità occupa comunque un suo posto, e noi di fatto abbiamo esperienze di cose che nascono e muoiono, di eventi che hanno un inizio nel tempo e che nel tempo si chiudono senza pretendere di essere necessariamente colti sullo sfondo di una qualche relazione causale che li connetta a ciò che sarà. Gli accadimenti hanno appunto questa forma: hanno un inizio, una loro interna continuità che è determinata dai nessi contenutistici che legano le une alle altre le fasi in cui si scandiscono, e hanno anche una fine, un punto in cui la parentesi temporale si chiude, permettendo che un’altra se ne apra.
Vorrei cercare di chiarire il senso di queste considerazioni e per farlo dovremo accettare di immergerci in una serie di esempi. Ora qualcuno lancia una boccia sul terreno di gioco e io la vedo correre veloce sulla terra battuta, ma non vi è davvero bisogno di guardare le smorfie del giocatore o la mimica partecipativa dei suoi gesti per convincersi che la boccia si fermerà un poco più in là della meta prescelta: che così andranno le cose lo vediamo, ed ogni nuova fase del decorso percettivo ci avverte del progressivo arrestarsi di quel movimento e insieme prepara il luogo temporale in cui quell’evento potrà dirsi concluso e il punto dello spazio in cui ciò accadrà. Ora la boccia è ferma e l’evento è concluso: non ci attendiamo nulla di nuovo, anche se il tempo non si è per questo fermato e la fisica ci assicura che l’evento cui abbiamo assistito continua in qualche modo nel movimento dell’aria, di qualche granello di sabbia, nel calore della boccia e così di seguito. Ma tutto questo per la percezione non c’è: vi è invece l’aprirsi e il chiudersi di un evento, e quindi anche il porsi di una fase percettiva — la fase finale — come momento che non ci fa più attendere nulla di nuovo e che tuttavia giunge come una conferma del senso che animava la percezione sin dalle prime battute di quel movimento. La boccia, appunto, lentamente si ferma, e nel suo fermarsi trovano soddisfazione le attese che il decorso percettivo ha sollevato e che si erano imposte alla percezione determinandone il senso. Ma ciò è quanto dire che la fase finale del movimento è anche il luogo temporale che soddisfa la regola che caratterizza l’intera unità del decorso e che ne introduce una nuova: ora che si è fermata, ci attendiamo che la boccia resti dov’è, e ci meraviglieremmo se improvvisamente tornasse sui suoi passi per avvicinarsi al boccino. Questa attesa, tuttavia, non aggiunge nulla all’evento trascorso e la sua conferma non ci parla più di ciò che è appena stato: la boccia ora è ferma e il suo movimento appartiene ad un passato che non è più necessario ricordare. Quando giunge in (P), lo sviluppo temporale chiude una fase contenutisticamente determinata, e l’evento sprofonda nel passato come un’unità di senso relativamente conclusa, che attraverserà insieme la soglia dell’oblio la cui distanza dal presente è dunque mutevole. Ma ciò è quanto dire che nell’unità di un decorso non tutte le fasi sono caratterizzate in modo eguale: alcune appartengono alla continuità di un cambiamento e ne dipendono quanto al loro senso poiché ne continuano la regola; altre invece segnano i confini di quel mutare e ne sono relativamente indipendenti, poiché segnano l’inizio di una nuova durata — il tempo in cui il movimento è cessato e l’oggetto è tornato a far parte dello sfondo su cui altri eventi prenderanno forma.
Di qui possiamo muovere poi per complicare un poco il nostro esempio. Lasciamo da parte le bocce e lanciamo una palla per osservare i rimbalzi che, cadendo, essa compie: la palla cade, tocca il terreno, risale fino ad una certa altezza e poi nuovamente cade, secondo una regola che è dettata dalla forza di gravità e dall’elasticità dei materiali, ma che percettivamente si dispiega in un progressivo avvicinarsi degli estremi tra cui il movimento oscilla — la terra e il culmine della salita — e da un’apparente accelerazione del movimento. Ora, questo movimento così consueto ha una struttura fenomenologica complessa: vi sono innanzitutto due momenti temporali che godono di una relativa indipendenza e che segnano nel tempo una discontinuità contenutistica — il momento dell’inizio e della fine del processo. Ma all’interno di questa parentesi temporale vi sono altre fasi del decorso che sembrano godere di una relativa autonomia poiché anch’esse segnano il porsi di una discontinuità: giunto al suo acme, il movimento si ferma e muta di segno e lo stesso accade quando la palla, cadendo, tocca il terreno, per spiccare subito dopo il suo balzo verso l’alto. In entrambi i casi la regola percettiva su cui si fonda l’unità del processo muta di segno, e la voce di ciò che è appena trascorso può essere tacitata, poiché non ci dice nulla che sia utile per comprendere ciò che ora si dipana sotto i nostri occhi: ora la palla non precipita più verso terra ma sale in alto, ora invece — dopo essere giunta al suo culmine — riprende a cadere. Certo, tra questi due momenti vi è comunque una differenza percettiva — prima di ricadere la palla si ferma e il punto di massima altezza è anche il luogo della conferma delle attese percettive, laddove il punto del rimbalzo è caratterizzato percettivamente da una discontinuità radicale e da una repentina delusione delle attese.
Di qui si potrebbe muovere per osservare che la struttura delle protenzioni e delle ritenzioni si spinge al di là di ogni singola fase: noi vediamo che la palla continua a rimbalzare e che tra poco si fermerà, e ciò è quanto dire che l’orizzonte temporale della percezione non è racchiuso in ogni singolo intervallo di oscillazione ma lo supera consentendoci di vedere che gli intervalli si fanno sempre più piccoli e tendono verso il punto della loro coincidenza — verso il luogo della stasi.
Su questi temi si potrebbero dire molte altre cose, ma possiamo accontentarci di queste poche osservazioni, che tuttavia ci consentono di dare una cornice più definita ai problemi cui Lessing alludeva quando invitava il pittore a vincolare la narrazione pittorica alla raffigurazione dei momenti fecondi, — di quei momenti, cioè, che lasciano libero gioco all’immaginazione e che la costringono ad integrare la scena presente alla luce di un possibile sviluppo. E che non tutti i momenti siano egualmente fecondi è una conclusione che sembra possibile trarre proprio dalle considerazioni che abbiamo appena proposto: ogni istante si inserisce in una continuità temporale ed ogni punto “ora” è contenutisticamente connesso agli istanti che lo precedono e che lo seguono, ma questo appunto non significa che tutte le fasi che appartengono ad un decorso percettivo siano caratterizzate da un eguale rapporto di dipendenza rispetto alla regola che sorregge la percezione di un evento determinato.
Potremmo allora esprimerci così: un momento è fecondo, nel senso di Lessing, se è tale da non porsi come il limite verso cui unitariamente tendono le attese che un determinato evento solleva, poiché se questo accade — se ad essere colta è quella fase del decorso percettivo che è indicata dalla regola e che ne garantisce la conclusione prefigurata — all’immaginazione non è lasciato alcuno spazio e la percezione riposa in se stessa.
Ora, forse, ci sembra plausibile attribuire un significato un poco più definito alla tesi secondo la quale vi sono momenti fecondi, e tuttavia — per quanto questa conclusione possa sembrarci plausibile — ciò che Lessing sostiene non basta per cavarci di impaccio, e questo proprio perché la possibilità di distinguere il modo di appartenenza delle fasi di un decorso percettivo alla regola che lo sorregge non ci dice nulla circa la possibilità di trasporre queste stesse considerazioni sul terreno figurativo. E per una ragione relativamente ovvia: perché si possa parlare di attese e di regole di un decorso percettivo è necessario che la percezione si sia già spinta al di là della puntualità del presente e che nella continuità del tempo si sia manifestata una regolarità che giustifichi la proiezione nel futuro di quelle stesse strutture che si sono attestate nel passato recente della percezione. Così, perché possa attendermi che la boccia infine si fermi, debbo aver già osservato il suo incedere sempre più lento ed incerto sulla terra battuta: se ciò non accadesse e se avessi esperienza soltanto di un istante di tempo non avrei possibilità di cogliere ciò di cui pure la percezione ci parla — il muoversi della boccia ed il suo indicare percettivamente il luogo in cui tra breve si fermerà. Ma se la durata temporale del decorso percettivo fosse contratta nell’unità di un istante e fermata nello scatto di una macchina fotografica, allora non potremmo percettivamente decidere se la boccia si muove ancora oppure è già ferma, perché nulla nell’immagine che abbiamo sotto gli occhi muterebbe se fosse già trascorso il tempo che conduce dal suo attuale muoversi al suo fermarsi. E se la possibilità di cogliere la regola percettiva che fa di una fase di decorso un momento fecondo poggia sulla continuità di un presente esteso che consenta il formarsi di attese percettive, non sembra avere alcun senso chiedere al pittore di dipingere momenti di tale natura poiché la loro capacità di “dar libero corso all’immaginazione” non può essere disgiunta dal costituirsi nel tempo della dinamica protenzionale. Un momento non è fecondo in sé, ma lo è in virtù delle attese che, nel tempo, arricchiscono il senso della percezione, e ciò sembra dire che un momento fecondo è tale soltanto quando appartiene ad un decorso percettivo. Chiedere ad un’immagine di raffigurare un momento fecondo sarebbe allora semplicemente privo di senso.
Per rispondere a questa obiezione si potrebbe rammentare che noi abbiamo comunque un’esperienza del mondo e che determinate attese sono comunque presenti, poiché — per esempio — sappiamo che un corpo pesante che si libra nel vuoto cadrà o che una freccia sospesa nel cielo sta, con buona pace di Zenone, raggiungendo comunque il suo bersaglio. Certo, il rimando all’esperienza passata ci assicura che così andranno le cose ma non basta per farci vedere in un’immagine un corpo che cade o una freccia che vola verso il bersaglio. Il rimando all’esperienza passata giustifica un’ipotesi, — ma il percepire non ha la forma di un periodo ipotetico, anche se naturalmente può giustificarlo. Di qui la necessità di trarre da un lato una conclusione che abbiamo in parte già anticipato e di cercare dall’altro un diverso fondamento intuitivo per la narrazione.
La conclusione, innanzitutto: anche se l’immagine sorregge la narrazione ed anche se non è vero che la dimensione del racconto si aggiunga come un corpo estraneo alla dimensione figurativa, credo si debba comunque riconoscere che una narrazione vi è solo quando ci disponiamo in una dimensione immaginativa e raccontiamo l’immagine, disponendola su un terreno in cui le parole e la scena dipinta trovano un nuovo accordo. Le forme e i modi di questo nuovo accordo dipendono probabilmente da diversi fattori, ma tra questi un ruolo centrale spetta alla forma intuitiva dell’immagine e allo stile narrativo prescelto. La narrazione che ci consente di cercare nel quadro la fotografia di un momento saliente è prossima all’intuizione e non chiede all’immaginazione ludica dello spettatore di andare al di là della scena raffigurata, segmentandola in vario modo. E se poi a mettere in movimento la scena non è un generico rimando all’esperienza passata, ma è l’inscenarsi di un decorso percettivo che è sorretto dall’immagine stessa, allora la narrazione si dispiegherà sotto i nostri occhi con relativa facilità. Al contrario quanto più l’immagine narrativa si allontana dal modello che Lessing ci propone, tanto più evidente si fa lo scarto tra ciò che l’intuizione porge e ciò che si dipana nella drammatizzazione che prende forma nel nostro gioco con l’immagine stessa.
Si deve dunque riconoscere che, seppure secondo una misura mutevole, vi è comunque un intreccio tra la dimensione contenutistica della raffigurazione e il gioco narrativo che ci invita a coglierla alla luce di un divenire nel tempo. E tuttavia, ed è questo il secondo punto su cui intendiamo riflettere, riconoscere il ruolo che l’immaginazione gioca non significa affatto sostenere che il terreno figurativo non possa offrire altro sostegno alla prassi del racconto se non quello che deriva dal rimando all’esperienza passata. La puntualità dell’immagine non si dischiude ad un orizzonte temporale soltanto in virtù di ciò che l’esperienza ci ha insegnato e nelle pagine del Laocoonte è indicato un diverso cammino che conduce a questa meta: Lessing sostiene infatti che in ogni quadro narrativo si possono trovare unite in un unico nodo spaziale scene che sembrano appartenere ad istanti di tempo contigui.
Per individuare un movimento sono necessari almeno due punti nello spazio e nel tempo, e di questa verità così ovvia dobbiamo avvalerci, se vogliamo comprendere che cosa permetta ad un dipinto di andare al di là del presente che gli appartiene: per poter leggere e insieme vedere un movimento dobbiamo fissare un percorso nel tempo, e possiamo farlo solo se nascondiamo nella contiguità spaziale una contiguità temporale, solo se raffiguriamo uno accanto all’altro corpi i cui atteggiamenti si spieghino alla luce del tempo.
Ora, io credo che vi siano diversi modi in cui ciò può accadere, anche se tutti debbono ricondurci ad un analogo risultato: debbono convincerci che la sintesi spaziale delle parti dell’immagine non è sino in fondo percorribile e debbono insieme invitarci a sovrapporre alla forma della coesistenza una sintesi temporale che proietti nel senso dell’immagine il tempo di ricezione dello spettatore e il suo dipanarsi secondo un percorso che sia definito dalla natura stessa dell’immagine. Possiamo allora esprimerci così: una raffigurazione può invitarci a leggere il percorso che attua la sintesi spaziale delle parti dell’immagine come una sintesi temporale e narrativa se qualcosa nella raffigurazione vieta o almeno ostacola il nostro tentativo di immaginare insieme ciò che di fatto è insieme nell’unità della tela. La porta del tempo si apre quando la strada della coesistenza spaziale o si restringe e sembra farsi praticabile soltanto al prezzo di una qualche fatica o ci appare definitivamente sbarrata.
Avremo modo di tornare tra breve su questa disgiunzione. Ora vorrei invece osservare che non è facile tracciare una tavola delle forme di cui l’immagine può avvalersi per costringerci a declinare la forma dell’uno accanto all’altro alla luce della regola dell’uno dopo l’altro. Ma vorrei egualmente indicare quali penso che siano le linee generali del discorso che andrebbe qui sviluppato. Credo che una raffigurazione non sappia convincerci della natura soltanto spaziale della sintesi delle sue parti quando qualcosa nel suo contenuto sembra andare contro ad una di queste leggi di carattere generale:
1. La legge del presente condiviso. Appartenere al presente significa anche reagire a ciò che accade e la presenza si accompagna nella norma ad un comune sentire, ad un accordarsi unanime alle situazioni che si vengono creando sotto i nostri occhi; può darsi tuttavia che qualcuno non presti attenzione a ciò che accade e non abbia presa sulla situazione cui pure appartiene: diremo allora che non è presente a ciò che accade, — un’espressione curiosa su cui vi invito a riflettere.
Ora, nella vita quotidiana l’infrazione alla legge che ci chiede
di accordarci ad un sentire e ad un agire comuni si paga con un’esclusione
metaforica dalla sfera della presenza; nel caso della raffigurazione, invece,
può spingerci ad un’interpretazione temporale che diviene tanto più cogente
quanto più le infrazioni sono ordinate secondo un percorso temporale, — secondo
una possibile successione. Lo sguardo percorre la tela e la scena sembra
scandirsi secondo una successione di piccole infrazioni alla regola della condivisione
del presente: qualcuno teme che accada ciò che per altri si sta realizzando o è
appena avvenuto, ed è questa successione di atteggiamenti che lo sguardo che percorre lungo l’asse della profondi tà la Strage degli innocenti del Reni ci mostra,
proiettando sulla scena dipinta l’eco del tempo che passa. Una serie di piccole
infrazioni: questo punto deve essere sottolineato. L’unità della scena dipinta
non si scandisce in eventi disgiunti, ma sembra disporsi in un attimo in cui
ancora risuona l’eco di ciò che è appena trascorso solo perché lo scarto temporale
che sembra aprirsi tra le singole parti della scena è sufficientemente
contenuto da poter essere raccolto nell’unità di un evento, di un presente che
si inarca sull’unità di una durata per racchiuderne il senso.
tà la Strage degli innocenti del Reni ci mostra,
proiettando sulla scena dipinta l’eco del tempo che passa. Una serie di piccole
infrazioni: questo punto deve essere sottolineato. L’unità della scena dipinta
non si scandisce in eventi disgiunti, ma sembra disporsi in un attimo in cui
ancora risuona l’eco di ciò che è appena trascorso solo perché lo scarto temporale
che sembra aprirsi tra le singole parti della scena è sufficientemente
contenuto da poter essere raccolto nell’unità di un evento, di un presente che
si inarca sull’unità di una durata per racchiuderne il senso.
Sulle forme e sui modi in cui può realizzarsi un’infrazione alla legge della condivisione del presente vi sarebbero molte altre cose da dire. Qui dobbiamo tuttavia accontentarci invece di ribadire la conclusione cui siamo giunti e che vorrei formulare così: l’attesa che tutto nello spazio si accordi all’unità di un presente diviene il mezzo per suggerire all’immaginazione una lettura che colga nello spazio della scena il tempo di una vicenda. Una lettura, è forse il caso di sottolinearlo, che cresce sulla percezione e ad essa si intreccia, e che determina la forma che attribuiamo alla scena che si dispiega sotto i nostri occhi.
2. La legge della conformità alla meta. Le azioni sono guidate e sorrette da scopi determinati che si manifestano nella coerenza dell’agire. Voglio cogliere un frutto dal ramo e allora mi alzo sulla punta dei piedi, tendo il braccio quanto più posso, allungo le dita, in una serie di gesti che tradisce bene ciò che mi muove. Ora, se immagino di fissare un momento di questo processo in un’immagine fotografica avrò un istante che non chiede necessariamente di essere colto in una dimensione narrativa: so per esperienza che quel gesto non può essere sostenuto nel tempo e quindi immagino che esso appartenga ad un rapido sviluppo temporale, e tuttavia non per questo vedo l’immagine muoversi. Nella Cacciata di Eliodoro, Raffaello propone molte figure animate da un forte dinamismo e la tensione dei gesti ci assicura che tra breve qualcosa avverrà, ma non per questo l’immagine si distende nel tempo. Questo accade invece quando la legge della conformità alla meta è infranta, ed un gesto nuovo si affianca al vecchio in una sintesi che denuncia uno spessore temporale e, insieme, il nostro esserci fatti sorprendere da ciò che sta ora accadendo. Qualcuno ci lancia la palla, e noi ce ne accorgiamo troppo tardi e le braccia si stendono in un direzione che nega quella del corpo: siamo così — ed è un’altra curiosa espressione — fuori o contro tempo. Ma se di un gesto possiamo dire che è fuori tempo, della sua rappresentazione dobbiamo affermare invece che ha un possibile spessore narrativo: l’immagine che raffigura l’insistere dei corpi in un atteggiamento che viene negato dall’insorgere di un gesto altrimenti orientato diviene così il mezzo per disporre l’immagine sulla soglia di un trapasso temporale che è reso tanto più apertamente percepibile, quanto più, ancora una volta, lo sguardo è guidato in un percorso che mostra dapprima l’ambiguità dei gesti cui alludevamo e poi lo sciogliersi di quest’ambigua sospensione temporale in altri corpi univocamente orientati verso la meta presente.
Dovremo in seguito tornare su questa possibile modalità figurativa, e tuttavia prima di disporci sul terreno degli esempi, è necessario osservare che le infrazioni a queste due prime leggi di fatto ci riconducono prevalentemente al tema del momento fecondo di cui Lessing ci parla, — un tema che le riflessioni che abbiamo proposto rendono, spero, un po’ meno misterioso. La narrazione che qui prende forma è narrazione di un momento esemplare, colto nella dinamicità del suo dispiegarsi, e le infrazioni alle “leggi” di cui abbiamo parlato sono il mezzo che consente all’immagine di ostacolare una lettura soltanto spaziale delle sue parti. Ora lo sguardo corre sulla tela e le scene che si susseguono vengono colte come se in esse si dipanasse un unico racconto, racchiuso in un arco minimo di tempo — l’arco di un presente che si distende sull’orizzonte di ciò che è appena stato e che si protende verso ciò che accadrà. E ciò è quanto dire che qui la narrazione non abbandona il piano intuitivo e può ottemperare al precetto di Lessing: tutto ciò che la tela dice deve saperlo mostrare. Tutto il resto appartiene al novero di quelle molteplici costruzioni di natura linguistica ed allegorica che, almeno per il Laocoonte, debbono essere espunte dall’ambito figurativo. E tuttavia, prima di addentrarci su questo terreno, è opportuno osservare che la possibilità di avvalersi delle infrazioni a queste due prime leggi per dare alla scelta dell’attimo una dinamicità narrativa non esclude ancora che si possa disporne anche sul terreno di una narrazione che non si dispone nei limiti segnati dal Laocoonte e accetta di travalicare la dimensione del presente, per disporsi nelle forme di una narrazione che fissa nel tempo dei punti, per disporvi gli eventi di una storia[23].
3. La legge di identità. Non sempre, tuttavia, la narrazione pittorica si avvale della via indicata da Lessing ed anzi talvolta segue un cammino da cui il Laocoonte prende apertamente le distanze, quando ci invita a liberarci dal cattivo gusto di chi raffigura in un’unica tela eventi che appartengono a diversi luoghi temporali. Ora, non è naturalmente nostro compito quello di decidere se una simile scelta sia o meno esteticamente felice, poiché ciò che ci interessa è soltanto questo: mostrare come ciò sia possibile e quali siano le forme intuitive che ci costringono ad indebolire la sintesi spaziale delle parti di un’immagine per leggere nel tempo ciò che si dà nello spazio. Tra queste forme una ci riconduce senz’altro all’infrazione di un principio che gode di un’importanza centrale nella nostra esperienza — il principio generale secondo il quale in uno stesso istante di tempo un individuo non può essere caratterizzato da determinazioni che si escludano reciprocamente. Così, uno stesso oggetto non può essere nello stesso tempo in due luoghi differenti, proprio come non può accadere che uno stesso luogo ospiti in un identico punto del tempo due diversi colori, due forme differenti e così di seguito.
Ora, non è possibile che una qualsiasi scena sia da un lato oggetto di percezione e, dall’altro, contravvenga al principio fenomenologico che abbiamo appena enunciato: un’esperienza possibile che vada al di là delle condizioni di possibilità dell’esperienza non può evidentemente darsi. È possibile invece che la scena sia configurata in modo tale da raffigurare qualcosa che sembri andare contro il principio che abbiamo formulato. Così in una stessa immagine possiamo raffigurare più volte lo stesso personaggio, come fa per esempio Masaccio nel Pagamento del tributo e possiamo raffigurarlo in modi e forme diverse, che ci costringano a cogliere lo spazio figurativo come se fosse scandito in scene diverse, in luoghi che possono comunicare solo se si consente al tempo di dire la sua. Lo spazio figurativo si suddivide in una serie di spazi che hanno una loro necessaria autonomia poiché ospitano corpi che non possono coesistere.
Alla discontinuità degli spazi fa eco la discontinuità del tempo: quando osserviamo l’affresco di Masaccio di cui discorriamo non si dipana sotto i nostri occhi un tempo che dura, ma la sua scansione in eventi distinti, in scene che hanno ciascuna un luogo temporale definito secondo la regola del prima e del poi, ma che non per questo appartengono ad un identico arco di presenza, ad uno svolgimento continuo. L’infrazione alla legge di identità si pone così come un mezzo che ci invita a percorrere lo spazio dell’immagine alla luce di un procedimento immaginativo che dall’impossibilità di riconnettere le parti dell’immagine in unico spazio muove per delineare la discontinuità di un racconto che evochi scene passate, ordinandole secondo una trama unitaria pur senza riconnetterle nella continuità di uno sviluppo temporale. Un procedimento immaginativo, appunto: come abbiamo osservato, quanto più abbandoniamo il terreno circoscritto dalla dinamica del «momento fecondo» di cui Lessing ci parla, tanto più necessario diviene chiamare in causa la dimensione immaginativa. La scena dipinta ci mostra uno spazio unitario, ma se accettiamo il gioco che l’immagine ci porge, lo spazio si frantuma in una successione temporale e lo spazio figurativo diviene soltanto la cornice unitaria che abbraccia l’unità di un racconto. Ora l’invito a non leggere l’immagine nelle forme della spazialità assume le forme di un divieto che è difficile eludere, ma il «no» che ci distoglie dal tentativo di connettere nello spazio ciò che pure è racchiuso dalla cornice non è pronunciato dalla grammatica del vedere, ma dalla regola che l’immaginazione segue nel dar vita al quadro, mettendone in scena i personaggi, i luoghi e le vicende narrate. Possiamo allora esprimerci così: l’infrazione alla legge di identità ci riconduce ad uno stile narrativo che non mette in movimento la scena, ma trova nel suo necessario scandirsi in moduli il fondamento di un racconto, di un’immaginazione che si dispiega nel tempo, scandendone passo dopo passo il trascorrere.
Annotazione. Nel suo Arte romana (Die Wiener Genesis, (1912), trad. it. a cura di C. Anti, Le Tre Venezie, 1947) Franz Wickhoff aveva distinto tre differenti forme di narrazione pittorica: la forma distintiva, la forma integrativa e la narrazione continua. Quale sia il modo distintivo è presto detto: la narrazione distintiva è la narrazione cui Lessing allude quando ci invita a scegliere un momento saliente dell’azione e a raffigurarlo, nella convinzione che, a partire di qui, sia possibile porre la scena rappresentata nello sviluppo temporale di un racconto. Alla modalità distintiva Wickhoff affianca poi la forma integrativa, che è caratterizzata dal fatto che in un’unica scena vengono riuniti elementi che appartengono a momenti diversi di uno sviluppo narrativo, ma che tuttavia convergono nel renderne palese il senso. La scena dipinta ospita così conseguenze e premesse di un fatto, ma senza per questo porre di fronte ai nostri occhi l’apparente contraddizione di una stessa figura che si ripete più volte. Così, quando Klitias nel cosiddetto vaso François rappresenta la morte di Troilo, da un lato mostra il giovane figlio di Priamo che esce di casa, al centro pone Achille che balza per ucciderlo e, infine, rappresenta Polissena ed Antenore che corrono ad avvisare il vecchio re della morte del figlio ed Ettore che si arma per vendicarlo: un’unica scena ospita così eventi che si susseguono nel tempo, ma che sono congiunti dall’unità di un nesso di motivazioni. A queste due prime modalità narrative, Wickhoff affianca poi la forma continua che è propriamente caratterizzata dalla ripetizione all’interno di uno spazio coerente della stessa figura che compare più volte, in un susseguirsi nello spazio che deve essere colto come un succedersi nel tempo. Scrive Wickhoff:
Questo modo di narrare è molto singolare: esso si distacca completamente anche da quello che siamo abituati a vedere anche nell’arte dei nostri giorni. Non è scelto un momento saliente che riunisca i personaggi principali del racconto in un’unica azione particolarmente importante per poi mostrarceli, in una seconda illustrazione, in un’altra situazione non meno significativa […]. Non si compongono in ciclo singole illustrazioni di momenti rilevanti e sensazionali, quasi a gareggiare per mezzo di tante figure distinte […] con la fluente narrazione degli antichi miti; ma i protagonisti del racconto accompagnano il testo nel suo svolgersi, in situazioni che si susseguono in continuità, in uno scorrere unito e ininterrotto, così come lungo le sponde di un fiume il paesaggio si svolge davanti agli occhi di chi sta passando in barca (ivi, pp. 32-33).
Non è difficile scorgere nel modo continuo di narrare i temi che abbiamo sfiorato in queste nostre ultime considerazioni, e non vi è dubbio che la Colonna traiana in cui l’imperatore compare più di novanta volte sia un buon esempio di infrazione alla legge dell’identità. E tuttavia, se è opportuno rammentare qui il saggio di Wickhoff non è tanto per la sua descrizione teorica della forma continua di narrazione, ma per un’osservazione storica che è forse discutibile, ma che merita di essere rammentata: per Wickhoff la narrazione continua è tipica dell’arte romana e si lega strettamente con la piega illusionistica che la caratterizza. Si tratta di una tesi che, di primo acchito, non può non lasciarci perplessi: la ripetizione in una stessa scena degli stessi personaggi non può legarsi ad un’arte che voglia davvero ingannarci, ed anzi proprio la ripetizione in più luoghi di una stessa figura vale come un segno evidente del carattere meramente figurativo della scena che abbiamo sotto gli occhi. Possiamo anzi spingerci un passo in avanti ed osservare che l’infrazione alla legge di identità ci costringe a forzare l’aspetto intuitivo dell’immagine per comprenderla: capire che cosa raffiguri Il pagamento del tributo di Masaccio vuol dire infatti rinunciare a lasciarsi guidare soltanto da ciò che lo sguardo ci mostra, per vincolarlo alla regola in cui si imbatte il tentativo di inscenare ciò che quell’affresco ci presenta. E tuttavia, nel proporre questa sua tesi, Wickhoff ci invita a volgere lo sguardo su un momento su cui vale egualmente la pena di riflettere: perché si possa parlare di una ripetizione delle stesse figure è infatti necessario che la scena abbia una sua interna coerenza e che il pittore sappia costruire le azioni che dipinge su uno sfondo unitario che permane al di là degli eventi narrati e che funge da cornice che li abbraccia e che, riunendoli, ci costringe a immaginarli nella forma di una successione temporale. Così queste pagine di Wickhoff ci invitano a tenere conto di una condizione implicita nella narrazione continua: il suo disporsi all’interno di uno spazio intuitivamente unitario — all’interno di uno sfondo che da un lato ci costringe ad avvertire come inaccettabile il farsi avanti in due luoghi di una stessa figura e che, dall’altro, racchiude nell’unità di un racconto il susseguirsi delle partiture che l’immaginazione traccia nel suo raccontare l’immagine.
4. La legge della coerenza spaziale. Vi è, infine, un’ultima legge che vorrei rammentare e che ci riconduce per altra via ai temi e ai problemi che abbiamo appena discusso. Come abbiamo osservato, lo spazio è uno e ciò che vale per il mondo reale, vale nella norma anche all’interno dello spazio figurativo, entro cui si muovono le figure dipinte. Ma non è sempre così. Talvolta lo spazio dell’immagine è costruito per luoghi che si lasciano connettere a fatica e che sono relativamente indipendenti gli uni dagli altri: l’immagine tende allora a sgranarsi in altre immagini, che segnano le tappe di un possibile percorso. All’interno di una raffigurazione si fanno così avanti più immagini che chiedono di essere connesse in una relazione che può assumere un valore temporale. Talvolta questa relazione è apertamente metaiconica: è questo il caso dei polittici le cui immagini alludono spesso ad una narrazione silenziosa e quindi anche ad una diversa dislocazione temporale delle scene di cui si compongono.
Ma ciò che nei polittici assume la forma di una relazione metaiconica, si pone invece come un sostegno della narratività dell’immagine là dove il quadro mantiene, almeno formalmente, la sua unità. Così quanto più l’immagine sembra articolarsi in parti che non sappiamo vedere come se fossero le une assieme alle altre, tanto più si fa strada nell’immaginazione un diverso modo di vivere la scena raffigurata: ciò che vediamo disgiunto ci appare così perché ci si mostra da una diversa scena temporale. Il presente si rapporta al passato come una parte dell’immagine si rapporta all’altra, e il quadro assume nel suo complesso il senso temporale di un presente che si fa carico di un passato, assumendo su di sé l’onere di un ricordo.
2. Esempi
Vorrei cercare ora di dare una maggiore consistenza alle
considerazioni su cui ci siamo appena soffermati, proponendo qualche esempio.
Il primo esempio ci riconduce ad un quadro di cui abbiamo già in precedenza
discusso: la Deposizione del Pontormo. Si tratta di un quadro che si
pone senz’altro sotto l’egida della narrazione così come Lessing la intende:
Pontormo sceglie di dipingere l’attimo in cui il corpo di Cristo, staccato
dalla croce, sta per essere deposto a terra — un momento che prelude alla
chiusura dell’evento, ma che non è ancora capace di soddisfare con la sua
presenza sensibile la  trama
delle attese che l’agire di cui il quadro narra deve aver sollevato. Abbiamo
dunque a che fare con un’immagine che si situa in un momento fecondo, che può
tuttavia essere raffigurato come tale solo perché Pontormo costruisce la scena
in un’aperta violazione della legge del presente condiviso. Il tempo scorre
seguendo un cammino che va dalla profondità del quadro allo spettatore e che
coincide con il movimento che il quadro attribuisce al corpo di Gesù. La parte
alta del quadro ci mostra ciò che è appena accaduto: il corpo di Gesù è
stato staccato dalla croce e Maria dal dolore cadde a terra, priva di sensi. Ma
appunto: questa scena è appena trascorsa e ora i due angeli sollevano il
corpo di Cristo e lo portano verso noi spettatori, che in un futuro ormai
prossimo potremo sorreggerlo. Il movimento drammatico che Pontormo attribuisce
al suo dipinto e che ne determina il carattere dialogico ha dunque anche un’eco
temporale che non deve sfuggirci perché in realtà si intreccia con il
significato profondo di quest’immagine. Da Maria allo spettatore: questo è il
movimento che il corpo di Gesù traccia nel quadro. E questo movimento nella sua
scansione temporale ripete nella forma di un gesto la vicenda stessa di Gesù:
il suo essere un dio che nasce in una famiglia di uomini, ne condivide in parte
il destino, per prenderne poi necessariamente commiato. Maria è il passato: è
la dimensione, ormai chiusa, dell’umanità degli affetti. Con la morte di Gesù
il tempo di Maria si chiude e se ne apre un altro, rivolto al futuro: lo
spettatore deve prepararsi a sorreggere il corpo di Cristo, e dietro il
velo di questa descrizione reale traspare il senso di una metafora antica, che
qui si dispiega sotto gli occhi. Lo spettatore deve prepararsi a ricevere il
corpo di Gesù — nella comunione.
trama
delle attese che l’agire di cui il quadro narra deve aver sollevato. Abbiamo
dunque a che fare con un’immagine che si situa in un momento fecondo, che può
tuttavia essere raffigurato come tale solo perché Pontormo costruisce la scena
in un’aperta violazione della legge del presente condiviso. Il tempo scorre
seguendo un cammino che va dalla profondità del quadro allo spettatore e che
coincide con il movimento che il quadro attribuisce al corpo di Gesù. La parte
alta del quadro ci mostra ciò che è appena accaduto: il corpo di Gesù è
stato staccato dalla croce e Maria dal dolore cadde a terra, priva di sensi. Ma
appunto: questa scena è appena trascorsa e ora i due angeli sollevano il
corpo di Cristo e lo portano verso noi spettatori, che in un futuro ormai
prossimo potremo sorreggerlo. Il movimento drammatico che Pontormo attribuisce
al suo dipinto e che ne determina il carattere dialogico ha dunque anche un’eco
temporale che non deve sfuggirci perché in realtà si intreccia con il
significato profondo di quest’immagine. Da Maria allo spettatore: questo è il
movimento che il corpo di Gesù traccia nel quadro. E questo movimento nella sua
scansione temporale ripete nella forma di un gesto la vicenda stessa di Gesù:
il suo essere un dio che nasce in una famiglia di uomini, ne condivide in parte
il destino, per prenderne poi necessariamente commiato. Maria è il passato: è
la dimensione, ormai chiusa, dell’umanità degli affetti. Con la morte di Gesù
il tempo di Maria si chiude e se ne apre un altro, rivolto al futuro: lo
spettatore deve prepararsi a sorreggere il corpo di Cristo, e dietro il
velo di questa descrizione reale traspare il senso di una metafora antica, che
qui si dispiega sotto gli occhi. Lo spettatore deve prepararsi a ricevere il
corpo di Gesù — nella comunione.
Non credo sia difficile trovare e discutere altri esempi che
mostrino all’opera la legge del “presente condiviso”, e tuttavia piuttosto che
soffermarmi su questo tema vorrei richiamare l’attenzione sulla nostra seconda
legge, per mostrare come il racconto possa trovare un sostegno intuitivo nelle
scene che la violano. Un possibile esempio ci è of ferto dalla Disputa
di Raffaello, nella stanza della segnatura. Si tratta di un affresco
ferto dalla Disputa
di Raffaello, nella stanza della segnatura. Si tratta di un affresco  famoso che si trova di
fatto di fronte alla Scuola di Atene
cui idealmente risponde poiché trae in parte il suo senso dal dialogo con
la raffigurazione del sapere terreno e dalla constatazione della sua incapacità
a rispondere alle domande ultime sull’origine delle cose e sulla natura della
verità. La risposta a queste domande deve essere lasciata alla fede, almeno per
Raffaello, che raffigura per questo di fronte alle discussioni dei filosofi i
misteri della fede: la Trinità in alto e, sullo stesso asse centrale, il mistero
eucaristico. Ma al dialogo con l’affresco che le corrisponde nella stanza della
segnatura, la Disputa affianca un dialogo interno cui Raffaello dà una
veste drammatica: così se nel centro del dipinto si assiste ad un’epifania
della Trinità e al suo eco nella celebrazione della comunione, ai margini
dell’affresco sono raffigurate invece le figure dei sapienti che hanno cercato
di comprendere nella pazienza della lettura ciò che ora si rivela. Da quei
libri si può ora distogliere lo sguardo per volgersi verso la manifestazione
visibile che occupa la scena, e il farsi avanti di questa transizione temporale
e di questo nuovo presente è resa visibile da Raffaello nella contorsione dei
corpi che tradisce il loro dinamico tendere dal passato al presente. Qualcosa
li trattiene ancora al passato — l’orientamento del corpo o l’improvviso
volgersi all’indietro dello sguardo — ma la strada è segnata e il movimento
del tempo li condurrà infine a volgersi verso lo spazio centrale dell’affresco,
che racchiude la risposta alle loro domande.
famoso che si trova di
fatto di fronte alla Scuola di Atene
cui idealmente risponde poiché trae in parte il suo senso dal dialogo con
la raffigurazione del sapere terreno e dalla constatazione della sua incapacità
a rispondere alle domande ultime sull’origine delle cose e sulla natura della
verità. La risposta a queste domande deve essere lasciata alla fede, almeno per
Raffaello, che raffigura per questo di fronte alle discussioni dei filosofi i
misteri della fede: la Trinità in alto e, sullo stesso asse centrale, il mistero
eucaristico. Ma al dialogo con l’affresco che le corrisponde nella stanza della
segnatura, la Disputa affianca un dialogo interno cui Raffaello dà una
veste drammatica: così se nel centro del dipinto si assiste ad un’epifania
della Trinità e al suo eco nella celebrazione della comunione, ai margini
dell’affresco sono raffigurate invece le figure dei sapienti che hanno cercato
di comprendere nella pazienza della lettura ciò che ora si rivela. Da quei
libri si può ora distogliere lo sguardo per volgersi verso la manifestazione
visibile che occupa la scena, e il farsi avanti di questa transizione temporale
e di questo nuovo presente è resa visibile da Raffaello nella contorsione dei
corpi che tradisce il loro dinamico tendere dal passato al presente. Qualcosa
li trattiene ancora al passato — l’orientamento del corpo o l’improvviso
volgersi all’indietro dello sguardo — ma la strada è segnata e il movimento
del tempo li condurrà infine a volgersi verso lo spazio centrale dell’affresco,
che racchiude la risposta alle loro domande.
 Alle
immagini che debbono la loro dinamica narrativa alla violazione della legge
della conformità al movimento si debbono affiancare poi le raffigurazioni che,
per dirla con Wickhoff, vanno sotto il titolo della narrazione continua. Un
primo esempio ci è offerto da un quadro di Memling, che sembra voglia mostrarci
quante narrazioni possono racchiudersi nell’unità di un quadro. Una Gerusalemme
dai tetti spioventi racchiude nello snodarsi delle sue strade la storia della
passione di Cristo che vediamo entrare in città il giorno della domenica delle
palme, celebrare l’ultima cena, pregare nell’orto del Getsemani, ricevere da Giuda il bacio del tradimento, subire
l’arresto, le percosse, la flagellazione, il verdetto di condanna, e poi salire
verso il Golgota, essere crocifisso e poi deposto dalla croce. E in
questo rapido succedersi delle stazioni della passione, la figura di Gesù
compare sempre di nuovo, in una palese negazione del principio di
individuazione. Ma se in uno stesso spazio non è possibile trovare più
volte la stessa persona, il tempo nel suo trascorrere, può invece ospitare la
trama delle sue azioni. Così, la lunga strada che Memling dipinge e che si
dipana dalla sinistra alla destra del quadro assume la forma di un visibile
sostegno della narrazione. Lo spazio figurativo si frammenta così nella sua
consistenza reale e diviene insieme lo scenario immobile che fa da sfondo alla
vicenda narrata e, insieme, la cornice che garantisce l’unità della storia, il
suo dipanarsi in momenti che danno un passo discontinuo al tempo del racconto,
ma che si riconoscono tuttavia nell’unità di una trama.
Alle
immagini che debbono la loro dinamica narrativa alla violazione della legge
della conformità al movimento si debbono affiancare poi le raffigurazioni che,
per dirla con Wickhoff, vanno sotto il titolo della narrazione continua. Un
primo esempio ci è offerto da un quadro di Memling, che sembra voglia mostrarci
quante narrazioni possono racchiudersi nell’unità di un quadro. Una Gerusalemme
dai tetti spioventi racchiude nello snodarsi delle sue strade la storia della
passione di Cristo che vediamo entrare in città il giorno della domenica delle
palme, celebrare l’ultima cena, pregare nell’orto del Getsemani, ricevere da Giuda il bacio del tradimento, subire
l’arresto, le percosse, la flagellazione, il verdetto di condanna, e poi salire
verso il Golgota, essere crocifisso e poi deposto dalla croce. E in
questo rapido succedersi delle stazioni della passione, la figura di Gesù
compare sempre di nuovo, in una palese negazione del principio di
individuazione. Ma se in uno stesso spazio non è possibile trovare più
volte la stessa persona, il tempo nel suo trascorrere, può invece ospitare la
trama delle sue azioni. Così, la lunga strada che Memling dipinge e che si
dipana dalla sinistra alla destra del quadro assume la forma di un visibile
sostegno della narrazione. Lo spazio figurativo si frammenta così nella sua
consistenza reale e diviene insieme lo scenario immobile che fa da sfondo alla
vicenda narrata e, insieme, la cornice che garantisce l’unità della storia, il
suo dipanarsi in momenti che danno un passo discontinuo al tempo del racconto,
ma che si riconoscono tuttavia nell’unità di una trama.
Nel quadro di Memling la storia della passione di Cristo è tutta raccolta nell’unità di un’immagine, ma per l’esemplarità di questa riconduzione di un ciclo pittorica nei quattro legni di una sola cornice non è facile scorgere una ragione che ci riconduca ad una qualche istanza espressiva.
 Diversamente
stanno le cose per il quadro di Botticelli che racconta la storia di Nastagio
degli Onesti. Nella pineta di Ravenna Nastagio assiste al supplizio di una giovane
che fugge da un cavaliere armato e da cani feroci che infine la raggiungono e
la sbranano. Ma all’epilogo cruento segue una ripetizione del dramma, e
Botticelli ci consente di vedere l’eternità della punizione nella ciclicità
che la forma continua di narrazione imprime all’immagine. Lo sfondo presenta il passato, il primo
piano il presente, ma nel corso del tempo la fuga inverte il suo senso, e
l’inseguimento assume un andamento circolare che proietta su questa lugubre
scena l’immagine ludica della giostra e il suo essere vincolata alla regola di
una ripetizione continua.
Diversamente
stanno le cose per il quadro di Botticelli che racconta la storia di Nastagio
degli Onesti. Nella pineta di Ravenna Nastagio assiste al supplizio di una giovane
che fugge da un cavaliere armato e da cani feroci che infine la raggiungono e
la sbranano. Ma all’epilogo cruento segue una ripetizione del dramma, e
Botticelli ci consente di vedere l’eternità della punizione nella ciclicità
che la forma continua di narrazione imprime all’immagine. Lo sfondo presenta il passato, il primo
piano il presente, ma nel corso del tempo la fuga inverte il suo senso, e
l’inseguimento assume un andamento circolare che proietta su questa lugubre
scena l’immagine ludica della giostra e il suo essere vincolata alla regola di
una ripetizione continua.
 Vorrei
infine proporre almeno due esempi per chiarire che cosa si debba intendere
quando si osserva che la dimensione narrativa può far leva sulla difficoltà di
stringere in un nodo di coesistenza le parti dello spazio figurativo, la cui
possibile unificazione sembra dipendere dalla nostra capacità di immaginare lo
spazio nel tempo, la sintesi delle sue parti nell’unità di un percorso. Di un percorso che unisce al
presente un passato lontano come nell’Annunciazione
di Cortona del Beato Angelico — un quadro che ha il sapore antico e la
complessità teologica di un’icona. Beato Angelico ambienta la discesa
dell’angelo in uno spazio costruito secondo una prospettiva molto libera, ma
comunque capace di rendere bene la successione dei piani e il gioco delle lontananze.
Il primo piano è tradizionale: un colonnato divide lo spazio umano di Maria
dallo spazio divino dell’angelo, e la comunicazione tra gli spazi è garantita
dai piccoli sconfinamenti delle due figure rispetto alla cornice che li racchiude.
Lo sfondo, invece, racchiude un pensiero si cui vorremmo riflettere: su una
piccola altura accade una scena che non sembra appartenere allo spazio della
narrazione che ci si mostra in primo piano e il quadro tende proprio per questo
a dividersi in due luoghi differenti. E tuttavia, per quanto l’immagine tenda a
scandirsi in due eventi distinti, l’unità dello spazio figurativo ci invita a
cercare una sintesi tra le parti che lo compongono. L’incoerenza sincronica
dello spazio deve così alludere ad una sua ricomposizione diacronica e la separatezza
dei luoghi dell’immagine è superata e tolta dalla possibilità di istituire un
percorso — nel tempo. Così nell’Annunciazione di Cortona la dualità
dei luoghi allude ad un cammino nel tempo che sappia mediare e togliere
quell’apparente estraneità, e così ciò che ci appare nel punto verso cui alludono
le linee di fuga del porticato diviene il tempo iniziale cui si riconnette come
una risposta il tempo presente. Ed a questo punto i nostri ricordi biblici debbono
essere sollecitati per dare un nome alla coppia che abbandona mesta il luogo in
cui era: si tratta evidentemente di Adamo ed Eva, dal cui peccato dipende
l’evento che il primo piano ci mostra. Se l’angelo reca la “buona novella” a
Maria è solo perché è necessario redimere quel peccato: passato e presente si
dispongono così in una dualità di scene la cui unità deve essere compresa e può
esserlo solo se la sintesi spaziale si lega ad una sintesi temporale, ad una
lettura narrativa dell’immagine che tende a farci vedere come il senso di ciò
che accade abbia le sue radici nel tempo maiuscolo dell’origine.
Vorrei
infine proporre almeno due esempi per chiarire che cosa si debba intendere
quando si osserva che la dimensione narrativa può far leva sulla difficoltà di
stringere in un nodo di coesistenza le parti dello spazio figurativo, la cui
possibile unificazione sembra dipendere dalla nostra capacità di immaginare lo
spazio nel tempo, la sintesi delle sue parti nell’unità di un percorso. Di un percorso che unisce al
presente un passato lontano come nell’Annunciazione
di Cortona del Beato Angelico — un quadro che ha il sapore antico e la
complessità teologica di un’icona. Beato Angelico ambienta la discesa
dell’angelo in uno spazio costruito secondo una prospettiva molto libera, ma
comunque capace di rendere bene la successione dei piani e il gioco delle lontananze.
Il primo piano è tradizionale: un colonnato divide lo spazio umano di Maria
dallo spazio divino dell’angelo, e la comunicazione tra gli spazi è garantita
dai piccoli sconfinamenti delle due figure rispetto alla cornice che li racchiude.
Lo sfondo, invece, racchiude un pensiero si cui vorremmo riflettere: su una
piccola altura accade una scena che non sembra appartenere allo spazio della
narrazione che ci si mostra in primo piano e il quadro tende proprio per questo
a dividersi in due luoghi differenti. E tuttavia, per quanto l’immagine tenda a
scandirsi in due eventi distinti, l’unità dello spazio figurativo ci invita a
cercare una sintesi tra le parti che lo compongono. L’incoerenza sincronica
dello spazio deve così alludere ad una sua ricomposizione diacronica e la separatezza
dei luoghi dell’immagine è superata e tolta dalla possibilità di istituire un
percorso — nel tempo. Così nell’Annunciazione di Cortona la dualità
dei luoghi allude ad un cammino nel tempo che sappia mediare e togliere
quell’apparente estraneità, e così ciò che ci appare nel punto verso cui alludono
le linee di fuga del porticato diviene il tempo iniziale cui si riconnette come
una risposta il tempo presente. Ed a questo punto i nostri ricordi biblici debbono
essere sollecitati per dare un nome alla coppia che abbandona mesta il luogo in
cui era: si tratta evidentemente di Adamo ed Eva, dal cui peccato dipende
l’evento che il primo piano ci mostra. Se l’angelo reca la “buona novella” a
Maria è solo perché è necessario redimere quel peccato: passato e presente si
dispongono così in una dualità di scene la cui unità deve essere compresa e può
esserlo solo se la sintesi spaziale si lega ad una sintesi temporale, ad una
lettura narrativa dell’immagine che tende a farci vedere come il senso di ciò
che accade abbia le sue radici nel tempo maiuscolo dell’origine.
Considerazioni
abbastanza simili valgono anche per il quadro in cui Mantegna ci ripropone la
preghiera solitaria di Gesù nel Getsemani. Si tratta di un quadro che
innanzitutto ci colpisce per il suo articolarsi in tre luoghi distinti che
mostrano ciascuna una diversa realtà: gli apostoli che dormono, Gesù che prega,
Giuda e i soldati che vengono per arrestarlo. Alla tripartizione dello spazio
figurativo fa eco la dualità delle direttrici spaziali che si dipartono da un
primo piano fortemente scorciato e ravvicinato. La prima  rappresenta
il colloquio muto e senza tempo tra Gesù e il Padre. È un colloquio cui gli
apostoli non possono prendere parte, perché di fatto verte su una scelta su cui
gli uomini non possono interferire e che li supera interamente: Gesù deve scegliere
se appartenere al tempo per superarlo e quindi morire per poi risorgere o se
gli è ancora possibile allontanare da sé quel calice amaro. La scelta è ben
nota, ma è comunque resa visibile da ciò che nel futuro si prepara e che si
mostra nel lungo corteo degli uomini che dalla città — e quindi dall’umanità e
dalla storia — giunge sino al Cristo, per condurlo sulla scena della passione.
Lo spazio diviene così il luogo di un incrocio temporale e di una narrazione
silenziosa: il primo piano è il presente — il sonno dell’uomo, in alto è il tempo
senza tempo di un dialogo divino dove si decide ciò che è da sempre deciso, a
destra, infine, nell’incedere dalle profondità dello spazio si fa visibile il
futuro che scioglie l’enigma di quel dialogo senza tempo, mostrandoci ciò che
tra breve accadrà. Ma ciò è quanto dire che la complessità spaziale
dell’immagine, la sua costruzione prospettica, crea uno schema sensibile nuovo
e più ricco che concede una nuova e diversa modalità narrativa. L’incombere del
passato o del futuro sulla scena ci appare ora nella scena stessa, come qualcosa
che appartiene al suo tempo. E ciò è quanto dire che il presente è entrato
davvero a far parte della narrazione: ciò che è accaduto in un istante definito
del tempo ci appare ora alla luce di un senso che trascende la definitezza temporale,
— che la trascende però solo perché l’immagine ci mostra come il presente sia
comunque gravido di una passato e di un futuro che le appartengono e che
proprio per questo occupano la scena pittorica. Il mistero teologico della
morte del dio uomo si fa così concretamente narrazione[24].
rappresenta
il colloquio muto e senza tempo tra Gesù e il Padre. È un colloquio cui gli
apostoli non possono prendere parte, perché di fatto verte su una scelta su cui
gli uomini non possono interferire e che li supera interamente: Gesù deve scegliere
se appartenere al tempo per superarlo e quindi morire per poi risorgere o se
gli è ancora possibile allontanare da sé quel calice amaro. La scelta è ben
nota, ma è comunque resa visibile da ciò che nel futuro si prepara e che si
mostra nel lungo corteo degli uomini che dalla città — e quindi dall’umanità e
dalla storia — giunge sino al Cristo, per condurlo sulla scena della passione.
Lo spazio diviene così il luogo di un incrocio temporale e di una narrazione
silenziosa: il primo piano è il presente — il sonno dell’uomo, in alto è il tempo
senza tempo di un dialogo divino dove si decide ciò che è da sempre deciso, a
destra, infine, nell’incedere dalle profondità dello spazio si fa visibile il
futuro che scioglie l’enigma di quel dialogo senza tempo, mostrandoci ciò che
tra breve accadrà. Ma ciò è quanto dire che la complessità spaziale
dell’immagine, la sua costruzione prospettica, crea uno schema sensibile nuovo
e più ricco che concede una nuova e diversa modalità narrativa. L’incombere del
passato o del futuro sulla scena ci appare ora nella scena stessa, come qualcosa
che appartiene al suo tempo. E ciò è quanto dire che il presente è entrato
davvero a far parte della narrazione: ciò che è accaduto in un istante definito
del tempo ci appare ora alla luce di un senso che trascende la definitezza temporale,
— che la trascende però solo perché l’immagine ci mostra come il presente sia
comunque gravido di una passato e di un futuro che le appartengono e che
proprio per questo occupano la scena pittorica. Il mistero teologico della
morte del dio uomo si fa così concretamente narrazione[24].
Lezione diciannovesima
Considerazioni conclusive
C’è un quadro del Ghirlandaio che rappresenta un vecchio e un
bambino. È un ritratto molto bello che ci costringe a prendere atto di un
doloroso contrasto: nonno e nipote sono l’uno di fronte all’altro e si
scambiano uno sguardo malinconico e intenso, ma l’uno è sfigurato dai segni
della  vecchiaia
e della malattia, l’altro ci appare invece nei tratti gentili e delicati
dell’infanzia. Il vecchio, che ci appare riccamente vestito e che appartiene ad
una qualche ricca famiglia fiorentina, è già morto quando Ghirlandaio lo
ritrae, e un disegno conservato a Stoccolma lo mostra con gli occhi già chiusi
e ci costringe a rammentare che un tempo la prima funzione di un ritratto era
proprio questa — salvare un volto e i suoi lineamenti dal disfacimento e dalla
dimenticanza.
vecchiaia
e della malattia, l’altro ci appare invece nei tratti gentili e delicati
dell’infanzia. Il vecchio, che ci appare riccamente vestito e che appartiene ad
una qualche ricca famiglia fiorentina, è già morto quando Ghirlandaio lo
ritrae, e un disegno conservato a Stoccolma lo mostra con gli occhi già chiusi
e ci costringe a rammentare che un tempo la prima funzione di un ritratto era
proprio questa — salvare un volto e i suoi lineamenti dal disfacimento e dalla
dimenticanza.
Eppure questo quadro non è soltanto un ritratto e non ci consente solo di rammentare l’espressione e la forma di un volto che non c’è più: è anche, insieme, una nekuia, un dialogo con un morto. Lo è di fatto, se come sembra, il quadro ritrae insieme un vivo ed un morto, ma lo è anche nel suo senso più pieno e lo si coglie nel gesto leggero della mano del bimbo che sfiora quasi senza toccare il corpo del nonno — un gesto che traduce nel linguaggio immobile della pittura e in un registro più rassegnato e malinconico il triplice abbraccio di Ulisse alla madre Anticlea.
La mano sfiora in un contatto irreale l’ombra dipinta di un morto, ma quel gesto cerca un contatto e di fatto il dialogo si ripete e continua nel gioco degli sguardi che legano il nonno al nipote. Innanzitutto lo sguardo del bambino che interroga e sembra chiedere la ragione di ciò che nel passare del tempo è accaduto. Lo sguardo chiede, io penso, esattamente ciò che nel quadro si mostra: la domanda verte proprio sulla contrapposizione così evidente tra il volto del vecchio e il volto del bambino — una contrapposizione che deve apparirci ora nella sua enigmaticità. Il bambino guarda il nonno e chiede qualcosa come una ragione per il trascorrere del tempo, per il suo strano bisogno di procedere di pari passo con la vecchiaia e con la morte.
|
|
|
|
|
Bertrand Russell a 4, a 35 e a 92 anni |
||
Allo sguardo malinconico del bambino che sembra chiedere conto del tempo e dei suoi segni, e che sembra insieme comprendere che il suo trascorrere non è un destino individuale ma comune, risponde come può lo sguardo, che vorrebbe essere protettivo, del vecchio — uno sguardo che ci ricorda che una ragione, naturalmente, non c’è, anche se bisogna egualmente farsene una ragione. Il tempo, come si vede, passa: bisogna saperlo e accettarlo.
Così, in questa nekuia rinascimentale prende forma una
riflessione sul tempo che si fa tanto più malinconica e sconsolata, quanto più
la guardiamo alla luce di ciò che si ripete nel vano della finestra — in questo
quadro nel quadro cui, seguendo una diffusa possibilità espressiva, il
Ghirlandaio affida il compito di pronunciare un commento sul dialogo che
il quadro propriamente raffigura. Un tratto in quel paesaggio ci colpisce, ed è
la simmetria con la scena che domina il primo piano dell’immagine: qui sulla
destra il volto delicato e dolce di un bambino cui fanno da contrappunto a
sinistra i lineamenti segnati dagli anni e dalle malattie del vecchio, là nel
vano della finestra a destra un paesaggio dolce e vivo di colline e di alberi
che si chiude sulla sinistra sull’immagine scabra e spoglia di una montagna,
priva di vita e bruna per la distanza. E anche tra questi due voci così diverse
del paesaggio vi è un contatto e un legame: una strada tortuosa conduce dalle
colline verdi alla montagna grigia, svolgendosi nella profondità del quadro.
Così, racchiuso nella cornice della finestra, il paesaggio che Ghirlandaio
dipinge per noi assume un’ovvia valenza metaforica e si pone come un commento
obiettivo a ciò che soggettivamente si dispiega nei pensieri e nei gesti dei
personaggi del quadro: ci dice che il tempo passa e che, nel suo scorrere,
conduce dalla vita alla morte. Il quadro nel quadro ci mostra così, in epitome,
il senso profondo del dialogo fatto di sguardi e di gesti trattenuti che lega
il vecchio al bambino  e
ci costringe insieme a capire la ragione di quella consolazione senza argomenti
e di quella protezione senza fiducia che si legge nello sguardo del vecchio e
che costituisce la cifra drammatica del quadro: è così che è fatta la vita,
proprio come esemplarmente ci mostra quel paesaggio fatto di colline verdi e di
montagne lontane tra cui corre una strada.
e
ci costringe insieme a capire la ragione di quella consolazione senza argomenti
e di quella protezione senza fiducia che si legge nello sguardo del vecchio e
che costituisce la cifra drammatica del quadro: è così che è fatta la vita,
proprio come esemplarmente ci mostra quel paesaggio fatto di colline verdi e di
montagne lontane tra cui corre una strada.
Ma perché questa digressione su un quadro che non ha un contenuto narrativo e non ci mostra lo scorrere del tempo, ma solo una riflessione sul tempo? Per una ragione semplice: questo ritratto del Ghirlandaio ci permette infatti di comprendere con la forza che è propria degli esempi come le immagini possano parlarci del tempo — ed eventualmente narrarlo — avvalendosi di una molteplicità di sostegni intuitivi che ci riconducono spesso ad una radice comune: alla forma della spazialità e al suo profondo legame con le strutture della temporalità. La narrazione pittorica ha regole su cui abbiamo tentato di far luce; e tuttavia, se le immagini possono così facilmente narrare è anche perché lo spazio può porsi come un sostegno immaginativo del tempo e può farlo innanzitutto perché tempo e spazio, nella loro forma esperita, sono caratterizzati da un’analoga struttura prospettica. Vi è un «qui» dello spazio e vi è un «qui» del tempo, e proprio per questo ha senso parlare di una prospettiva spaziale e di una prospettiva temporale, e dire che sono accomunate da un’analoga regola di progressione che ci consente di parlare nell’uno e nell’altro caso di vicinanza e di lontananza. Si può essere prossimi e remoti nello spazio e nel tempo, e nello spazio e nel tempo la lontananza assume comunque la forma di un contrarsi degli eventi, di un loro progressivo sottrarsi alla presa della soggettività. I ricordi sbiadiscono e si fanno confusi secondo la stessa regola che Leonardo proponeva per la pittura. Le cose lontane, scrive Leonardo, tendono come colore al grigio e ciò determina la loro propensione a perdersi sullo sfondo. E al venir meno della vivacità cromatica si affianca il perdersi della forma individuale dell’oggetto, la sua presenza:
Ogni corpo ombroso, il quale sia di qualunque figura si voglia, in lunga distanza pare essere sferico; e questo nasce perché s’egli è un corpo quadrato, in brevissima distanza si perdono gli angoli suoi, e poco più oltre si perdono i lati minori che restano; e così, prima che si perda il tutto, si perdono le parti per esser minori del tutto» (Leonardo, Trattato sulla pittura, Milano, p. 279)
— una constatazione questa, dietro la quale non è difficile scorgere una poetica della lontananza che viene colta come la forma stessa del perdersi dell’individualità e della vita.
La profondità dello spazio può così raffigurare la lontananza nel tempo, e l’incedere nell’una può divenire metafora del trascorrere del tempo, del movimento che costringe il presente a sprofondare nel passato. Di qui l’importanza che strade, viottoli e ponti possono assumere in seno alle immagini: lo spazio si fa ancora più prossimo al tempo quando qualcosa ci invita a percorrerlo. Basta tracciare una strada che unisca le colline alla montagna grigia perché lo spazio si faccia percorribile e assuma un senso e possa, proprio per questo, più facilmente porsi come sostegno di un’immaginazione carica di temporalità. Così stanno, per esempio, le cose nel quadro del Ghirlandaio che ci consente di riflettere sul tempo disponendo soltanto dello spazio, della sua profondità e di una strada che si inerpica in essa.
Lo spazio, tuttavia, non è un veicolo dell’immaginazione temporale solo perché gode di un’analoga struttura prospettica: lo rende vicino al tempo anche la sua continuità e la possibilità ovvia di segmentarlo.
Lo spazio è continuo, e ciò consente di raffigurare facilmente
il fluire del presente nel passato come ci mostra ancora una volta il quadro
del Ghirlandaio. Ma lo spazio è anche segmentabile e può essere suddiviso in
parti, proprio come accade al tempo quando, ricordandoci di qualcosa,
ritagliamo nella sua continuità una parentesi. Il tempo è continuo, ma la sua
ricomposizione nell’unità dei ricordi non può che restituirci un insieme di
luoghi, di stanze di cui il ricordo può spalancare la porta ma cui può
giungere solo attraverso un salto che dal presente lo riconduce al passato, in
un movimento che è insieme una soluzione della continuità temporale. L’immagine
delle stanze della memoria, che ha cittadinanza anche  nei
manuali di mnemotecnica, è un’immagine spaziale da cui è difficile prendere
commiato e che sembra illustrare bene la natura della memoria: il suo spalancare
nel passato stanze cui non è più altrimenti possibile accedere. Così, non è un
caso se Magritte ci invita a immaginare la memoria da un lato come se fosse
una ferita nel presente e, dall’altro, lo spalancarsi di un mare vasto al di là
di una tenda o di un muro — ricordarsi significa comunque segnare una discontinuità
con l’attimo nel quale si vive.
nei
manuali di mnemotecnica, è un’immagine spaziale da cui è difficile prendere
commiato e che sembra illustrare bene la natura della memoria: il suo spalancare
nel passato stanze cui non è più altrimenti possibile accedere. Così, non è un
caso se Magritte ci invita a immaginare la memoria da un lato come se fosse
una ferita nel presente e, dall’altro, lo spalancarsi di un mare vasto al di là
di una tenda o di un muro — ricordarsi significa comunque segnare una discontinuità
con l’attimo nel quale si vive.
Potremmo seguire ancora la metaforica del tempo che lo spazio ci offre e a partire di qui potremmo comprendere meglio quali siano i sostegni intuitivi di cui la narrazione pittorica può avvalersi. E tuttavia vorrei, per concludere, richiamare l’attenzione su una differenza ovvia che separa lo spazio dal tempo — una differenza che ci invita a riflettere. Lo spazio raccoglie le cose e le tiene per noi: vi sono cose lontane e vicine, ma lo spazio le abbraccia tutte e le rende egualmente disponibili. Il tempo, invece, passa e l’immagine della memoria come una grande casa in cui si aprono infinite stanze che possono accoglierci e in cui si può dimorare è un’immagine consolatoria. La metaforica spaziale del tempo racchiude tacitamente in sé l’utopia della memoria: il suo sapersi opporre pienamente alla vocazione iconoclastica del tempo. Di quest’utopia le immagini sono spesso una chiara espressione, ed io credo che una delle ragioni che spingono le raffigurazioni a cercare nello spazio il tempo e ad assumere comunque una piega narrativa sia proprio qui: nel desiderio di arginare la fuga del tempo imprigionandola nello spazio.
Del resto, ogni narrazione è in qualche misura animata da questo bisogno. Il tempo passa, ma il racconto lo ripete e lo rende sempre di nuovo ripetibile, attribuendogli una forma ed un’individualità peculiari. Il luogo esistenziale della narrazione è dunque, almeno in parte, qui: nel suo porsi come un tentativo di dare forma al trascorrere del tempo, per poterlo ripetere.
E se ci si pone in questa prospettiva il carattere statico della narrazione pittorica, il suo essere contraddittoriamente sospesa sul divenire e sull’essere e il suo tentare di dire la successione nella dimensione spaziale della coesistenza debbono apparirci come la forma esemplare in cui, attraverso le immagini, si esprime l’utopia del racconto: il suo voler salvare il tempo nel tempo[25].
Appendice
Cenni
sulla natura del metodo prospettico secondo le due regole del vignola
1. La prospettiva come
intersezione piana della piramide visiva
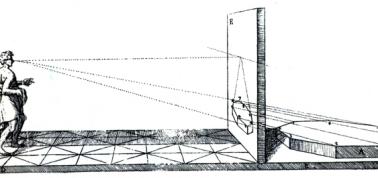
Il disegno mostra che cosa si intenda quando si sostiene che un quadro prospettico è un’intersezione piana della piramide visiva, e cioè del fascio di raggi di luce che sono riflessi dall’oggetto e che convergono in un punto — il punto che è assegnato allo spettatore. Fissato il punto di osservazione è possibile tracciare sul piano E (che per comodità è posto come perpendicolare al terreno) i punti di intersezione che sono segnati dai raggi luminosi che si dipartono dal prisma ottagonale A per giungere al punto di osservazione occupato dallo spettatore (da uno dei suoi occhi). L’immagine che si viene a formare sul piano E è l’immagine prospettica di A.
In modo particolare, la retta parallela al terreno che dal punto di osservazione cade perpendicolarmente sul piano E segna il punto di fuga del disegno, e cioè il punto verso cui convergono le immagini prospettiche delle rette perpendicolari al piano (le linee della profondità). Il punto di fuga si trova a sua volta sulla linea dell’orizzonte che è parallela al terreno e che Vignola segna con chiarezza nel suo disegno.
2. La prima regola

Questa regola ci mostra
come costruire una successione di quadrati digradati. BE rappresenta il piano
di intersezione (il quadro), mentre i quadrati 1, 2 e 3 rappresentano gli
oggetti da rappresentare prospetticamente. G è evidentemente il punto di vista.
Ora se segniamo sul segmento A-B i punti corrispondenti a R, P, Q avremo i
punti L, K, H che rappresentano le altezze dei quadrati scorciati.
Poi ci disponiamo nel punto
C e osserviamo dalla stessa distanza (CA=GB) l’immagine prospettica che su AE
disegnano i lati del quadrato paralleli alla linea di terra, e avremo così le
larghezze scorciate. Possiamo così costruire prospetticamente l’immagine dei
tre quadrati.
È il caso di osservare che
nel suo disegno Vignola fa coincidere l’estremo B del segmento EB con il punto
di fuga dell’immagine così come si disegna per lo spettatore.
Potremmo così fin da
principio tracciare le linee di profondità che si dipartono da Z, T, S, e A
verso B e poi, una volta segnate su AB le altezze, tracciare le linee parallele
a ZA che passano per L, K, H, ecc. Di qui si può costruire comodamente il piano
prospettico di base.
3. La seconda regola
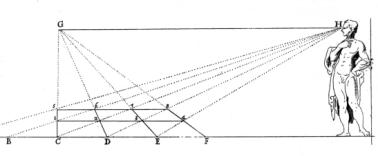
Prendiamo su GC da H il segmento CB e lo riportiamo sul nostro quadro GC ottenendo l’altezza del quadrato scorciato. Poi Vignola ci invita a considerare ogni linea che conduca al punto di veduta G come un possibile schermo perpendicolare al terreno su cui segnare l’immagine prospettica ora del lato CD, poi di DE, poi di EF, secondo una iterazione che ci consente di costruire senza problemi la base prospettica del nostro disegno.














