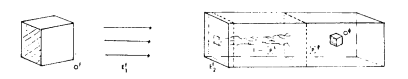
|
Capitolo Secondo L’unità come problema per la psicologia |
(continuazione)
Kafka, Il Castello
§ 1. Alcune proposte della teoria della gestalt.
Invece, proprio questo è stato il programma della psicologia della gestalt, solo vent’anni dopo la morte di Helmholtz.
Riconsideriamo per un momento lo schema proposto alcune pagine addietro: Of è l’oggetto fisico, dal quale partono catene causali indipendenti Ef1; Ef2 sono gli effetti di queste catene causali sui recettori sensoriali periferici. L’organismo dell’osservatore ha notizia solo di questi effetti indipendentemente da ciò che è avvenuto prima. Solo Ef2 rappresenta, nel suo insieme, le condizioni di una data percezione. If sta ad indicare i canali d’informazione attraverso i quali tali condizioni agiscono sul cervello, cioè su un ’sistema fisico particolarmente complesso dove hanno luogo i processi (P), responsabili della struttura complessiva dell’esperienza dell’osservatore in un dato momento. Può essere che If siano ancora catene causali indipendenti.
Dal punto di vista di Helmholtz (P) deve essere considerato come diviso in almeno due parti: una di esse è costituita dall’esito immediato che le informazioni, alla fine dell’itinerario If, determinano in (P) : le «sensazioni». Esse sono fatti psichici corrispondenti biunivocamente a ciascuna delle informazioni avviate dalla periferia al centro tramite If. Un’altra parte di (P) è costituita da quei fatti mentali già altamente organizzati, indipendentemente dalle percezioni, e che appunto servono ad organizzarle, anzi a farle sparire come tali per mettere al loro posto ciò che chiamiamo «le cose». Tutto ciò che l’esperienza presenta come dato organizzato, dunque, è frutto delle attività mentali superiori, memoria, giudizi, ragionamenti.
Ma questo non è l’unico punto di vista possibile.
La nostra ignoranza quasi totale di ciò che accade in (P), inteso come sistema fisico, autorizza la formulazione di ipotesi diverse.
Queste possono essere costruite seguendo un piano epistemologico interamente nuovo.
Helmholtz voleva che ci si attenesse ai «fatti accertati»:
ma (a) sono le «sensazioni», invisibili negli oggetti organizzati, veramente fatti accertati o accertabili? Inoltre, egli voleva che l’indagine venisse a dipendere da principii metodologici ineccepibili: ma (b) è veramente ineccepibile il metodo che consiste nel dedurre, da premesse fisiche e fisiologiche, come l’esperienza diretta deve essere costituita?
Soffermiamoci brevemente su queste due domande.
a) Lo status delle sensazioni è ambiguo.
O le identifichiamo con qualche fase particolare dei processi fisiologici che avvengono a monte della retina (o a monte di qualche altro ricettore sensoriale periferico), e allora devono essere semplicemente un dato per il fisiologo: un processo fisico che avviene in un certo luogo dello spazio fisico. Ma allora non sono la contropartita psicologica elementare di qualcuno dei processi; usando il linguaggio helmholtziano, dobbiamo dire che non appartengono alla sfera della coscienza.
Oppure appartengono a tale sfera, e sono frammenti d’esperienza, realtà psichiche; ma allora non possono sfuggire all’osservazione diretta. In ogni momento deve essere possibile indicare le sensazioni che compongono una data esperienza.
In realtà, non sono né questo né quello.
Prendiamo il caso del colore rosso. Con la parola «rosso» possiamo voler indicare ciò che intende il fisico, cioè un treno d’onde elettromagnetiche di una data frequenza; oppure un processo fotochimico che interessa la retina; oppure una sequenza di impulsi che percorre il nervo ottico; oppure un processo fisico di altra natura che ha luogo nel cervello. In nessuno di questi casi la parola «rosso» ha il significato che le spetta quando parliamo di esperienze cromatiche reali, come avviene nell’uso quotidiano di tale termine. Le onde elettromagnetiche non sono colorate di rosso, nè sono rossi i processi fotochimici, o gli impulsi elettrici, ecc. Dato che la sensazione del rosso, per essere sensazione, deve essere intesa proprio nel senso dell’uso quotidiano, essa non trova posto tra quegli eventi fisici.
D’altra parte, quando vediamo realmente il rosso da qualche parte nella realtà circostante, non lo vediamo mai allo stato di «sensazione»: o è il colore filmare, cioè piatto e impenetrabile, di una superficie, o è la luminosità trasparente di un cristallo, o è una sorgente luminosa, un punto brillante nello spazio buio di una stanza. Non è possibile incontrarlo allo stato puro. Possiamo solo costruire un’astrazione (il «rosso» in sé) dall’esperienza di vari oggetti: ma naturalmente, cosi, non è più affatto un dato sensibile.
La sensazione del rosso non è tra gli eventi fisici, e non è tra i dati osservabili. È tutt’altro che un dato accertato o accertabile.
Dunque, o ci dedichiamo alla fisiologia, ma senza inferenze intorno all’esperienza effettiva dei colori, o ci dedichiamo ai colori, ma allora dobbiamo studiarli nella complessa fenomenologia degli oggetti e degli eventi cromaticamente rilevanti.
b) In secondo luogo, è corretto dedurre l’esistenza delle sensazioni come costituenti del mondo esperito per il fatto che le premesse fisiche e fisiologiche indicano con insistenza in tale direzione? Non corretto: secondo quello schema gli oggetti realmente esperiti dovrebbero essere pensati come la risultante dell’azione di «giudizi inconsci» sul materiale di queste «sensazioni inavvertite»: due ordini di fatti che sfuggono totalmente a qualsiasi forma di analisi empirica. Ammettere l’esistenza di zone inosservabili nell’esperienza diretta è un passo molto grave: secondo un argomento sviluppato da Köhler con grande finezza logica, un’ammissione così apre la via a qualsiasi teoria, togliendo la possibilità di verificare quale sia vera e quale sia falsa [1]: supponiamo di proporre una teoria qualunque dei rapporti psicofisici, che sia plausibile in base a due o tre fatti; ebbene, potremmo giustificare tutti gli altri fatti non congruenti con tale teoria dicendo che sono eccezioni dovute a qualcosa (ad es.: l’azione dei giudizi inconsci sulle sensazioni non avvertite) che è accaduto in una zona inosservabile dell’esperienza. E chi ci può smentire?
Selezionare una teoria tra molte possibili vuoi dire dimostrare che le altre sono false. Tolta questa possibilità, il discorso teorico diventa un soprappiù che grava intorno ai fatti, e la ricerca diventa una collezione di esperimenti magari correttamente eseguiti, ma incapaci sia di confermare che di produrre ipotesi.
Per questi motivi il terreno dello psicologo che lavora sulla percezione è la realtà fenomenica, così come essa si presenta, e pensata senza interstizi inaccessibili. Il ricercatore non può credere di aver concluso il suo lavoro nel momento in cui gli è riuscito di dedurre come la realtà dovrebbe risultare, date certe premesse; la sua opera comincia proprio con la verifica diretta intorno a come essa risulta all’osservazione.
Ora, accettando come punto di partenza una impostazione di tipo helmholtziano, appare chiaro che per isolare le sensazioni occorre procedere alla distruzione dei dati organizzati della esperienza. Questo modo di condurre la ricerca può essere pericoloso in un senso ben preciso: nell’ipotesi che le informazioni separate, all’uscita di If, non si affacciassero immediatamente alla coscienza in forma di sensazioni, ma invece subissero ulteriori trasformazioni, interferendo le une sulle altre in modo definito attraverso un certo numero di processi, noi non saremmo mai in grado di scoprire le leggi di quelle trasformazioni, né la dinamica di quei processi.
Per isolare una sensazione, occorre prescindere dal contesto in cui si trova celata. Ma il contesto esiste, ed esiste come un dato; se questo dato viene eluso nel corso delle ricerche, le leggi della sua costituzione ci sfuggiranno sempre. Converrà dunque assumere come oggetto di osservazione e di analisi prima di tutto i contesti organizzati.
Questo è il punto di partenza della teoria gestaltista.
Nel compiere questo passo, possiamo benissimo accettare lo schema Of - Ef1- Of2- Ef2 - If nella maniera in cui era stato utilizzato da Helmholtz. Of viene chiamato, dai gestaltisti, «stimolo distale»; e l’azione di Ef1 su Ef2 viene chiamata «stimolo prossimale».
Bisognerà invece mutare radicalmente l’interpretazione di ciò che avviene in (P).
Benché le prime mosse in questa direzione siano state compiute da Max Wertheimer - tanto nel settore della teoriaquanto in quello delle ricerche sperimentali - noi riassumeremo qui in breve alcune tesi di W. Köhler, che ha dedicato la massima parte della sua attività a questo tipo di studi.
Possiamo pensare alla struttura del sistema nervoso centrale come a quella di un sistema fisico straordinariamente complicato, una parte del quale è esposta direttamente all’azione di forze fisiche presenti all’esterno dei suoi confini (gli occhi, l’orecchio; e - attraverso una rete complicata di conduzioni -l’intero organismo). Tutto il sistema, nel suo complesso, tende spontaneamente all’equilibrio. Se una forza esterna agisce su una sua zona esposta, l’equilibrio assume un determinato assetto; se un’altra forza si aggiunge a quella già data, si realizzerà un nuovo tipo di equilibrio, che naturalmente è diverso da quello che avrebbe luogo se le due forze agissero separatamente, prima l’una, ad es., e dopo un certo tempo l’altra.
Molti sistemi fisici si comportano esattamente in questa maniera. Köhler ha dedicato un libro [2] allo studio di tali sistemi: esempi utili possono essere ritrovati tra particolari tipi di conduzioni idrauliche, o tra particolari casi di equilibrio osmotico; ma i casi più interessanti si danno nel settore dei campi magnetici ed elettrici: ad esempio la struttura delle linee di forza determinate dalla presenza di due poli magnetici, che varia con il variare della forma di essi, oltre che con la distanza tra essi intercorrente, e la distribuzione delle cariche elettrostatiche su di un semiconduttore, che varia con il variare della sua forma.
Un altro caso molto istruttivo è quello dei «problemi con condizioni assegnate al contorno». Srive Köhler: «Essi riguardano il raggiungimento spontaneo dell’equilibrio nell’interno di un sistema con caratteristiche fisiche note, quando ai suoi confini sono date determinate condizioni. Un caso ben noto di tali problemi è il seguente: mantenendo la superficie di un corpo (di materiale noto e di una data forma) a una certa temperatura, si tratta di trovare il tipo di distribuzione delle temperature e delle linee del flusso termico all’interno di esso, qualora si sia costituito spontaneamente un stato stazionario.
Altri esempi sono: il flusso di una corrente elettrica stazionana in un sistema continuo di forma data e per dati potenziali agli elettrodi; la distribuzione stazionaria spontanea della corrente di diffusione in una soluzione di data forma e date concentrazioni ai propri margini» [3].
Nella soluzione di questi problemi, leggi generali permettono di stabilire quali sono, a un momento dato, le condizioni interne del sistema in base alla sola conoscenza delle condizioni esterne, cioè quelle «assegnate». Essendo note queste ultime e le leggi generali, è noto lo stato interno: non sarà possibile allora, essendo nota una parte dello stato interno di un sistema (cioè (P)F ) e le condizioni agenti al contorno, individuare le leggi? È chiaro che in un primo momento tali leggi potranno essere solo postulate; ma attraverso successive generalizzazioni e particolarizzazioni - in casi diversi da quello studiato in partenza - non è escluso che si possa arrivare a un modello logico che sia strettamente aderente alla struttura dei processi.
Inoltre, gli stati di spontaneo equilibrio di un sistema fisico non devono essere considerati come mere analogie, in rapporto al reale funzionamento del cervello. Il sistema nervoso è un sistema fisico collocato nello spazio e nel tempo della fisica, e deve funzionare in base a leggi universalmente valide nel campo della fisica. Quali dei citati sistemi tendenti all’equilibrio funzionino in esso, non possiamo dire oggi con sicurezza. Ad ogni modo, la loro identificazione può essere raggiunta per almeno due vie: la ricerca puramente fisiologica ed anatomica, e quel particolare tipo di analisi funzionale che è, in psicologia, l’analisi fenomenologica.
Quest’ultima consiste nella ricerca sistematica delle condizioni grazie alle quali i fatti dell’esperienza diretta si presentano all’osservazione; condizioni, dunque, variando le quali, i fatti osservati subiscono modificazioni determinate, classificabili, misurabili (quando occorra), e nella maggior parte dei casi ripetibili.
I fatti dell’esperienza, naturalmente, vanno assunti come oggetto di studio in tutta la loro complessità, o - più esattamente - vanno semplificati entro limiti compatibili con l’integrità della struttura che si vuole studiare [4]. Non ci soffermeremo oltre ad illustrare con esempi questo tipo di tecnica, per il fatto che quasi tutte le prossime pagine di questo libro saranno occupate da descrizioni di ricerche. Qui occorre solo sottolineare che gli oggetti dell’esperienza, intesi in questo senso, coincidono con quel che Helmholtz riteneva essere il risultato delle inferenze inconscie sulla materia delle sensazioni, cioè il «sinolo» tra le facoltà mentali superiori e gli esiti immediati dell’attività degli organi di senso.
Per comprendere esattamente in che modo l’analisi fenomenologica può condurre all’individuazione delle leggi dei processi (P), occorre pensare che tali processi possano essere distinti in due classi: (P)S , la classe dei processi che si svolgono senza produrre alcuna conseguenza avvertibile nell’esperienza del soggetto (K. Koffka chiama questa fase «silent-organization»); e (P)F, la classe dei processi dai quali la struttura dell’esperienza attuale di un soggetto in un istante dato dipende intieramente, fin nei minimi dettagli e senza alcuna possibile eccezione (nella terminologia di Koffka, «manifest», oppure «non-silent organization»).
Più sopra, abbiamo proposto di denotare gli oggetti della esperienza diretta con il simbolo OF; ebbene, il campo totale di tutti gli OF e di tutte le relazioni intercorrenti tra essi coincide con il campo dei processi (P)F, completamente, e senza residui. Non c’è proprietà osservabile di OF cui non corrisponda un definito processo in (P)F (ancorché non noto alla fisiologia); non vi è alcuna forma di rapporto constatabile tra una proprietà e un’altra di OF cui non corrisponda un processo che mette in rapporto due definiti processi in (P)F. Se il colore di un oggetto veduto varia con il variare della forma del suo contorno, questo significa che esiste una connessione funzionale definita fra due processi in (P)F . Se la lunghezza visibile di un segmento varia in funzione della sua collocazione nello spazio, vi sarà un particolare processo in (P)F che varia col variare dei rapporti che lo legano a un certo numero di altri processi, sempre in (P)F.
In definitiva, se un certo risultato fenomenico dipende, nel
campo attuale delle esperienze, da n condizioni, ciò vuoi dire che in (P)F greco vi è un processo fisico il cui decorso dipende da n variabili.
Questo è il significato del «postulato dell’isomorfismo», proposto da Köhler in più luoghi delle sue opere.
È chiaro che, se si assume questo postulato come criterio per inferire dalle analisi fenomenologiche qualcosa intorno ai processi, quando ci accade di scoprire che un determinato aspetto dell’esperienza dipende - supponiamo da tre condizioni accertate sperimentalmente, il processo corrispondente in (P)F non potrà essere un processo fisico il cui decorso è sempre regolato da una variabile sola, o da due. Così, potremo scartare con sicurezza una interpretazione fisica definita dal campo delle possibili ipotesi fisiologiche.
In breve, volendo utilizzare uno dei modelli fisici proposti da Köhler, quello del corpo con «condizioni assegnate al contorno», potremmo riassumere l’interpretazione gestaltistica dei processi (P) con l’aiuto di questo schizzo:
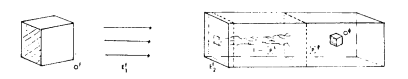
Le condizioni assegnate sono l’azione di Ef1 sulla faccia Ef2 del parallelepipedo, unica regione del corpo esposta all’azione di forze esterne. Il tratto (P)S è la zona della «silent organization», in cui la propagazione degli effetti di Ef2 all’interno del corpo avviene in un mezzo che permette interazioni tra essi. Infine (P)F è la zona in cui tali effetti - già ristrutturati dalle interazioni - terminano; e in questa zona nulla avviene che non sia un evento direttamente esperibile: non possiamo pensare altrimenti, perché per definizione i processi privi di contropartita nell’esperienza diretta appartengono alla classe delle «silent organizations», che nel nostro schema giacciono in una zona diversa. L’analisi sistematica di quanto avviene in (P)F è appunto l’analisi fenomenologica, essendo ogni processo in (P)F un fenomeno direttamente osservabile, per definizione. L’esito di tale analisi può essere sempre confrontato con la distribuzione delle condizioni al contorno, e questo confronto può fornire validi indizi intorno alle leggi che governano la propagazione attraverso (P)S.
Naturalmente, affinché le inferenze di questo genere siano attendibili, occorre stare assai attenti a realizzare correttamente le analisi fenomenologiche.
In primo luogo, nessuno degli aspetti fenomenici di una data situazione deve essere a priori scartato dall’elenco delle condizioni da cui la situazione in esame può dipendere. Un certo colore può apparire in un dato modo per la forma che ha l’oggetto di cui è colore, per il tipo di margini da cui è delimitato, per l’illuminazione che è diffusa nell’ambiente, per la distanza che lo divide da noi, ecc.
Ognuna di queste condizioni può essere quella decisiva; oppure può essere decisivo un gruppo di esse, o tutte.
In secondo luogo, è necessario evitare un tipico errore che spesso si infiltra subdolamente nelle analisi fenomenologiche: l’errore dello stimolo.
Köhler definisce l’errore dello stimolo nel modo seguente:«il pericolo di confondere la nostra conoscenza delle condizioni fisiche dell’esperienza sensoriale con questa esperienza in se stessa» [5]. Crediamo di interpretare correttamente il pensiero di Köhler includendo tra le «condizioni fisiche» tutti i momenti dello schema discusso nelle pagine precedenti, e in particolare quelle due sezioni di esso che abbiamo chiamato «stimolo distale» e «stimolo prossimale». L’errore consiste in questo: nell’attribuire all’oggetto della nostra analisi fenomenologica caratteristiche che non sono fenomenicamente tali, cioè che non sono attualmente ed esplicitamente suoi attributi qualitativi avvertibili; ma che invece sappiamo esser possedute, in qualche forma, dalle condizioni fisiche in gioco nella situazione considerata. Per rendere chiara l’idea, facciamo un caso limite: mostro un bicchiere a qualcuno, e chiedo a costui di descrivermi ciò che vede. Se mi risponde «uno sterminato aggregato di atomi» o «un fascio di raggi luminosi» egli - pur facendo una asserzione in un certo senso non sbagliata - commette l’errore dello stimolo. Questa, infatti, non è una descrizione fenomenologica.
È ovvio che non ci si imbatte mai, nel corso delle ricerche, in errori dello stimolo così ben visibili. Ma può succedere benissimo che, di fronte ad una figura disegnata così (fig. 1a) qualche osservatore decida di descriverla come un gruppo di figure geometriche piane più o meno regolari una accanto all’altra (fig. 1b). In effetti, dal punto di vista delle condizioni fisiche (considerate sia come «stimolazioni distali» che come «stimolazioni prossimali»), la descrizione non è scorretta -
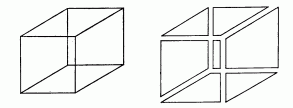
Fig. 1a Fig. 1b
Fig. 2
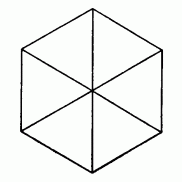
almeno entro certi limiti. Sta di fatto, però, che ciò che qui realmente si vede è un cubo, sia pure solo disegnato. Nella descrizione inficiata dall’errore dello stimolo non è presente una importante caratteristica dell’oggetto esaminato: la sua apparente tridimensionalità. Gli vengono invece attribuite due caratteristiche che non possiede: i) quella di essere una pluralità di aree contigue (mentre invece appare come «uno»); le quali nell’insieme giacciono su un piano una accanto all’altra, come quelle della fig. 2.
Descrivendo le cose a questo modo, tutto un problema fenomenologico va perduto, e precisamente questo: per quale motivo le figure 1a e 2, che sono tutte e due proiezioni di un cubo, differiscono così radicalmente tra loro per quanto riguarda il carattere di tridimensionalità apparente? [6].
Un altro esempio. Vediamo passare un treno merci, sui vagoni del quale sono sistemate, per il trasporto, molte autovetture. La descrizione fenomenologica più corretta di questa situazione è anche quella più spontanea: i vagoni si muovono, le autovetture stanno ferme [7]; rispetto alle condizioni fisiche distali della situazione ciò è falso: vagoni e autovetture si spostano con la stessa velocità; e per quanto riguarda ciò che accade sulla retina, ad ogni spostamento della proiezione retinica di un vagone corrisponde un identico spostamento della proiezione retinica di una autovettura trasportata. Se la descrizione dello stimolo distale o quella dello stimolo prossimale vengono prese per descrizioni fenomenologiche, un altro problema andrà perduto: quello che sorge dalla distinzione tra movimenti attivi e puri spostamenti nello spazio.
Il miglior modo di guardarsi dall’errore dello stimolo sta nel prendere alla lettera il principio di Berkeley, «esse est percipi», nel senso più radicale in cui può essere inteso: cioè: a) non vi è nulla che sia percepito e che si possa trattare come inesistente, e, b), non si deve attribuire esistenza a nulla, nel campo della esperienza attuale, che non vi appaia esplicitamente.
§ 2. Unità e omogeneità.
Tenendo presenti i principii che caratterizzano l’impostazione gestaltistica di fronte al problema delle organizzazioni dell’esperienza diretta, proviamo ora a prendere in considerazione alcuni fatti molto elementari.
Supponiamo di avere sotto gli occhi un quadrato nero perfettamente omogeneo, quale è difficile trovare altrove, che nei laboratori di psicologia. La sua superficie non presenta alcuna increspatura, alcuna asperità, niente di discernibile dal nero stesso.
Per ottenere un nero così perfetto, abbiamo rivestito il fondo di una scatola completamente con velluto nero; poi abbiamo praticato un foro quadrato sul coperchio, e, chiusa la scatola col coperchio così intagliato, l’abbiamo esposta all’osservatore, curando che la luce diffusa della stanza entri in essa meno che è possibile.
Questa situazione non ci serve per realizzare un esperimento, ma per farci intorno alcuni ragionamenti.
Possiamo dire che questo quadrato nero «ha parti»?
C’è un senso in cui possiamo dirlo: ognuno capisce quello che intendo quando dico «l’angolo del quadrato in alto a destra «, o «la parte del quadrato vicina al lato che fa da base». Ogni figura che abbia qualche estensione possiede parti in questo senso: quelle verso destra o sinistra, quelle verso l’alto o il basso, e la zona centrale.
Queste parti, però, non confinano tra loro in maniera definita: procedendo dall’una verso l’altra non incontriamo un confine visibile che le divide.
In questo senso il nostro quadrato è realmente una unità. È un oggetto al quale non può essere applicata la critica che Baumann avanzava contro l’applicazione del concetto di unità agli oggetti empirici. Baumann scriveva «le cose esterne non presentano alcuna proprietà rigorosa; esse ci danno gruppi di punti separati o punti sensibili, ma questi gruppi possono a loro volta venir considerati come nuove molteplicità».
Il quadrato considerato da noi ha più di una proprietà rigorosa: ha quattro lati visibili ben definiti che non possono essere confusi uno coll’altro, i quali delimitano una forma complessiva che non muta a seconda di come noi ci impostiamo per guardarla, ed è omogeneo al suo interno, senza parti discernibili e quindi enumerabili.
I «punti separati» di Baumann, infatti, non sono proprietà reali del nostro quadrato. Essi possono essere «pensati» ma non «visti»; attribuirli come proprietà, al quadrato vuol dire commettere l’errore dello stimolo. Alla luce dell’«esse est percipi» metodologico proposto poco fa, è chiaro che se il quadrato non appare fatto di punti, esso non è fatto di punti. I punti ci sono sulla retina, o viaggiano lungo le fibre del nervo ottico; ma in questo senso non sono eventi visibili, o dati immediati d’esperienza - sono solo nozioni della fisiologia.
Quanto alla loro ulteriore infinita suddivisibilità, essa è una interessante costruzione logica che non è necessario riferire al nostro quadrato più che a qualsiasi altra cosa reale, immaginata o puramente pensata.
Il quadrato veduto non cambia neppure di poco, in modo fenomenicamente esplicito, mentre pensiamo una cosa o l’altra; esso resta «uno» esattamente come resta «nero». La sua unità è indipendente dai nostri ragionamenti sulla sua suddivisibilità.
A questo punto, noi possiamo supporre che questa sua unità dipenda esclusivamente dalla sua omogeneità interna. È una ipotesi plausibile. Ma può essere smentita con una prova.
Al posto del quadrato, mettiamo davanti all’osservatore (e usando il procedimento già descritto), un’altra figura altrettanto omogenea, fatta come questa:
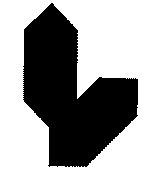
Fig. 3
Le sue caratteristiche sono nettamente diverse: qui abbiamo sotto gli occhi due unità [8]. Se avessimo assunto come criterio esclusivo dell’unitarietà l’omogeneità interna, dovremmo dire che si tratta di un poligono irregolare. Ma noi non abbiamo assunto l’omogeneità come criterio, bensì come ipotesi; esaminando la figura 3 è possibile stabilire che accanto all’omogeneità interna gioca almeno anche un altro fattore, anch’esso fenomenicamente del tutto esplicito, cioè l’andamento del contorno.
L’omogeneità è una proprietà visibile, e l’andamento del contorno è una proprietà visibile; insieme, determinano la proprietà visibile di essere «uno» o «due».
Complicando l’andamento del contorno, possiamo ottenere una pluralità di oggetti, discernibili l’uno dall’altro a dispetto del fatto che non vi è interruzione nell’ omogeneità del colore grazie al quale esistono come oggetti contro il fondo bianco della pagina.
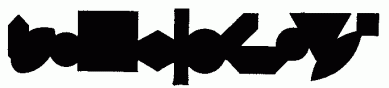
Fig. 4
§ 3. Vicinanza e somiglianza.
Ma anche di «due» oggetti, o di «più» oggetti, si può parlare in sensi differenti.
Confrontiamo le due file di punti a) e b):
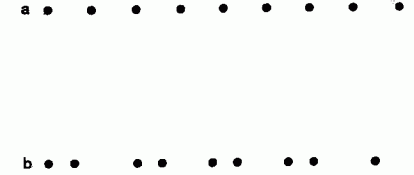
Fig. 5
In tutti e due i casi si tratta di nove punti uno dopo l’altro. Ma la «fila di punti» a) differisce nettamente dalla fila b). Quest’ultima può essere descritta come quattro coppie di punti più un punto.
Indubbiamente, anche la fila a) può essere «pensata» come formata da quattro coppie più un punto; allo stesso modo, può anche essere «pensata» come formata da tre triplette, o da otto punti più uno. Questi «pensieri» possono essere formulati altrettanto bene nei confronti della fila b). Occorre però notare che se ci mettiamo su questo piano non abbiamo più ragione alcuna neppure per distinguere la fila a) dalla fila b), dato che la stessa nozione di «fila» cessa di avere un senso qualsiasi; anzi, nel formare gruppi puramente «pensati» potremmo includere nelle combinazioni anche i punti che dividono, nel testo scritto, un periodo dall’altro; e infine potremmo supporre che sulla pagina vi siano innumerevoli punti bianchi come la pagina stessa, e perciò non visibili, ma enumerabili come membri di queste collettività «pensate».
Dal momento, però, che stiamo cercando di evitare di collocarci nella prospettiva di Hume, non possiamo ammettere questi punti bianchi sulla pagina: essi non vi appaiono. E i punti neri, dato che sono discernibili dalla pagina stessa, vi occupano un luogo determinato. Proprio grazie a questo fatto siamo in grado di comprendere senza alcuno sforzo il senso dell’espressione «file di punti». Ebbene: il fatto che la descrizione «quattro coppie di punti più uno» sia calzante per la fila b) e non per la fila a) dipende esattamente dagli stessi motivi : cioè dai rapporti tra le collocazioni spaziali che i vari punti hanno.
I punti sono una pluralità concretamente riscontrabile proprio perché sono distribuiti nello spazio; e si può parlare di «distribuzione» perché tra essi intercorrono distanze definite.
Possiamo accorciare una distanza intercorrente tra due punti finché diventa sensibilmente più piccola di quelle che dividono gli altri punti compresenti nel campo d’osservazione, e allora abbiamo una «coppia»; un nuovo tipo di unità.
Questa osservazione costituisce il primo passo della ricerca di Max Wertheimer sulla costituzione delle unità d’esperienza, che esporremo ampiamente nel corso del presente capitolo [9]. Tanto più piccola è la distanza tra i punti, e tanto maggiore è la forza dell’unità formata da essi:
Questa legge non riguarda soltanto l’organizzazione degli oggetti visivi, ma anche quella delle esperienze acustiche e tattili.
Nel campo acustico il fenomeno gode di un’evidenza particolare: basta provare a battere sul tavolo con l’estremità della matita una serie di colpi così distribuiti:

Fig. 6
I gruppi di colpi si costituiscono come unità segregate ognuna delle quali ha una sua propria struttura interna ben definita. Nelle serie e) e f), in cui la distanza temporale tra un colpo e l’altro è particolarmente piccola, la successione assume l’aspetto di una «scarica», in cui i colpi non possono essere distinti o contati, ma concorrono insieme a produrre un particolare tipo di rumore. Ogni tratto di rumore è una ben definita unità, mentre la stessa cosa non può più esser detta dei singoli colpi da cui risulta.
Negli esempi realizzabili in campo acustico, come è ovvio, la nozione di «vicinanza» riguarda gli intervalli temporali; ma il tempo fenomenico, in questo caso come in molti altri, è una dimensione dell’esperienza con proprietà funzionali assai simili a quelle dello spazio. Nel linguaggio d’ogni giorno le relazioni temporali vengono normalmente descritte con metafore spaziali; «a distanza di tempo», «lungo tempo» «in un prossimo tempo», «più oltre» ecc. un modo di parlare che ha un concreto fondamento nella psicologia della percezione.
In campo visivo, la legge della «vicinanza» (prima legge di Wertheimer) serve molto bene a definire il concetto di «parte
naturale» di un tutto. Dal momento che l’unitarietà varia con il variare dei rapporti di vicinanza, è possibile costruire organizzazioni in cui sono chiaramente visibili «parti», le quali a loro volta sono composte di parti elementari, cioè i punti stessi.
Ad esempio:
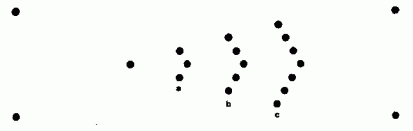
Fig. 7
Il raggruppamento dei punti ha press’a poco la forma di un aquilone, scandita in quattro substrutture ben distinte, tre delle quali fatte di punti connessi da una forte vicinanza, e una costituita da un punto solo. Inoltre lontani da questa figura, vi sono altri quattro punti. Le substrutture fanno parte di un’unica organizzazione, in quanto sono abbastanza vicine tra loro (per esempio, rispetto ai punti collocati ai margini dell’illustrazione); ma -restano ben discernibili, perché gli elementi visibili in esse si trovano tra loro a distanze ancora minori.
Il tentativo di raggruppare i punti in maniere diverse può, forse, riuscire per qualche attimo, con uno sforzo di impostazione soggettiva. Ma, se si realizza, la nuova configurazione dura assai poco.
Esattamente in questo senso i gruppi «a», «b», e «c» della fig. 7 sono «parti naturali»: sono parti, in quanto sono veduti come parti, e sono naturali, in quanto la loro organizzazione in quella forma è spontanea, resiste ai tentativi di trasformazione. E tanto l’essere parti quanto l’essere così organizzate - e non in altro modo - dipende intieramente dalla distribuzione dei rapporti di vicinanza.
Se l’unico fattore di organizzazione in unità fosse quello ora descritto, sarebbe impossibile produrre esempi di unificazioni - ad es. in coppie - tra oggetti equidistanti. Il fatto che questa circostanza possa aver luogo dimostra che altri aspetti dell’esperienza diretta sono in grado di svolgere un ruolo analogo.
Osserviamo la fig. 8:
![]()
Fig. 8
Si tratta di una serie di punti equidistanti, però chiaramente raggruppati in coppie.
Il fattore d’unificazione, in questo caso, è l’identità cromatica dei punti: Wertheimer lo ha chiamato «fattore della somiglianza» (seconda legge di Wertheimer).
In campo acustico, l’esempio della fig. 8 può essere realizzato battendo - in una successione ritmicamente regolare - colpi a due a due simili per timbro (due colpi di campanello e due battiti con le nocche delle dita contro la porta).
Quando nella medesima costellazione di punti compaiono i due fattori insieme, essi possono cooperare alla formazione di unità, oppure possono agire in senso opposto. Ecco i due relativi esempi:
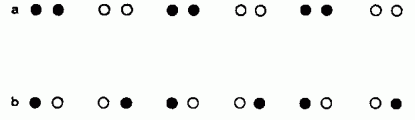
Fig. 9
L’esempio b) riveste un’importanza particolare. È possibile, infatti, variando opportunamente la distanza tra i punti, stabilire qual’è la «forza» della somiglianza rispetto a quella della vicinanza. Occorre disporre i punti in maniera che là dove agisce la vicinanza come fattore di unificazione, agisca la somiglianza come fattore di segregazione, e quindi accertare per quali distanze l’unificazione si realizza solo per vicinanza e per quali altre solo per somiglianza. Nell’esempio b) della fig. 9 la somiglianza agisce piuttosto fortemente; in quello della fig. 10; non altrettanto:
![]()
Fig. 10
Vi è certamente una zona intermedia in cui è possibile vedere ugualmente bene - alternativamente - le due forme di unificazione. In questi casi, si può dire che le due forze si bilanciano tra loro, lasciando un margine all’impostazione soggettiva dell’osservatore. La descrizione è un po’ astratta, in quanto tali forze non si vedono: sotto gli occhi non c’è altro che una collocazione specifica di punti dotati di specifiche proprietà; solo che le relazioni d’unificazione tra essi intercorrenti mutano con facilità ogni volta che compiamo un leggero sforzo diretto intenzionalmente a realizzare una unificazione piuttosto che l’altra. Questo atto d’impostazione è veramente avvertito come «sforzo», ed è avvertito come «soggettivo»; lo possiamo dunque appropriatamente chiamare «sforzo soggettivo»; poi siamo indotti a trasferire il concetto di forza anche alle relazioni spaziali e qualitative tra i punti. Il che è utile, cioè comodo, ma improprio.
§ 4. Destino comune e impostazione obbiettiva.
Vi è un terzo fattore che è in grado di prevalere tanto sulle unificazioni per vicinanza quanto su quelle per somiglianza, ed è il fattore del «destino comune» (terza legge di Wertheimer).
Prendiamo le due seguenti file di punti, una già divisa in gruppi in forza della vicinanza, a), l’altra in forza della somiglianza, b):
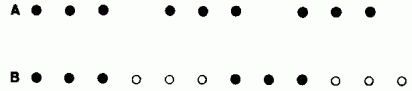
Fig. 11
e all’improvviso, senza che il soggetto se lo aspetti, ma sotto i suoi occhi, facciamo slittare verso l’alto, ad es., tutti i punti dispari di una serie o dell’altra.; istantaneamente le unificazioni per vicinanza o per somiglianza si rompono: al loro posto si formano due unità nuove, quella che comprende tutti i punti pari e quella che comprende tutti i punti dispari. Cioè, si unificano tutti i punti coinvolti in uno stesso destino: o legati da un movimento solidale, o rimasti fermi.
Questo esperimento può riuscire in maniera particolarmente evidente e con l’impiego di mezzi facilmente accessibili: basta disporre di un proiettore e di due rettangoli di vetro aventi le dimensioni adatte per essere infilati nella guida in cui vengono fatte passare le diapositive. Su ognuno dei vetri si segna, ad es., con l’inchiostro di china, una costellazione di puntini neri; poi, si infilano i due vetri insieme, sovrapposti: sullo schermo così appare una costellazione di punti che è la somma delle due costellazioni segnate sui vetri.
Questa costellazione è unica, finché i punti restano fermi; ma non appena uno dei due vetri viene fatto scivolare sull’altro, di colpo vi sono sullo schermo due costellazioni, una in moto e l’altra ferma. Arrestando lo scorrimento, dopo qualche attimo abbiamo davanti agli occhi ancora una costellazione unica. La scissione in due unità è immediata, coercitiva, evidentissima.
Lo scorrimento relativo di alcuni punti rispetto ad altri serve a mettere in luce anche un’altro fattore di unificazione: quello dell’impostazione obbiettiva. L’impostazione soggettiva di cui abbiamo parlato poco fa dipende essenzialmente da un atto intenzionale compiuto dall’osservatore nei confronti della struttura che ha davanti a sé: se le forze obbiettive in conflitto si bilanciano - abbiamo visto - c’è spazio per l’azione di quest’atto, e se ne vedono gli effetti.
L’impostazione oggettiva produce anch’essa effetti di unificazione in situazioni nelle quali le forze obbiettive istantanee si trovano in equilibrio, ma non dipende da un atto avvertito come soggettivo, bensi dalla struttura dinamica della situazione stessa.
Ecco la situazione in cui la sua azione può essere osservata:
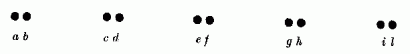
Fig. 12
Inizialmente, gli intervalli a-b c-d ecc. sono - poniamo - di due millimetri, e quelli grandi, b-c d-e ecc. di venti milli metri.
Lentamente, facciamo scivolare i punti b, d, f, h, i verso destra, finché i rapporti di vicinanza siano invertiti: cioè b-c d-e ecc. saranno distanze di due millimetri, e a-b- c-d ecc. distanze di venti millimetri.
Realizzando questo scorrimento in modo continuo, è chiaro che a un certo momento tutti i punti si troveranno per un attimo equidistanti; nel momento in cui, cioè, l’intervallo tra l’uno e l’altro avrà raggiunto il valore di undici millimetri.
Se la presentazione viene vista ferma a questo punto, essa è identica alla situazione della fig. 5, a): non vi è alcuna unificazione fenomenicamente privilegiata; il fattore della vicinanza non vi può funzionare realizzando coppie particolari.
Ma se l’osservatore ha assistito fin dall’inizio allo spostamento solidale, le coppie a-b c-d ecc. gli risultano ancora chiaramente collegate. Anzi, procedendo oltre, l’unificazione di partenza continua ad esserci anche dopo che per i rapporti di vicinanza è incominciata l’inversione; per non molto, naturalmente, ma in modo abbastanza sensibile.
In questo senso, l’intero evento dinamico del trasferimento dei punti b, d, f, h, l. agisce da fattore di unificazione contro i rapporti istantanei di vicinanza che hanno luogo, momento per momento, nel corso di esso.
§5. Direzione e chiusura.
Un altro fattore di unificazione può essere opposto a quello della vicinanza, cioè il fattore della «direzione» (quarta legge di Wertheimer).
Nella costellazione di punti visibili in fig. 13, a, è chiaro che i punti i quali formano - per vicinanza - la linea verticale sono più vicini ai punti che formano la prima metà della linea orizzontale, di quanto non lo siano quelli costituenti la seconda metà della stessa.
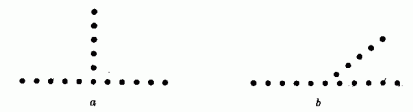
Fig. 13
Tuttavia, le due metà della linea orizzontale sono perfettamente unificate, tanto che, percettivamente, tale linea è «una», e solo astrattamente pensabile come composta da due metà. Nella figura 13, b, la vicinanza tra i punti che formano la sbarra obliqua ed alcuni punti della linea orizzontale è ancora. più grande. Tuttavia, la sbarra obliqua è ugualmente bene isolata.

Fig. 14
Questa proprietà funziona anche quando abbiamo a che fare con curve: in un caso come quello della fig. 14, dopo l’incrocio, ognuno dei quattro segmenti di curva a, b, c, d, potrebbe in teoria unificarsi con qualunque degli altri tre. Eppure, continua nel segmento il cui andamento - nel primo tratto dopo l’incrocio - è più simile a quello che esso ha in prossimità dell’incrocio stesso.
La robustezza di questo fattore risulta particolarmente chiara quando tentiamo - in alcuni casi almeno - di modificare con l’impostazione soggettiva la sua azione, cercando di vedere una struttura, in cui esso agisce, secondo altre configurazioni teoricamente possibili.
Ad es.:
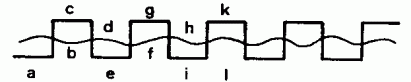
Fig. 15
nella fig. 15 si dovrebbe poter vedere una segmentazione del tipo a, b, e, f, i, l. accanto ad una segmentazione c, d, g, h, k; ma è praticamente impossibile. La segmentazione naturale a, c, e, g, i, k e la linea ondulata b, d, f, h, l, risultano ineludibili.
Naturalmente, se un segmento di curva fa capo ad una biforcazione dalla quale partono linee con un andamento abbastanza simile, le soluzioni percettive sono due. Basta confrontare i due disegni tracciati nella fig. 16:
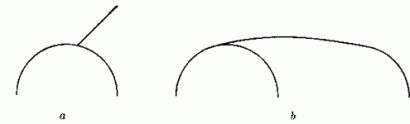
Fig. 16
nel primo caso (a) è assai difficile che una parte dell’arco di cerchio trovi la sua continuazione nel segmento di retta, il quale appare come una «appendice» aggiunta; nel secondo caso (b) due unificazioni sono quasi ugualmente possibili: quella in un arco di ellissi (con una appendice che è un arco di cerchio) e quella in un arco di cerchio (tangente in un punto all’estremità di un arco di ellisse).
La quinta legge di Wertheimer riguarda il comportamento del fattore di «chiusura».
Supponiamo di avere due linee tracciate cosi:

fig. 17a
Se vengono opportunamente congiunte, esse cessano d’essere unità per conto proprio, e danno luogo ad una figura segmentata in due oggetti, ciascuno chiuso in se stesso (fig. 17 b).
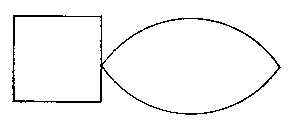
fig. 17b
L’esistenza di una specifica tendenza alla chiusura risulta in modo particolarmente chiaro - come è naturale - in situazioni dove ci si potrebbe aspettare anche un tipo di soluzione percettiva diversa.
Nelle due figure 18a e 18b le linee continue e le linee punteggiate sono disposte in modo da poter offrire l’occasione anche ad una unificazione d’altro tipo: cioè a forma di ¥ . Tuttavia, la configurazione più stabile è quella che consente di vedere due aree accostate, tangenti in un punto, chiuse in se stesse.
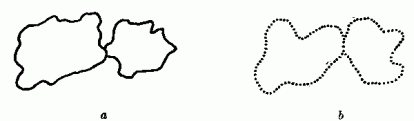
fig. 18
Non sempre, d’altra parte, la chiusura si realizza, anche essendo presenti le condizioni materiali dalle quali - in astratto - potrebbe aver luogo. Basti pensare all’esempio della fig. 15, in cui, da un punto di vista strettamente topologico, vi sono otto regioni interamente circoscritte da un confine, e tuttavia ciò che appare è una specie di semplice greca attraversata da una linea ondulata.
Non occorre, del resto, che la chiusura sia realizzata completamente. Wolfgang Köhler cita un esempio particolarmente dimostrativo, in questo senso [10].
Osserviamo la seguente serie di linee verticali:
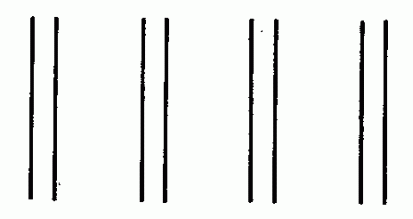
Fig. 19
Qui l’unificazione avviene in forza del fattore di vicinanza: lo spazio compreso tra le linee più vicine ha un carattere sensibilmente diverso dallo spazio compreso tra le linee distanti. Quest’ultimo è semplicemente il bianco della pagina, che passa tra le coppie di linee; in mezzo a queste, invece, il bianco ha maggiore compattezza, come avviene di solito con i colori appartenenti alle figure, in confronto con i colori diffusi nello sfondo. Le linee vicine delimitano una «cosa»; il resto è spazio.
Basta però introdurre una piccola modifica perché la situazione si inverta. Ecco come:
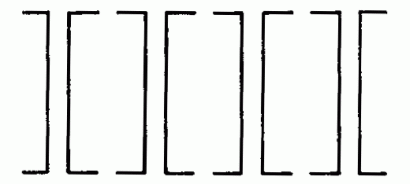
Fig. 20.
Nella fig. 20 lo spazio vuoto passa attraverso i canali più stretti, e il colore compreso tra le linee distanti è diventato quello caratteristico delle «cose», non degli «sfondi». Questa soluzione percettiva ha luogo anche senza che si sia realizzata una chiusura completa. Ovviamente, il risultato diventa ancora più chiaro nel caso in cui ciò venga fatto.
Nel caso ora considerato, la chiusura agisce in maniera decisiva contro il fattore di vicinanza; ma può anche essere messa contro la somiglianza, cosi:
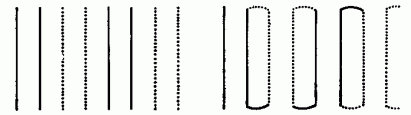
Fig. 21
oppure contro la continuità della direzione, che pure è un fattore molto forte, cosi:

Fig. 22.
§ 6. La pregnanza.
Spesso, comunque, le organizzazioni fondate sul fattore della chiusura risultano complicate dalla presenza di un altro fattore, non così agevolmente definibile come gli altri. Si tratta della «buona forma», o «pregnanza» (sesta legge di Wertheimer). La nozione di «buona forma», disgraziatamente, è chiarissima sul piano intuitivo, ma difficile da analizzare. Sono buone forme i cerchi, i quadrati, gli esagoni, tutte le figure geometriche regolari. Esiste, in campo percettivo, qualche forma ben definita di tendenza alla pregnanza: ogni figura che sia molto prossima per forma ad una data figura regolare, appare piuttosto come quella forma regolare «sbagliata», che come una figura diversa: un angolo che abbia poco più o poco meno di 90° sottolinea Wertheimer [11] - difficilmente appare come un angolo ottuso o acuto: è un angolo retto «sbagliato». Difatti se viene presentato ad un osservatore solo per un attimo brevissimo, questi lo vede assai spesso come retto.
Ma la pregnanza può essere «regolarità», «semplicità», «simmetria». Nella seguente figura, la regolarità ritmica del zig-zag fa fallire l’unificazione per continuità di direzione dei segmenti a e b, con quelli che sarebbero i loro naturali prolungamenti dopo l’incrocio:
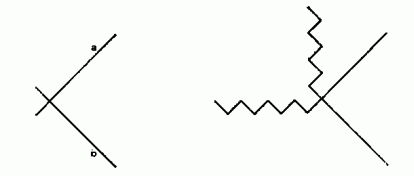
Fig. 23
Nel caso della fig. 24, la regolarità della distribuzione delle linee orizzontali forma un’unità così compatta, da impedir di vedere, in una di esse, il terzo lato di un triangolo che mostra ben visibilmente gli altri due [12].
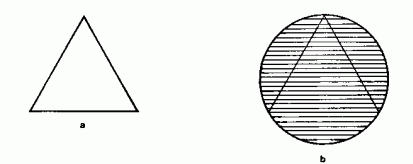
Fig. 24
La buona forma come simmetria e semplicità, invece, entra in campo quasi sempre quando si tratti di configurazioni fondate sulla chiusura. Ecco un caso semplicissimo:
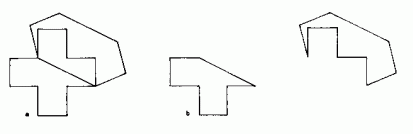
Fig. 25.
Il disegno a della fig. 25 dovrebbe potersi articolare (per quanto riguarda gli altri fattori d’unificazione) nelle due figure b e c. Ma percettivamente è assai difficile che succeda, per il fatto che una croce ed un esagono possiedono l’una quattro e l’altro due assi di simmetria laddove le figure b e c non ne hanno alcuno [13].
Così nei seguenti esempi di Wertheimer:
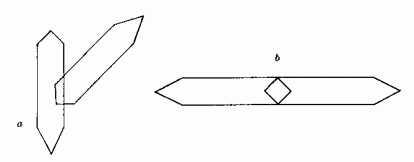
Fig. 26 a
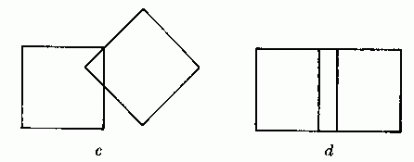
Fig. 26 b
Nei casi a e c della fig. 26 è assai probabile che, accanto alla continuità della direzione, agisca, sul particolare tipo di chiusura che si instaura, anche la pregnanza, intesa come tendenza alla simmetria. Tuttavia, l’aspetto più importante di questi ultimi esempi sta - secondo Wertheimer - nel fatto che l’organizzazione delle figure a e c è nettamente duale. Nelle figure b e d, invece, si ha piuttosto come risultato un nuovo tipo di unità. Nell’uno e nell’altro caso ogni unità in se stessa realizza il massimo della simmetria consentito dalla distribuzione delle linee. L’irregolarità delle zone di intersezione tra i due elementi presenti nelle figure a e c non ha alcun peso, dal momento che tali intersezioni non sono in alcun modo figure a sé, ma solo, di caso in caso, una parte di ciascuna delle figure che si realizzano percettivamente come unità.
§ 7. L’esperienza passata.
L’ultima legge di unificazione presentata da Wertheimer nella sua ricerca è quella dell’ «esperienza passata» (settima legge di Wertheimer).
Può essere esposta cosi: se siamo abituati a incontrare frequentemente nell’esperienza immediata gli oggetti A e B associati insieme, e siamo abituati ad incontrare - in altre occasioni - l’oggetto C isolato; e, inoltre, non abbiamo mai occasione di incontrare B e C associati insieme; allora, di fronte al complesso ABC, a parità di tutte le altre condizioni, si realizzerà spontaneamente una segmentazione percettiva di tipo AB/C.
Un esempio può essere questo: generalmente ci accade di vedere, leggendo, lettere insieme con lettere e numeri insieme con numeri. Quando siamo di fronte ad un aggregato formato così: 473HP, non possiamo fare a meno di vederlo come composto di due parti, 473/HP. Con ogni probabilità questa segmentazione non avrebbe luogo per un osservatore che non conoscesse il nostro sistema di numerazione ed il nostro alfabeto.
La caratteristica fondamentale di questo principio sta nel fatto che, rispetto a tutte le altre leggi di unificazione precedentemente illustrate, esso non fa riferimento ad alcun aspetto concretamente presente nella struttura delle situazioni date, o a relazioni visibili tra esse, o al loro contenuto. Il risultato dell’organizzazione dipende essenzialmente da un’abitudine, cioè da un fatto «esterno, estrinseco, arbitrario» rispetto a ciò che è attualmente veduto.
La legge dell’esperienza passata può essere letta anche in una forma diversa: se siamo abituati ad incontrare frequentemente ABCD, connessi insieme in una forma definita, la sola presenza di ABC può - almeno in determinate condizioni - provocare l’esistenza di D senza che vi sia per D alcuno specifico tipo di stimolazione. L’esempio è ben noto:
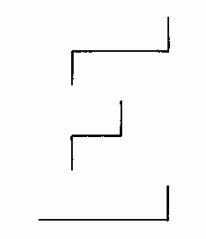
Fig. 27
Anche qui, un osservatore che non conosce il nostro alfabeto non può vedere la lettera E in queste tre linee spezzate. Noi stessi, se il foglio viene girato di novanta gradi, stentiamo a rintracciarla. La lettera E si vede in quanto il suo contorno viene completato nei punti dove materialmente manca sulla carta, da una particolare forma di margine.
Questo margine, a seconda del grado di evidenza che assume, può essere paragonato ad una linea virtuale come quella che unisce i punti della fig. 28 dando luogo ad una linea ondeggiante, o ad un margine quasi-percettivo [14] come quello che delimita il triangolo «apparente» (ma fenomenicamente ben reale) nella fig. 29.

fig. 28

Fig.29
Qualunque delle due forme esso abbia per un determinato osservatore, tale margine corre in modo da completare la raffigurazione di una grossa E in rilievo ed in prospettiva.
L’esperienza passata come fattore di unificazione percettiva, dunque, esiste, produce effetti ben definiti, e svolge un ruolo specifico in alcune organizzazioni dell’esperienza attuale. Probabilmente la lista degli esempi di organizzazioni in unità dovute a tale fattore può essere allungata ancora : non c’è alcuna ragione teorica che impedisca di ammettere la sua azione accanto a quella degli altri già elencati.
La faccenda si prospetta però in modo diverso se cerchiamo di generalizzare la funzione dell’esperienza passata, al punto di renderla responsabile di ogni organizzazione unitaria dell’esperienza attuale.
Parecchi studiosi (al tempo in cui Wertheimer scriveva; non molti più che oggi, del resto), e appartenenti anche a scuole diversamente orientate, sono stati favorevoli alla riduzione di tutti i casi di unificazione finora esaminati all’ «esperienza passata», «ritenendo di aver risolto ogni problema con l’assai facile uso di questa parola» [15].
Le loro obbiezioni possono anche apparire, a tutta prima, convincenti: linee diritte, o bene curvate, l’angolo retto, il quadrato ecc. sono dati comunissimi dell’esperienza, non c’è dubbio che li abbiamo visti innumerevoli volte. Il fatto stesso di leggere su pagine stampate insegna a vedere «insieme» le lettere che costituiscono le singole parole - infatti, tra ogni parola e la successiva vi è uno spazio. Ragionamenti analoghi possono essere applicati più o meno agevolmente a ciascuno dei fattori d’unificazione trattati fin qui, nel corso del presente capitolo.
Tutto questo è ovvio, ma non risolve alcun problema. Occorrerebbe contare caso per caso (in quello della vicinanza, della somiglianza, della chiusura, ecc.) quante volte veramente l’esperienza c’è stata, per ogni dato osservatore: cioè, occorrerebbe dimostrare che veramente le organizzazioni del tipo precedentemente discusso sono state frequentissime, e rare quelle di tipo diverso. Ma esaminando i casi da vicino la cosa appare molto improbabile.
Prendiamo quello dell’angolo retto. Parrebbe che fin da bambini abbiamo visto dappertutto angoli retti: guardando case, finestre, tavoli, lavagne libri, quadri ed innumerevoli altri manufatti. Ma a parte che è ben difficile incontrare esperienze così, non appena si esca dall’ambito degli oggetti costruiti dall’uomo - è abbastanza evidente che le circostanze nelle quali avviene di trovarsi di fronte agli angoli retti in modo che essi siano tali anche nella proiezione retinica sono piuttosto fuori del comune.
È raro capitare davanti a qualcosa che abbia angoli retti nella sua struttura, collocati proprio in posizione frontoparallela a noi che li osserviamo. In questo senso, si può dire che ogni bambino fa caso mai un gran numero di esperienze di angoli acuti e ottusi.
D’altra parte, se il problema viene spostato dall’ambito delle stimolazioni retiniche a quello delle vere ed attuali esperienze organizzate, tutto l’argomento si ripropone tale e quale da capo: il bambino vede ogni giorno, effettivamente, innumerevoli angoli retti; ma il problema è: quando ha imparato a vedere gli angoli acuti presenti nelle stimolazioni retiniche come angoli retti? [16].
La circolarità della tesi empiristica, quando assuma quest’ultima forma, può essere resa particolarmente ben visibile nel modo seguente: chiamiamo E una certa esperienza, avente alcune ben definite caratteristiche (l’angolo retto, il colore rosso, l’accordo di tonica, il sapore amaro ecc.), ed indichiamo con numeri progressivi le varie volte che una stessa persona ha avuto tale esperienza; E1, E2, E3, ... En è la serie di esperienze E riscontrabili nella biografia di quella persona fino a un certo momento della sua vita. Che cosa significa la frase «egli vede E così e così proprio perché lo ha già visto altre volte?». Se questa affermazione è riferita alla particolare occasione storica En, significa che l’individuo in questione vede in En - quello che vede, per il fatto che aveva visto qualcosa di strettamente analogo (o piuttosto di identico - cfr. il prossimo capitolo, §§ 6-7) in En-1; e in En-1 ha visto quello che ha visto per il fatto che lo aveva visto in En-2; e così via. A un certo momento - se la serie è finita, come non può non essere - si arriva ai casi E3, E2, ed infine al caso E1,. Bene; a questo punto il ragionamento non può essere ripetuto. O postuliamo, come Platone nel Menone, che tutta la serie di esperienze E1,E2,E3 ... En è stata resa possibile da una precedente esperienza «assoluta» avuta prima di nascere, nel corso di un’altra vita; oppure, e questa alternativa ci sembra la più compatibile con lo spirito che anima oggi come oggi la maggior parte dei ricercatori, tutta la serie E1, E2, E3, ... En rappresenta niente più che il numero delle ripetizioni dell’esperienza E per un dato osservatore: in cui nessun membro modifica, né spiega, la struttura dei successivi. Una macchia rossa è una macchia rossa sia che io l’abbia vista una volta, che cento.
Le critiche possibili nei confronti dell’ «esperienza passata», intesa come spiegazione di tutte le articolazioni del mondo percettivo, sono innumerevoli, tanto sul piano logico che sul piano empirico. Un catalogo molto bene argomentato di esse, e corredato da alcuni contributi originali di tipo sperimentale, è contenuto in un recente lavoro di G. Kanizsa, al quale rimandiamo il lettore [17]. Ciò che qui importa sottolineare, ora, è piuttosto il fatto che il rifiuto dell’esperienza passata come unico fattore d’unificazione, e la riassunzione di questo stesso concetto nella forma di un fattore che agisce (quando può) accanto agli altri, costituisce un netto vantaggio nei confronti di nuove possibilità di ricerca.
8. Gli esperimenti di Gottschaldt.
Abbiamo visto nel corso di questo capitolo come la vicinanza possa essere messa in conflitto con la somiglianza, con la continuità della direzione, con la chiusura; e a sua volta la chiusura con la continuità della direzione, con la somiglianza ecc.; allo stesso modo - se l’esperienza passata non è il fattore magico su cui ogni unificazione è fondata, ma è u n fattore tra gli altri - devono potersi realizzare situazioni in cui ognuno dei fattori formali già descritti entra in relazione (antagonistica o sinergetica) con quelle strutture che dovremmo aspettarci in base all’esperienza, alle abitudini, alla ripetizione ecc.
Gli esempi potrebbero essere molti. Ci limiteremo a riferire quelli pubblicati da Kurt Gottschaldt nel 1926, che egli utilizzò per un gruppo di esperimenti suggeriti da Wertheimer.
Gottschaldt, all’inizio del suo saggio, sottolinea molto opportunamente il fatto che il concetto stesso di «esperienza passata» (Erfahrung) è piuttosto confuso. Non sempre facile stabilire che cosa significa realmente, caso per caso. Per poter dare corpo ad una ricerca convincente occorre prima di tutto costruire una definizione univoca di tale concetto, a rischio di restringerlo anche di molto rispetto all’estensione ampia e non bene circoscritta che di solito ha.
Ammettiamo di aver imparato a vedere i vari pezzi dell’esperienza attuale (Erlebnis) che si presentano come unitari attraverso una serie di «incontri» con un dato tipo di stimoli; se facciamo nostro questo assunto, dobbiamo accettare anche le sue conseguenze: prima di tutto, l’ipotesi di una influenza esercitata da ogni «incontro» sul successivo, e da tutti gli «incontri» sull’ultimo, cioè sul dato attuale; in secondo luogo, l’ipotesi che tale influenza poggi su certe proprietà delle ripetizioni: ad esempio, il loro numero, il tipo di stimoli presentati volta per volta, il tempo compreso tra l’una e l’altra di esse. In breve; la coesione dell’unità esperita deve dipendere da qualcuno di questi fattori operativamente definibili, o da tutti insieme: altrimenti l’esperienza passata non è una spiegazione, ma un flatus vocis e basta.
Se le teorie empiricistiche sono corrette, deve succedere che una segmentazione /ABC/, fondata su un grande numero di ripetizioni, deve emergere meglio da un complesso di stimoli KLMABCXYZ (nella forma KLM/ABC/XYZ) di quanto non possa emergere una segmentazione abc fondata su un numero di ripetizioni assai più piccolo.
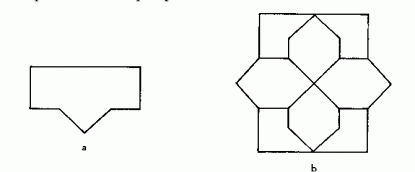
Fig. 30.
Ad esempio, la fig. 30 a - che non appare immediatamente come parte della fig. 30 b - dovrà essere trovata in questa più complessa configurazione più facilmente da chi l’ha già vista un mezzo migliaio di volte, isolata; con maggiore difficoltà da chi l’ha vista solo una volta o due.
Prendiamo due gruppi di osservatori, allora. Ad ogni osservatore del primo gruppo facciamo guardare alcune delle figure semplici (indicate con a nelle nostre illustrazioni) per tre volte; ogni presentazione dura un secondo; l’intervallo tra una presentazione e l’altra dura tre secondi.
Agli osservatori del secondo gruppo facciamo guardare le figure a un gran numero di volte: Gottschaldt le mostrava in più riprese, durante un periodo di addestramento di due settimane - per un totale di 520 volte. Le condizioni di presentazione erano analoghe a quelle impiegate con gli osservatori del gruppo precedente.
Dopo questa preparazione, Gottschaldt procedeva nel modo seguente: ad ogni osservatore di ciascun gruppo venivano presentate le figure di tipo b, costruite in modo da contenere tutti gli elementi delle rispettive figure a, mascherati mediante una opportuna applicazione delle leggi di Wertheimer. Il compito di ogni osservatore era quello di descrivere la figura che aveva davanti a sé, con la maggior possibile ricchezza di dettagli. La descrizione veniva stenografata.
Le descrizioni venivano successivamente suddivise in cinque classi:
i) quelle da cui risultava con chiarezza che l’osservatore aveva visto subito la figura a nella figura b;
ii) quelle dalle quali risultava che la descrizione stessa aveva aiutato l’osservatore a scoprire la figura a;
iii) quelle in cui veniva menzionata la presenza di una figura a, benché l’osservatore non fosse in grado di indicarne la posizione;
iv) quelle in cui erroneamente veniva indicata la presenza di una data figura a;
v) infine, le descrizioni da cui non risultava la presenza di figure a, e nemmeno la supposizione che ci dovessero essere da qualche parte, nel contesto delle figure b.
Le prestazioni dei due gruppi di osservatori furono praticamente identiche: considerando le risposte appartenenti alle classi iv) e v) come tali da garantire plausibilmente che la figura a non era stata ravvisata, la loro somma occupava da sola quasi il novantacinque per cento di tutte le risposte ottenute, sia nel primo gruppo che nel secondo; ma è da notare che le sole descrizioni classificate nella classe v) erano, in ciascuno dei due gruppi, in misura superiore al novanta per cento.
In pratica, quasi nessuno - addestrato o no che fosse - sapeva «vedere» le figure a nelle figure b.
L’esperienza passata - almeno se viene intesa nell’ovvio senso di «ripetizione» dell’incontro tra un dato osservatore ed una certa costellazione di stimoli - pesa praticamente niente nel dare corpo ad una unità segregata, qualora gli altri fattori di organizzazione siano distribuiti nel campo in modo da agire contro di essa [18].
Vediamo quali erano questi fattori nel caso delle figure di Gottschaldt.
La figura a, nel caso seguente (fig. 31), è un parallelepipedo visto in prospettiva: dunque, un solido che risulta tale grazie a una particolare disposizione di alcuni segmenti sul piano della carta. La figura b è una specie di ornamento che si svolge interamente sul piano:

Fig. 31.
Prima di tutto, non è possibile vedere un oggetto percettivamente «solido», tridimensionale, in un oggetto bidimensionale. Questa è la ragione principale della difficoltà di ravvisare a in b.
Inoltre, i contorni che delimitano (come spigoli) la faccia del parallelepipedo rivolta verso l’osservatore cessano di essere i contorni di qualcosa: quello verticale a destra - nella figura a - diventa in b, grazie alla legge della continuità della direzione, una parte dell’asse verticale che divide in due la configurazione; i due orizzontali spariscono nelle linee che dividono la configurazione orizzontalmente, sempre per continuità di direzione; i segmenti che rappresentano gli spigoli sviluppati nella terza dimensione fanno parte - in b - dei zigzag all’interno della cornice.
Ogni segmento cambia la sua funzione, nel nuovo contesto. E quest’affermazione va intesa nel senso più radicale; ogni segmento non è più in b quello che era in a; cioè, in b non c’è nulla che fosse in a, e dunque non deve destare meraviglia il fatto che non vi si trovi nulla.
Un altro esempio (fig. 32).
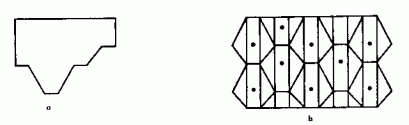
Fig. 32
Ogni segmento del contorno di a assume diverse funzioni in b. Inoltre, a nel complesso è un poligono irregolare, mentre b può essere descritta come una costellazione di poligoni distribuiti con una certa regola.
Nell’esempio seguente, la configurazione di b risulta composta da una cornice, entro la quale sono collocate due unità figurali: un fascio di segmenti che si incrociano in un punto, e una griglia di segmenti paralleli. I pezzi della figura a si dissolvono tra la cornice e quelle due unità (fig. 33), tutti per la legge della continuità della direzione, meno il lato superiore, che si unifica con l’intiero quadrato in forza della chiusura.
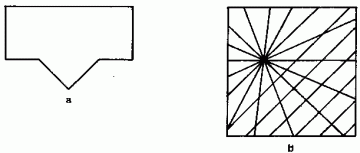
Fig. 33
Ci sembra utile proporre al lettore ancora qualche figura tratta dal saggio di Gottschaldt, senza corredarla con spiegazioni: l’analisi delle difficoltà che si incontrano nel tentativo di enucleare le figure a dalle figure b è il miglior mezzo per capire bene il senso della ricerca di Gottschaldt, e la tesi centrale di Wertheimer intorno all’esperienza passata.
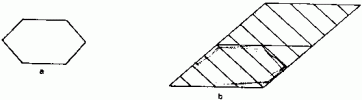
Fig. 34.

Fig. 35.
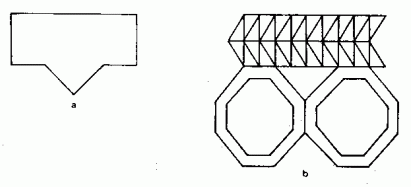
Fig. 36
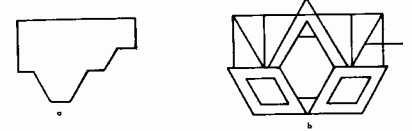
Fig. 37
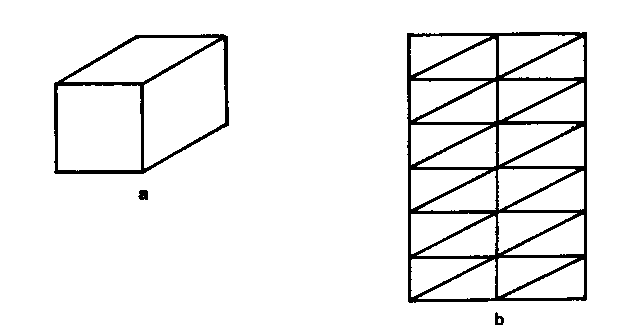
Fig. 38
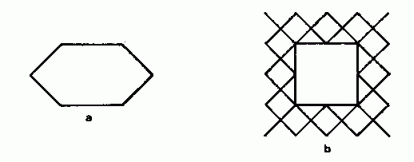
Fig. 39
§ 9. Il tutto e le parti.
In più luoghi, nel corso delle discussioni contenute in questo capitolo, abbiamo avuto occasione di menzionare il rapporto «tutto-parti»; l’abbiamo fatto lasciando che il lettore si affidasse al significato più intuitivo legato a tale espressione, senza ulteriori commenti, solo accennando al fatto che le parti possono essere intese come vere proprietà di qualche oggetto esperito (parti naturali), o come pezzi d’esperienza delimitati facendo forza sull’unità interna degli oggetti, secondo criteri di resezione più o meno arbitrari (parti arbitrarie).
La meccanica degli esperimenti di Gottschaldt dipende interamente dalla possibilità di questa distinzione, che può essere ulteriormente chiarita. Ogni segmento delle figure a e delle figure b può essere considerato come una «parte arbitraria»: in questo senso si può affermare che «le figure a sono contenute nelle figure lì». Ma le «parti naturali» delle figure a e delle figure b (specialmente di queste, come appare chiaramente guardandole) risultano quasi sempre da specifiche connessioni tra più segmenti legati da rapporti particolarmente stretti (vicinanza, continuità di direzione, chiusura, pregnanza ecc.): e in questo senso è vero che «le figure a non sono contenute nelle figure b».
Cosi, guardando molte volte le figure a non impariamo proprio niente intorno alla struttura delle figure b. La ripetizione di uno stimolo non è base per apprendere qualcosa, per il semplice fatto che noi non vediamo mai stimoli; e la ripetizione dell’esperienza organizzata di un oggetto O’, diverso da O», non ha niente a che vedere con quanto ci succederà dopo, incontrando O’», proprio perché essi sono oggetti diversi.
Alcuni esempi studiati da Wertheimer serviranno a mostrare che quando si dice «diversi», in casi come questi, si intende usare tale aggettivo nel suo significato più stretto.
Su uno sfondo omogeneo sono ben visibili alcuni punti, così distribuiti:
![]()
Fig. 40
essi appaiono come: a/bcd/e.
Mentre li stiamo osservando due di essi (c, e) spariscono; quelli che rimangono sono alcuni di quelli che erano presenti anche prima:
![]()
Fig. 41
In (i) i punti a ed e svolgono lo stesso ruolo, rispetto al centro della struttura, che è il punto c; e così b e d. Ma in (ii) centro è b; e a è a sinistra quello che d è a destra [18].
Se indichiamo con il segno «~»la proprietà relazionale tra oggetti «omotipici» (che svolgono la stessa funzione in un tutto dotato di qualche centro o asse di simmetria), e con il segno «@» la proprietà relazionale opposta, esistente tra oggetti «eterotipici», possiamo scrivere che in (i) «b~d». «d@ a»; mentre in (ii) «b@ d». «d~a».
«Nell’esaminare le relazioni implicite nel confronto, non si possono scrivere correttamente nemmeno le stesse lettere per i punti in (i) e in (ii) (bisogna fare distinzione tra bi e bii, ecc.) il contenuto è diverso in (ii) e in (i)» [19].
Né si tratta solo di una differenza riguardante il ruolo dei diversi punti nei due contesti; alla differenza di ruolo corrispondono altre proprietà interne del tutto: per esempio, nella presentazione (ii) si vede bene che a e d sono equidistanti dal punto centrale b; nella presentazione (i) si vede in modo altrettanto chiaro che b e d sono equidistanti da c, oppure a ed e da c o da b e d; ma in (i), non risulta altrettanto chiaramente che d dista da b come b dista da a. L’equidistanza è un rapporto fenomenicamente esplicito là dove c’è simmetria, ed èdifficile avvertire la sua presenza tra elementi che nel tutto occupano posizioni eterotipiche. Wertheimer riferisce che nella configurazione (i), quando sia riprodotta a memoria dopo qualche tempo, difficilmente l’equidistanza a-b = b-d viene rispettata, mentre lo sono, normalmente, le equidistanze tra elementi omotipici -
Altro esempio:
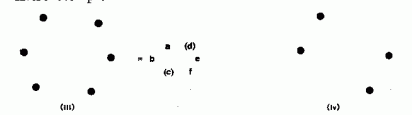
Fig. 42
La costellazione (iv) differisce dalla costellazione (iii) per la sottrazione dei due punti c e d: in realtà cambia tutto l’orientamento della figura. La figura (iii) poggia su una base orizzontale, e i punti sono unificati tra loro in forma di esagono. La figura (iv) è orientata in modo nettamente diverso: è inclinata; i punti si unificano a coppie (a-b; e-f), e se si realizzano unificazioni tra punti appartenenti alle due diverse coppie, di solito risultano costituite così : b-e; a-f.
In (iii) «a@ b». «f@ e». «be@ af» ; in (iv) «a~b». «f~e». «be~af».
Ancora:
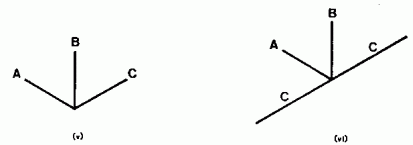
Fig. 43.
In (v) B è un asse di simmetria, e A e C sono omotipici; nella struttura (vi) - che è ottenuta dalla figura (v) semplicemente allungando di un tanto le estremità del segmento C - la coppia AB costituisce l’elemento centrale, che poggia su una base inclinata CC: dunque, in (v) «A ~ C». «A @ B»; in (vi) «A @ C». «A ~B».Tutte le proprietà fondamentali della figura sono implicate in questo mutamento dei rapporti omotipici ed eterotipici. La simmetria di (v) non è disturbata dal fatto che la linea B venga allungata o scorciata; ma se compiamo la stessa operazione in (vi), è proprio la simmetria a risentirne.
Su questo gioco di rapporti può essere concretamente fondato il concetto di «esigenzialità» («requiredness» [20]).
In un campo omogeneo sono così disposi cinque punti
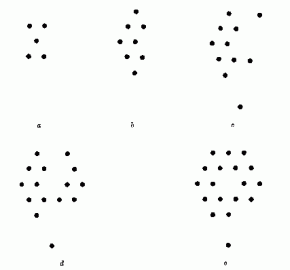
Fig. 44
a questi, vengono aggiunti poco dopo altri tre (fig. b): il centro fenomenico della figura resta quello di prima, ma nasce «quasi» un rombo; «quasi» significa: manca un punto a destra. La necessità interna della nuova figura richiede un completamento.
In fig. c sono stati aggiunti altri tre punti. Essi appaiono estranei alla struttura: sono come una linea aggiunta sul foglio, accanto alla figura, ma in una zona esterna ad essa. Permane la «mancanza» del punto a destra, che completerebbe il rombo.
In fig. d la situazione è la stessa, solo che a destra è comparso un nuovo rombo, più piccolo.
Ora, a quest’ultima configurazione fatta da un rombo «quasi» completo, una linea di tre punti e un rombo piccolo, aggiungiamo di colpo un nuovo gruppo di punti (fig. 45):
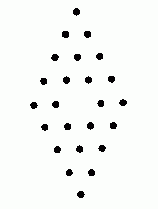
Fig. 45
«Ciò che avevamo prima è bruscamente mutato. Il gruppo a sinistra è crollato (il suo centro non è più il centro...), la caratteristica delle figure che si trovavano «una vicino all’altra» non è più presente: tutti i punti si sono ordinati in una figura unita, si trovano ad essere ora parti di questa figura» [21]; «il processo rivela, nell’esistenza di «manchevolezze» concrete, e nel loro modo di venir soddisfatte, forti proprietà dinamiche» [22].
Un ultimo esempio, in campo musicale.
Una brevissima frase, tre note, può determinare esattamente una tonalità, come in questo caso:
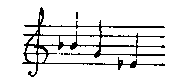
Fig. 46
siamo in mi bem. maggiore.
Aggiungiamo due note, così:
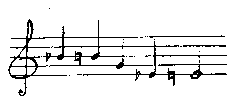
Fig. 47a
in scrittura corretta:
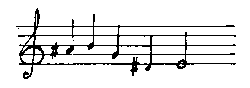
Fig. 47b
Ora siamo in mi minore. La prima nota di questa frase non è più una dominante, ma il suo ritardo; la nota più bassa non è il grado della tonica, ma il grado della sensibile, e l’intervallo che conduce ad essa dalla precedente è una quarta diminuita, non più una terza [23]. La scrittura musicale corretta sottolinea efficacemente questo mutamento di funzione degli elementi, che dal punto di vista puramente acustico - come è ovvio - rimangono gli stessi.
Quando si dice, ripetendo Lao-Tse o citando Platone [24], che «il tutto non è la somma delle parti», si può voler dire effettivamente qualcosa di molto concreto: trascurando quella che può essere la portata ideologica di simili asserzioni (e qui non è il caso di discuterne) non c’è dubbio che un aspetto ineludibile del mondo con cui abbiamo direttamente a che fare è costituito proprio da rapporti tra dati osservabili che obbediscono - o meglio: danno un senso - a tale legge. A qualunque livello di generalizzazione si voglia portare quest’idea, non è consigliabile prescindere dal senso che essa ha nell’ambito delle cose visibili e tangibili. Lo stesso Platone (che non sempre appare molto attratto dalla discussione di problemi empirici) trattando il problema del tutto e delle parti, nel Teeteto, e riferendosi forse alle tesi di Antistene scrive: «Noi abbiamo, per dir così, come ostaggi della dottrina, gli esempi di cui si valse colui che disse tutte queste cose» [23]; e procede discutendo dettagliatamente il sistema di rapporti che lega le lettere dell’alfabeto in una sillaba, l’unità degli oggetti fatti di pezzi (commentando l’emistichio di Esiodo «i cento pezzi del carro» [26]), e i numeri intesi come somme di numeri - sia nella forma di entità matematiche pure, sia nel caso particolare dei sistemi di misura [27].
Non è affatto strano che a volte venga trovata giusta la tesi secondo cui «il tutto è somma delle parti» - che conduce all’asserzione «gli elementi hanno una conoscibilità molto più evidente dei nessi» [28]; e altre volte la tesi secondo la quale «il tutto è diverso dalla somma delle parti» - che conduce all’asserzione «gli elementi sono inconoscibili, tutti i nessi invece conoscibili» [29].
A seconda degli esempi utilizzati, può essere vera appunto l’una o l’altra tesi.
Nel caso della misura, realmente lo stadio è di 600 piedi, come il metro è una somma di centimetri, di millimetri; come il quintale di chili e così via; e per quanto riguarda le lettere dell’alfabeto e le sillabe, quando stiamo imparando la lettura e la scrittura (almeno dai tempi di Platone, e fino a pochi anni fa) «tu, nell’apprendere codeste lettere, non hai fatto altro continuamente che esercitarti a distinguerle ciascuna per sé, sia con la vista che con l’udito, in modo che la posizione loro, nella pronuncia o nella scrittura, non ti confondesse [30] «.
Ma d’altra parte, parlando o sentendo parlare, non si può fare a meno di riconoscere che in qualche modo «la sillaba non è le lettere, bensì una specie di idea unica nata da quelle, con un’unica forma sua per se stessa, e diversa dalle lettere» [31]; e che «il nesso è un’idea unica costituita di elementi ogni volta armonizzati insieme; e ciò tanto se si tratta di lettere quanto di ogni altra specie di elementi» [32]; «.... o vuoi dire che anche l’intero è costituito da parti, pur essendo un’idea unica diversa da tutte le sue parti?» [33].
§ 10. Parti e frammenti.
Gli esempi costruiti da Wertheimer e da Gottschald sono gli «ostaggi della dottrina» della gestalt. Ragionare su di essi, sulla dinamica del tutto e delle parti come si realizza sotto i nostri occhi caso per caso, è l’unica via per capire il senso che la tesi della non sommatività può avere in una teoria scientifica della percezione. È molto facile, poi, lasciarsi tentare dalle suggestioni, indubbiamente presenti nell’enunciato generale «il tutto non è mai somma di parti»; è confortante immaginare il mondo come una totalità fortemente connessa, in cui ogni cosa ha significato in rapporto al tutto: ognuno di noi diventa più importante; può sembrare che l’io tocchi (magari assai tenuemente) i limiti più lontani dell’universo, e che quest’ultimo abbia, in qualche modo, bisogno di noi. La scienza volgarizzata fornisce, a volte, di questi conforti. Naturalmente, non possiamo sapere se affermazioni di questo tipo sono vere, o anche solo sensate.
Per quanto riguarda l’ambito degli oggetti osservabili, è da notare che la stessa esistenza di entità organizzate secondo la legge del tutto che non è somma di parti pone forti limitazioni alla possibilità di generalizzare tale legge, al punto di farne un passe-partout concettuale capace di aprire tutte le porte. Solo in specifiche condizioni possiamo assistere a modificazioni di struttura come quelle sopra descritte: un’applicazione indiscriminata della legge ad ogni possibile oggetto dell’esperienza conduce prima o poi a grossi malintesi, il più dannoso dei quali consiste - a nostro avviso - nell’esclusione aprioristica dell’esistenza, nel campo percettivo, di eventi tra loro indipendenti, e di fatti che si costituiscono come «aggregati» di cose.
Se la legge valesse nel suo senso più ampio e retorico, ogni modificazione introdotta in una unità d’esperienza dovrebbe sensibilmente mutarla, se non renderla irriconoscibile. Ma ciò non è vero: già Wertheimer aveva elencato, accanto ai casi di «mascheramento formale» dovuti all’inserimento di determinate unità in altre, casi paralleli in cui le aggiunte effettuate su una figura data non mutano nulla di essa.
L’esagono a nella figura b sparisce, ma nelle figure c e d non viene minimamente mutato (fig. 48).
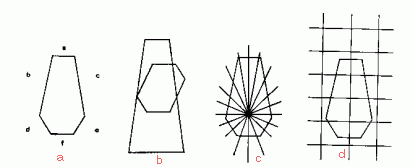
Fig. 48
e così il numero 4 nel seguente esempio di Köhler (fig. 49):
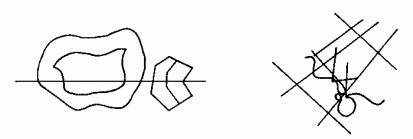
Fig. 49
È consigliabile tenere sempre presente il seguente argomento: se fosse universalmente vero che ogni fatto d’esperienza dipende realmente da ogni altro fatto d’esperienza, ogni modificazione avvertibile in qualche luogo qui ed ora dovrebbe ripercuotersi dappertutto, mutando ogni volta l’intero quadro degli eventi esperiti; il che, di fatto, non succede. Inoltre, in teoria, non sarebbe mai possibile compiere alcun esperimento sugli oggetti direttamente constatati, né appurare in che modo qualche cosa dipenda da qualche altra cosa: poiché, introdotta che fosse qualche modifica nel campo, tutto il campo verrebbe a mutare.
Le «gestalt» esistono, proprio perché esistono a condizioni ben definite.
Per questo le teorie elementaristiche, in ogni tempo, hanno potuto fornire i loro «ostaggi della dottrina».
Del resto, il problema del rapporto tra tutto e parti non si esaurisce intierarnente nel problema dell’insorgenza di «parti naturali» da connessioni tra «parti arbitrarie» nella dinamica delle unità percettive.
Per strano che possa sembrare in base alla teoria esposta fin qui, anche un oggetto solo, collocato in un campo omogeneo, può apparire come «parte» (fig. 50):

Fig.50.
Questo è un frammento di corona circolare.
«Mutilato - scrive Aristotile [34]
- non si dice in tutti i casi d’una cosa fornita di quantità ...
Bisogna che la sostanza rimanga: se si tratta di una coppa, dev’essere ancora
coppa. Anzi, in generale, delle cose per le quali la situazione ![]() delle parti è indifferente, come per l’acqua o il fuoco, nessuna può
essere mutilata... E neppure tutte le cose intere diventan mutilate col privarle
di una qualunque parte. Bisogna che questa parte non sia la principale per la
sostanza; né è indifferente che si prenda di qua o di là:
per es. se la coppa ha un buco, non perciò si dice mutilata, ma se si
asporta il manico o un pezzetto dell’orlo. Né si dice mutilato un uomo
se gli si levi un po’ di carne o di milza, ma una estremità; e neppure
una qualunque, bensì una che asportata per intero non cresce più:
perciò i calvi non si chiamano mutilati».
delle parti è indifferente, come per l’acqua o il fuoco, nessuna può
essere mutilata... E neppure tutte le cose intere diventan mutilate col privarle
di una qualunque parte. Bisogna che questa parte non sia la principale per la
sostanza; né è indifferente che si prenda di qua o di là:
per es. se la coppa ha un buco, non perciò si dice mutilata, ma se si
asporta il manico o un pezzetto dell’orlo. Né si dice mutilato un uomo
se gli si levi un po’ di carne o di milza, ma una estremità; e neppure
una qualunque, bensì una che asportata per intero non cresce più:
perciò i calvi non si chiamano mutilati».
Come abbiamo detto, è possibile chiamare «parte» una porzione qualunque di una superficie omogenea (come il quadrato che abbiamo descritto all’inizio di questo capitolo) risultante da una suddivisione ideale di tale superficie: in tal caso la «parte» non è un dato fenomenico, ma l’oggetto di una definizione, o l’occasione per un particolare uso linguistico. In questo senso, come abbiamo visto, può essere ulteriormente suddivisa in parti, all’infinito. Tale problema non riguarda lo studio delle strutture esperibili.
Possiamo chiamare «parte» anche ogni porzione discernibile di un oggetto percettivamente unitario (spesso proprio in questo modo possono essere indicate le «parti arbitrarie», come negli esempi di Gottschaldt), o qualche raggruppamento di esse (e a questo livello abbiamo a che fare, di solito, con le «parti naturali»).
Ma il breve brano di Aristotile e gli esempi delle figg. 50 e 51 indicano che esiste la possibilità di parlare di «parti» in un senso ancora più concreto e calzante: proprio nel senso di «pezzi» rotti da qualcosa che è un’unità; il risultato della rottura, o di qualche altro particolare tipo di scissione operata su una unità organizzata [35].

Fig. 51
In molti casi il carattere di «pezzo» che un oggetto assume dipende dall’andamento o dalla struttura del margine lungo un determinato tratto del contorno che lo delimita.
Di fronte a una distribuzione di aree omogenee come quella riportata in fig. 52 gli osservatori danno (più o meno nelle stesse proporzioni) due tipi di descrizioni : 1) «è un quadrato suddiviso in quattro quadrati (o un quadrato con soìra una crocebianca) «, oppure 2) «si tratta di quattro quadrati, uno accanto all’altro».

Fig. 52.
Di fronte a strutture come quelle visibili in fig. 53 a e 53 b l’unità, invece, non viene mai menzionata si tratta, per tutti gli osservatori, di quattro macchie, di quattro «cose» ameboidali o spigolose:
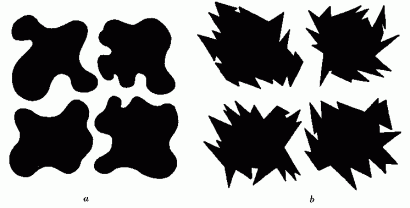
Fig. 53
Nessuna di esse appare come «pezzo» di qualcosa d’altro: è semplicemente fatta così, possiede quel tipo di contorno.
Le cose cambiano appena cominciamo ad alternare, in ogni macchia, contorni di diverso tipo, disponendoli in modo che i tratti di margine rivolti verso le macchie accanto abbiano la stessa struttura, diversa da quella posseduta dai tratti di margine che guardano verso l’esterno, verso lo sfondo che è intorno al «gruppo di macchie» (fig. 54).
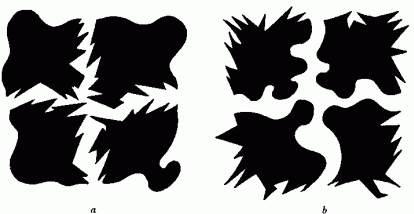
Fig.54.
Oppure (fig. 55):
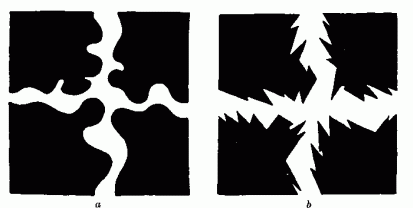
Fig.55.
In casi come questi, le descrizioni degli osservatori sono, come nel caso della fig. 52, di due tipi: o contengono subito un riferimento esplicito all’unità della configurazione («una» figura o «un» oggetto: una macchia, un foglio, un’ameba - ma «rotta» «strappata» «divisa» «tagliata» ecc.), o all’inizio menzionano quattro «cose», di cui viene però sottolineata la connessione («parti» «frammenti» «ritagli» ecc.). Ciò, in misura assai notevole nei casi delle figure 54a, 55a e 55b: oltre l’85% delle descrizioni fornite da quaranta osservatori. Meno (43%), nel caso della figura 54 b.
Quando l’andamento dei contorni è realizzato come nelle illustrazioni di fig. 56 a e 56 b, Le descrizioni parlano univocamente di «una» cosa:
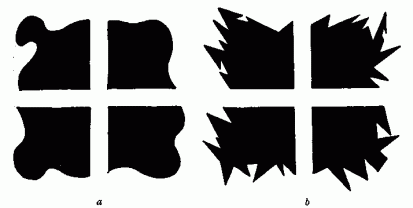
Fig. 56
«una macchia divisa in quattro», «una chiazza con sopra una croce bianca» ecc.
È da notare che nelle figure 54a e 54 b, 55a e 55 b, i margini che si guardano tra loro (quelli cioè che danno sui canali interni delle figure) non sono mai tracciati in modo da poter combaciare una volta che i pezzi venissero accostati fino a toccarsi: non è la complementarità delle frastagliature o dei tagli cnrvilinei a suggerire l’idea di una possibile connessione.
L’analisi dettagliata delle proprietà di queste figure e del loro modo complessivo di apparire pone parecchi problemi, ai quali non è il caso di accennare in questa sede. Ciò che importa, in vista del problema generale dei rapporti tra il tutto e le parti, consiste nel fatto che «il modo di essere parte» di qualcosa può cambiare in funzione di alcune proprietà figurali ben definite della situazione: nel nostro caso, in funzione del tipo e della posizione dei contorni; ma non è escluso che anche altre condizioni, in altri tipi di figure, possano venir successivamente trovate.
I differenti «modi di essere parte» risultano, nelle descrizioni da noi raccolte, dall’uso di determinati nomi ed aggettivi, e dalla frequenza con cui compaiono in connessione con determinate figure: nei casi delle figg. 54 a, 55 a e 55 b si menzionano prevalentemente «pezzi» «frammenti» «ritagli», di figure «rotte» «strappate» «spezzate» «tagliuzzate» «ritagliate» ecc.; nei casi delle figure 52, 56 a e 56 b (quando la suddivisione viene sottolineata) si menzionano piuttosto «parti» «settori» «zone staccate», o «distinte», di una unità «tagliata» «divisa» «sezionata». Mentre nessun accenno a divisioni o a parti vien fatto a proposito delle figure 53 a e 53 b, ed altre simili utilizzate nella nostra ricerca, pure essendo le zone colorate in nero divise da. distanze simili a quelle impiegate in tutti gli altri casi.
§ 11. La quantità come qualità.
Queste ultime sono unità a sé stanti: alcune unità legate dal puro ed estrinseco legame della vicinanza.
In questo modo dal problema del rapporto tutto-parti nasce il problema della percezione della molteplicità.
Abbiamo a che fare con una molteplicità, in senso fenomenologicamente stretto, proprio quando tra più cose compresenti e discernibili non esistono specifici rapporti di dipendenza da un tutto di cui possano essere dette parti: «le cose si diranno molte in sensi opposti a quelli dell’uno», aveva scritto Aristotile - e questa affermazione può voler dire proprio ciò che abbiamo detto noi ora.
Naturalmente, possiamo sempre sostenere che le quattro macchie della fig. 53 a o 53 b sono parti della figura complessiva: come possiamo dire che ogni oggetto presente intorno a noi è parte di questa stanza, o un libro parte di una biblioteca, o un sasso parte del greto del fiume. Ogni oggetto pensabile può essere parte di qualcosa, come ogni entità o insieme di entità può esser fatto appartenere a qualche classe, in senso strettamente logico. Ma se in concreto vi sono connessioni più o meno forti, come abbiamo cercato di mostrare, tra diversi segmenti d’esperienza, è giusto rispettare la loro esistenza:
L’uso comune del linguaggio marca il confine tra le «parti di un oggetto» e i «più oggetti» senza alcuna difficoltà, e l’analisi fenomenologica fa bene a seguire le sue indicazioni.
Se gli osservatori dicono: «quattro macchie», vuoi dire che ci stiamo già muovendo tra i termini di un problema nuovo: quand’è che si dice «quattro», «dodici», «più», «pochi», «molti» ecc.?
Il problema nuovo è quello dell’uso «qualitativo» dei numeri e delle espressioni che indicano quantità, così come viene spontaneamente impiegato nel descrivere i fatti dell’esperienza diretta.
Anche di fronte a un numero abbastanza grande di oggetti disposti in modo da poter esser veduti tutti insieme, un osservatore può dare un giudizio sulla loro quantità, pur senza essere in grado di dire esattamente quanti sono. Le nostre macchie erano quattro: se gli oggetti sono tre, quattro o cinque, il giudizio verrà dato con sicurezza e senza il ricorso ad alcuna operazione di conteggio. Questo è il punto importante, il primo passo per distinguere le quantità in senso qualitativo dalle quantità intese come misure. Tre o quattro oggetti su un tavolo sono «tre» o «quattro» prima ancora che si inizi a contarli.
Ma supponiamo che siano di più: ben pochi osservatori se la sentirebbero di affermare con sicurezza che quegli oggetti sono ventitré, quarantuno o diciassette senza averli contati, e nello stesso senso in cui è possibile dire di aver visto che un tavolino aveva tre gambe invece di quattro.
Oltre un certo limite possiamo ricorrere ad espressioni come: sono molti, pochi, moltissimi, né molti né pochi, ecc. oppure possiamo servirci anche dei nomi dei numeri - ma sapendo bene che in questo caso li usiamo in un modo del tutto particolare, non confondibile con l’uso delle stesse parole quando è fatto dopo un conteggio accurato. «Nel caso di un’operazione di stima in cui il risultato differisca dal risultato di un’operazione di misura corrispondente, scrive Musatti, è [36] non è a rigore neppur legittimo il tener conto della differenza tra i due risultati come di una misura di un caso particolare di illusione, in quanto quella differenza sarebbe ottenuta fra due termini non omogenei, l’uno avendo il vero significato di elemento della serie numerale, l’altro il puro senso di aspetto qualitativo, sia pur determinato da antecedenti esperienze di operazioni di misura».
Dunque, in casi come questi, abbiamo a che fare con collettività composte da un numero finito di oggetti, il quale è insieme un numero indefinito; anche nei casi in cui ci serviamo del nome di qualche numero della serie naturale per indicare press’a poco l’ammontare delle cose che ci stanno davanti.
La logica, tuttavia, non ci permetterebbe mai di dire una cosa simile.
«È vero che la tigre non può avere sul suo fianco un certo numero di striature scure senza anche averne un numero definito; perché dire che essa ha parecchie di queste striature, ma non un numero definito, sarebbe autocontraddittorio. Ma non ne segue che essa ha un certo numero di striature senza che questo numero sia definito: perché le caratteristiche che si suppone di ascrivere a questa regione del campo dell’esperienza («sense-field») non sono necessariamente quelle che la tigre ha, ma sono quelle che in essa sono visibili; così che il modello sul quale dobbiamo fondare il nostro uso dell’espressione «esser numeroso», in questo contesto, non sono le caratteristiche fisiche dell’esser numeroso, ma le caratteristiche reali dell’ «apparire numeroso» [37]. Dire che le striscie della tigre sono numerose non implica - parlando dell’esperienza diretta - dire che sono diciotto o ventitré o tot.
«Nel dire che il campo sensoriale in questione contiene un certo numero di striature, intendiamo dire non più che quella zona ha la qualità «gestalt» di essere striata; e finché la presenza di questa qualità è incompatibile con l’esserci un definito numero di striature, la prima circostanza non necessita logicamente la seconda» [38]. Quando un epiteto come «numeroso» viene applicato ai dati sensibili, esso può fare a meno di avere quel significato che gli dà il fisico quando lo applica ai suoi oggetti.
La nostra esperienza è in ogni attimo piena di collezioni finite di oggetti, e tuttavia assai raramente «vediamo» il loro numero (o lo sentiamo: quante note ha la tale melodia, ascoltandola?). L’operazione del contare è proprio nata - ci sembra lecito credere questo - dalla necessità di venir a conoscere l’ammontare degli insiemi abbastanza ampi, quelli di cui non si «vedrebbe» altrimenti il numero: e l’operazione del numerare - quando è terminata - produce la «convinzione» intorno al numero degli oggetti dati; convinzione che non può essere verificata da un’ulteriore occhiata d’insieme buttata là, dove essi si trovano.
Appunto in questo senso la quantità va considerata come un aspetto qualitativo dell’esperienza. Naturalmente, discutere di questo aspetto qualitativo è una faccenda diversa dal discutere la teoria dei numeri o della misura - anche se a volte ci accade di dire frasi che suonano identiche a quelle che potremmo incontrare studiando quei campi. L’errore dello stimolo è nascosto un po’ dappertutto.
Questa circostanza offre l’occasione per realizzare un particolare tipo di esperimenti.
§ 12. La percezione della molteplicità.
Supponiamo che davanti a noi (sparsi su una superficie omogenea, disposti disordinatamente) ci sia un buon numero di punti, tanti da apparire come «un centinaio». Contandoli, potranno risultare 150, o 90, non importa. È ovvio che, sottraendone parecchi, a un certo punto avremo a che fare con «una cinquantina».
Qualche osservatore potrà impiegare espressioni più precise: potrà dire «centodieci», «novantuno», «cinquantasette», «quarantotto». Questi numeri «suonano» più esatti che la «cinquantina» o il «centinaio», ma hanno il medesimo significato qualitativo: l’osservatore in questione non è certo disposto a giurare che sono centodieci o cinquantasette; solo ha l’impressione che questi numeri descrivano bene (meglio che altri) la numerosità dell’insieme di punti che ha davanti a sé.
Diminuendo il numero oggettivo dei punti in maniera opportuna anche la loro «quantità» fenomenica diminuisce.
La numerosità è funzione - banalmente, se vogliamo - del numero, inteso come risultato di un conteggio.
Ma non solo di questo fattore.
Vittorio Benussi, nel 1918 [39], ha provato che un altro fattore determinante è la disposizione dei punti. Benussi presentava per un tempo brevissimo (in modo che qualsiasi operazione di conteggio risultasse impossibile) costellazioni di punti come quelle riprodotte qui di seguito. Il compito era quello di valutare l’ammontare delle varie collettività, e veniva affidato, in momenti successivi, ad un medesimo osservatore.
Le due costellazioni, riprodotte nella figura 57, sono formate da 98 punti: ma appare più numerosa quella in cui i punti sono disposti su una superficie circolare.
Lo stesso osservatore, di fronte a costellazioni come quelle riprodotte in figura 58, fatte anch’esse di 98 punti, valutava come più numerosa quella stellare, rispetto a quella amorfa; e tutte e due queste ultime come molto più numerose delle due precedenti.
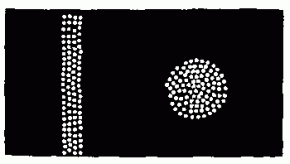
Fig.57.
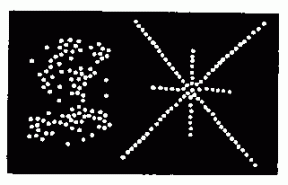
Fig. 58
Delle due costellazioni seguenti (fig. 59). quella di destra è veduta come formata da un numero quasi doppio di punti rispetto a quella di sinistra (in tutti i due i casi i punti sono 69) ma per l’osservatore erano 42 a sinistra e 80 a destra:
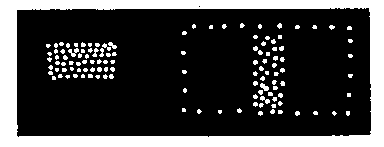
Fig.59
Anche delle due costellazioni seguenti una appare assai più numerosa dell’altra, nei dati di Benussi (fig. 60):
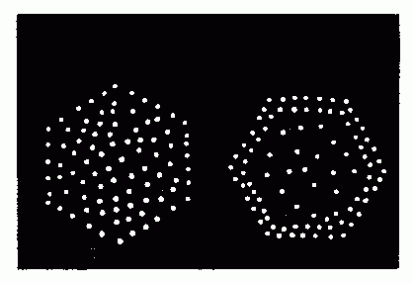
Fig. 60
in entrambe i punti sono 90: ma la costellazione di sinistra appare di 50 punti, e quella di destra di 98.
Guardando le figure riprodotte qui, sulla pagina, può sembrare che tali scarti siano un po’ esagerati. Ma occorre tener presente che le presentazioni effettuate erano assai brevi, meno di un secondo. Un’osservazione protratta anche di poco permette una valutazione migliore, e di conseguenza le differenze tra costellazioni equipotenti tendono a diminuire. I dati che abbiamo riferito sono stati forniti da un osservatore che nell’intera serie di prove aveva mostrato di sottovalutare sistematicamente le collettività proposte. Lavorando con osservatori portati alla sopravvalutazione troveremmo, naturalmente, altri numeri, ma distribuiti secondo gli stessi rapporti. Questo fatto dimostra che la configurazione complessiva delle collettività gioca un ruolo determinante in questo tipo di valutazioni.
Prendendo lo spunto da questi dati di Benussi, e da altri raccolti successivamente da Mario Ponzo [40] e da H. Mokre [41], nel 1929 Silvia De Marchi realizzò un ampio gruppo di esperimenti su questo problema, cercando di individuare il maggior numero possibile di fattori che regolano l’impressione di «quantità» in situazioni simili.
Non esporremo tutti i problemi affrontati dalla De Marchi in quel suo studio, benché si tratti di uno dei più bei lavori di psicologia sperimentale pubblicati in Italia nella prima metà di questo secolo; ci soffermiamo solo su alcune esperienze, a nostro avviso particolarmente importanti.
Intanto, è possibile - con metodi simili a quelli impiegati da Benussi - stabilire che cosa significano le espressioni «pochissimi» «pochi» «né pochi né tanti» «molti» e «moltissimi».
La De Marchi proiettava su di uno schermo, in ordine casuale e per un brevissimo lasso di tempo (meno di mezzo secondo), 23 «collettività di punti» diversamente numerose:
5, 7, 9, 11, ... 27, 32, 37, 47, ... 102, 122, 127, 162. Il compito degli osservatori era quello di dire, ogni volta, se i punti erano «moltissimi» o «pochissimi» o «molti» o «pochi» o «imprecisabili» (nel senso di «nè molti nè pochi»).
Dai cento punti in su, tutti vanno d’accordo nel dire che i punti sono «moltissimi»; le collettività di 5 e 7 punti sono invece quelle su cui tutti sono d’accordo nel dire «pochissimi». Molti osservatori dicono che si tratta di «nè molti nè pochi» quando il numero di punti è compreso tra una ventina ed una cinquantina. Le collettività di «pochi» punti ne comprendono al massimo una trentina; «molti» sono tra i quaranta e gli ottanta.
Facendo l’esperimento inverso - cioè invitando gli osservatori a dire quanti punti di quelli dovrebbero esserci su uno schermo per poter dire che sono «pochissimi» o «pochi» ecc., avendo sotto gli occhi solo lo schermo ed un punto - si ottengono risultati quasi uguali. Dunque, il significato delle espressioni che nel linguaggio ordinario indicano quantità indefinite è molto meno vago di quanto normalmente siamo portati a credere. È vero che si tratta di una situazione specifica, realizzata in condizioni particolari. Ma questo significa solo che con ogni probabilità - in altre situazioni specifiche ed in altre condizioni particolari - si avranno altre valutazioni: non per questo meno consistenti.
Un altro risultato notevole trovato dalla De Marchi è il seguente: l’impressione di quantità cambia a seconda che i punti siano disposti in modo da formare una linea, un «contorno» che delimita un’area, oppure siano sparsi in modo da ricoprire un’area. Diciotto punti collocati in modo da formare una linea sono un po’ più che se sono disposti in cerchio; ma ventidue punti sparsi entro un’area circolare pari a quella delimitata da quel cerchio sono meno di quei diciotto. Novantotto punti disposti in modo da segnare i lati di un quadrato appaiono come una settantina, ma sparsi su un’area quadrata delle stesse dimensioni non arrivano ad essere una cinquantina.
In quest’ultimo caso, se l’esposizione viene portata a circa un secondo e mezzo, la valutazione assoluta cambia, ma il rapporto resta: i punti disposti come i lati del quadrato appaiono come oltre centoventi, mentre quelli distribuiti nell’area qua- drata sono una settantina.
Un terzo risultato riguarda il fattore del movimento: se una collettività di punti si muove più velocemente di un’altra obiettivamente equipotente, la prima appare come più numerosa: una costellazione di 15 punti che proceda lentamente ècome se ne avesse 25; ma se procede con velocità doppia può averne anche 50. Ed è da notare che in quest’ultima esperienza i tempi d’osservazione erano molto più comodi, dal momento che andavano da due secondi e mezzo fino a sei secondi e mezzo.
Oltre i fattori ora detti, contano in modo decisivo la durata delle esposizioni, la grandezza delle superfici occupate dai punti, la loro densità, il fatto d’essere presentati insieme o in successione, la rapidità di tali successioni ecc.; inoltre giocano un ruolo importante anche le varietà d’impostazione che l’osservatore può assumere, per quanto sia difficile precisare come e in quale misura.
Sommario dei Capitoli Primo e Secondo
L’unità
È possibile sostenere che l’unità e la molteplicità sono caratteristiche direttamente riscontrabili negli oggetti dell’esperienza quotidiana, come i colori, le forme, il peso, la collocazione spaziale? Il senso comune sembra suggerire una risposta affermativa. L’uso quotidiano dei concetti quantitativi elementari si svolge quasi interamente in rapporto a situazioni concrete, a proposito di cose, di eventi, di fatti, considerati come unità o come membri di collettività più o meno estese. L’unità e la molteplicità esistono nell’esperienza, prima ancora che noi incominciamo a ragionarci sopra.
Tuttavia, questo punto di vista sembra condurre a molte difficoltà logiche.
Gottlob Frege, già alla fine del secolo scorso, ne aveva indicate alcune, particolarmente rilevanti.
(a) Innanzitutto ogni oggetto pensato in un primo momento come unitario può essere successivamente pensato come una collettività di parti, di elementi che concorrono a costituirlo; tale collettività può essere numerosa quanto si voglia: non c’è limite alla possibilità di compiere suddivisioni. Le concezioni psicologiche correnti ai tempi di Frege lo appoggiavano in questa critica: ogni oggetto non è affatto «uno», ma una miriade di sensazioni combinate tra loro in maniera estremamente complessa.
(b) Se fosse vero che le foglie di un albero sono «mille» nello stesso senso in cui sono «verdi», potremmo costruire sillogismi del seguente tipo: «le foglie del tale albero sono mille» -«questa è una foglia del tale albero» - «dunque questa foglia è mille».
(c) Quando diciamo che un dato oggetto è rosso, o che Solone è saggio, intendiamo comunicare qualcosa a proposito diquell’oggetto o di Solone, escludendo che l’uno sia verde o blu, e l’altro non saggio. Supponiamo ora che «uno» sia un aggettivo: quando siamo di fronte a un oggetto, è inutile aggiungere che tale oggetto è «uno»; infatti, non esiste una classe complementare di oggetti la cui proprietà sia quella di essere «non uni». L’attributo «uno» non serve a determinare maggiormente un oggetto rispetto agli altri, e in definitiva non svolge un ruolo di attributo.
(d) Supponiamo che l’unità sia quella proprietà empirica che permette di distinguere un oggetto da un altro. Se il numero 1 rappresenta tale proprietà, bisognerà contrassegnarlo in maniera differente a seconda dell’oggetto a cui si riferisce:
l’oggetto x è 1’, l’oggetto y è 1’’ ecc. Questa notazione permette di fare operazioni come la seguente:
(1’+1’’+1’’’) - (1’’+1’’’) = 1’
ma non operazioni come questa:
(1’+1’’+1’’’) - (1’’’’+1’’’’’) = ?
(e) D’altra parte, se supponiamo che l’unità sia quella proprietà empirica degli oggetti che resta dopo aver tolto ad essi tutte le caratteristiche che permettono di distinguerli l’uno dall’altro, viene a mancare la possibilità di introdurre numeri più grandi di 1: togliendo idealmente tutte le proprietà per cui due gatti differiscono tra loro non ottengo il concetto di 2, ma quello generale di Gatto.
(f) Se si accetta che l’unità può essere esemplificata per mezzo dell’atto di pensare qualche cosa come una entità indivisibile, come alcuni hanno suggerito, essa resta applicabile solo a questo tipo speciale di oggetto; dunque, non serve più a contare quelle cose che normalmente sono l’oggetto dei nostri calcoli.
Le critiche riferite in (e) e in (f) implicano entrambe l’ammissione che il concetto di numero - benché non possa essere fondato su qualche aspetto dell’esperienza - deve tuttavia poter essere applicato agli oggetti esperibili nel senso in cui ciò avviene nelle normali operazioni di conteggio. Altrimenti - scrive Frege - «non ci resterebbe quasi più nulla cui poter attribuire il nome di unità e cioè quasi più nulla che possa venir contato».
Questa affermazione, naturalmente, ripropone la discussione di alcuni temi riguardanti la fenomenologia dell’esperienza, in rapporto al problema dell’unità e della molteplicità. Daccapo sorge il problema: ma di quali proprietà devono godere i fatti dell’esperienza per poter essere oggetto di una enumerazione? Se l’esperienza fosse un flusso continuo privo di segmentazioni interne, veramente non ci sarebbe nulla che possa venir contato.
Frege, avendo abbandonato l’idea di una fondazione empirica dell’idea di unità, offre per la sua definizione alcuni criteri puramente logici : l’unicità, e l’indivisibilità logica dei concetti, l’uguaglianza e la distinguibilità come relazioni formali.
L’applicazione del numero alle cose richiede che si possano mettere in luce nelle cose stesse, in quanto oggetti dell’esperienza diretta, proprietà corrispondenti ai quattro requisiti proposti da Frege. La teoria gestaltistica della percezione ha ispirato molte ricerche dirette proprio in questo senso, dalle quali sono emerse le leggi che governano, nel campo percettivo, la formazione delle unità (le quali costituiscono il «pendant» fenomenologico dell’unicità), e la dinamica del rapporto tra il tutto e le parti (di cui sono momenti essenziali l’indivisibilità fenomenica delle organizzazioni percettive in «parti arbitrarie», e la distinguibilità, nei tutti, di «parti naturali»).
I problemi fenomenologici connessi all’uguaglianza di Frege - cioè l’identicità-permanenza - sono trattati nei Capp. III e IV di questo libro.
Un avvicinamento a tali problemi da parte della psicologia sarebbe stato impossibile nel quadro delle teorie elementaristiche che dominarono gli studi sulla percezione nel corso del sec. XIX. Il ruolo assegnato, per esempio, da Helmholtz alle «sensazioni» nell’economia complessiva del rapporto tra soggetto percipiente e mondo esterno non permette di parlare di vere unità percettive organizzate più di quanto lo autorizzi la teoria associazionistica di Hume. Helmholtz, trattando questo tema, si esprime quasi con le stesse parole del filosofo scozzese. L’unica unità ammissibile, sia per l’uno che per l’altro di questi Autori, è la singola sensazione («minimum visibile»), considerata per se stessa, ed enucleata artificialmente da quei complessi di sensazioni che le abitudini acquisite e le attività intellettuali superiori ci inducono a considerare arbitrariamente come «oggetti». Un rapporto articolato e dinamico tra il tutto e le parti, come quello prospettato già da Aristotile nella «Metafisica», non appare, in tale quadro, teoreticamente possibile. D’altra parte, le ricerche helmholtziane sul funzionamento degli organi di senso e sulla fisiologia delle conduzioni nervose non ammette prospettive diverse da quella elementaristica.
Il mutamento intervenuto con la teoria della gestalt consiste principalmente nel riconoscere ai fatti dell’esperienza diretta e a tutte le loro proprietà un ruolo importante almeno quanto quello delle acquisizioni raggiunte attraverso lo studio degli aspetti fisici e fisiologici implicati nel processo percettivo.
Il compito dello psicologo è quello di studiare le proprietà degli eventi presenti nell’esperienza stessa, così come esse si presentano, e di analizzare sperimentalmente le loro condizioni, al fine di ottenere un quadro sempre più completo delle leggi che connettono tra loro specifiche costellazioni di stimoli a specifiche varietà di esperienze; non è quello di derivare, dalle premesse della fisica e della fisiologia, un quadro dell’esperienza, quale dovrebbe essere.
Quanto sappiamo di queste due scienze non deve indurci a suddividere il mondo della percezione in una classe di esperienze «reali», accanto ad un’altra di esperienze «illusorie». Nell’analisi fenomenologica vale il principio dell’» esse est percipi», assunto come criterio metodologico di base.
In questo senso, se un oggetto appare come un’unità, esso è un’unità. Possiamo «immaginare» di dividerlo in parti, ma queste parti «pensate» o «immaginate» non prendono corpo in esso, non si realizzano. Possono comparire solo se modifichiamo obbiettivamente la sua struttura intervenendo sulle condizioni della sua unità.
In questo senso strettamente specifico non si può affermare che gli oggetti dell’esperienza siano suddivisibili a piacere.
L’unità, inoltre, può ammettere varie intensità: un complesso di parti può effettivamente essere più o meno unitario. Per questo si può dire sensatamente che «un oggetto è uno», intendendo dire che la sua unità è particolarmente forte.
Le condizioni che regolano l’intensità delle organizzazioni unitarie sono state messe in evidenza ed enunciate nel quadro di una teoria organica da M. Wertheimer. Diversi equilibri tra l’azione di fattori come la «vicinanza», la «somiglianza», la «chiusura» ecc. determinano l’intensità di ogni unificazione, da un massimo fino a un minimo che corrisponde alla disgregazione dell’oggetto.
Entro quest’ambito hanno luogo differenti modi di connessione tra le varie parti di un tutto, che è possibile analizzare per via sperimentale.
Quando tali connessioni tra i diversi segmenti del campo sono particolarmente deboli, possono aver luogo i puri «aggregati» di oggetti, le semplici «molteplicità» di elementi giustapposti; una caratteristica saliente di tali «molteplicità» è la numerosità (esperimenti di Benussi e De Marchi): in queste situazioni abbiamo a che fare con la quantità intesa come proprietà qualitativa dell’esperienza diretta, e con il numero in veste di attributo capace di esprimerne la consistenza.
L’insieme di tutti questi fatti colloca in una luce particolare la critica alla fondazione empirica del concetto di unità e di numero da cui siamo partiti. Anche accettando che tali concetti devono poggiare su una fondazione puramente logica, resta vero che la loro applicazione al mondo delle cose esperibili dipende dall’esistenza in esso, di determinate proprietà qualitative sperimentalmente analizzabili e direttamente connesse con l’uso linguistico corrente di termini ed espressioni «quantitative».
![]()
Note
[1] W. Köhler Ueber unbemerkte Empfindungen und Urteilstäuschungen,, « Zeitsch. für Psych.», 1913, Bd 66, pagg. 51-80. Un’esposizione dettagliata dell’argomento è in: P. Bozzi, Introduzione alle tesi di Köhler, in: W. Köhler, Principi dinamici in psicologia, Firenze, 1966, pagg. V-XXXVIII.
[2] W. Köhler, Die Physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand, Braunschweig, 1920.
[3] W. Köhler, Gestaltprobleme und Anfänge einer Gestalttheorie «Jahresb.ü.d.gesam. Physiologie «, 1922. Trad. it. di G. Tampieri, in «Principi dinamici in Psicologia», Firenze, 1966, pag. 178.
[4] Vedi cap. IV, § 8.
[5] W. Köhler, Gestalt Psychology, N. Y., 1947, pag. 162.
[6] H. Kopermann, Psychologische Untersuchungen über die Wirkung zweidimensionaler Darstellungen körperlicher Gebilde, « Psych. Forsch.», 1930, pagg. 293 e segg.
[7] Vedi cap. VI, § 10, esp. 3.51.
[8] Koffka, Principles, ed. 1955, pag. 141.
[9] M. Wertheimer Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt, II, « Psych. Forsch.», 1923, pagg. 301 e segg.
[10] W. Köhler, Some tasks of gestalt psychology, in « Psychologies of 1930», vol. II: Worcester, 1930. Trad. it. di G. Vicario, in « Principi di Psicologia Dinamica», Firenze, 1966, pag. 126.
[11] M. Wertheimer, Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt, II, « Psych. Forsch. «, 1923, pag. 318.
[12] A. Galli e A. Zama, Untersuchungen über die Wahrnehmung ebener geometrischen Figuren die ganz oder teilweise von anderen geometrischen Figuren verdeckt sind, «Ztschr. f. Psych «, 1931, 3, pagg. 308-318.
[13] W. Metzger, Gesetze des Sehens, Frankfurt a. M., 1936, pag. 20.
[14] G. Kanizsa, Margini quasi-percettivi in campi con stimolazione omogenea, « Riv. di Psic., «, 1955, pagg. 7 e segg.
[15] M. Wertheimer, Op. cit., pag. 332.
[16] M. Wertheimer, 0p. cit., pag. 333
[17] G. Kanizsa, Percezione attuale, esperienza passata e l’ «esperimento impossibile» in «Ricerche sperimentali sulla percezione», Trieste, 1968, pag. 9 e segg.
[18] K. Gottschaldt, Ueber den Einfluss der Erfarung auf die Wahrnehmung von Figuren «Psich. Forsch.» 1926, pagg. 1-87.
[19] M. Wertheimer, Zu dem Problem der Unterscheidung von Einzelinhalt und Teil, « Ztschr. f. Psych.», 1933, pagg. 353 e segg. Trad. it. M. Giacometti e R.Bolletti, in «Il Pensiero produttivo», Firenze, 1965, pagg. 279 e segg.
[20] M. Wertheimer, Op. cit., pagg. 57-67, e passim.
[21] Op. cit., pag. 283.
[22] Op. cit., pag. 283.
[23] Op. cit., pag. 283.
[24] Platone, Teeteto, trad. it. di M.Valgimigli, Bari, 196510. Per i riscontri, abbiamo utilizzato l’edizione di Burnet, Oxford, 1946. L’affermazione è contenuta in 204 e.
[25] Ibidem, 202 e.
[26] Ibidem, 207 a-c.
[27] Ibidem, 204 d.
[28] Ibidem, 206 b.
[29] Ibidem, 202 e.
[30] Ibidem, 206 a.
[31] Ibidem, 203 c.
[32] Ibidem, 204 a.
[33] Ibidem, 204 a.
[34] Arist. Metaph., 1024 .
[35] Gli esempi delle figure 50 e 51, e gli altri che verranno discussi qui di seguito, sono tratti dal materiale di una ricerca sperimentale da me realizzata nell’Istituto di Psicologia dell’Università di Padova, riguardante i gradi di «coesione « tra oggetti percettivi equidistanti.
[36] C. L. Musatti, Analisi del concetto di realtà empirica, Città di Castello, 1926, pagg. 132-133. Cfr. gli interi due §§ 59 e 60.
[37] A. J. Ayer, The Terminology of Sense-data, in «Philosophical Essays», London, 1963; pag. 94 e segg.
[38] A. J. Ayer, The Terminology oj Sense-data, ed. cit., ibidem.
[39] V. Benussi, Aus der forensischen Psychologie: Die Fehlerwurzeln unserer Aussagen, «Der Friede», 1918, pagg. 323 e segg.
[40] M. Ponzo, Illusioni negli apprezzamenti di collettività, «Arch. It. di Psic. «, 1928-1.
[41] H. Mokre, Ueber den Einfluss von Grösse und Abstand auf die Mengenauffassung, «Ztsch. f. Psych. «, 1927 (105) pag. 195 e segg. Vedi: S. De Marchi, Le valutazioni numeriche di collettività, Torino 1929.